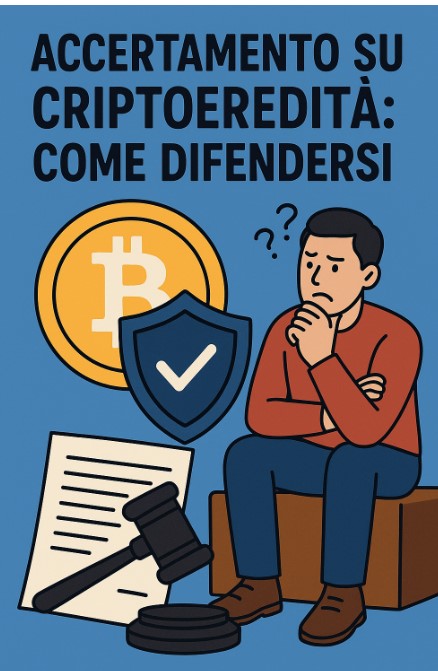Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per criptovalute o asset digitali ereditati?
Negli ultimi anni il Fisco ha intensificato i controlli sulle criptoeredità, cioè sui wallet, exchange o conti digitali ereditati dal defunto. In questi casi, l’Agenzia presume spesso che le valute virtuali non siano state dichiarate nella successione o nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Gli accertamenti su eredità digitali stanno aumentando grazie ai nuovi strumenti di tracciamento e agli accordi internazionali con le piattaforme di scambio. Le conseguenze possono essere molto pesanti: imposta di successione, tassazione dei presunti redditi, sanzioni fino al 30% e perfino ipotesi di evasione o riciclaggio. Tuttavia, con una difesa solida e documentata, è possibile dimostrare la legittima provenienza delle criptovalute e ridurre o annullare la pretesa dell’Agenzia.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta criptovalute ereditate
– Se il wallet o l’account exchange del defunto non è stato indicato nella dichiarazione di successione
– Se gli asset digitali non sono stati dichiarati nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale
– Se i trasferimenti di criptovalute verso gli eredi non trovano tracciabilità documentale
– Se l’Ufficio presume che le cripto derivino da attività non dichiarate o da operazioni speculative
– Se emergono dati anomali dalle piattaforme di scambio o dalle segnalazioni antiriciclaggio (AML)
Conseguenze della contestazione
– Applicazione dell’imposta di successione sulle criptovalute non dichiarate
– Sanzioni dal 3% al 15% (fino al 30% se detenute su exchange esteri non collaborativi)
– Tassazione dei redditi presunti generati dalla rivalutazione delle criptovalute
– Interessi di mora sulle somme accertate
– Nei casi più gravi, segnalazioni per riciclaggio o omessa dichiarazione di attività estere
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare con chiavi pubbliche, estratti exchange o atti notarili la provenienza ereditaria delle criptovalute
– Presentare report di transazioni o certificazioni rilasciate da piattaforme di scambio e wallet provider
– Provare che le cripto erano già state dichiarate o tassate dal defunto
– Contestare la presunzione di evasione se i trasferimenti sono stati effettuati con strumenti tracciabili e verificabili
– Evidenziare errori di calcolo, carenze istruttorie o vizi di motivazione nell’atto di accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la provenienza, la tipologia e la tracciabilità degli asset digitali contestati
– Verificare la legittimità della procedura di accertamento e la correttezza degli atti notificati
– Assistere nella ricostruzione dei wallet, nel recupero delle chiavi o dei report blockchain
– Predisporre un ricorso fondato su prove tecniche e convenzioni internazionali contro la doppia imposizione
– Difendere gli eredi davanti ai giudici tributari e tutelare il patrimonio ereditato da sanzioni eccessive
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– Il riconoscimento della provenienza ereditaria e non reddituale degli asset digitali
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– La certezza di pagare solo quanto realmente dovuto secondo la legge e le convenzioni internazionali
⚠️ Attenzione: le criptoeredità sono oggi tra le principali fonti di contestazione da parte del Fisco.
Molti eredi ignorano che anche le criptovalute devono essere dichiarate nel quadro RW e incluse nella successione. È quindi fondamentale agire subito, con una difesa documentata e una strategia legale mirata.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, successioni e fiscalità delle criptovalute – spiega come difendersi in caso di accertamento su criptoeredità e quali strategie adottare per proteggere il patrimonio digitale di famiglia.
👉 Hai ricevuto un accertamento su criptovalute ereditate?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo la fondatezza della contestazione e costruiremo la difesa più efficace per tutelare i tuoi interessi e il patrimonio digitale ereditato.
Introduzione
L’uso di criptovalute e di crypto‐asset (NFT, token utilità, token security, token aziendali o di governance) è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Attività speculative, pagamenti, programmi di finanziamento tramite tokenizzazione di beni e servizi e, più recentemente, strumenti DeFi (decentralised finance) sono entrati nella vita quotidiana di cittadini, imprenditori e professionisti. Il legislatore, per lungo tempo incerto sulla natura di questi strumenti, ha progressivamente dettato norme fiscali e civilistiche applicabili; parallelamente, la giurisprudenza ha elaborato principi che incidono sulle procedure di accertamento fiscale e sulla tutela del patrimonio degli eredi.
Il quadro normativo italiano è dinamico: la legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) la lettera c‑sexies all’art. 67, qualificando le plusvalenze derivanti da operazioni su cripto‐attività come redditi diversi e istituendo un’imposta sostitutiva; la legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha innalzato l’aliquota (26 % nel regime transitorio 2025 e 33 % dal 2026) e ha consentito la rivalutazione delle cripto‐attività tramite imposta sostitutiva dell’18 % . Inoltre, la normativa anti‑riciclaggio e di vigilanza sui servizi che offrono custodia o scambio di crypto‑asset è stata rafforzata con l’obbligo di registrazione presso l’OAM, l’applicazione della travel rule europea e il monitoraggio da parte dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) .
Questa guida, aggiornata a settembre 2025, intende fornire un’analisi dettagliata e trasversale sulle verifiche fiscali e successorie relative ai crypto‑asset, con particolare attenzione alle strategie difensive del debitore e dell’erede. È suddivisa in sezioni tematiche: normative fiscali, disciplina successoria, ruolo delle autorità (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, notai, tribunali), giurisprudenza recente, obblighi dichiarativi, strategie preventive e difensive, domande frequenti, tabelle riepilogative e simulazioni pratiche.
1. Definizioni e tipologie di cripto‑asset
1.1 Cripto‑attività e criptovalute
Le cripto‑attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e archiviate elettronicamente mediante tecnologia DLT (distributed ledger technology). La direttiva (UE) 2018/843 e il decreto legislativo 231/2007 definiscono la virtual currency come “la rappresentazione digitale di valore non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta legalmente istituita, che non ha lo status giuridico di valuta o di moneta, ma che è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” . Questo concetto comprende i bitcoin, i token utilità, i token di pagamento e, secondo la normativa fiscale italiana, anche NFT (Non‑fungible tokens) se hanno valore patrimoniale.
La sentenza della Cassazione n. 1569/2024 (depositata nel 2025) ha precisato che il bitcoin, per la sua volatilità e per l’assenza di garanzia da parte di una banca centrale, non possiede lo status di moneta legale; di conseguenza, in un procedimento penale per frode fiscale, il sequestro di bitcoin non può essere giustificato come sequestro per equivalente (ossia finalizzato alla confisca del denaro risparmiato a seguito del reato), ma deve riferirsi all’importo di imposta evaso in euro . Questa distinzione tra criptovalute e valuta legale è fondamentale anche in sede di accertamento fiscale e successorio.
1.2 NFT, token aziendali e altri strumenti digitali
Gli NFT sono certificati digitali unici registrati su blockchain che attestano la titolarità di un contenuto (immagine, video, opera artistica, asset digitale). La Cassazione, nella sentenza n. 8269/2025, ha qualificato i proventi derivanti dalla vendita di NFT come redditi di lavoro autonomo; i compensi ricevuti in criptovalute sono economicamente valutabili e pertanto devono essere dichiarati, con l’obbligo di convertire il controvalore in euro al momento della percezione . Il mancato adempimento costituisce violazione del dovere di presentare una dichiarazione corretta e integra il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 del D.Lgs. 74/2000 .
Oltre alle criptovalute e agli NFT, l’ecosistema blockchain comprende token aziendali (ad esempio security token che rappresentano partecipazioni societarie), token utilità (danno accesso a servizi), token di governance (conferiscono diritti di voto in piattaforme DeFi) e token infrastrutturali (utilizzati per pagare commissioni). Tutte queste categorie rientrano nel concetto di cripto‑attività se hanno valore economico e sono trasferibili. In ambito successorio e fiscale occorre valutarne:
- Natura giuridica: titolo di proprietà, diritto reale, diritto di credito;
- Modalità di detenzione: wallet self‑custodito (hardware o software), wallet custodial gestito da intermediario (exchange, broker), multi‑firma;
- Tracciabilità e valore: volatilità, valutazione di mercato, conversione in valuta fiat.
2. Quadro normativo fiscale delle cripto‑attività in Italia
2.1 Evoluzione normativa: dal vuoto al riconoscimento
Per anni il legislatore italiano ha ignorato le criptovalute, delegando alle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza il compito di qualificare la natura fiscale degli utili derivanti da operazioni su blockchain. Le prime pronunce fiscali e circolari (interpello n. 72/E 2016, risoluzione n. 6/E 2018) assimilavano i bitcoin alle valute estere, mentre altre interpreti li qualificavano come strumenti finanziari. Il vuoto normativo è stato colmato solo con la legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197), che ha introdotto la lettera c‑sexies all’art. 67 comma 1 TUIR, includendo le plusvalenze derivanti da “cripto‑attività” tra i redditi diversi, con un’imposta sostitutiva del 26 %. Tale disposizione ha definito le cripto‑attività come “la rappresentazione digitale di valore o di diritti che può essere trasferita e memorizzata elettronicamente, utilizzando la tecnologia della distributed ledger o una tecnologia analoga” .
Nel 2024, la legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha modificato l’aliquota dell’imposta sostitutiva portandola al 26 % per il solo anno 2025 e al 33 % a regime dal 2026 . Inoltre, ha eliminato la franchigia di 2.000 euro sui guadagni netti annui, in precedenza prevista per escludere dalle imposte le plusvalenze di modesta entità . Questa riforma ha quindi reso tassabile qualsiasi plusvalenza, anche minima, realizzata a decorrere dal 2025.
2.2 Rivalutazione delle cripto‑attività
Uno strumento di pianificazione fiscale introdotto con la legge di Bilancio 2025 è l’opzione di rivalutazione delle cripto‑attività possedute alla data del 1° gennaio 2025: il contribuente può versare un’imposta sostitutiva del 18 % sul valore normale risultante alla medesima data, determinato sulla base di quotazioni riportate da soggetti qualificati (exchange regolamentati). Il pagamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo . Il beneficio consiste nel far emergere il valore latente del crypto‑portafoglio, al fine di ridurre o azzerare le future plusvalenze tassabili. Questa opzione è particolarmente utile per i contribuenti che detengono ingenti crypto‑asset con forte plusvalenza non realizzata.
2.3 Norme transitorie 2023–2024 e dubbi interpretativi
Per le annualità 2023 e 2024, la normativa non era ancora univoca: la legge di Bilancio 2023 non prevedeva alcuna aliquota specifica, ma l’Agenzia delle Entrate riteneva applicabile l’imposta sostitutiva del 26 % prevista per i redditi diversi. Alcune dottrine ipotizzavano l’aliquota del 12,5 % (applicabile ai redditi di capitale), ma la Fondazione nazionale dei commercialisti ha sottolineato che la legge di Bilancio 2025 ha fissato l’aliquota al 26 % solo per il 2025 e al 33 % dal 2026, lasciando irrisolto il regime 2023–2024 . L’incertezza giustifica una gestione prudenziale: in assenza di ulteriori interventi, i contribuenti sono invitati a richiedere interpelli o ad aderire alla sanatoria introdotta nel 2023.
2.4 Sanatoria e regolarizzazione delle cripto‑attività
L’art. 1, commi 133–139, della legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di emersione volontaria delle cripto‑attività detenute e non dichiarate al 31 dicembre 2022. I contribuenti potevano presentare istanza di sanatoria entro il 30 novembre 2023, dichiarando le cripto‑attività non indicate nel Quadro RW e versando:
- una sanzione dello 0,5 % del valore delle cripto‑attività non dichiarate per ogni anno;
- una imposta sostitutiva del 14 % sul valore al 1° gennaio 2023 in caso di plusvalenze non tassate;
- imposta sostitutiva dello 0,2 % (IVAFE) sul valore delle cripto‑attività detenute all’estero.
Chi aderiva alla sanatoria era esonerato dalle sanzioni più gravi e dalle responsabilità penali relative ai reati di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione. Tale regolarizzazione ha ridotto notevolmente il rischio di accertamenti futuri per periodi pregressi ma non opera per le annualità successive.
2.5 Monitoraggio fiscale e dichiarazione nel quadro RW
Il Quadro RW della dichiarazione dei redditi è riservato al monitoraggio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero o presso istituti non residenti; vi rientrano anche i portafogli crypto se la custodia avviene su exchange esteri oppure se la detenzione è in wallet self‑custoditi (in quanto attività estere di natura finanziaria). L’assenza di un sostituto d’imposta residente impone al contribuente di dichiarare:
- il valore delle cripto‑attività al 31 dicembre e la giacenza media per l’IVAFE (0,2 %);
- le plusvalenze realizzate, versando l’imposta sostitutiva tramite il modello F24;
- eventuali redditi da staking, mining, airdrop o altre modalità di produzione di crypto‑asset.
Le omissioni del quadro RW comportano sanzioni dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato, raddoppiate (6–30 %) se l’attività è detenuta in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La giurisprudenza ritiene che la mera detenzione di crypto‑attività non costituisca di per sé reato, ma l’omissione sistematica del quadro RW può essere considerata parte di una condotta fraudolenta e alimentare la prova del dolo nel reato di dichiarazione infedele .
2.6 Trattamento di mining, staking e airdrop
Il legislatore non ha ancora disciplinato in modo puntuale i redditi derivanti da mining, staking, yield farming o airdrop. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 30/E del 2023, ha affermato che:
- i premi da staking rappresentano redditi di capitale assimilabili agli interessi;
- le ricompense da mining e da fornitura di liquidità a protocolli DeFi sono redditi diversi e devono essere valutate al valore di mercato al momento della ricezione;
- gli airdrop (distribuzione gratuita di token) generano redditi diversi se sono corrisposti in cambio di prestazioni (es. partecipazione a community, compiti di marketing), altrimenti sono liberalità irrilevanti per l’imposta.
La complessità dell’ecosistema DeFi rende necessaria un’analisi caso per caso, soprattutto per gli imprenditori che utilizzano token per remunerare dipendenti o per raccogliere capitali. Nel contesto di un accertamento occorrerà produrre evidenze (smart contract, indirizzi on‑chain, report degli exchange) che dimostrino l’assenza di corrispettivi tassabili o la corretta determinazione dei redditi.
3. Disciplina civilistica e successoria delle cripto‑attività
3.1 La nozione di eredità digitale
Le eredità digitali comprendono l’insieme di dati, diritti e beni detenuti in formato digitale dal de cuius (la persona deceduta). Esse si dividono in:
- Beni digitali non patrimoniali: profili social, email, archivi fotografici personali; la loro trasmissibilità è spesso limitata dalle condizioni d’uso delle piattaforme;
- Beni digitali patrimoniali: conti bancari online, portafogli di criptovalute, token non fungibili, domini internet, licenze software. Questi beni hanno un valore economico e rientrano nell’asse ereditario .
Nel contesto della cripto‑eredità, assumono rilevanza due profili: accessibilità (reperimento e gestione delle chiavi private) e valutazione patrimoniale (determinazione del valore fiscale). La circolare 30/E 2023 ha chiarito che per la dichiarazione di successione si applicano le regole generali dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma la quantificazione del valore delle cripto‑attività richiede riferimento a prezzi di mercato (quotazioni medie di exchange regolamentati) e può essere soggetta a volatilità .
3.2 Regole sulla devoluzione ereditaria
L’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o per donazione. Le aliquote variano in base al grado di parentela (4 % con franchigia di € 1 milione per coniuge e figli; 6 % per fratelli e sorelle con franchigia di € 100.000; 6 % senza franchigia per parenti fino al 4° grado; 8 % per altri soggetti). I cripto‑asset rientrano tra i beni assoggettati all’imposta; ai fini della dichiarazione di successione è necessario indicare il loro valore al momento dell’apertura della successione (data del decesso). La Cassazione con ordinanza n. 18252/2025 ha stabilito che l’obbligazione tributaria dell’imposta di successione nasce al momento dell’apertura della successione (chiamata all’eredità) e non al momento dell’accettazione da parte degli eredi; di conseguenza, gli eredi rispondono dell’imposta anche se la successione devolutasi al de cuius non era stata da lui accettata . Tale principio implica che gli eredi possono essere chiamati a pagare l’imposta di successione sulle cripto‑attività appartenenti a eredità pregresse non accettate dal de cuius .
La Cassazione n. 14063/2025 ha ulteriormente precisato che l’accettazione dell’eredità, anche tacita, è inefficace se manca una valida chiamata; la revoca di un testamento retroagisce alla data del decesso, eliminando l’efficacia degli atti compiuti dagli eredi non legittimamente chiamati . Tali pronunce sono fondamentali per comprendere i profili processuali di un accertamento su cripto‑eredità: l’amministrazione finanziaria può recuperare imposta e sanzioni anche dopo anni se emerge che l’erede aveva acquisito beni digitali in forza di una chiamata non valida.
3.3 Formalità della dichiarazione di successione
Gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall’apertura della successione. Occorre indicare tutti i beni ereditari, compresi i crypto‑asset, con una descrizione idonea (ad esempio: “Portafoglio bitcoin: n. x BTC in wallet hardware identificato da indirizzo public key XXX”; “Token NFT x” ecc.). La valutazione può basarsi su:
- Quotazioni medie desunte da exchange regolamentati;
- Prezzi di mercato rilevati da agenzie accreditate (CoinMarketCap, CryptoCompare, etc.);
- Valori di riferimento forniti da periti indipendenti.
In caso di disaccordo con l’Agenzia delle Entrate sulla valutazione, gli eredi possono proporre autotutela o ricorso alla Commissione tributaria. Tuttavia, la mancanza di un mercato centralizzato può rendere difficile dimostrare l’esattezza della stima. È consigliabile allegare documenti estratti dalle piattaforme di scambio o dai servizi di blockchain analytics per attestare la quantità e il valore delle crypto.
3.4 Pianificazione successoria con testamento, trust e smart contract
Una corretta pianificazione è essenziale per evitare dispute e facilitare l’accesso alle chiavi. Le soluzioni includono:
- Testamento olografo o pubblico: il de cuius può specificare nel testamento la presenza di crypto‑asset, indicare gli indirizzi dei wallet e i beneficiari. È sconsigliato inserire le chiavi private nel testamento stesso per ragioni di segretezza; meglio depositarle presso notaio o in cassette di sicurezza accessibili dagli eredi.
- Trust e fiducie: si possono costituire trust inter vivos con trustee (persona o società fiduciaria) incaricata della custodia e della distribuzione delle chiavi secondo le istruzioni. I trust possono essere soggetti a imposizione indiretta ma garantiscono protezione patrimoniale.
- Multi‑signature wallets: i crypto‑asset possono essere conservati in wallet multi‑firma che richiedono la firma di più soggetti per autorizzare operazioni. L’erede può essere detentore di una delle chiavi, mentre il de cuius o un fiduciario detiene le altre. Alla morte, la terza chiave può essere rilasciata dal notaio in favore dell’erede.
- Smart contract: sistemi automatizzati che trasferiscono i token al verificarsi di un evento (ad esempio la pubblicazione dell’atto di morte su una blockchain certificata). Questi strumenti, sebbene innovativi, sollevano questioni di validità e contrasto con le norme italiane sulla forma testamentaria; necessitano quindi di una combinazione con strumenti tradizionali per essere efficaci .
3.5 Ordine di accesso alle chiavi e problemi pratici
L’accesso alle chiavi private costituisce il principale ostacolo per gli eredi. Se il de cuius detenendo un wallet self‑custodito non ha lasciato indicazioni, i crypto potrebbero andare perduti. Secondo un’analisi di esperti di digital forensics, è possibile:
- Recuperare i dati dai dispositivi del deceduto (computer, smartphone) con strumenti di analisi forense;
- Utilizzare tecniche di estrazione hardware come il chip off per estrarre la memoria di hardware wallet se il PIN è sconosciuto ;
- Chiedere collaborazione agli exchange se il de cuius aveva un account intestato; in questo caso occorrerà presentare la documentazione successoria (atto di morte, certificato di erede, ecc.) .
Gli eredi hanno diritto, in base al regolamento eIDAS e alle normative sui servizi digitali, a ottenere dal gestore dell’exchange i dati relativi al conto del deceduto; tuttavia, la normativa sulla protezione dei dati personali impone la cancellazione dei dati non necessari. È quindi consigliabile rivolgersi tempestivamente a un avvocato o a un notaio per richiedere la conservazione dei log e l’esibizione dei saldi.
4. Autorità coinvolte negli accertamenti su cripto‑eredità
4.1 Agenzia delle Entrate e sistema di accertamento
L’Agenzia delle Entrate è titolare del potere di accertare le imposte dovute sui redditi, sulle plusvalenze e sull’imposta di successione. Nei procedimenti che coinvolgono cripto‑attività, l’Agenzia acquisisce informazioni tramite:
- Anagrafe dei rapporti finanziari: nel 2024 è stato istituito un registro anche per gli operatori di crypto‑asset iscritti all’OAM, i quali devono trasmettere i movimenti dei clienti.
- Scambi di informazioni internazionali: l’Italia partecipa al Crypto‑Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE e al DAC8 dell’UE, che prevedono la raccolta e lo scambio automatico dei dati sulle transazioni crypto da parte dei fornitori di servizi.
- Quadro RW e modelli dichiarativi**: l’assenza di indicazione di crypto‑asset o la discordanza con i dati della anagrafe può generare un alert.
- Segnalazioni UIF e Guardia di Finanza: transazioni sopra soglie prefissate o movimenti sospetti possono essere oggetto di segnalazione di operazioni sospette (SOS) e innescare un controllo.
Una volta individuata la possibile evasione, l’Agenzia emette un avviso di accertamento con la motivazione e l’indicazione dell’imposta, sanzioni e interessi. Il contribuente può presentare osservazioni (contraddittorio) e fornire documentazione; in caso di disaccordo, può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni.
4.2 Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza svolge attività di polizia economico‑finanziaria e collabora con l’Agenzia delle Entrate, in particolare nei controlli anti‑evasione e anti‑riciclaggio. Essa dispone di unità specializzate in cyber investigazioni e può:
- Effettuare indagini finanziarie su flussi di criptovalute, utilizzando software di blockchain analytics per ricostruire le transazioni;
- Eseguire perquisizioni e sequestri di hardware wallet, smartphone o computer;
- Richiedere ai fornitori di servizi (exchange, wallet provider) le informazioni relative agli utenti, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 231/2007, che impone l’obbligo di collaborazione .
La Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 1760/2025, ha stabilito che il sequestro probatorio di bitcoin per reati fiscali deve essere limitato al valore corrispondente all’imposta evasa in euro e non può essere eseguito “per equivalente” sulla criptovaluta . La Guardia di Finanza, quindi, dovrà convertire la crypto in euro al tasso di mercato al momento del sequestro oppure limitarsi a bloccare la quantità di crypto pari al debito tributario.
4.3 Notai
I notai rivestono un ruolo fondamentale nella pianificazione e nell’esecuzione delle cripto‑eredità:
- Possono redigere testamenti che menzionano la presenza di crypto‑asset e fornire istruzioni per la consegna delle chiavi private;
- Custodiscono le chiavi o le depositano presso la carta notarile;
- Assistono gli eredi nella redazione della dichiarazione di successione, verificando la regolarità formale;
- Svolgono la funzione di pubblico ufficiale nella verifica dell’identità dei soggetti e nella trascrizione degli atti dispositivi.
La mancanza di una regolamentazione specifica per la digital inheritance obbliga i notai a interpretare in chiave moderna gli artt. 600 ss. c.c. (testamento) e a combinare strumenti informatici (criptografia) con la tradizionale sicurezza notarile. Essi possono inoltre ricorrere a smart contract notarizzati o a time capsule depositate presso l’archivio notarile come prova dell’ultima volontà del de cuius.
4.4 Giudici tributari e giudici civili
I giudici tributari sono chiamati a risolvere le controversie tra contribuente ed Agenzia delle Entrate sulle imposte sui redditi e sull’imposta di successione. Essi interpretano le norme in base ai principi generali e alla giurisprudenza comunitaria. L’intervento dei giudici civili può essere necessario per le azioni di petizione di eredità, divisione, rivendica o responsabilità professionale per la perdita di crypto‑asset (ad esempio per negligenza del fiduciario). La giurisprudenza recente dimostra come i giudici siano sensibili alla particolarità delle crypto: nel 2025 la Cassazione ha negato la natura di moneta legale ai bitcoin e ha esteso la responsabilità degli eredi per chiamate pregresse , mentre la Cassazione n. 8269/2025 ha esteso la nozione di reddito di lavoro autonomo ai proventi in crypto .
5. Profili penali e sanzionatori
5.1 Dichiarazione infedele e omessa dichiarazione
Le principali ipotesi di rilevanza penale connesse alle cripto‑attività sono i reati del D.Lgs. 74/2000. In particolare:
- Dichiarazione infedele (art. 4): si realizza quando il contribuente, al fine di evadere le imposte dirette o l’IVA, indica elementi attivi inferiori o elementi passivi fittizi per un importo superiore a 150.000 euro di imposta evasa. L’omessa indicazione di plusvalenze o di redditi in criptovaluta, come nel caso degli artisti che vendono NFT e incassano Ethereum, può integrare tale reato .
- Omessa dichiarazione (art. 5): punisce il contribuente che non presenta, per oltre novanta giorni dalla scadenza, la dichiarazione annuale dei redditi, dell’IVA o dell’IRAP, se l’imposta evasa supera 50.000 euro. Nel contesto crypto, riguarda chi effettua numerose operazioni senza registrarle né presentare il quadro RW e le dichiarazioni.
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) e frode nelle dichiarazioni (art. 3): possono essere contestati se un imprenditore utilizza token o NFT per creare false fatturazioni o gonfiare i ricavi.
Le recenti pronunce (Cassazione n. 8269/2025) hanno chiarito che l’errore sulla legge tributaria, dovuto all’incertezza normativa sulle crypto, non esclude la punibilità se il contribuente avrebbe potuto informarsi e interpretare correttamente la disciplina . Solo l’errore inevitabile per mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate può costituire causa di non punibilità.
5.2 Riciclaggio e autoriciclaggio
Le cripto‑attività possono essere utilizzate per trasferire e occultare proventi di reati. Il reato di autoriciclaggio (art. 648‑ter.1 c.p.) punisce chi impiega, sostituisce o trasferisce denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza. La Cassazione, nella sentenza n. 27023/2022, ha qualificato l’acquisto di bitcoin con proventi di reati fiscali come autoriciclaggio; inoltre, la vendita di token a investitori al dettaglio senza autorizzazione può integrare il reato di abusivismo finanziario ex art. 166 del TUF .
La normativa anti‑riciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e s.m.) impone ai virtual asset service provider (VASP) di effettuare l’adeguata verifica della clientela, la registrazione delle operazioni e la segnalazione delle transazioni sospette alla UIF. Il Regolamento UE 2023/1113 (travel rule) obbliga i VASP a trasmettere i dati identificativi del mittente e del destinatario per trasferimenti superiori a 1.000 euro . La mancata adempienza a tali obblighi può comportare sanzioni amministrative e, in casi gravi, responsabilità penale delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001.
5.3 Sequestro e confisca di cripto‑attività
Le autorità investigative possono procedere al sequestro probatorio o preventivo delle cripto‑attività quando sono corpo del reato o profitto. Tuttavia, la volatilità e la natura decentralizzata delle crypto hanno indotto la giurisprudenza a limitare i sequestri. La Cassazione n. 1569/2024 (deposito 2025) ha annullato il sequestro di bitcoin disposto per la presunta evasione dell’imposta sui redditi, affermando che i bitcoin non sono moneta legale e non possono costituire oggetto di sequestro per equivalente . La Corte ha specificato che il sequestro deve riferirsi all’ammontare dell’imposta evasa convertito in euro, evitando la perdita di valore dovuta alle fluttuazioni .
Questa pronuncia incide sia sugli accertamenti fiscali sia su quelli successori: se la Guardia di Finanza sequestra le crypto di un erede per presunto debito d’imposta, deve dimostrare che l’importo sequestrato corrisponde al valore delle imposte dovute e non eccede la somma del tributo e delle sanzioni. In caso contrario, il sequestro è illegittimo e può essere impugnato.
6. Strategie difensive del debitore nel corso degli accertamenti
6.1 Prima fase: prevenzione e compliance
La migliore difesa contro un accertamento è la compliance preventiva. Le strategie includono:
- Tenuta della documentazione: conservare gli estratti conto degli exchange, i report delle transazioni e la cronologia degli indirizzi wallet. Esistono software di tracking (CoinTracking, Koinly, Blockpit) che generano report fiscali integrabili con la dichiarazione.
- Indicazione nel quadro RW: dichiarare annualmente le crypto detenute, anche se non sono realizzate plusvalenze. In caso di dubbio circa l’interpretazione, presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate per ottenere una risposta vincolante.
- Valutazione dei redditi da mining/staking: tenere traccia del momento di maturazione dei premi e del loro valore in euro; versare le imposte tramite F24. Una gestione professionale del mining può richiedere l’apertura di partita IVA con regime ordinario.
- Pianificazione successoria: predisporre un testamento o utilizzare strumenti come trust, multi‑signature e depositi fiduciari per proteggere le chiavi e assicurare la trasparenza fiscale agli eredi. Si consiglia di affidare la custodia delle chiavi a un professionista oppure a dispositivi fisici in cassaforte.
- Rivalutazione e sanatoria: valutare l’opportunità di rivalutare i portafogli al 1° gennaio 2025 pagando l’imposta del 18 % e di aderire alla sanatoria per l’emersione di crypto pre‑2023, riducendo i rischi di contestazione per gli anni passati.
- Controllo dell’operatività in DeFi: molte transazioni avvengono su piattaforme decentralizzate che non rilasciano rendicontazioni. È opportuno registrare manualmente ogni operazione, predisporre screenshot delle interazioni con gli smart contract e conservare le ricevute (hash delle transazioni). Si suggerisce l’uso di moduli come Metamask o Ledger Live per esportare lo storico.
6.2 Seconda fase: reazione all’avviso di accertamento
Quando l’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento per plusvalenze o per omissione del quadro RW, il contribuente deve valutare se impugnare o aderire. Le strategie possibili sono:
- Contraddittorio preventivo: il contribuente ha diritto a partecipare al procedimento amministrativo, fornendo documentazione e osservazioni prima dell’emissione del provvedimento definitivo. È importante dimostrare la correttezza delle dichiarazioni (stato del portafoglio, calcolo della plusvalenza). Le irregolarità procedurali, come la mancata instaurazione del contraddittorio quando obbligatorio, possono costituire motivo di annullamento dell’avviso.
- Contestazione dei presupposti: se l’avviso si basa su presunzioni (ad esempio, movimenti di wallet non collegati al contribuente), è possibile fornire prove contrarie, come la dimostrazione che l’indirizzo non è riconducibile al soggetto o che le somme si riferiscono a trasferimenti tra wallet personali senza realizzo. La giurisprudenza impone all’Amministrazione di fornire elementi probatori certi; in mancanza, l’accertamento è illegittimo.
- Dimostrazione dell’assenza di plusvalenze: le plusvalenze sono tassate solo se risultano da transazioni che generano un differenziale positivo tra corrispettivo di vendita e costo di acquisto. Gli scambi tra crypto (ad esempio da BTC a ETH) possono non essere tassabili se non comportano il rientro in valuta fiat, ma tale interpretazione non è unanimemente condivisa; occorre dimostrare che non vi è stata conversione in euro e che le crypto sono rimaste nel patrimonio digitale. La dottrina suggerisce di applicare il metodo LIFO/FIFO per calcolare il costo medio.
- Vizi di motivazione e decadenza: verificare se l’avviso di accertamento è motivato in maniera sufficiente e se è stato notificato entro i termini di decadenza (cinque anni dalla presentazione della dichiarazione per le imposte dirette). Eventuali carenze possono essere sollevate in giudizio.
- Ricorso alla Giustizia tributaria: se non si raggiunge un accordo, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. È auspicabile allegare perizia tecnica sulle crypto e memorie difensive che richiamano la giurisprudenza favorevole (Cassazione 1760/2025 sulle modalità di sequestro, Cassazione 18252/2025 sull’apertura della successione, Cassazione 8269/2025 sull’obbligo di dichiarare i compensi in crypto ecc.).
6.3 Terza fase: gestione del contenzioso
Nel contenzioso tributario, le argomentazioni difensive possono toccare diversi aspetti:
- Interpretabile incertezza normativa: la normativa sulle crypto è recente e talvolta contraddittoria. L’art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente prevede che le sanzioni non si applicano se il comportamento è stato determinato da obiettive condizioni di incertezza. Si può argomentare che, prima delle circolari 2023, l’obbligo di indicare nel quadro RW era controverso, soprattutto per i wallet self‑custoditi.
- Principio del favor rei: nei dubbi interpretativi, si applica l’interpretazione più favorevole al contribuente. Alcuni giudici tributari hanno annullato sanzioni per errori formali, valorizzando la buona fede.
- Difetto di prova: l’Amministrazione deve dimostrare con dati concreti l’esistenza di plusvalenze imponibili. Non è sufficiente l’applicazione di presunzioni semplici (somme in wallet = reddito imponibile). La sentenza n. 31287/2019 ha stabilito che l’Ufficio deve provare l’effettività delle operazioni.
- Prova contraria: fornire estratti conto, hash, contratti e registri blockchain per dimostrare il reale ammontare dei guadagni e la loro derivazione (ad esempio, investimenti con capitali già tassati).
- Applicazione del regime disciplinare corretto: contestare l’applicazione dell’aliquota 26 % o 33 % a periodi per i quali non era ancora in vigore; richiamare l’interpretazione della Fondazione nazionale dei commercialisti .
6.4 Difesa in ambito successorio
Nel caso in cui l’accertamento riguardi l’imposta di successione su cripto‑attività, l’erede deve:
- Dimostrare la legittimità della chiamata: se l’Agenzia contesta la validità del testamento o la mancanza di accettazione, è necessario produrre il testamento, l’atto notorio e l’atto di accettazione (esplicita o tacita). La Cassazione 14063/2025 ha riconosciuto che l’accettazione è inefficace in assenza di valida chiamata , ma l’erede può opporsi provando la sussistenza di un testamento valido.
- Contestare la decorrenza del termine: l’imposta nasce all’apertura della successione; se la contestazione avviene molti anni dopo, può essere eccepita la decadenza del potere accertativo (dieci anni). Tuttavia, se emergono cripto‑asset occultati, il termine decorre da quando l’Amministrazione ne viene a conoscenza.
- Richiedere la detrazione dell’imposta pagata: in caso di doppia imposizione (successione estera e italiana), è possibile chiedere il credito d’imposta. L’art. 25 del D.Lgs. 346/1990 consente la detrazione dell’imposta pagata all’estero per corrispondenti beni.
- Dimostrare l’assenza di disponibilità: se l’erede non ha ricevuto le chiavi private o non ha potuto accedere alle crypto, può sostenere di non avere avuto la disponibilità effettiva del bene; di conseguenza, l’imposta dovrebbe essere calcolata su un valore ridotto (valore della chiamata, non del possesso). Occorre però considerare che l’imposta di successione si applica alla nuda proprietà, non alla disponibilità effettiva.
7. Strategie difensive preventive: gestione del patrimonio crypto
7.1 Wallet self‑custoditi e sistemi di sicurezza
Detenere crypto in wallet self‑custoditi garantisce maggiore autonomia ma richiede rigore nella conservazione delle chiavi. Le best practices sono:
- Utilizzare hardware wallet (Ledger, Trezor) anziché software wallet su smartphone per ridurre il rischio di hacking. Gli hardware wallet generano chiavi offline e richiedono la conferma fisica delle transazioni.
- Creare copie di backup della seed phrase (frase mnemonica) su supporti fisici resistenti (carta, acciaio) da conservare in luoghi separati e protetti da incendio o smarrimento.
- Impostare un sistema di multi‑firma con almeno tre chiavi: una conservata dal proprietario, una depositata presso un notaio o avvocato e una presso un fiduciario o un family office. L’uso di multi‑firma evita che un singolo smarrimento impedisca l’accesso.
- Creare un protocollo di istruzioni segrete: redigere un documento (lettera istruzioni) contenente la mappa delle risorse digitali e l’ubicazione dei backup, da aprire solo dopo la morte. Questo documento non deve contenere le chiavi ma può indicare un indice o codici parziali per la verifica.
7.2 Custodia presso exchange e broker regolamentati
La custodia presso exchange semplifica l’accesso ma comporta rischi di insolvenza (caso FTX), hacking e sequestro. È consigliabile:
- Scegliere exchange autorizzati (iscritti al registro OAM) e preferire quelli con sede in giurisdizioni che aderiscono a normative MiCA (Reg. UE 2023/1114) e assicurazioni su depositi;
- Abilitare l’autenticazione a due fattori e depositare solo la quantità necessaria per le operazioni. Il grosso del patrimonio dovrebbe essere conservato in wallet personale;
- Aggiornare regolarmente i dati dell’account e indicare un contatto di emergenza;
- Valutare la stipula di un contratto di conto cointestato con l’erede, che consenta la continuità dell’accesso. Tuttavia, l’apertura di conti cointestati su exchange è ancora poco diffusa.
In caso di morte del titolare, gli exchange richiedono la presentazione di documenti (certificato di morte, atto di successione) per sbloccare i fondi . Tuttavia, non sempre vi è uniformità di procedure; pertanto è utile documentarsi preventivamente e, se possibile, ottenere un atto di disposizione inter vivos presso notaio per l’accesso.
7.3 Token aziendali e startup: governance e compliance
Le imprese che emettono token per finanziarsi devono strutturare la governance in modo da evitare violazioni del TUF e incorrere in sanzioni per raccolta abusiva di capitale. Per esempio:
- Gli security token che rappresentano quote di capitale sociale sono assimilati a strumenti finanziari e richiedono prospetto informativo, autorizzazione CONSOB e rispetto delle norme MiFID/MiCA. La vendita a pubblico senza autorizzazione integra il reato di abusivismo finanziario .
- I utility token devono essere emessi con chiarezza sui diritti conferiti; se remunerano prestazioni di lavoro, i proventi sono redditi di lavoro autonomo o subordinato e devono essere trattati come tali dal punto di vista fiscale.
- I token di governance implicano diritti di voto su protocolli DeFi; le imprese devono definire statuti o white paper con trasparenza su votazioni, distribuzioni e rischio di perdita.
In caso di morte dell’imprenditore, i token aziendali possono rientrare nell’asse ereditario; è opportuno predisporre clausole di joint ownership o di successione negli smart contract aziendali affinché i token siano trasferiti agli eredi o riscattati dalla società.
7.4 NFT e diritti d’autore
Gli artisti e le imprese creative che producono NFT devono considerare:
- Inquadramento giuridico: l’NFT certifica la proprietà dell’opera digitale ma non sempre comporta il trasferimento dei diritti d’autore. Occorre specificare nei contratti (smart contract e off‑chain) quali diritti sono trasferiti (licenza d’uso, diritti di riproduzione, ecc.).
- Regime IVA: la cessione di NFT può essere soggetta a IVA se ritenuta prestazione di servizi elettronici; la determinazione della base imponibile dipende dal prezzo in crypto convertito in euro.
- Fiscalità dei proventi: come precisato dalla Cassazione 8269/2025, i proventi da NFT sono redditi di lavoro autonomo e devono essere dichiarati . Occorre emettere fattura e convertire il controvalore in euro.
La pianificazione successoria deve considerare che gli NFT possono essere trasmessi agli eredi come opere d’arte; tuttavia, il mercato può valutare gli NFT in maniera volatile e non garantita. È opportuno predisporre clausole di vendita o di distruzione a certe condizioni.
8. Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Evoluzione normativa sulle cripto‑attività in Italia
| Anno | Riferimento normativo | Novità principale | Aliquota/imposta |
|---|---|---|---|
| 2016–2022 | Interpello 72/E 2016, Risoluzione 6/E 2018 | Prime interpretazioni: criptovalute assimilate a valute estere; obblighi di monitoraggio nel quadro RW; tassazione come redditi diversi; nessuna norma specifica | Aliquota 26 % (redditi diversi generici); incertezza sulla soglia di esenzione |
| 2023 | Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) | Introduzione della lettera c‑sexies all’art. 67 TUIR: definizione di cripto‑attività; plusvalenze tassate come redditi diversi; possibilità di sanatoria per crypto non dichiarate al 31 dicembre 2022 | Imposta sostitutiva 26 %; franchigia 2.000 €; sanatoria: 0,5 % di sanzione e 14 % di imposta sostitutiva su valore al 1° gennaio 2023 |
| 2024 | Circolare 30/E 2023; riforma anti‑riciclaggio D.Lgs. 129/2023; adeguamenti MiCA | Chiarimenti su trattamento di mining/staking, airdrop; obblighi di adeguata verifica e travel rule per VASP | Aliquota 26 % sulle plusvalenze; IVAFE 0,2 % |
| 2025 | Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) | Aliquota sostitutiva 26 % per il 2025; eliminazione franchigia 2.000 €; reintroduzione del regime di rivalutazione delle cripto‑attività con imposta del 18 % | 26 % (transitorio); 18 % su rivalutazione (pagabile in tre rate) |
| Dal 2026 | Legge di Bilancio 2025 | Aliquota a regime 33 %; abolizione definitiva della franchigia | 33 % |
Tabella 2 – Principali pronunce giurisprudenziali (2024–2025)
| Pronuncia | Data | Oggetto | Principio di diritto |
|---|---|---|---|
| Cassazione n. 1569/2024 (dep. 2025) | 2025 | Sequestro di bitcoin in un procedimento per evasione | I bitcoin non sono moneta legale; il sequestro per equivalente è illegittimo; il sequestro deve riguardare l’importo dell’imposta evasa in euro |
| Cassazione n. 1760/2025 | 2025 | Sequestro probatorio di bitcoin | La definizione di virtual currency della direttiva UE 2018/843 implica che le crypto non sono valuta legale; il sequestro deve limitarsi al valore del profitto del reato, convertito in euro |
| Cassazione n. 18252/2025 | 2025 | Imposta di successione | L’imposta di successione nasce all’apertura della successione e non all’accettazione; gli eredi sono responsabili anche per successioni pregresse non accettate dal de cuius |
| Cassazione n. 8269/2025 | 2025 | Tassazione dei proventi da NFT | I proventi degli NFT sono redditi di lavoro autonomo; i compensi ricevuti in crypto devono essere convertiti in euro e dichiarati; l’errore di diritto non scusa il contribuente |
| Cassazione n. 14063/2025 | 2025 | Chiamata ereditaria e revoca di testamento | L’accettazione dell’eredità è inefficace senza valida chiamata; la revoca del testamento retroagisce alla data del decesso, eliminando gli effetti degli atti precedenti |
| Cassazione n. 27023/2022 | 2022 | Autoriciclaggio tramite bitcoin | L’acquisto di bitcoin con proventi di reati fiscali configura autoriciclaggio; può essere contestato anche il reato di abusivismo finanziario se i token sono emessi senza autorizzazione |
Tabella 3 – Profili sanzionatori
| Violazione | Sanzioni amministrative | Sanzioni penali | Note |
|---|---|---|---|
| Omissione quadro RW | 3–15 % del valore non dichiarato (6–30 % per Paesi black list) | Nessuna, salvo reati di dichiarazione infedele se collegata a evasione > 150.000 € | Possibile riduzione tramite ravvedimento operoso o sanatoria 2023 |
| Omissione plusvalenze crypto | 90–180 % dell’imposta evasa (art. 1 comma 1 D.Lgs. 471/1997) | Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se imposta evasa > 150.000 € | Importante dimostrare la buona fede e l’incertezza normativa |
| Mancato pagamento IVAFE (0,2 %) | 3–15 % del valore dei beni | Nessuna | Può essere sanata con ravvedimento |
| Omissione dell’imposta di successione | Sanzione dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta | Reati ex art. 3 D.Lgs. 74/2000 se false dichiarazioni | Contestazione possibile solo dopo accertamento |
| Violazione obblighi AML da parte di VASP | Sanzione amministrativa da 2.000 a 200.000 €; sospensione o revoca della licenza | Responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi D.Lgs. 231/2001; reato di riciclaggio o autoriciclaggio | Le segnalazioni sospette sono trasmesse a UIF |
| Emissione abusiva di token assimilabili a strumenti finanziari | Sanzioni CONSOB e interdittive; confisca | Reato di abusivismo finanziario (art. 166 TUF) | L’offerta al pubblico senza prospetto integra reato |
9. Domande frequenti e risposte (FAQ)
9.1 Devo dichiarare le criptovalute se non le vendo o non le converto in euro?
Sì. L’obbligo di indicare le cripto‑attività nel quadro RW sussiste a prescindere dalla realizzazione di plusvalenze. La sola detenzione di crypto presso wallet esteri, exchange o hardware wallet costituisce attività estera rilevante ai fini del monitoraggio. Tuttavia, l’imposta sostitutiva si applica solo alle plusvalenze: se non vi sono vendite o conversioni, non si paga imposta (salvo l’IVAFE dello 0,2 % sul valore medio annuo). In ogni caso, la legge di Bilancio 2025 ha eliminato l’esenzione di € 2.000, per cui anche le plusvalenze minime sono tassate .
9.2 Gli scambi da una criptovaluta a un’altra sono tassabili?
La normativa non è esplicita. L’Agenzia delle Entrate tende a considerare tassabili solo le conversioni in euro o in altra valuta fiat. In dottrina, si ritiene che gli scambi tra crypto (ad esempio da BTC a ETH) non generino un realizzo rilevante; tuttavia, la circolare 30/E 2023 suggerisce che la plusvalenza si determina in occasione di “permute” se il valore della crypto ricevuta è determinabile. Per prudenza, molti professionisti calcolano le plusvalenze anche per i cambi crypto‑crypto, applicando il metodo LIFO (Last In First Out) o FIFO (First In First Out) per determinare il costo.
9.3 Come si calcola la plusvalenza su cripto‑attività?
La plusvalenza si calcola come differenza tra corresponsivo di vendita e costo o valore di acquisto. Se la crypto è stata acquisita in tempi diversi, si può adottare il metodo globale (costo medio ponderato), oppure i metodi LIFO o FIFO se ci sono registrazioni specifiche. Nel caso di crypto ricevute gratuitamente (airdrop), il costo può essere zero; dunque, tutto il valore al momento della vendita è plusvalenza. Per le crypto ottenute tramite mining o staking, il costo è il valore in euro al momento della percezione; l’eventuale plusvalenza deriva dalla successiva vendita.
9.4 È vero che i bitcoin non possono essere sequestrati?
No. La Cassazione n. 1569/2024 non vieta il sequestro di bitcoin, ma stabilisce che non possono essere considerati denaro e quindi non possono essere sequestrati per equivalente al posto delle somme dovute. Le autorità possono sequestrare i bitcoin in quanto profitto del reato, ma devono dimostrare il legame con l’evasione e limitare il sequestro al valore dell’imposta evasa convertito in euro . In pratica, il sequestro è possibile ma deve essere proporzionato.
9.5 Che succede se eredito criptovalute ma non conosco la chiave privata?
Se non si dispone della chiave privata o della seed phrase, non si può accedere al wallet e le crypto sono, di fatto, irrecuperabili. Gli eredi possono tentare di recuperare le chiavi dai dispositivi del de cuius con l’aiuto di esperti di forensic computing; in caso di hardware wallet, è possibile estrarre i dati tramite tecniche invasive (chip off) . Se le crypto sono depositate su exchange, gli eredi possono rivolgersi alla piattaforma presentando la documentazione successoria. È fondamentale che il de cuius pianifichi la successione lasciando istruzioni sicure.
9.6 Come si determinano le imposte di successione sulle cripto‑attività?
Gli eredi devono dichiarare il valore delle crypto al momento dell’apertura della successione. Tale valore si determina usando il prezzo di mercato medio al giorno di apertura (data del decesso). Il tributo si calcola applicando le aliquote e franchigie previste dal D.Lgs. 346/1990 in base al grado di parentela. Ad esempio, se il de cuius lascia 10 BTC valutati 300.000 € al figlio, la franchigia di 1 milione copre integralmente il valore, quindi non si paga imposta; se invece lascia 2 milioni di euro in crypto al nipote, l’aliquota è 6 % senza franchigia su 1 milione. La Cassazione 18252/2025 ha precisato che l’imposta nasce con l’apertura della successione indipendentemente dall’accettazione .
9.7 È possibile donare criptovalute senza pagare imposte?
La donazione di crypto è soggetta all’imposta di donazione se il valore supera le franchigie previste; le aliquote sono le stesse dell’imposta di successione. Per importi inferiori alle franchigie, la donazione è esente. È importante stipulare la donazione per atto pubblico davanti a notaio (art. 782 c.c.) se l’importo supera i limiti di liberalità; in caso contrario, la donazione è nulla. In ogni caso, la tracciabilità della transazione su blockchain facilita la prova dell’avvenuta donazione.
9.8 Quali controlli effettua la Guardia di Finanza sui wallet crypto?
La Guardia di Finanza utilizza software di blockchain analysis per identificare i collegamenti tra indirizzi e transazioni. Può incrociare i dati degli exchange iscritti all’OAM con i registri pubblici; quando individua un indirizzo sospetto, può chiedere all’exchange di fornire l’identità dell’utente e i dettagli delle transazioni. Se il wallet è self‑custodito, l’indagine può avvalersi di perizie informatiche sui dispositivi sequestrati. Tuttavia, la mancanza di KYC sulle piattaforme decentralizzate rende difficile risalire al proprietario. In questi casi, le autorità si basano su indizi esterni (pagamenti di bollette, acquisti con crypto convertita in fiat) per ricostruire il flusso.
9.9 Devo pagare IVA sulla vendita di criptovalute?
La Corte di giustizia dell’UE (C‑264/14) ha stabilito che le operazioni di cambio di bitcoin e altre crypto contro valute tradizionali sono esenti da IVA in quanto prestazioni finanziarie. Tuttavia, la cessione di beni o servizi pagati in crypto è soggetta a IVA e deve essere fatturata al valore in euro del corrispettivo. Inoltre, la vendita di NFT potrebbe essere considerata prestazione di servizi elettronici e quindi imponibile ai fini IVA.
9.10 Cosa accade se l’erede non accetta l’eredità contenente crypto?
L’accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d’inventario (artt. 470 ss. c.c.). L’erede può rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio se teme debiti superiori ai beni. Se l’erede rinuncia, non diventa titolare delle crypto e non è soggetto all’imposta di successione, ma neppure potrà in seguito richiederle. La Cassazione 18252/2025 chiarisce che l’imposta sorge in capo agli eredi chiamati, indipendentemente dall’accettazione ; tuttavia, se l’erede rinuncia tempestivamente, non è tenuto al pagamento.
9.11 Le imposte pagate all’estero sulle crypto sono detraibili?
Sì. Se il de cuius o il contribuente residente in Italia paga imposte su plusvalenze crypto all’estero, può usufruire del credito d’imposta previsto dagli art. 165 TUIR e art. 25 D.Lgs. 346/1990, fino a concorrenza dell’imposta italiana dovuta. È necessario dimostrare l’effettivo pagamento estero (ricevute, certificazioni) e che si tratta della medesima categoria di imposta. Ciò è rilevante in caso di exchange che hanno sede in giurisdizioni che applicano imposte sui guadagni crypto (es. USA, Canada).
10. Simulazioni pratiche
10.1 Caso 1: accertamento sulle plusvalenze
Scenario: Maria, residente in Italia, nel 2023 acquista 5 ETH per 1.000 € cadauno (5.000 € totali). Nel 2024 vende 3 ETH a 2.500 € cadauno (7.500 € totali), realizzando una plusvalenza di 4.000 €. Maria non dichiara la plusvalenza e non inserisce i restanti 2 ETH nel quadro RW. Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate riceve un report dall’exchange estero di Maria e avvia un accertamento.
Difesa preventiva: Maria avrebbe dovuto indicare nel quadro RW la detenzione dei 5 ETH e dichiarare la plusvalenza realizzata nel 2024, applicando l’imposta sostitutiva del 26 %. Aveva a disposizione la sanatoria 2023 se possedeva crypto antecedenti al 2022. Nel 2025 può aderire alla rivalutazione per i 2 ETH ancora detenuti, pagando l’imposta del 18 % sul valore al 1° gennaio 2025.
Reazione all’avviso: Maria può contestare la sanzione rilevando la incertezza normativa per il periodo 2023–2024 e offrire il pagamento dell’imposta sostitutiva e degli interessi. Può dimostrare che l’errore deriva da interpretazioni contrastanti sull’obbligo di dichiarare crypto‑crypto swap (se la vendita era avvenuta in ETH per stablecoin). Se le transazioni avessero generato plusvalenze inferiori a 2.000 € (vecchia franchigia), potrebbe chiedere la disapplicazione della sanzione.
Esito possibile: l’Agenzia potrebbe accettare la rideterminazione del reddito in contraddittorio, applicare la sanzione minima e ricalcolare l’imposta. Se Maria dimostra la sua buona fede e la regolarizzazione tempestiva, la sanzione potrebbe essere ridotta.
10.2 Caso 2: sequestro di bitcoin in un procedimento penale
Scenario: Gianni è indagato per dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000. Nell’indagine, la Guardia di Finanza scopre che Gianni detiene 10 BTC nel suo wallet. Il pubblico ministero dispone il sequestro per equivalente dell’intero ammontare, stimando un’evasione di 100.000 €.
Difesa: L’avvocato di Gianni impugna il sequestro facendo leva sulla sentenza Cassazione 1569/2024, sostenendo che i bitcoin non sono moneta legale e non possono essere sequestrati per equivalente. Il sequestro deve essere limitato all’ammontare dell’imposta evasa, convertito in euro. Se il valore di mercato di 10 BTC (ad esempio 300.000 €) eccede la presunta evasione, il sequestro è sproporzionato. Inoltre, non è dimostrato il nesso tra i BTC e l’evasione (potrebbero derivare da investimenti leciti).
Possibile soluzione: Il giudice può accogliere il ricorso, riducendo il sequestro a 4 BTC (valore corrispondente a 100.000 €). In alternativa, può sostituire il sequestro dei BTC con sequestro di somme in euro su conti bancari. Ciò consente di tutelare il principio di proporzionalità e riduce i rischi legati alla volatilità dei bitcoin.
10.3 Caso 3: cripto‑eredità con chiavi smarrite
Scenario: Luca possedeva 100.000 USDC e 20 ETH in un wallet hardware; non aveva comunicato la seed phrase. Alla sua morte, i figli scoprono l’hardware wallet ma non conoscono il PIN né la seed. Presentano la dichiarazione di successione indicando il valore presunto delle crypto (150.000 €), ma non riescono a trasferire i token.
Azioni: Gli eredi si rivolgono a un tecnico specializzato che tenta il recupero tramite estrazione della memoria. Nel frattempo, ottengono dal notaio la conferma della situazione e presentano istanza all’Agenzia delle Entrate per richiedere la sospensione del pagamento dell’imposta, sostenendo l’impossibilità di acquisire la disponibilità dei beni. La Cassazione non si è espressa su questo caso specifico; si potrebbe invocare analogia con la perdita di beni. Se il recupero fallisce, gli eredi potrebbero chiedere la riliquidazione dell’imposta in base al valore effettivo (zero). Se invece riescono a recuperare la seed, dovranno completare la successione, pagando l’imposta sulla base dei valori di mercato all’apertura.
10.4 Caso 4: pianificazione con multi‑firma
Scenario: Francesca, imprenditrice, detiene un portafoglio crypto del valore di 5 milioni di euro in diverse criptovalute e NFT. Decide di proteggere la sua famiglia predisponendo un testamento pubblico presso notaio. In esso, indica l’esistenza di un wallet multi‑firma 2/3: una chiave in suo possesso, una in possesso del marito e una depositata presso il notaio. Alla sua morte, l’apertura del testamento prevede che marito e notaio debbano firmare congiuntamente per trasferire i fondi agli eredi.
Risultati: Questa strategia garantisce che le crypto non vadano perdute e che gli eredi possano accedere ai fondi con la collaborazione del notaio. Inoltre, avendo indicato i token e il loro valore nella dichiarazione di successione, gli eredi pagheranno l’imposta di successione in modo ordinato, evitando contestazioni. Se la legge di Bilancio 2025 rende disponibile la rivalutazione, Francesca potrebbe avere versato l’imposta del 18 % rendendo la plusvalenza latente non tassabile.
10.5 Caso 5: contestazione dell’eredità
Scenario: Andrea muore lasciando un testamento datato 2015 in cui attribuisce ai nipoti le sue crypto (15 BTC). Nel 2024 redige un secondo testamento olografo che revoca il precedente ma non viene depositato dal notaio. Alla sua morte, il vecchio testamento viene pubblicato e i nipoti ritirano i 15 BTC. Un anno dopo, la figlia di Andrea trova il testamento del 2024 e chiede la restituzione.
Aspetti giuridici: La Cassazione n. 14063/2025 afferma che la revoca di un testamento retroagisce al momento del decesso; la chiamata ereditaria del testamento revocato è inefficace . La figlia può agire con l’azione di petizione di eredità, chiedendo la restituzione dei 15 BTC o del loro controvalore. Dal punto di vista fiscale, la dichiarazione di successione dovrà essere riliquidata: i nipoti dovranno restituire l’imposta di successione eventualmente ottenuta in eccesso, mentre la figlia dovrà versare la differenza. L’Agenzia può rettificare l’imposta ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 346/1990.
11. Approfondimenti settoriali
11.1 Cripto‑attività nelle procedure concorsuali
La crisi di imprese basate su blockchain (exchange, DeFi, startup crypto) pone problemi nella liquidazione fallimentare. Nel 2023–2024 diversi tribunali italiani hanno affrontato i primi fallimenti di società che custodivano crypto per conto di terzi. Alcune questioni cruciali:
- Qualifica giuridica dei depositi: se i token depositati presso l’exchange sono in regime di deposito irregolare, entrano nel patrimonio del fallito e i clienti sono creditori chirografari; se invece il contratto prevede la separazione dei beni (custodia), i token non rientrano nella massa fallimentare.
- Nomina di curatori esperti: i curatori devono conoscere l’uso dei wallet e predisporre procedure per mettere in sicurezza i private key. In mancanza, i token possono essere vulnerabili a furti. Alcuni tribunali hanno nominato consulenti informatici per generare wallet multi‑firma a cui partecipano il curatore, il giudice delegato e un esperto blockchain.
- Valutazione e liquidazione: la vendita di crypto in fase di liquidazione deve avvenire a prezzo equo e con procedure che minimizzino l’impatto sul mercato (esecuzione OTC o tramite aste). L’assenza di mercato regolamentato comporta rischio di crollo del prezzo e di responsabilità del curatore.
11.2 Trust e protezione patrimoniale
L’uso dei trust (interni o esteri) per conferire crypto‑asset consente di proteggere il patrimonio dai creditori e di pianificare la successione. Tuttavia, occorre considerare:
- Fiscalità: i conferimenti in trust sono soggetti all’imposta di donazione; la distribuzione ai beneficiari è tassata come donazione salvo che il trust sia esclusivamente di scopo (es. protezione di minori). La prassi dell’Agenzia delle Entrate può variare; è opportuno predisporre un trust regolato da giurisdizioni che riconoscono i crypto‑asset (es. Malta, Svizzera) ma con beneficiari residenti in Italia, prevedendo clausole per la rendicontazione.
- Responsabilità del trustee: il trustee deve custodire le chiavi private; eventuali perdite per negligenza possono generare responsabilità civile. Si consiglia l’adozione di cold storage e assicurazioni.
- Opponibilità ai terzi: la costituzione del trust deve essere pubblicizzata o quantomeno dichiarata nel quadro RW; in caso contrario, l’Amministrazione può contestare l’abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000).
11.3 Sistema MiCA e regolamento TFRR
Il Regolamento UE 2023/1114 (Markets in Crypto‑Assets, MiCA) entrerà in vigore progressivamente entro il 2026. Esso disciplina l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di crypto‑asset, i requisiti degli emittenti di token e dei service providers. I punti principali:
- Obbligo di autorizzazione per i VASP e garanzie patrimoniali;
- Regole sulla stabilità per gli asset‑referenced token (stablecoin);
- Trasparenza dei white paper e tutela degli investitori;
- Possibilità per gli Stati membri di imporre misure fiscali conformi.
Il Regolamento UE 2023/1113 (Transfer of Funds Regulation Recast, TFRR) – noto come travel rule – si applica ai trasferimenti di crypto > 1.000 €. Impone ai VASP di raccogliere e trasmettere le informazioni del mittente e del destinatario. L’Italia ha recepito la regola tramite D.Lgs. 129/2023. Gli accertamenti fiscali potranno avvalersi di queste informazioni per identificare i flussi.
11.4 Avvocati e consulenti: nuove competenze
Il trattamento delle cripto‑attività richiede la collaborazione di figure specialistiche:
- Avvocati tributaristi: devono conoscere le norme fiscali, le circolari e la giurisprudenza sulle crypto, nonché saper interpretare i white paper e la documentazione tecnica per costruire la difesa.
- Notai e consulenti legali: devono combinare conoscenze tradizionali con competenze digitali, predisponendo testamenti e atti con clausole relative alla custodia delle chiavi.
- Commercialisti e revisori: devono saper contabilizzare le crypto come immobilizzazioni immateriali (se detenute per investimento) o come rimanenze (se destinate alla vendita). Il principio contabile OIC non disciplina specificamente i crypto, ma è possibile applicare analogia con i beni fungibili valutandoli al costo d’acquisto o al valore di mercato.
- Periti informatici: necessari per analizzare blockchain, recuperare chiavi, stimare valori. In contenzioso, la relazione tecnica del perito può convincere il giudice circa l’inesistenza di plusvalenze.
12. Conclusioni
La disciplina delle cripto‑attività in Italia si trova in una fase di consolidamento. La legge di Bilancio 2025 ha dato finalmente un quadro normativo chiaro per le plusvalenze, ma permangono incertezze operative (swap crypto‑crypto, trattamento di NFT, DeFi). La giurisprudenza ha fornito chiarimenti importanti: il bitcoin non è moneta legale e non può essere sequestrato per equivalente ; l’imposta di successione nasce con l’apertura della successione ; i proventi da NFT sono redditi di lavoro autonomo ; l’accettazione dell’eredità senza valida chiamata è inefficace . Questi principi offrono strumenti di difesa per i contribuenti e guidano la pianificazione patrimoniale.
Dal punto di vista del debitore, la prevenzione tramite compliance e pianificazione successoria rimane la strategia più efficace. Tenere traccia delle transazioni, dichiarare in modo completo, utilizzare strumenti come la rivalutazione e la sanatoria, adottare soluzioni di custodia sicure e predisporre testamenti chiari consente di ridurre i rischi di accertamento e di contenzioso. Nella fase di difesa, è fondamentale impugnare gli avvisi di accertamento facendo leva sulla giurisprudenza favorevole, sull’incertezza normativa e sulla proporzionalità delle sanzioni. L’intervento di professionisti specializzati (avvocati, notai, commercialisti e periti informatici) è essenziale per tutelare i diritti del contribuente.
Infine, la dimensione internazionale della blockchain impone di considerare anche le normative straniere e i futuri sviluppi europei (MiCA, TFRR, DAC8). Le cripto‑attività continueranno a evolvere e la normativa dovrà adattarsi; pertanto, è consigliabile aggiornarsi costantemente e adottare un approccio prudente e proattivo.
13. Fonti utilizzate
La guida si basa sulle seguenti fonti istituzionali e dottrinali, consultate in data settembre 2025:
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) e successive modifiche: introduzione della lettera c‑sexies all’art. 67 TUIR e istituzione della sanatoria.
- Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025): aumento aliquote al 26 % e 33 %; eliminazione franchigia; istituzione della rivalutazione delle cripto‑attività .
- Circolare 30/E 2023 dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti su mining, staking, airdrop, obblighi di monitoraggio .
- Ordinanza Cassazione n. 18252/2025: imposta di successione e chiamata ereditaria .
- Ordinanza Cassazione n. 1760/2025: sequestro probatorio di bitcoin .
- Sentenza Cassazione n. 1569/2024 (dep. 2025): bitcoin e sequestro per equivalente .
- Sentenza Cassazione n. 8269/2025: tassazione dei proventi da NFT .
- Sentenza Cassazione n. 14063/2025: revoca di testamento e inefficacia dell’accettazione .
- Sentenza Cassazione n. 27023/2022: autoriciclaggio tramite bitcoin e abusivismo finanziario .
- Regolamenti europei MiCA (2023/1114) e TFRR (2023/1113) e normativa anti‑riciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e D.Lgs. 129/2023).
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestati wallet o criptovalute ereditate non dichiarate o tassate in modo errato? Fatti Aiutare di Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestati wallet o criptovalute ereditate non dichiarate o tassate in modo errato?
Vuoi sapere cosa rischi e come difenderti da un accertamento su criptoattività di origine ereditaria?
👉 Prima regola: dimostra la provenienza ereditaria e lecita delle criptovalute, e verifica se sussiste davvero l’obbligo di dichiarazione o tassazione.
Molte volte i wallet del defunto non erano più operativi, oppure i token erano detenuti in piattaforme già soggette a controllo fiscale o con valore irrilevante.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Wallet o criptovalute ereditate non dichiarate nella successione.
- Mancata compilazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale di wallet o exchange esteri.
- Trasferimento di criptoattività dall’account del defunto senza tracciabilità documentale.
- Rendimenti o plusvalenze estere ritenute non tassate in Italia.
- Presunzione di evasione o di detenzione di capitali all’estero non dichiarati.
📌 Conseguenze della contestazione
- Sanzioni elevate dal 3% al 15% del valore delle criptovalute (fino al 30% se custodite in exchange esteri in Paesi black list).
- Recupero delle imposte su presunti redditi o plusvalenze non dichiarate.
- Interessi di mora su tutte le somme accertate.
- Verifiche patrimoniali estese su altri beni ereditati.
- Rischio di contestazioni penali (evasione, riciclaggio o autoriciclaggio) per importi significativi.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Le criptovalute erano già state dichiarate o tassate dal defunto?
- È dimostrabile la proprietà ereditaria (wallet, seed phrase, chiavi private)?
- Le somme derivano da acquisti tracciati o da attività già tassate?
- L’accertamento dell’Agenzia si basa su dati concreti (exchange, blockchain) o solo su presunzioni?
- È applicabile una convenzione internazionale contro la doppia imposizione su redditi esteri?
- È stato rispettato il valore di giacenza minima previsto per l’obbligo di monitoraggio?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Dichiarazione di successione e atti notarili di accettazione.
- Screenshot o estratti dei wallet e degli exchange riconducibili al defunto.
- Prove della titolarità (seed phrase, chiavi private, accessi, email di registrazione).
- Report delle piattaforme di trading o custodia.
- Documentazione fiscale del defunto e ricevute di eventuali imposte pagate.
- Dichiarazioni fiscali italiane e attestazioni estere di tassazione o detenzione.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la provenienza ereditaria e tracciabile delle criptoattività.
- Contestare la presunzione di evasione se mancano prove tecniche sulla proprietà o sulla disponibilità effettiva.
- Far valere l’assenza di obbligo di monitoraggio per wallet non più accessibili o con valore sotto soglia.
- Evidenziare errori di calcolo nel valore di mercato delle cripto al momento della successione.
- Chiedere l’annullamento in autotutela o proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
- In caso di importi elevati, predisporre una difesa preventiva penale-tributaria.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la successione e la documentazione blockchain o exchange del defunto.
- 📌 Valuta la fondatezza della contestazione e costruisce la miglior strategia difensiva.
- ✍️ Redige memorie e ricorsi tributari per tutelarti davanti all’Agenzia delle Entrate.
- ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, anche in sede penale.
- 🔁 Offre consulenza preventiva per la gestione regolare e la pianificazione fiscale delle criptoeredità.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario, fiscalità internazionale e criptoattività.
- ✔️ Specializzato nella difesa contro accertamenti fiscali su criptovalute e patrimoni digitali ereditati.
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Gli accertamenti su criptoeredità sono spesso fondati su presunzioni e scarsa conoscenza tecnica delle blockchain o delle piattaforme estere.
Con una difesa documentata e strategica, puoi dimostrare la provenienza ereditaria dei wallet, evitare doppie tassazioni e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.