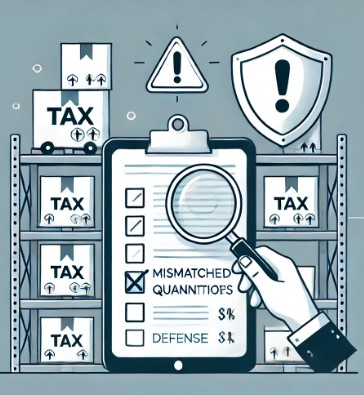Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per differenze inventariali? In questi casi, l’Ufficio presume che gli scostamenti tra il magazzino contabile e quello fisico siano indice di vendite non registrate (se le giacenze sono inferiori) o di acquisti non contabilizzati (se le giacenze sono superiori). Si tratta di una delle verifiche più frequenti durante i controlli fiscali nelle imprese commerciali e industriali. Le conseguenze possono essere molto pesanti: recupero delle imposte, sanzioni elevate e, nei casi più gravi, contestazioni penali per dichiarazione infedele. Tuttavia, non sempre le contestazioni sono fondate: con una difesa ben organizzata è possibile giustificare le differenze o ridurre l’impatto delle sanzioni.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta differenze inventariali
– Se le giacenze fisiche risultano inferiori rispetto a quelle riportate in contabilità
– Se le giacenze fisiche risultano superiori, indicando acquisti non registrati
– Se mancano documenti giustificativi per cali naturali, scarti di produzione o merce danneggiata
– Se i registri di magazzino non sono aggiornati o non coincidono con i dati contabili
– Se l’Ufficio presume che vi siano state vendite “in nero” o acquisti non fatturati
Conseguenze della contestazione
– Recupero a tassazione dei ricavi ritenuti non dichiarati
– Indeducibilità dei costi relativi a merci non contabilizzate
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme dovute
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o frode fiscale
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare che le differenze inventariali derivano da errori formali e non da ricavi occultati
– Produrre documentazione su scarti, resi, cali fisiologici o merce obsoleta
– Presentare registri di magazzino aggiornati e coerenti con la contabilità generale
– Contestare le ricostruzioni presuntive basate solo su rilievi fisici senza ulteriori prove
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o carenze di motivazione nell’avviso di accertamento
– Richiedere la riqualificazione delle violazioni come irregolarità formali con riduzione delle sanzioni
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare i rilievi inventariali e la documentazione di magazzino
– Verificare la legittimità della contestazione e l’uso corretto delle presunzioni fiscali
– Predisporre un ricorso basato su prove concrete e giurisprudenza favorevole
– Difendere l’impresa davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio aziendale e personale da pretese fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della natura non imponibile delle differenze inventariali
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: le differenze inventariali sono spesso contestate dal Fisco come prova indiretta di ricavi occulti, ma possono avere spiegazioni logiche e documentabili. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben strutturata.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – spiega come difendersi in caso di contestazioni per differenze inventariali e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.
👉 Hai ricevuto una contestazione per differenze inventariali? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la fondatezza della contestazione e costruiremo la strategia difensiva più efficace per tutelare i tuoi interessi.
Introduzione
Le differenze inventariali sono discrepanze tra la giacenza di merci risultante dalle scritture contabili (registro di magazzino, inventari, ecc.) e quella effettivamente riscontrata in magazzino o nei punti vendita. Si tratta di un fenomeno comune e fisiologico in molti settori (Grande Distribuzione Organizzata – GDO, retail, logistica, farmaceutico, ecc.), ma che può generare significative contestazioni legali. In ambito tributario, ammanchi o eccedenze di magazzino possono indurre il Fisco a presumere vendite non fatturate (ricavi “in nero”) o acquisti in evasione d’IVA . Sul piano penale, differenze rilevanti e non giustificate potrebbero configurare reati di frode fiscale, sottrazione di beni al fisco, bancarotta fraudolenta (se l’impresa fallisce) o appropriazione indebita. Vi sono inoltre implicazioni doganali, ad esempio per merci in depositi doganali o IVA, e civili, legate alla responsabilità degli amministratori, dei dipendenti o di terzi custodi delle merci.
Le contestazioni per differenze inventariali sono recentemente aumentate anche a causa della crescita dei furti e degli errori amministrativi nel retail: uno studio del 2023 ha stimato che nel 2022 le perdite da furti, scarti ed errori hanno inciso in media per l’1,38% del fatturato annuo delle aziende retail/GDO, pari a circa 4,6 miliardi di euro di merce, con un costo complessivo (incluse le spese di sicurezza) di 6,7 miliardi . Si tratta di un fenomeno trasversale – con settori come il fai da te e i supermercati che registrano incidenze vicine al 2% – che il Fisco monitora attentamente. Nel contempo, la giurisprudenza degli ultimi anni (2016–2025) ha affinato i principi in materia, chiarendo i limiti della presunzione di cessione in nero e l’onere della prova a carico del contribuente.
Scopo di questa guida aggiornata a settembre 2025 è fornire, dal punto di vista del debitore/contribuente, una trattazione avanzata ma divulgativa su come difendersi da contestazioni per differenze inventariali. Si esamineranno i profili tributari (accertamenti fiscali e strumenti difensivi), quelli penali (eventuali reati e strategie difensive), gli aspetti doganali e civilistici (responsabilità di amministratori, dipendenti e tutele contrattuali), citando le norme italiane rilevanti e le sentenze più recenti delle corti. Verranno forniti esempi pratici (casi di GDO, aziende industriali, depositi doganali, ecc.), check-list operative, modelli di difesa e una sezione Domande & Risposte per chiarire i dubbi più frequenti.
Struttura della guida: Dopo una definizione del fenomeno e del quadro normativo (Parte I), la guida analizza distintamente: in Parte II le contestazioni tributarie (presunzioni ex D.P.R. 441/1997, accertamenti e difese); in Parte III i risvolti penali (reati tributari, fallimentari e relative difese); in Parte IV i profili doganali (differenze in depositi doganali/IVA e sanzioni); in Parte V gli aspetti civilistici e di responsabilità interna (amministratori, personale, rapporti contrattuali). Seguono Parte VI con strategie difensive e modelli pratici (schemi procedurali, fac-simili di memorie/ricorsi, check-list) e Parte VII con FAQ – Domande e Risposte. In fondo (Parte VIII) è riportata la Bibliografia/Fonti con normativa e giurisprudenza citata.
Parte I – Nozione di differenze inventariali e quadro normativo
Cosa sono le differenze inventariali – Con questa espressione si indicano le differenze quantitative riscontrate tra le risultanze contabili di magazzino e le giacenze fisiche di beni. In altre parole, si ha una differenza inventariale quando mancano delle merci che secondo le scritture dovrebbero essere presenti (ammanco), oppure quando sono presenti in magazzino beni in più rispetto a quanto contabilizzato (eccedenza) . Tali scostamenti emergono tipicamente in sede di inventario fisico periodico o di verifica fiscale. Le cause possono essere molteplici e spesso fisiologiche soprattutto nel commercio al dettaglio e nella grande distribuzione organizzata: ad esempio furti (taccheggio da parte di clienti o sottrazioni da parte di dipendenti o fornitori), errori di registrazione (merce non correttamente “scontrinata” o codici errati nei carico/scarico), cali naturali o scarti di produzione, merce deperita o danneggiata, perdite durante il trasporto, distruzione per scadenza o obsolescenza, ecc . In un’azienda industriale, inoltre, vi possono essere differenze dovute a sfridi di lavorazione o cali tecnici in produzione.
Dal punto di vista civilistico e contabile, le differenze inventariali negative rappresentano generalmente costi/pertite per l’azienda, in quanto beni acquistati e non più rivendibili. A livello di bilancio, la corretta gestione impone di registrare tali ammanchi come rettifica delle rimanenze finali (scritture di rettifica di magazzino), con impatto sul conto economico. Non esiste una norma civilistica specifica che disciplini come contabilizzare gli ammanchi, ma vige il principio di rappresentazione veritiera e corretta: le giacenze finali devono riflettere i beni effettivamente esistenti. Fiscalmente, però, il rilievo delle differenze di magazzino può far scattare presunzioni a sfavore del contribuente, come si dirà tra poco. Proprio per l’importanza fiscale del dato di magazzino, alcune imprese sono obbligate per legge a tenere una contabilità di magazzino dettagliata: l’art.14, co.1, lett. d) D.P.R. 600/1973 richiede le scritture ausiliarie di magazzino (registro di carico-scarico) alle aziende di maggiori dimensioni (ad es. imprese con ricavi annui > ~5,16 milioni € e rimanenze finali > ~1,03 milioni € per due esercizi consecutivi) . Al di sotto di tali limiti dimensionali l’obbligo non sussiste, sebbene molte imprese tengano comunque registri di magazzino per esigenze gestionali interne. Questo distinguo – come vedremo – può influire sulle presunzioni fiscali applicabili (la Cassazione ha escluso le presunzioni legali di cessione per chi non è tenuto alle scritture obbligatorie di magazzino) .
Normativa di riferimento – In assenza di reati, le contestazioni per differenze inventariali vengono generalmente effettuate in sede amministrativa/tributaria. La normativa cardine è il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 441 (Regolamento sulle presunzioni di cessione e di acquisto di beni), emanato proprio per riordinare la previgente disciplina (in particolare ha sostituito l’art.53 del D.P.R. 633/1972 in materia IVA). Il D.P.R. 441/97 stabilisce:
- all’art.1: si presumono ceduti (ossia venduti senza fattura) i beni acquistati, importati o prodotti che risultano mancanti dai luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività, salvo prova contraria . In altre parole, se nel negozio/magazzino dell’impresa mancano delle merci che avrebbero dovuto esserci, il Fisco presume che l’impresa le abbia vendute “in nero” (senza documentarle né dichiararne i ricavi). Questa è la cosiddetta presunzione di cessione in evasione d’imposta. La norma specifica che per “luoghi” si intendono tutte le sedi, filiali, depositi dell’impresa nonché quelli di terzi dove l’impresa tiene beni in lavorazione, comodato o conto deposito (purché tali luoghi terzi siano noti al Fisco tramite comunicazione o risultino da pubblici registri) . Dunque l’assenza di beni può essere contestata non solo se mancano in sede, ma anche se risultano mancanti presso depositari terzi di cui non si è data preventiva comunicazione all’Agenzia Entrate (in tal caso si considerano sottratti al controllo fiscale).
- all’art.2: si presumono acquistati in evasione (cioè da fornitori “in nero” senza fattura) i beni che si trovano nei luoghi dell’attività ma non risultano dalle scritture. Questa è la presunzione speculare per le eccedenze: se in magazzino si trovano più beni di quelli contabilizzati, il Fisco presume che siano stati acquistati senza documenti (quindi evadevendo IVA e costi “in nero”) . Inoltre, lo stesso art.2 D.P.R. 441/97 stabilisce che assumono rilevanza per far scattare queste presunzioni le differenze quantitative risultanti dal raffronto tra le scritture ausiliarie di magazzino e le rimanenze fisiche (inventario fisico) . Ciò significa che, durante un controllo, i verificatori possono contestare ammanchi o eccedenze basandosi sia su un inventario fisico effettivo sia su un confronto documentale (ad es. incrociando il registro di magazzino con i documenti di acquisto/vendita, oppure confrontando le rimanenze finali riportate a bilancio con quelle emergenti dal libro inventari o da altre scritture) .
- all’art.3: disciplina la presunzione inversa sulle eccedenze, stabilendo che si presumono acquistati in evasione i beni rinvenuti in più (beni non documentati) salvo che il contribuente dimostri di averli ricevuti legittimamente (esibendo fattura di acquisto, bolla doganale d’importazione, ricevuta fiscale o altri documenti idonei) . In pratica, se durante un accesso l’ufficio trova beni non risultanti dalle fatture e registri dell’azienda, scatterà una contestazione per acquisti “in nero” a meno che l’azienda riesca a giustificare l’origine di quella merce con documenti.
- all’art.4: prevede le modalità con cui, in sede di verifica, possono essere attivate le presunzioni di cessione/acquisto e soprattutto disciplina le ipotesi di prova contraria e di esclusione delle presunzioni. In particolare, l’art.4 distingue due casistiche principali: (a) differenze riscontrate nelle scritture di magazzino obbligatorie (per i soggetti tenuti a tale contabilità) e (b) differenze riscontrate in altri casi (soggetti non obbligati). Se le differenze emergono dalle scritture ufficiali (caso a), opera una presunzione legale relativa a favore del Fisco, che sposta sul contribuente l’onere di provare il contrario (cioè provare che i beni mancanti non sono cessioni occulte, o che i beni in più non provengono da acquisti in nero) . Nel caso invece di differenze derivanti da scritture non obbligatorie o da altri elementi, la norma lascia intendere che la presunzione non operi automaticamente (non c’è l’“inversione” dell’onere probatorio), senza però precludere all’Ufficio di valorizzare tali elementi ai fini di un accertamento sulla base di presunzioni semplici (ex art.39 c.1 D.P.R. 600/73 e 2729 c.c.) . Su questo punto cruciale torneremo a proposito delle interpretazioni giurisprudenziali.
Va evidenziato che le presunzioni di cui al D.P.R. 441/97 operano ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES): se un bene è presumibilmente ceduto in nero, l’effetto sarà la ripresa a tassazione sia dell’IVA non applicata sia del ricavo non dichiarato ai fini reddituali . La disciplina, pur nata in ambito IVA, ha infatti portata generale in virtù di espresse previsioni e della convergenza di ragioni (evitare evasione di entrate erariali in generale) . Anche le sanzioni amministrative tributarie corrispondenti sono duplice: ad es., per le vendite non fatturate si applica la sanzione del 90% (oggi 100% per via di aumenti) dell’imposta evasa per IVA, e analoga sanzione sul maggior reddito non dichiarato, oltre a eventuali sanzioni accessorie.
Prova contraria e giustificazioni degli ammanchi – Il sistema del D.P.R. 441/97, configurando una presunzione legale relativa (iuris tantum), consente al contribuente di evitare le conseguenze fiscali fornendo prova contraria. Le norme indicano anche come fornire tale prova, con procedure differenti a seconda della causa della differenza inventariale:
- Se i beni mancanti sono stati impiegati nel ciclo produttivo, oppure sono andati perduti o distrutti per cause accidentali o fortuite (eventi indipendenti dalla volontà del contribuente), la presunzione di cessione non opera una volta dimostrata tale destinazione . In questo caso non è previsto un adempimento formale specifico ex lege: il contribuente può provare l’impiego o la perdita dei beni con qualsiasi mezzo di prova idoneo . Ad esempio, se la merce mancante è stata utilizzata come materia prima e incorporata in un prodotto finito, sarà utile produrre le distinte di produzione, i registri di lavorazione o una perizia tecnica che quantifichi gli scarti di produzione (c.d. cali naturali o tecnici). Se invece la merce è andata perduta per eventi come furti, incendi, rotture accidentali, occorrerà dimostrare tali eventi (denunce alle autorità, verbali dei Vigili del Fuoco, relazioni peritali sul sinistro, documentazione assicurativa, ecc). La Corte di Cassazione ha chiarito che anche gli “sfridi” o cali tecnici fisiologici possono costituire valida giustificazione: un accertamento basato su differenze inventariali è illegittimo se non tiene conto dei cali naturali e degli sfridi tipici del settore . In una sentenza del 2016 (Cass. 18073/2016) è stato ad esempio annullato un avviso di accertamento perché l’ufficio aveva ignorato le percentuali di calo/pedita nella produzione tessile, pretendo ricavi occulti laddove il deficit di magazzino era spiegabile con la normale perdita di materia prima nel processo .
- Se i beni sono stati distrutti o trasformati volontariamente dall’azienda (ad es. merce invenduta avviata alla distruzione perché obsoleta o scaduta, oppure beni trasformati in prodotti di minor valore), la legge richiede un adempimento formale: secondo l’art.2, co.4 D.P.R. 441/97 il contribuente deve comunicarlo tramite apposita denuncia o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare 5 giorni prima della distruzione/trasformazione . In pratica, l’impresa che intende distruggere stock di magazzino (perché ad esempio merce avariata, scarti non vendibili, ecc.) deve predisporre un verbale e darne preavviso al Fisco (denuncia alla Guardia di Finanza o comunicazione all’Agenzia Entrate) almeno 5 giorni prima dell’operazione, cosicché eventualmente possa essere disposto un controllo. In alternativa, può redigere un atto notorio (autocertificazione) descrivendo la quantità e la causa della distruzione, da autenticare e conservare . L’inosservanza di questa procedura pregiudica la possibilità di opporre la distruzione come prova contraria: in mancanza della denuncia preventiva, l’ufficio potrebbe non riconoscere la giustificazione (salvo circostanze eccezionali). Va detto, però, che per le imprese della grande distribuzione con migliaia di referenze è stata ammessa una certa flessibilità: la Circolare AE n.31/E/2006 ha riconosciuto che nel settore GDO gli ammanchi fisiologici di modesta entità possono essere provati anche senza singola denuncia, attraverso adeguata documentazione interna, inventari a campione e analisi statistiche di settore . Attenzione: questa prassi non esime formalmente dall’obbligo di denuncia, ma in sede contenziosa può sostenere la buona fede del contribuente nel non aver potuto denunciare ogni minimo ammanco.
- Se i beni mancanti sono stati ceduti gratuitamente a determinati enti (destinazioni benefiche): l’art.2, co.2 D.P.R. 441/97 esclude la presunzione per beni ceduti a titolo gratuito a ONLUS, enti caritativi, istituzioni religiose, scuole, PA, a condizione che tali cessioni risultino da apposito documento di trasporto e siano comunicate entro 5 giorni prima della consegna . In altre parole, donazioni di eccedenze di magazzino (per importi sopra €15.000) devono essere preannunciate al fisco e documentate (oggi l’adempimento è in parte confluito nelle normative sulle cessioni gratuite a fini solidaristici, es. Legge “antisprechi” n.166/2016 per il settore alimentare, che prevede semplificazioni burocratiche). Se tali condizioni sono rispettate, l’ammanco per cessione gratuita non genera presunzione di vendita in nero.
Riassumendo, la legge individua alcune cause lecite di differenze (distruzione, furto, utilizzo produttivo, donazione benefica) e prescrive per alcune di esse specifiche formalità probatorie. L’onere della prova grava sul contribuente: è compito dell’azienda predisporre e conservare la documentazione attestante la legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale, da esibire in caso di verifica . Se la prova fornita è ritenuta idonea, la presunzione fiscale “cade” e non si procederà ad accertare ricavi non dichiarati su quei beni. Al contrario, in assenza di giustificazioni o se queste sono ritenute insufficienti, l’Ufficio procederà a riprendere a tassazione i beni mancanti come vendite occultate (applicando imposte e sanzioni).
Esempio: un supermercato riscontra a fine anno un ammanco di 100 bottiglie di liquore. Se non fornisce spiegazioni, il Fisco potrà presumere che siano state vendute senza scontrino (recuperando l’IVA e i ricavi evasi). Se invece l’azienda presenta le denunce di furto allegate ai verbali della vigilanza (es. taccheggi documentati da video) per 80 bottiglie e un verbale di distruzione per le restanti 20 (andate rotte durante il trasporto e distrutte alla presenza di testimoni con atto notorio), allora con buona probabilità avrà fornito prova contraria sufficiente a evitare l’accertamento. È importante la tempestività: le denunce di furto vanno fatte appena scoperto l’ammanco (in genere entro 48 ore) e i verbali di distruzione vanno preannunciati; produrre tali documenti solo dopo, a verifica avviata, può destare sospetti di auto-giustificazione postuma.
Il punto sulle presunzioni legali e semplici – Un aspetto fondamentale da comprendere è la differenza tra presunzione legale “relativa” ex D.P.R. 441/97 e presunzioni semplici in ambito accertativo. Se ricorrono i presupposti formali (es. differenze emerse da inventario ufficiale per soggetto con obbligo di registro di magazzino), la presunzione legale solleva l’ufficio dall’onere di provare l’evasione: il fatto stesso dell’ammanco “ufficiale” costituisce prova prima facie di cessione irregolare, salvo prova contraria del contribuente . Viceversa, se tali presupposti stretti non ricorrono (es. l’ammanco risulta solo da contabilità interna non obbligatoria, oppure l’azienda non era tenuta al registro di magazzino), la presunzione legale non si attiva e dunque l’ufficio – per accertare materia imponibile – dovrà costruire un ragionamento presuntivo semplice, basato su indizi gravi, precisi e concordanti (art.39, c.1, lett.d D.P.R.600/73). In pratica dovrà dimostrare che, pur mancando la presunzione legale, quelle differenze rendono inattendibile la contabilità e giustificano un accertamento induttivo. La distinzione ha effetti importanti sull’onere probatorio: con la presunzione legale “mista” del D.P.R. 441/97 è il contribuente a dover dimostrare di non aver evaso (fornendo prove vincolate, come visto), mentre con le sole presunzioni semplici è l’Agenzia che in caso di ricorso deve convincere i giudici della validità degli indizi raccolti (fermo restando che il contribuente può sempre confutare la pretesa con proprie prove).
Giurisprudenza recente in ambito tributario
La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sul tema, delineando in modo più preciso l’ambito di applicazione delle presunzioni su differenze inventariali e i limiti entro cui il contribuente può opporre giustificazioni. Di seguito sintetizziamo i principi chiave emersi dalle sentenze più autorevoli (sez. tributaria) degli ultimi anni, evidenziando come difendersi alla luce di essi.
- Presunzione e scritture contabili obbligatorie – Con una decisione del 2025, la Suprema Corte ha affermato che la presunzione legale di cui al D.P.R. 441/97 non opera per i soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, cioè per le imprese più piccole . Nel caso in esame (Cass., ord. n.198 del 07/01/2025) una società della GDO contestava un accertamento fondato su differenze emerse dalla sola contabilità gestionale interna (non obbligatoria per legge). La Cassazione gli ha dato ragione sul punto di diritto: se i registri di magazzino non erano legalmente obbligatori, l’ufficio non poteva applicare automaticamente la presunzione di cessione (che per legge presuppone differenze in inventari fisici o scritture obbligatorie) . Ciò tuttavia non annulla l’accertamento, ma lo declassa ad accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici. In tal caso, chiarisce la Corte, l’ufficio può comunque accertare maggiori ricavi ex art.39 co.1 lett.d D.P.R.600/73 e art.54 D.P.R.633/72 usando quelle differenze come indizio di evasione, ma spetterà al giudice valutarne la gravità, precisione e concordanza . Difesa: se la vostra azienda non è tenuta per legge al registro di magazzino e un controllo vi contesta ammanchi basandosi su contabilità interna o rilevazioni extra-contabili, potete eccepire l’inapplicabilità della presunzione legale (violazione del D.P.R.441/97) e pretendere che l’accertamento stia in piedi solo se l’ente fornisce ulteriori elementi probatori. Ad esempio, Cass. 19214/2024 ha ribadito proprio che differenze desunte da scritture non obbligatorie comportano onere dell’ufficio di provare l’evasione con altri riscontri, non bastando la mera difformità contabile interna .
- Differenze “minime” e prova contraria – In passato si era discusso se ammanchi di modesta entità, rientranti magari nella fisiologica wastage aziendale, potessero di per sé essere considerati prova che non vi fosse evasione. Alcune pronunce di merito avevano escluso accertamenti per scostamenti sotto l’1-2% del venduto, ritenendoli trascurabili. La Cassazione inizialmente ha mostrato apertura: una sentenza del 2018 (Cass. n.27549/2018) sottolineò che la esiguità dei valori e la plausibile spiegazione in termini di errore umano possono costituire elementi idonei a vincere la presunzione, privilegiando “una valutazione di buon senso” . In quel caso, relativo a una differenza inventariale molto piccola rispetto al volume d’affari, la Suprema Corte confermò l’annullamento dell’accertamento, ritenendo che il giudice di merito avesse correttamente valutato come prova contraria il fatto che lo scostamento fosse percentualmente irrisorio e verosimilmente dovuto a errori di conteggio del personale . Tuttavia, più di recente la Cassazione ha assunto un orientamento opposto: con l’ordinanza 19206/2024 ha stabilito che anche errori/scostamenti di minima entità non esonerano il contribuente dal fornire la prova contraria secondo le modalità tassative del D.P.R. 441/97 . Nella vicenda (Brand Loyalty Italia s.p.a., 1,32% di differenza sul venduto) i giudici tributari avevano dato rilevanza alla marginalità dello scostamento, richiamando persino la circ. 31/E/2006 dell’Agenzia (che tende a non considerare evasivi ammanchi entro certi limiti fisiologici) . Ma la Cassazione ha cassato tale approccio, affermando in massima principi di rigore: in caso di differenze inventariali – per quanto percentualmente ridotte – opera la presunzione legale di cessione/acquisto, e il contribuente è tenuto alla prova contraria mediante gli specifici mezzi previsti (denunce, verbali, documenti) . Non basta dunque invocare la “normalità” statistica dell’ammanco o l’errore contabile: occorre comunque dimostrare la legittima fuoriuscita dei beni dal magazzino. Questa pronuncia segna un richiamo alla lettera della legge, che non prevede soglie di tolleranza (in effetti, D.P.R. 441/97 non fissa alcuna soglia minima di differenza sotto la quale l’ufficio non possa accertare ). Difesa: ciò non significa che non possiate valorizzare in giudizio l’esiguità dello scostamento – anzi, può essere un argomento di equità – ma sappiate che in Cassazione tale argomento da solo non vi salverà; dovrete comunque corredarlo di elementi concreti (ad es. per quell’1,32% di ammanco, presentare dati sui cali fisiologici medi del settore, documentare la bontà dei processi inventariali aziendali, ecc.). In altre parole, la modesta entità dell’ammanco può servire a convincere i giudici di merito, ma non supplisce all’assenza di prove documentali se la legge le richiede.
- Compensazione tra differenze negative e positive – Un’ulteriore questione è se, in presenza contemporanea di ammanchi ed eccedenze, l’ufficio debba “compensarli” prima di accertare. Ad esempio: mancano 100 pezzi di articolo A (presunta vendita in nero) ma vi sono 50 pezzi in più di articolo B (presunto acquisto in nero). L’azienda potrebbe obiettare che parte delle differenze si bilanciano (magari errori di codifica). La legge non prevede espressamente una compensazione automatica: in teoria l’AE potrebbe contestare sia la cessione non fatturata di A sia l’acquisto occulto di B. Tuttavia, in sede di contraddittorio, è possibile far presente che spesso le differenze derivano da errori di carico/scarico e che sarebbe illogico considerare solo quelle a sfavore del Fisco. Giurisprudenza: la CTR Lombardia in una decisione (confermata in Cassazione) ha ritenuto che l’ufficio avesse agito scorrettamente limitandosi a contestare gli ammanchi senza considerare le eccedenze (che in quel caso avrebbero ridotto il netto) . La Cassazione non ha fissato un principio generale sulla compensazione, ma è importante segnalare nel ricorso se l’accertamento enfatizza le differenze unidirezionalmente. Difesa: evidenziate eventuali eccedenze non contestate dall’ufficio, argomentando che, se l’azienda avesse voluto evadere, difficilmente avrebbe acquistato merci in nero per poi non venderle; la presenza di eccedenze potrebbe indicare errori contabili piuttosto che evasione. Ciò può aiutare a minare la “precisione” delle presunzioni dell’ufficio.
- Inventari di apertura/mancata quadratura iniziale – Spesso le differenze emergono confrontando le rimanenze finali di un esercizio con quelle iniziali dell’esercizio successivo. La Cassazione ha ricordato che vige il principio di continuità delle rimanenze: le rimanenze finali dichiarate in un anno costituiscono automaticamente esistenze iniziali nel successivo (art.92, co.7 TUIR) . Dunque se in bilancio al 31/12/N risultano merci per 100, ma al 1/1/N+1 l’inventario fisico dettagliato ne trova solo 80, c’è un buco di 20 non spiegato. In un caso simile la Cassazione (ord. 26484/2023) ha avallato l’accertamento di sottofatturazione: la società aveva sistematicamente sovrastimato le rimanenze finali in bilancio rispetto all’inventario analitico, creando l’apparenza di vendite inferiori al reale (minori ricavi dichiarati) . L’aver “gonfiato” le giacenze finali (e iniziali dell’anno seguente) è stato considerato un artificio contabile idoneo a generare presunzioni di evasione, perché presentava vendite più basse e permetteva anche di dedurre costi l’anno dopo (scaricando quelle rimanenze inesistenti) . Difesa: assicuratevi sempre che le rimanenze finali in bilancio coincidano con quelle effettive; discrepanze tra inventario contabile e fisico da un esercizio all’altro sono molto pericolose. In caso di errori di contabilizzazione di fine anno (es. inventario stimato, poi rettificato), documentate e spiegate bene l’origine dell’errore, altrimenti l’AE potrebbe sospettare intenzionalità. Se ereditate una situazione del genere da un precedente contabile o amministratore, evidenziatelo (comunque la società risponde, ma può rilevare in ambito penale per la valutazione del dolo).
- Attendibilità globale della contabilità – La presenza di gravi carenze nella tenuta degli inventari (ad es. mancata tenuta delle scritture di magazzino obbligatorie, oppure inventari talmente lacunosi da non consentire verifiche) può portare l’ufficio ad applicare un accertamento induttivo “puro”, ai sensi dell’art.39, co.2, D.P.R.600/73, prescindendo in toto dalle scritture e ricostruendo il reddito con qualsiasi mezzo . La Cassazione ha ritenuto legittimo l’induttivo puro, ad esempio, se dall’esame del libro inventari emerge che il contribuente non ha trascritto il dettaglio delle rimanenze o i criteri di valorizzazione : ciò rende inattendibile la contabilità e giustifica presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità/precisione (le c.d. presunzioni supersemplici). Difesa: in tal caso l’unica strategia è dimostrare, se possibile, che l’inattendibilità non era tale da impedire ogni calcolo (magari si dispone di registri ausiliari anche se non formalmente tenuti, o altre evidenze), oppure contestare la proporzionalità della ricostruzione dell’ufficio (se ha esagerato nelle stime). Ad ogni modo, prevenire è meglio: tenere in ordine le scritture (specie se obbligatorie) è la prima difesa contro accertamenti induttivi.
Conclusione (fisco) – In sintesi, la Cassazione oggi interpreta in modo piuttosto rigoroso le norme: se l’ufficio dimostra differenze inventariali rilevanti, scatta la presunzione di legge (salvo i casi di non obbligo contabile), e il contribuente deve attivarsi prontamente per giustificarle con elementi concreti e specifici. Non esistono più “zone franche” automatiche per ammanchi minimi, per cui ogni differenza merita attenzione e documentazione. Tuttavia, la stessa giurisprudenza conferma anche che il contribuente ha diritto di difendersi con qualsiasi prova idonea a spiegare le differenze: le tipizzazioni del D.P.R. 441/97 (denuncia, atto notorio, ecc.) non sono esaustive delle possibili prove contrarie . Ad esempio, in un caso la Cassazione ha ammesso che il contribuente possa anche provare in modo non formalistico che i beni mancanti sono stati distrutti o impiegati, purché raggiunga convincimento (principio del libero mezzo di prova in giudizio tributario). Dunque, se avete mancato qualche adempimento formale, non rinunciate: presentate comunque le vostre prove (anche tardive) in contenzioso, argomentando la sostanza economica delle operazioni.
Procedura di accertamento e strumenti difensivi tributari
Le contestazioni per differenze di magazzino solitamente emergono durante una verifica fiscale. I soggetti preposti sono la Guardia di Finanza (verifiche tributarie, spesso in loco) o funzionari dell’Agenzia delle Entrate (controlli in ufficio su dati dichiarativi o PVC della GdF). Vediamo le fasi tipiche e come difendersi:
- Accesso, ispezione e PVC: se avviene un accesso presso l’azienda (ispezione), i verificatori possono effettuare conte fisiche di magazzino e richiedere esibizione di documenti. È importante collaborare ma anche far mettere a verbale eventuali dichiarazioni a favore. Se, ad esempio, durante la conta emergono ammanchi, potete subito dichiarare (verbalizzandolo) eventuali motivi noti: “le differenze potrebbero derivare da furti subiti, di cui allego copie delle denunce già presentate” oppure “una parte della merce mancante è stata distrutta a magazzino il mese scorso per infestazione, abbiamo verbale interno”. Questo può convincere i verificatori a non procedere con eccessivo zelo o quantomeno risulterà agli atti. Al termine della verifica, se vengono constatate irregolarità, viene rilasciato un Processo Verbale di Constatazione (PVC). Diritti del contribuente: lo Statuto del Contribuente (L.212/2000) all’art.12, co.7, prevede che da quando viene consegnato il PVC avete 60 giorni per presentare osservazioni e richieste prima che l’ufficio emetta avviso di accertamento (salvo casi di particolare urgenza) . Usate questo periodo per predisporre una Memoria difensiva scritta, allegando tutta la documentazione giustificativa degli ammanchi/eccedenze e contestando eventuali errori dei verbalizzanti. Ad esempio, se ritenete che i verificatori abbiano ignorato dei vostri registri o abbiano sbagliato conteggi, ditelo nella memoria. L’ufficio è tenuto a valutare tali deduzioni (il mancato riscontro può viziare l’accertamento per violazione del contraddittorio, come riconosciuto da Cassazione e Corte UE in alcune situazioni). In ogni caso, presentare memorie vi consente spesso di convincere l’Ufficio a ridurre o archiviare alcune contestazioni prima che diventino atto impositivo.
- Avviso di accertamento: trascorsi i 60 giorni (o anche prima se dichiarato motivatamente urgente), l’Agenzia Entrate emette l’atto di accertamento con la richiesta di maggiori imposte, sanzioni e interessi. Da quel momento avete 60 giorni per impugnare l’atto davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione dal 2023 delle Commissioni Tributarie Provinciali). Prima di ricorrere, potete valutare l’accertamento con adesione: è un procedimento deflattivo che, se attivato dal contribuente entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, sospende i termini per ricorrere e consente di discutere con l’ufficio per trovare un accordo (eventualmente riducendo imponibili e sanzioni). Nelle contestazioni da differenze inventariali, l’adesione può essere utile se riconosciute alcune irregolarità: ad esempio, ammettete un ammanco non giustificato ma contestate la quantificazione, potreste in adesione ottenere uno sconto sanzioni (1/3) e forse una riduzione della base imponibile accertata, evitando il contenzioso. Se invece ritenete l’accertamento totalmente infondato (es. avete tutte le prove ma non sono state accolte) conviene presentare ricorso tributario. Nel ricorso è fondamentale argomentare sia i vizi di legittimità (es. mancato rispetto dei 60 giorni dal PVC – se applicabile – o difetto di motivazione, errori procedurali, ecc.) sia il merito, confutando punto per punto la pretesa fiscale. Allegare le prove contrarie documentali è essenziale. Spesso nei ricorsi si richiamano le pronunce di Cassazione in situazioni analoghe: es. “la presunzione non opera in quanto la differenza emerge da documenti non obbligatori, conforme a Cass. 198/2025 ” oppure “la modesta entità dell’ammanco (0,5%) unita alle misure di sicurezza adottate dall’azienda configura quella situazione di normalità operativa che secondo Cass. 27549/2018 può costituire prova liberatoria ”. Citare la giurisprudenza aggiornata mostra al giudice che la tesi è fondata.
- Contenzioso tributario: la causa si svolge davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (CGT). In primo grado, se le prove presentate sono convincenti, è possibile ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto. Ad esempio, la CGT potrebbe riconoscere valide le giustificazioni per una parte degli ammanchi (annullando quella ripresa) e confermare la restante. Se l’esito è sfavorevole, potete appellare alla CGT di secondo grado (ex CTR) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. In secondo grado, la controversia viene riesaminata. Infine c’è il ricorso in Cassazione (entro 60 gg dalla sentenza d’appello) solo per motivi di diritto. Strategia difensiva: nei gradi di merito, puntate molto sui fatti e sulle prove (testimonianze, perizie, documenti che spieghino le differenze). La Cassazione infatti non valuterà nuovi documenti o fatti, quindi è cruciale introdurli prima. Ad esempio, se le differenze sono dovute a furti, potete portare a testimoniare il responsabile sicurezza che illustri i casi di taccheggio frequenti; oppure produrre statistiche di settore per dimostrare che il vostro ammanco rientra nella media (approccio seguito talvolta dalle Commissioni per convincersi della buona fede del contribuente). Nota bene: se l’ammanco ha generato anche rilievi penali (vedi infra Parte III), la pendenza di un procedimento penale non sospende automaticamente il processo tributario (salvo richiedere voi una sospensione in casi particolari). Quindi dovrete portare avanti la difesa su entrambi i fronti eventualmente, coordinando le strategie (ciò che dite in uno potrà influire sull’altro).
- Definizioni agevolate: tenete presente eventuali normative speciali. Nel 2023-2024, ad esempio, sono state previste sanatorie o conciliazioni agevolate per i giudizi tributari pendenti: se vi trovate in causa per differenze inventariali e il legislatore apre a una definizione agevolata con sanzioni ridotte, valutate l’opportunità economica di chiudere la lite pagando magari solo le imposte (specie se l’esito è incerto).
- Prescrizione e decadenza: le contestazioni fiscali devono rispettare i termini di decadenza dell’accertamento (normalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o settimo se omessa). Le differenze inventariali spesso vengono contestate per più annualità in una volta, specie se emergono da un inventario che copre più anni. Verificate sempre che ogni annualità rientri nei termini. Se un anno è decaduto, eccepite l’intervenuta decadenza in ricorso (è una eccezione in senso proprio, quindi sollevatela chiaramente). Sul fronte della riscossione, se l’atto diventa definitivo (nessun ricorso o sentenza passata in giudicato) le somme dovute vanno versate nei 60 gg oppure l’AE iscrive a ruolo l’importo (cartella esattoriale). Potete eventualmente chiedere una rateazione (fino a 8 rate trimestrali o 16 se >€50k, secondo D.Lgs. 218/97) per importi alti, o ricorrere alla definizione agevolata delle sanzioni (se applicabile, pagando 1/3 in caso di acquiescenza entro 30 gg). Ogni strategia di pagamento va ponderata sulla base della fondatezza della contestazione e delle risorse finanziarie aziendali.
Parte III – Profili penali (reati tributari e fallimentari)
Le differenze inventariali, di per sé, non costituiscono un reato. Diventano penalmente rilevanti quando sono indice o risultato di condotte fraudolente o gravi violazioni tributarie. I due ambiti principali sono: i reati tributari (D.Lgs. 74/2000 e successive modifiche) nel caso le differenze celino evasioni oltre soglie di punibilità, e i reati fallimentari (artt.216-217 Legge Fallimentare, ora D.Lgs. 14/2019 Codice della Crisi) se l’impresa fallisce lasciando “buchi” di magazzino. Inoltre, condotte come la sottrazione o distruzione di beni per non pagarne i creditori possono configurare reati ad hoc. Esaminiamo i principali:
Evasione fiscale e dichiarazione fraudolenta – Se le differenze inventariali riflettono vendite non fatturate di entità rilevante, potrebbe scattare il reato di dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs. 74/2000) o, in casi più articolati, di dichiarazione fraudolenta (art.3 se vi è ricorso a mezzi fraudolenti). Ad esempio, un grande magazzino che ogni anno occulta sistematicamente il 5% delle vendite (giustificando il calo come furti fittizi) sta evadendo IVA e imposte sui redditi; se l’ammontare evaso supera le soglie penali, l’amministratore potrà essere perseguito. Attualmente (dopo la riforma del 2015 e ulteriori ritocchi) il reato di dichiarazione infedele scatta se l’imposta evasa supera 100.000 € e l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione supera il 10% del reddito dichiarato o comunque 2 milioni di €. Il reato di dichiarazione fraudolenta si applica se si usano artifici per evadere (ad esempio falso in bilancio o alterazione di registri). Nel caso delle differenze inventariali, se il contribuente “trucca” le scritture contabili di magazzino per occultare le vendite, potrebbe profilarsi l’art.3 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante artifici) perché si sono utilizzate false annotazioni o altri mezzi ingannevoli . Per esempio, la Cassazione ha considerato artificio fraudolento l’alterazione volontaria delle rimanenze finali per abbattere i ricavi e dedurre costi fittizi l’anno dopo . Questo comportamento, se effettuato dolosamente, oltre all’accertamento fiscale ha portato a una denuncia penale. Sanzioni: la dichiarazione infedele è punita con la reclusione da 2 a 4.5 anni; la dichiarazione fraudolenta (art.3) da 3 a 8 anni.
Omessa dichiarazione IVA – Un’ipotesi estrema: se le differenze sono dovute a intere attività occulte, ad esempio un magazzino parallelo fuori contabilità, e l’azienda non dichiara proprio quei ricavi, si può arrivare al reato di omessa dichiarazione (art.5) o emissione di fatture false (art.8) se c’è un sistema di copertura. Tipicamente, però, i reati più attinenti sono quelli della distruzione o occultamento di scritture contabili (art.10 D.Lgs.74/2000), in cui potrebbe incorrere chi deliberatamente ha sottratto o falsificato registri di magazzino per non renderli disponibili al controllo (pena 3–7 anni). Se, ad esempio, all’ispezione GdF il responsabile aziendale non esibisce il registro di magazzino obbligatorio o risulta che lo ha artefatto, potrebbe esserne accusato.
Profili soggettivi – I responsabili penali, in ambito tributario, sono essenzialmente gli amministratori o legali rappresentanti che hanno sottoscritto le dichiarazioni infedeli o che hanno tenuto le condotte fraudolente. Anche il direttore finanziario o chi materialmente tiene la contabilità di magazzino potrebbe concorrere se ha concorso nell’illecito (ad es. un CFO che organizza la falsificazione delle rimanenze). L’azienda in quanto tale non è punibile penalmente per i reati tributari (attualmente il D.Lgs. 231/2001 non include i reati fiscali tra quelli imputabili agli enti, salvo fatture false in certe condizioni), ma potrebbe subire sanzioni interdittive se i reati fiscali si accompagnano ad altri (ad es. reati doganali, contrabbando). In ogni caso, l’impatto reputazionale di un’indagine penale è rilevante, dunque prevenire anche sul piano fiscale evita grane giudiziarie.
Difesa penale – Se vi contestano un reato tributario legato a differenze di magazzino, la difesa può svilupparsi su più fronti: tecnico-contabile (dimostrare che l’evasione in realtà non c’è stata, o che le soglie non sono superate, magari ottenendo perizia di parte; oppure dimostrare che l’ammanco era genuino e non frutto di vendite occulte), procedurale (verificare la validità delle prove dell’accusa: es. i rilievi del PVC, eventuali errori nelle % di ricarico utilizzate per quantificare l’evaso) e soggettiva (assenza di dolo specifico di evasione, ad esempio sostenendo che l’amministratore credeva davvero che la merce fosse stata rubata e non venduta; se ciò è credibile si esclude l’intenzionalità fraudolenta). Ricordiamo che nel penale vige la prova oltre ogni ragionevole dubbio: la difesa può instillare dubbi sulla effettiva destinazione dei beni mancanti. Ad esempio, se dall’inventario mancano beni per 300.000€, l’accusa dirà “venduti in nero”, ma la difesa potrebbe portare testimonianze che in magazzino vi era un problema di furti da parte di dipendenti (magari alcuni licenziati per questo) e quindi la mancanza è dovuta a peculato altrui e non profitto dell’imprenditore. Se ciò crea dubbio, il giudice penale non potrà affermare con certezza il dolo di evasione. Anche in penale valgono le prove documentali (le stesse denunce usate in ambito fiscale qui diventano cruciali per mostrar che non c’era volontà di evasione, ma reale evento di perdita). Un bravo difensore cercherà poi di smontare il calcolo dell’imposta evasa: a volte la GdF ricostruisce i ricavi occulti con coefficienti discutibili (mark-up standard, ecc.). Dimostrare che quei calcoli sono errati o gonfiati può far scendere l’evaso sotto soglia (e far cadere il reato) . Da ultimo, esistono cause di non punibilità: ad esempio, l’“adempimento di un dovere” per chi distrugge beni pericolosi su ordine autorità (caso raro) o il force majeure. Ma più pratico è, ove possibile, rimuovere l’evasione: se prima del dibattimento il contribuente paga integralmente il debito tributario, alcune fattispecie (es. dichiarazione infedele) beneficiano di attenuanti o esclusione di punibilità (recenti riforme hanno ampliato questi effetti premiali). La cd. “voluntary disclosure” o ravvedimento operoso non esclude il reato una volta scoperto, ma il pagamento può incidere sulla concessione della sospensione condizionale o sull’entità della pena.
Reati fallimentari – Se l’impresa incorre in fallimento (o liquidazione giudiziale, secondo il nuovo Codice della Crisi), differenze inventariali significative possono originare contestazioni in sede penale fallimentare. L’ipotesi tipica è la bancarotta fraudolenta patrimoniale: gli amministratori che distraggono o occultano beni aziendali prima del fallimento ne rispondono penalmente (art.216 L.F., ora art.322 CCII). Se dal confronto inventariale risultano beni mancanti rispetto alle scritture, e l’azienda fallisce, il curatore fallimentare potrebbe denunciare gli amministratori ipotizzando che abbiano sottratto quei beni a danno dei creditori. Ad esempio, se dal bilancio risultavano rimanenze per 1 milione € e al fallimento il magazzino vale 100.000 €, vi è un ammanco di 900.000 € non giustificato – indizio classico di distrazione di beni. La difesa in tal caso dovrà provare che la differenza è dovuta a cause genuine (furti subiti, svendite sottocosto documentate, errori contabili senza dolo). Ma attenzione: anche l’omessa tenuta o esibizione delle scritture di magazzino in fallimento configura reato di bancarotta semplice o fraudolenta documentale. Quindi, se il fallito non aveva tenuto i registri di magazzino ed è impossibile ricostruire le rimanenze, l’amministratore può essere accusato di bancarotta fraudolenta per sottrazione di scritture (se c’è dolo di nascondere informazioni) o bancarotta semplice (se per negligenza non ha tenuto le scritture causando confusione patrimoniale). Difesa: in ambito fallimentare la soglia di tolleranza è bassa; bisogna documentare ogni giustificazione. Se parte delle merci erano state regolarmente vendute ma non ancora scaricate dalle scritture, bisogna recuperare quei documenti di vendita; se c’erano state rotture/danneggiamenti, mostrare eventuali report interni o comunicazioni assicurative. Altrimenti, l’assenza di beni senza spiegazione viene quasi automaticamente letta come volontà di distrazione.
Furti e appropriazioni indebite – In alcuni casi, differenze inventariali molto elevate possono derivare non da evasione del titolare, ma da reati commessi da terzi (es. dipendenti infedeli che rubano merce, furti organizzati). In tali casi, dal punto di vista dell’imprenditore vittima, occorre sporgere denuncia di furto verso ignoti o querela verso eventuali dipendenti sospetti. Ciò è duplice: da un lato protegge fiscalmente (come visto, la denuncia è prova contraria per il fisco), dall’altro attiva l’azione penale contro gli autori. Se poi viene identificato un dipendente colpevole (magari tramite telecamere, ecc.), questi potrà essere accusato di furto aggravato o appropriazione indebita a seconda delle circostanze. L’azienda potrà costituirsi parte civile per il risarcimento. In tali procedimenti, è utile evidenziare come l’azienda abbia procedure di controllo e come l’evento sia avvenuto aggirandole (per evitare contestazioni di corresponsabilità).
Sanzioni doganali penali – Una menzione: se le differenze riguardano merci estere in dogana, casi estremi possono configurare il reato di contrabbando (artt.282-301 T.U.Leggi Doganali). Ad esempio, mancata presentazione in dogana di merce vincolata a transito o temporanea custodia, con dazi evasi di grande entità, può portare a incriminazioni. Tuttavia, la maggior parte di queste condotte oggi è depenalizzata e trattata come illecito amministrativo (vedi Parte IV). Solo condotte fraudolente rilevanti (come introdurre merci in Paese senza dichiararle affatto) rimangono penali. Se un deposito doganale presenta un ammanco enorme non dichiarato, il gestore potrebbe essere indagato per sottrazione al pagamento di dazi in concorso con eventuali complici. La difesa penale qui consisterebbe nel dimostrare che la mancanza è dovuta a errore o caso fortuito, senza dolo di contrabbando.
Riassumendo (penale): La prospettiva penale richiede di focalizzarsi sull’elemento soggettivo (dolo intenzionale di evasione o di distrazione). Differenze inventariali possono costituire “il fatto materiale”, ma la punibilità dipende dalla volontarietà di chi le ha causate. Una gestione caotica o negligente del magazzino, che porti a buchi, potrà avere conseguenze fiscali ma non sempre penali (potrebbe configurare al più bancarotta semplice, che è contravvenzione minore). Invece una gestione dolosa volta a occultare ricavi o svuotare l’azienda certamente integra reati seri. Pertanto, chi si difende dovrà evidenziare l’assenza di vantaggio personale e la mancanza di scopo illecito dietro le differenze di magazzino. Inoltre, nel penale vige la presunzione di innocenza: non basta per la condanna la presunzione fiscale di cessione in nero; serviranno prove aggiuntive (es. movimentazione di denaro contante non giustificato, confessi, false fatture, etc.). Un abile legale cercherà di isolare la contestazione penale come “mero riflesso di presunzioni tributarie” non suffragate da evidenze concrete di incassi occulti.
Parte IV – Profili doganali e IVA intracomunitaria
Le differenze inventariali assumono particolare rilievo quando riguardano beni vincolati a regimi doganali o IVA speciali (es. depositi doganali, depositi IVA, transiti, regime di temporanea importazione, ecc.). In tali casi, infatti, ammenchi ed eccedenze possono implicare il mancato assolvimento di dazi doganali o IVA all’importazione, con conseguenti sanzioni. Vediamo le situazioni tipiche e le difese.
Depositi doganali – Un deposito doganale è un luogo autorizzato dove merci estere possono essere stoccate senza pagare immediatamente i dazi e l’IVA, in attesa di una successiva destinazione (importazione, riesportazione, transito, etc.). Il gestore del deposito deve tenere una scrupolosa contabilità di entrate/uscite. Se all’atto di un controllo periodico (inventario di riscontro) le merci mancanti eccedono quelle registrate come uscite regolari, significa che tali beni sono stati sottratti al controllo doganale senza pagar dazio. In tal caso si genera un’obbligazione doganale: l’operatore deve pagare i dazi e l’IVA come se avesse importato quei beni (artt.79-80 del Codice Doganale dell’Unione, Reg. UE n.952/2013). Inoltre, viene applicata una sanzione amministrativa. In Italia, l’art.303 del T.U. Dogane (D.P.R. 43/1973) – modificato dal 2012 – disciplina le sanzioni per dichiarazioni inesatte su quantità/qualità delle merci: se la quantità reale differisce da quella dichiarata oltre una tolleranza del 5%, si applica una multa proporzionale al differenziale . In particolare, per deficit di merce corrispondenti a dazi evasi: fino a 500 € di dazi evasi la sanzione va da 103 a 500 €; dazi evasi €500-1000 sanzione 1.000-5.000 €; €1000-2000 → 5.000-15.000 €; €2000-3999 → 15.000-30.000 €; oltre €4.000 di dazi evasi, multa da 30.000 € fino a 10 volte l’importo dei dazi evasi . Queste soglie (come vedete, piuttosto punitive per importi alti) sono volte a dissuadere la sottrazione di merci dal regime sospensivo.
Se invece si riscontrano eccedenze in un deposito doganale (merci in più di quelle dichiarate in ingresso), ciò potrebbe significare che merci sono state introdotte irregolarmente (forse provenienti dall’esterno senza dichiarazione) – anche qui configurando un’evasione di dazi se non regolarizzate. In genere, la dogana richiederà di giustificare l’origine di quelle eccedenze o, in difetto, di assolvere dazi/IVA come se fossero importazioni non dichiarate.
Difese in ambito doganale – La normativa doganale prevede anch’essa possibilità di esonero dalla tassazione in caso di perdita o furto di merci sotto vigilanza doganale, ma con condizioni stringenti. Ad esempio, l’art.124 del Codice Unionale prevede l’estinzione del debito doganale se le merci sono state distrutte o irrimediabilmente perse per cause imprevedibili o forza maggiore, oppure se mancano per colpa dell’autorità doganale stessa. Ciò significa che se in un deposito doganale si verifica un incendio, o un furto documentato (non imputabile a negligenza del depositario), l’operatore può chiedere di non pagare i dazi su quelle merci andate distrutte/furate. Ovviamente occorre fornire prova rigorosa dell’evento (rapporti di polizia, perizia sull’incendio, ecc.) e notificare subito l’accaduto all’autorità doganale. Se tali condizioni non ricorrono, ogni differenza verrà considerata come merchandise released for free circulation senza dichiarazione, quindi imponibile.
A differenza del fisco interno, qui non c’è una presunzione di cessione a titolo di ricavo, ma piuttosto l’attenzione è sul dazio non pagato. Quindi l’aspetto “evasione di ricavi” (reddito) non interessa la dogana, interessa piuttosto l’IVA all’import e i dazi. Un caso frequente: depositi IVA o zone franche in cui sparisce merce. Anche se fiscalmente l’IVA interna non è dovuta (perché la cessione poteva essere non nazionale), l’IVA di importazione invece sì.
Sanzioni e processo – Le contestazioni doganali seguono un iter amministrativo: l’Agenzia delle Dogane notifica un verbale di accertamento con richiesta di tributi evasi e sanzioni. Ci si può difendere presentando osservazioni e memorie in dogana, oppure, dopo l’irrogazione formale della sanzione, ricorrere alle Corti di Giustizia Tributaria (poiché le controversie doganali sono assegnate alle stesse, essendo tributi). Va sottolineato che l’apparato sanzionatorio doganale italiano è stato spesso ritenuto non proporzionato dalla giurisprudenza UE; la Cassazione ha a sua volta operato interpretazioni per mitigare certe sanzioni in eccesso. Ad esempio, si discute se applicare cumulativamente le soglie di cui sopra o se considerare il cumulo giuridico in caso di atti contestuali. Una difesa comune è invocare il principio di proporzionalità: se l’ammanco è minimo, l’applicazione di una sanzione forfettaria elevata (es. 30.000€ per dazi evasi di poco oltre 4.000€) potrebbe essere contestata come eccessiva rispetto al danno erariale . In qualche caso, la giurisprudenza interna ha ridotto sanzioni doganali in virtù di tale principio.
Contestazioni doganali vs penali – Come accennato, la maggior parte di queste situazioni è trattata come illecito amministrativo. Solo se le differenze mascherano un vero traffico di contrabbando (introdurre merci clandestinamente) ci sarà un procedimento penale parallelo. Ma se state affrontando una sanzione ex art.303 TULD, siamo nel campo amministrativo. In tal caso, non rischiate arresto o altro, ma le sanzioni pecuniarie possono essere ingenti. Si può tentare un’istanza di pagamento ridotto ex art.16 L.689/1981 (spesso non applicabile alle doganali per come sono congegnate, ma da valutare) oppure un’definizione agevolata se prevista (in passato condoni o rottamazioni hanno riguardato anche sanzioni doganali).
Difesa pratica: in sede contenziosa, per difendersi da una contestazione di ammanco doganale, occorre provare o che non vi è stato ammanco reale (p.es. errore inventariale: merce registrata male ma fisicamente presente altrove; se potete, rintracciatela) oppure che l’ammanco rientra in margini tecnici di calo. La normativa 2012 citata prima ha eliminato la franchigia del 5% come non punibilità (ora oltre 5% scatta la multa), ma comunque entro il 5% non c’è sanzione . Quindi se l’ammanco è modesto (es. 2% sul totale), evidenziate che rientra entro il 5% e dunque sarebbe non sanzionabile (ovviamente dovrete comunque pagare i dazi su quel 2% mancante). Se invece supera 5%, cercate di ridurlo: magari alcuni beni considerati dispersi erano in realtà già stati importati con bolle a parte (verificate la documentazione, potreste scoprire che la dogana ha contato come mancanti beni che erano stati regolarizzati separatamente). Oppure provate che si tratta di calo naturale: in alcuni settori, come stoccaggio di liquidi o derrate, esistono cali fisiologici di peso (evaporazione, calo peso volumetrico). L’amministrazione doganale talvolta riconosce percentuali di calo tecnico (soprattutto per prodotti soggetti ad accisa, tipo alcolici, carburanti). Se il vostro ammanco rientra in tali percentuali standard, contestate la sanzione richiamando eventuali disposizioni tecniche o prassi.
Depositi IVA – Un cenno: nel deposito IVA (diverso dal doganale, è un regime in cui beni UE o nazionali sono stoccati senza applicazione dell’IVA finché non estratti) possono esserci differenze. Se manca merce in un deposito IVA, significa che è uscita senza assolvere l’IVA: l’AdE può richiedere l’IVA evasa e sanzione del 30% per omesso versamento. Tuttavia, la normativa recente impone che per estrarre dal deposito IVA bisogna emettere autofattura e versare l’imposta, quindi i casi di ammanco si sono ridotti. Ma qualora succeda (es. merce rubata dal deposito IVA), la difesa consisterà nel provare il furto per far sì che l’IVA non sia dovuta (in linea teorica, IVA non è dovuta su beni andati distrutti o rubati, ma va documentato per evitare presunzione di consumo).
Case study doganale: una società logistica gestisce un deposito doganale di prodotti elettronici importati dalla Cina. Un controllo dell’ADM riscontra che mancano 100 tablet di un certo modello che risultavano ancora formalmente in regime di deposito. Se il gestore non trova quei tablet, dovrà pagare i dazi e IVA su 100 tablet come se li avesse importati in nero. I dazi e IVA ammontano poniamo a €5.000. Inoltre, secondo l’art.303 TULD, essendo >5% e dazi >€4.000, la sanzione applicabile va da €30.000 fino a 10 volte i dazi (quindi max €50.000). L’ADM irroga ad esempio €30.000. Il gestore, disperato, indaga e scopre che in realtà 60 di quei tablet erano stati inviati ad un altro magazzino e regolarmente importati, ma per errore non sono stati scaricati dal registro del deposito (errore amministrativo). Altri 40 invece risultano probabilmente rubati da personale infedele (trova evidenze di manomissioni a magazzino). Difesa: il gestore presenta ricorso allegando i documenti di importazione dei 60 tablet (chiedendo di stralciare quella parte di contestazione, poiché non c’è evasione: i dazi su quei 60 sono stati pagati, fu solo un errore di registro) e le denunce di furto per i restanti 40 (chiedendo l’esonero da dazi su quelli ai sensi art.124 CDU). Argomenta inoltre che, detraendo i 60 erroneamente imputati, i dazi evasi effettivi scendono sotto €4.000, per cui la sanzione dovrebbe eventualmente rientrare nello scaglione inferiore (massimo €30.000 -> scenderebbe a max €15.000). In Commissione (CGT), se la documentazione convince, l’esito potrebbe essere: niente dazi su 60 (già pagati altrove), dazi su 40 da pagare (perché furto magari non riconosciuto come forza maggiore piena), sanzione ridotta magari al minimo edittale per lo scaglione corrispondente (es. €103 essendo dazi residui piccoli, in virtù del furto comprovato).
Parte V – Profili civilistici e responsabilità nel privato
Oltre agli aspetti fiscali e pubblicistici, le differenze inventariali possono generare conflitti e responsabilità in ambito privato, all’interno dell’azienda o nei rapporti contrattuali con terzi. Ci focalizzeremo su: (A) la responsabilità di amministratori e organi sociali verso la società o i creditori per la perdita di beni; (B) la responsabilità (e gli eventuali addebiti) a carico di dipendenti o altri soggetti per ammanchi; (C) le controversie contrattuali tra imprese legate a differenze di magazzino (es. depositi, appalti logistici, assicurazioni).
A) Responsabilità degli amministratori e organi sociali
Gli amministratori di società hanno per legge l’obbligo di gestire diligentemente il patrimonio sociale (artt. 2392 e 2476 c.c. per SPA e SRL). Ingenti differenze inventariali possono essere sintomo di cattiva gestione, potenzialmente generando una responsabilità patrimoniale degli amministratori verso la società. Ad esempio, se a fine anno risulta mancante merce per 500.000 € a causa di negligenza (nessun controllo, furti a ripetizione non contrastati), la società ha subito un danno patrimoniale (il “buco” di magazzino) che, in teoria, potrebbe richiedere agli amministratori.
Un caso tipico è nelle società con più soci o nelle controllate: i soci, venuti a conoscenza di ammanchi, potrebbero accusare gli amministratori di non aver predisposto adeguati controlli interni (mancanza di sistemi antitaccheggio, niente inventari periodici, nessuna assicurazione furti, ecc.). Se si dimostra che un amministratore per dolo o colpa grave ha permesso un depauperamento del magazzino, questi può essere chiamato a risarcire i danni. Attenzione: non ogni ammanco giustifica un’azione di responsabilità – va provata la colpa grave. Ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto responsabile un amministratore unico che, in una società commerciale, non effettuava mai inventari e ha scoperto tardi che un dipendente rubava merce da anni, causando ingenti perdite: tale omessa vigilanza fu considerata grave negligenza.
Diverso sarebbe se l’amministratore dimostra di aver messo in atto le cautele del caso (inventari regolari, sistemi antifurto) e nonostante ciò ci siano differenze: in tal caso è difficile imputargli colpa grave, potendo l’evento essere considerato rischio d’impresa residuo.
Altra ipotesi è la responsabilità verso i creditori sociali: qualora le differenze inventariali portino all’insufficienza del patrimonio a pagare i debiti, i creditori potrebbero agire contro gli amministratori ex art.2394 c.c., sostenendo che la mala gestio (ammanco di beni) li ha danneggiati. Questo scenario si concretizza soprattutto in fallimento (dove interviene il curatore come visto) o liquidazioni societarie con passivo.
Azioni preventive per gli amministratori: per evitare questi rischi, l’organo amministrativo dovrebbe: – Implementare un solido sistema di controllo interno sul magazzino (procedure di inventario, doppie verifiche, sistemi anti-frode). – Documentare nei verbali di CDA di aver affrontato il tema (es. “il CDA prende atto delle differenze inventariali del Q1 2025 e del piano di riduzione delle stesse…”). – Attivare polizze assicurative furto/incendio per mitigare il danno economico di eventuali ammanchi (anche se l’assicurazione non evita il buco, almeno porta risarcimento). – Se un ammanco anomalo viene scoperto, agire tempestivamente (indagine interna, consulenze) per dimostrare reattività.
Simulazione: in una SRL familiare, il socio di minoranza scopre che negli ultimi 3 anni il magazzino ha registrato perdite per 200k € di merce senza adeguate spiegazioni. Il socio ritiene che l’amministratore (socio di maggioranza) abbia gestito in modo disastroso la logistica e magari sospetta che dietro agli ammanchi ci siano vendite a suoi amici “fuori registro” (ma senza prove di appropriazione). Il socio potrebbe convocare un’assemblea per revocare l’amministratore per giusta causa e successivamente promuovere un’azione di responsabilità ex art.2476 c.c. chiedendo il risarcimento di 200k€ alla società (che poi indirettamente beneficerebbe anche lui). In giudizio, se l’amministratore non prova di aver agito diligentemente (e.g. nulla documentato, depositi incustoditi, nessuna denuncia di furto), potrebbe soccombere e dover rifondere la società.
D’altro canto, se l’amministratore prova che gli ammanchi erano dovuti a cause imprevedibili (es. un dipendente infedele molto scaltro, poi denunciato appena scoperto) e di aver adottato misure standard di controllo, la domanda risarcitoria può essere respinta per assenza di colpa grave.
NB: L’amministratore risponde anche dei danni fiscali cagionati da sue omissioni: se per colpa sua la società subisce un accertamento fiscale con sanzioni, tale esborso può essere un danno risarcibile alla società. Nel nostro contesto, se non ha curato le prove per gli ammanchi e la società paga 100k di tasse/sanzioni, i soci potrebbero rivalersi per quei 100k.
Infine, attenzione alle clausole di manleva e coperture assicurative D&O: molti amministratori hanno polizze di responsabilità civile che potrebbero coprire queste situazioni (non se c’è dolo ovviamente). E in alcune società i soci approvano regolarmente il bilancio che ingloba le perdite da differenze: tale approvazione potrebbe, se motivata, configurare una sorta di quietanza sull’operato, rendendo più difficile lamentarsi poi (salvo occultamenti).
B) Responsabilità dei dipendenti e addebito di ammanchi
Un tema delicato è se l’azienda possa far pagare ai dipendenti gli ammanchi di magazzino o di cassa. Si pensi ai cassieri di supermercato o ai magazzinieri: spesso i contratti di lavoro o i regolamenti aziendali prevedono verifiche inventariali periodiche e talvolta clausole di “responsabilità” del personale per eventuali differenze superiori a una franchigia. Ma la legislazione del lavoro italiana pone limiti precisi: il lavoratore risponde verso il datore solo in caso di dolo o colpa grave (art.2106 c.c. disciplina sanzioni disciplinari, e più in generale l’art.2104 c.c. l’obbligo di diligenza). Non è ammesso trasferire sul dipendente i normali rischi d’impresa.
In pratica: se un negozio subisce taccheggi da parte di clienti, non può semplicemente decurtare dallo stipendio dei commessi l’importo della merce rubata (a meno che provi che i commessi fossero conniventi o gravemente negligenti, il che è difficile). Allo stesso modo, se in un inventario di magazzino emerge un ammanco, il datore di lavoro potrà aprire un procedimento disciplinare se sospetta negligenza o furto di un dipendente specifico, ma non può addebitare automaticamente il valore al personale in generale.
La giurisprudenza in materia ha affermato che eventuali patti di responsabilità firmati dal dipendente (tipo “mi impegno a rimborsare l’azienda per eventuali differenze inventariali”) sono nulli se comportano una rinuncia preventiva a diritti inderogabili (come la retribuzione) e se prescindono dall’accertamento di colpa. Ad esempio, in certi contratti collettivi del commercio vi furono clausole per cui al direttore del punto vendita veniva trattenuta una percentuale delle differenze inventariali eccedenti un certo limite: tali clausole sono state contestate in giudizio e spesso ritenute illegittime perché configurano una penalizzazione economica del lavoratore senza prova di una sua colpa specifica.
Il datore di lavoro, per tutelarsi, può: – Esercitare la facoltà disciplinare: se individua responsabilità di uno o più dipendenti negli ammanchi (es. negligenza grave nel controllo, o addirittura furto), può sanzionarli (fino al licenziamento per giusta causa nei casi gravi). Ad esempio, un magazziniere che firma di aver ricevuto 100 pezzi e ne mette a scaffale solo 90 (per distrazione o per appropriazione) può essere sanzionato. – Chiedere il risarcimento del danno al dipendente responsabile: ciò però richiede di provare la colpa grave o il dolo. In giudizio, l’azienda dovrà dimostrare il nesso tra la condotta del dipendente e l’ammanco. Spesso, se c’è dolo (furto), conviene procedere penalmente e civilmente insieme: una condanna per appropriazione indebita rende più agevole ottenere anche risarcimento. – Stipulare polizze o fondi interni: alcune aziende preferiscono assicurare i rischi di cassa e magazzino, oppure istituire un fondo alimentato da piccole trattenute contrattualmente concordate (in alcuni CCNL le “mancanze casse” sono gestite con un fondo cassa alimentato con arrotondamenti, ecc., ma sempre con consenso sindacale).
Esempio: una gioielleria scopre un ammanco di un diamante dal caveau. Indaga e sospetta del commesso che aveva le chiavi quel giorno. Non avendo prove certe, lo trasferisce ad altra mansione e migliora la sicurezza. Non potrebbe togliere dal suo stipendio il valore del diamante (sarebbe illecito). Se però emergesse un video del commesso che prende il diamante, allora scatterebbe il licenziamento per giusta causa e la denuncia per furto, con richiesta danni.
Attenzione: se il dipendente ammette volontariamente la responsabilità e accetta una trattenuta, questo può sanare la questione (es: il cassiere che ha sbagliato a dare resti e ha 50€ di ammanco può acconsentire a restituirli). Ma dev’essere un atto volontario, non imposto.
In alcuni ruoli di grande responsabilità (es. tesorieri, gestori contanti) la giurisprudenza applica una sorta di presunzione di colpa in caso di differenze di cassa: il cassiere è depositario del denaro e se manca è lui a dover spiegare. Questo non significa addebito automatico, ma facilita al datore l’azione di responsabilità se il cassiere non riesce a giustificare altrimenti la mancanza (principio simile al deposito irregolare ex art.1768 c.c.: il depositario deve custodire con diligenza).
In sintesi, l’azienda non può “scaricare” semplicemente i costi delle differenze sui dipendenti onesti. Può invece colpire i disonesti o negligenti, secondo le regole (disciplina, licenziamento, risarcimento). E per prevenire, deve formare il personale, implementare procedure anti-ammanchi (ad es. controllo in doppio delle casse, ispezioni a sorpresa in magazzino), in modo da rendere più facile individuare chi sbaglia o ruba, anziché dover penalizzare tutti. Anche in termini di clima aziendale, è meglio investire in prevenzione che mettere “clausole punitive” generiche.
C) Rapporti contrattuali: logistica, assicurazione, fornitori
Contratti di deposito e appalto logistico – Spesso un’azienda affida il proprio magazzino a un operatore logistico terzo (3PL). In tal caso, il contratto di deposito o logistica disciplinerà la responsabilità del depositario per le differenze di giacenza. Il codice civile (artt.1766 ss.) prevede che il depositario restituirà le cose ricevute; se mancano, risponde per inadempimento a meno che provi un caso fortuito o forza maggiore. Nei contratti è usuale però limitare la responsabilità del depositario con clausole (es. non risponde per furti senza effrazione, o limita il risarcimento a un certo importo per kg, ecc.). Molti magazzinieri fanno sottoscrivere al cliente un inventario iniziale e poi inventari periodici controfirmati: se al termine risultano differenze non giustificate, il depositario dovrà risarcire il valore della merce mancante (spesso al costo di acquisto). Alcune clausole stabiliscono franchigie o scoperti.
Difesa depositario: per non pagare, il depositario deve provare che la differenza è dovuta a cause non imputabili a sua colpa (es. furto qualificabile come forza maggiore, oppure errore nella consegna iniziale – infatti verifica e controfirma l’inventario iniziale è fondamentale). Se i furti avvengono a causa di misure di sicurezza inadeguate del depositario, di solito è responsabile. Può magari invocare il fatto che il contratto esclude la responsabilità per “ammanco inferiore all’1% annuo” come fisiologico (talvolta si pattuisce una percentuale di calo ammessa, specie per derrate alimentari soggette a calo peso).
Esempio: Tizio affida 1000 pezzi a Caio Logistica srl in conto deposito. Dopo un anno, 50 pezzi mancano. Se Caio non giustifica, Tizio chiederà danni per 50 pezzi. Se il contratto prevedeva una franchigia del 2% su ammanchi, 50 su 1000 = 5% > franchigia, quindi Caio paga per 30 (eccedente 2%). Se Caio prova che una banda armata ha svaligiato il magazzino nonostante allarme e vigilanza (caso fortuito non evitabile), potrebbe essere esonerato, purché denunciato e provi di aver custodito con diligenza.
Vendite e forniture – Le differenze inventariali a volte emergono in controversie tra venditore e compratore: ad esempio, il compratore afferma di aver ricevuto meno merce di quella fatturata (short shipment). Se non contesta entro tempi brevi, rischia di dover pagare tutto. Qui si applicano le regole della vendita: il compratore deve denunciare immediatamente la difformità di quantità (vizio) ex art.1495 c.c. Una volta denunciato, se il venditore contesta, si andrà in lite sul fatto: serve inventario di arrivo, testimoni, etc. Non è esattamente la “differenza inventariale” oggetto di questa guida, ma correlato. Diciamo che se la differenza sta a monte (fornitore inviò meno di quanto documentato), il compratore potrebbe trovarsi con il magazzino mancante e far partire un contenzioso civile.
Assicurazioni – Molte aziende assicurano il magazzino contro furti, incendi e simili. In caso di ammanco per eventi coperti (furto con scasso ad es.), l’assicurazione indennizza il valore. Però se il furto non è documentabile (es. taccheggio diffuso, mancanze graduali), difficilmente la polizza lo copre, in quanto richiede evidenza di un evento specifico. Alcune polizze coprono il “mistery disappearance” fino a un tot, ma costano. È importante per l’azienda leggere bene le condizioni: spesso c’è obbligo di denuncia alle autorità entro X ore per validità copertura. Dal lato opposto, se l’assicurazione paga, subentra nei diritti verso eventuali responsabili (es. se dipendente infedele rubò, l’assicurazione può surrogarsi e agire contro di lui).
Franchising – Nei contratti di franchising retail, il franchisor può imporre standard di inventario. Se un franchisee ha differenze elevate, potrebbe violare gli standard contrattuali (spesso i franchisor pretendono accuratezza di gestione stock) e ciò può portare a penali o, se grave, risoluzione del contratto. Ad esempio, McDonald’s richiede differenze di cassa/magazzino entro limiti, se costanti violazioni, può recedere. In tali dispute, il franchisee potrebbe difendersi dicendo che il sistema informatico fornito dal franchisor era fallace ecc. Sono questioni contrattuali complesse, ma mostrano come differenze inventariali possano avere impatto su relazioni commerciali continuative.
Conclusione (civile) – Dal punto di vista civilistico, difendersi dalle contestazioni su differenze inventariali implica: per l’amministratore dimostrare di aver agito diligentemente (documentazione di controlli, misure, etc.); per il dipendente evitare di assumersi responsabilità oltre le proprie mansioni e, se accusato ingiustamente, impugnare eventuali sanzioni o trattenute; per gli operatori logistici curare la contrattualistica (limitare per iscritto la responsabilità, definire procedure di verifica) e mantenere standard di custodia elevati; per l’azienda assicurata seguire le procedure di denuncia per non invalidare la copertura.
Spesso, le contestazioni civili si risolvono con transazioni: es. il magazziniere infedele licenziato paga una parte del valore pur di evitare denuncia; il depositario rimborsa metà del danno riconoscendo qualche negligenza ma non tutte. Il conteggio preciso di cosa manca, quando e perché è fondamentale: ecco perché investire in un sistema ERP di gestione magazzino, con tracciamenti, può fare la differenza non solo nel prevenire ammanchi ma anche nel risolvere pacificamente dispute (dati oggettivi invece di accuse generiche).
Parte VI – Strategie difensive e modelli pratici
In questa parte forniamo strumenti operativi: schemi riassuntivi, modelli di atti difensivi e check-list di azioni da compiere in caso di contestazioni per differenze inventariali. L’obiettivo è aiutare concretamente chi si trova ad affrontare tali problemi, offrendo spunti su come organizzare la propria difesa e prevenire situazioni sfavorevoli.
Schema riepilogativo per ambito di contestazione
| Ambito | Chi contesta (controparte) | Norme principali | Conseguenze/Rischi | Strumenti di difesa |
|---|---|---|---|---|
| Tributario (Fisco) | Agenzia Entrate / GdF (verifica fiscale) | D.P.R. 441/1997 (presunzioni cessione/acquisto);<br>Art.39 c.1 lett.d D.P.R.600/73 (accert. induttivo);<br>D.Lgs. 471/1997 (sanzioni trib.) | Accertamento maggiori imposte (IVA, IRES/IRPEF);<br>Sanzioni 90%-180% imposta evasa; <br>Iscrizione a ruolo importi | – Prova contraria di perdita, furto, uso produzione (denunce, verbali) ;<br>– Osservazioni entro 60gg da PVC (Statuto contrib.) ;<br>– Ricorso CGT entro 60gg (contestando presupposti presunzione);<br>– Accertamento con adesione (riduz. sanzioni) |
| Penale-Tributario | Procura della Repubblica (tribunale penale) | D.Lgs. 74/2000 (reati tributari: art.4 infedele, art.3 fraudolenta, art.10 occultamento scritture, ecc.);<br>C.P.P. (procedura penale) | Processo penale; <br>Pene detentive fino a 8 anni (dich.fraud.);<br>Sequestri preventivi beni per equivalente; | – Dimostrare mancanza di dolo (es. errore contabile in buona fede);<br>– Dimostrare importi evasi sotto soglie (per escludere reato);<br>– Utilizzare perizie tecnico-contabili a discarico;<br>– Pagamento integrale tributi (possibile causa di non punibilità attenuata) |
| Doganale (mancanza merci in deposito) | Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) | Codice Doganale UE 952/2013 (artt.79-80, 124);<br>D.P.R. 43/1973 (TULD) art.303; | Recupero dazi + IVA importazione su merce mancante;<br>Sanzione amm.va proporzionale (103€ fino a 10 volte dazi) ;<br>Eventuale sospensione autorizzazioni deposito | – Prova di caso fortuito/forza maggiore per perdita (es. furto con scasso, incendio) per esonero dazi ;<br>– Documentare eventuali errori contabili (merce in realtà regolarizzata altrove);<br>– Contestare entità sanzione per eccesso (principio proporzionalità) ;<br>– Rateizzare tributi evasi, chiedere sospensione sanzioni in attesa giudizio CGT |
| Civilistico – Societario | Società (azione di resp.), soci o curatore fallimentare | Artt. 2392, 2476 c.c. (responsabilità amm.);<br>Artt. 2486-2487 c.c. (gestione liquidat.);<br>L.F. art.146 (azione del curatore) | Azione risarcitoria contro amministratori o liquidatori per danno patrimoniale (buco di magazzino);<br>In fallimento: bancarotta, ma sul civile richiesta danni al patrimonio; | – Provare di aver adottato controlli adeguati (assenza colpa grave);<br>– Dimostrare che l’ammanco era imprevedibile/non evitabile anche con diligenza normale;<br>– Se già approvato bilancio con perdita merci, soci potrebbero aver rinunciato a far causa (tacito discarico);<br>– Polizza D&O a copertura (in fase di esecuzione eventuale sentenza) |
| Civilistico – Dipendenti | Datore di lavoro (contestazione disciplinare) | Artt. 2104-2106 c.c. (diligenza e sanzioni);<br>Statuto Lavoratori; CCNL di settore | Sanzioni disciplinari (richiamo, multa, sospensione, licenziamento) per negligenza o furto;<br>Richiesta danni in sede civile (raramente, se importi alti e dolo) | – Impugnare sanzioni ingiustificate (es. se datore prova solo differenza ma non colpa specifica);<br>– Non firmare accordi di addebito senza consulenza (alcune aziende chiedono lettere di responsabilità: farle definire chiaramente limiti colpa grave);<br>– Collaborare nell’indagine interna per individuare cause (dimostra buona fede);<br>– Se accusato ingiustamente di furto: raccolta testimonianze, eventuale querela per diffamazione se nome leso |
| Contrattuale – Deposito | Azienda proprietaria merci vs. depositario (causa civile) | Artt. 1766 ss. c.c. (deposito);<br>Contratto di deposito/logistica | Richiesta risarcimento valore beni mancanti;<br>Trattenuta su corrispettivo dovuto al depositario (se previsto) | – Verificare clausole limitative nel contratto (franchigie, casi esclusione resp.);<br>– Provare caso fortuito (es. furto con scasso, evento naturale);<br>– Contestare eventualmente inventario iniziale (se non concordato, magari merce mai consegnata);<br>– Offrire conciliazione equa (es. rimborso parziale) per mantenere rapporto commerciale |
| Contrattuale – Assicurazione | Compagnia assicurativa (eventuale diniego indennizzo) | Polizza assicurativa furto/incendio: condizioni generali e speciali; Cod. Civ. 1892 ss. | Rifiuto dell’indennizzo se non rispettate clausole (es. mancata denuncia tempestiva, misure sicurezza non attuate, ecc.);<br>Possibile rivalsa assicuratore su terzi responsabili dopo indennizzo | – Verificare di aver adempiuto a obblighi polizza (denuncia entro termini, allarme funzionante, etc.) e in caso negativo negoziare con assicuratore (talvolta transigono pagando parziale);<br>– Se assicuratore nega indebitamente, attivare arbitrato/perizia contrattuale se prevista o causa civile portando prove che le condizioni erano rispettate; |
(Legenda: CGT = Corte Giustizia Tributaria; D&O = Directors & Officers insurance)
Modelli difensivi precompilati
Di seguito proponiamo alcuni fac-simile semplificati di documenti che potrebbero essere utili in fase di difesa. Nota bene: sono modelli generici da adattare al caso concreto, con l’ausilio di un professionista legale. Vanno personalizzati inserendo dati reali, riferimenti precisi e allegati documentali.
1. Memoria difensiva al Fisco (entro 60 gg da PVC Guardia di Finanza) – da inviarsi a mezzo PEC all’ufficio accertatore:
**Oggetto:** Osservazioni e richieste ex art.12 c.7 L.212/2000 – PVC Guardia di Finanza del __/__/____ presso **XYZ Srl**
Egregio Direttore,
in qualità di legale rappresentante di *XYZ Srl* (P.IVA …), con riferimento al Processo Verbale di Constatazione in oggetto notificato in data __/__/____, si formulano le seguenti osservazioni difensive prima dell’emissione dell’eventuale avviso di accertamento.
**1. Sintesi della contestazione nel PVC:** Il PVC rileva presunte **differenze inventariali** per l’anno d’imposta ____: in particolare un ammanco di magazzino per €______ (beni mancanti) e un’eccedenza per €______ (beni in più), con applicazione della presunzione di cessione/acquisto ex D.P.R. 441/97. Si contesta così l’omessa fatturazione di ricavi per €____ e l’IVA relativa di €____.
**2. Rilievi in fatto – cause delle differenze:** Le differenze riscontrate sono riconducibili a eventi documentati e indipendenti dalla volontà della società:
– €______ di merci mancanti (settore: ____) sono dovuti a **furti comprovati**. Si allegano n.__ denunce presentate all’Autorità di P.S. tra cui la Denuncia n.__ del __/__/____ relativa a [descrizione merce] dal valore di €____ . Tali furti sono avvenuti nonostante adeguate misure di sicurezza, come da rapporti della vigilanza allegati.
– €______ di merci distrutte (es. prodotti alimentari scaduti il __/__/____) **non erano più vendibili** e sono state eliminate secondo prassi. In data __/__/____ è stato redatto verbale di distruzione alla presenza di [funzionario comunale/notaio], comunicato via PEC all’AdE (Prot. n.__, all. copia). Si evidenzia che trattasi di beni di modesto valore unitario, il cui smaltimento urgente era necessario per motivi igienico-sanitari.
– L’**eccedenza** riscontrata di €____ (n. __ pezzi di ____ trovati in più) è frutto di un **errore di registrazione**: detti beni, infatti, risultano da regolare fattura d’acquisto (All. 3, Fatt. n.__ del __/__/____) ma per mero disguido non erano stati caricati a magazzino. Di ciò si è immediatamente informata la pattuglia verbalizzante in sede di inventario (v. dichiarazione a pag.__ del PVC).
**3. Profili giuridici:**
– **Inapplicabilità presunzione legale:** Si rileva preliminarmente che XYZ Srl **non è soggetta all’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino** (ricavi €___, sotto soglia ex art.14 DPR 600/73). Le differenze sono state desunte da documenti interni non obbligatori (schede di stock): pertanto, ai sensi della Cass. civ. 198/2025, **non opera la presunzione legale di cessione** di cui al DPR 441/97 . L’Ufficio potrà eventualmente procedere con valutazione induttiva semplice, ma in tale sede si dovrà tener conto di tutti gli elementi probatori a favore del contribuente.
– **Prova contraria fornita:** In ogni caso, anche volendo applicare la presunzione, la società ha tempestivamente fornito **prova contraria vincolata** ai sensi degli artt.1-2 DPR 441/97. I furti subiti rientrano nella casistica di beni “perduti per eventi dipendenti da cause non imputabili” al contribuente: la giurisprudenza tributaria riconosce che la denuncia all’autorità di P.S. costituisce mezzo idoneo a superare la presunzione (ex multis Cass. 15966/2024: “la presunzione di ricavi in nero basata sulle differenze di magazzino è superabile dalla prova contraria del contribuente” ). Tali denunce – effettuate entro 48 ore dalla scoperta – comprovano che XYZ Srl non ha venduto di nascosto la merce, bensì ne è rimasta vittima di reato.
– **Quantificazione errata:** Si evidenzia che il PVC non ha compensato differenze negative e positive. In particolare, l’eccedenza di €____ avrebbe dovuto quantomeno ridurre l’asserito occultamento di ricavi (trattandosi di acquisti non contabilizzati che generano costi non dedotti, la cui conseguenza reddituale andava considerata). Ignorando ciò, l’accertamento prospettato risulta sovrastimato e non aderente al principio di capacità contributiva reale. La Cassazione ha ritenuto che elementi come l’esiguità percentuale dell’ammanco e la plausibile origine accidentale possano e debbano essere valutati quali prove contrarie dal giudice, evitando applicazioni automatiche della presunzione . Nel caso in esame, l’ammanco netto (al netto di cause giustificate) risulta inferiore allo 0,5% del venduto – parametro pienamente fisiologico nel settore (All. 4: studio di settore che indica cali medi 1-2%). Ciò conferma l’assenza di evasione sistematica.
**4. Richieste:** Alla luce di quanto sopra, *XYZ Srl* **chiede** che l’Ufficio:
– Voglia procedere all’archiviazione delle contestazioni relative alle differenze inventariali per l’anno ____ in oggetto, riconoscendo la validità della prova contraria fornita e l’assenza di ricavi non dichiarati.
– In subordine, riduca la pretesa nei limiti del solo importo non giustificato di €____ (eventualmente valutando l’opportunità di accertamento con adesione, già sin d’ora richiesto ai sensi di legge qualora residuassero imponibili).
– Si invita inoltre l’Ufficio a un contraddittorio orale: *XYZ Srl* si rende disponibile fin d’ora a illustrare di persona la documentazione prodotta e ogni ulteriore elemento possa occorrere.
Si allega la seguente documentazione probatoria:
1. Copia denuncia di furto n.__/____ Sporta c/o Questura di __ in data __/__/____ con elenco beni sottratti.
2. Verbale aziendale di distruzione merce del __/__/____ (autenticato dal funzionario comunale Dott.__).
3. Fattura di acquisto n.__ del __ (riferita alle merci trovate come “eccedenza”).
4. Studio/ricerca di settore su percentuali di differenze inventariali GDO.
5. [Altri documenti, foto, perizie…]
Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti.
Luogo, Data
**Firma**
Questo modello mette in fila i fatti, cita normative e sentenze rilevanti a supporto , e formula chiaramente cosa si vuole dall’ufficio (archiviazione o almeno riduzione). È importante il tono collaborativo ma fermo nel rivendicare i propri diritti.
2. Fac-simile di ricorso tributario (intro) – Qualora l’accertamento venga emesso, il ricorso da presentare alla Corte di Giustizia Tributaria competente potrebbe avere in apertura una struttura tipo:
**RICORSO**
dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di [Provincia]
Ricorrente: *XYZ Srl*, C.F./P.IVA…, con sede in…, in persona del legale rappr. pro tempore Sig. …, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. … (CF …) in…, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;
Contro
Resistente: *Agenzia delle Entrate, Ufficio di …*, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato ex lege in …;
**Avverso** l’Avviso di Accertamento n. … notificato in data … relativo all’anno d’imposta …, con il quale si recuperano IVA e IRAP per €… e si irrogano sanzioni per €… a titolo di vendite non fatturate derivanti da differenze inventariali.
**Fatti e svolgimento del procedimento:** (breve riassunto PV, memorie, emissione avviso)
… omissis …
**Motivi di ricorso:**
1. **Violazione di legge – Inapplicabilità della presunzione di cessione (DPR 441/97) a soggetto non obbligato a scritture di magazzino.** L’atto impugnato si fonda interamente sulla presunzione legale ex DPR 441/97 per differenze rilevate da scritture di magazzino. Tuttavia, parte ricorrente non rientra tra i soggetti di cui all’art.1 co.2 DPR 441/97 (trattandosi di piccola impresa commerciale con ricavi inferiori ai limiti di legge). Pertanto la pretesa viola detta normativa, come interpretata dalla recente giurisprudenza (Cass. 198/2025) che esclude l’operatività automatica della presunzione in tali casi . L’accertamento avrebbe dovuto semmai essere supportato da presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, qui inesistenti o comunque non evidenziati dall’Ufficio.
2. **Travisamento dei fatti – Esistenza di prova contraria ignorata (artt.1-2 DPR 441/97).** L’Ufficio ha omesso di valutare le giustificazioni fornite in sede precontenziosa: a) furti documentati della merce mancante (denunce allegate in fase amministrativa, che si riproducono), b) cali tecnico-produttivi sui beni X, c) errata registrazione di beni poi risultati “eccedenze”. Tali elementi – che qui si ribadiscono e comprovano – integrano prova contraria sufficiente a superare la presunzione, in base alla normativa citata e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15966/2024) . L’atto impugnato è pertanto illegittimo per difetto di motivazione e violazione dell’art.7 L.212/2000, avendo l’ufficio disatteso senza spiegazione le osservazioni presentate.
3. **In subordine, eccesso di potere per illogicità manifesta – Quantificazione errata e contraddittoria.** L’AE ha considerato solo le differenze negative, omettendo le positive, assumendo perciò che l’intero ammanco fosse stato venduto senza fattura, ma che l’eccedenza di altro prodotto non rilevasse. Ciò è contraddittorio: se merce aggiuntiva è presente, significa che costi non dedotti sono stati sostenuti, che avrebbero semmai ridotto il reddito evaso. Inoltre l’importo dell’asserita evasione (€…, pari al …% del fatturato) è del tutto implausibile per l’azienda, contrastando con indici di settore (All. …). L’atto risulta dunque viziato anche nel quantum ed emendabile ex art.36 D.Lgs.546/92. …
**Richiesta:** si chiede dunque a codesta Ill.ma Corte di:
– In via principale, annullare l’avviso impugnato per i motivi esposti;
– In via subordinata, ridurre la pretesa fiscale nell’importo ritenuto di giustizia, con eliminazione/riduzione delle sanzioni;
– Con vittoria di spese del giudizio.
Si offrono in comunicazione, e si insiste per l’esibizione/ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., i seguenti documenti: … (lista documenti, incluse denunce, verbali, perizie).
(Segue poi la procura alle liti e la relata di notifica del ricorso.)
Questo schema mostra come impostare i motivi di ricorso, che riprendono in sostanza le linee difensive già discusse (violazione di legge, difetto di motivazione, ecc.), con citazione di norme e Cassazione .
3. Lettera di contestazione verso depositario – Un esempio di lettera che un’azienda potrebbe inviare al proprio depositario logistico dopo aver riscontrato differenze:
Oggetto: Contestazione ammanchi di magazzino rispetto all’inventario – Richiesta di chiarimenti e risarcimento
Egr. Sig. __ (legale rappresentante di [Depositi Logistici] Srl),
a seguito dell’inventario annuale al 31/12/2024 presso il Vs. magazzino di ____, la nostra società [Committente] S.p.A. ha rilevato significative differenze nelle giacenze affidateVi in custodia. In particolare risultano mancanti n. 120 unità del prodotto codice SKU 548X (“Tablet Alpha”) e n. 75 unità del prodotto codice SKU 66Y (“Laptop Beta”), per un valore complessivo di €45.000. Tali ammanchi, confermati dal Vs. responsabile di magazzino in data 05/01/2025, non risultano giustificati da regolari documenti di uscita o consegna.
Ai sensi del contratto di deposito logistico in essere e degli artt.1766 ss. c.c., Vi riteniamo responsabili della perdita di suddette merci. Non risultano infatti circostanze di forza maggiore idonee a spiegare la sottrazione: dai verbali di sicurezza non emergono effrazioni o intrusioni nel periodo considerato. Inoltre, come da Vostre comunicazioni precedenti, l’ultimo episodio di furto segnalatoci risale al 2022 e riguardava beni diversi. Pertanto, in mancanza di elementi contrari, l’ammanco pare imputabile a una Vostra carente custodia o a fatti dei Vostri dipendenti/collaboratori.
Con la presente Vi **intimiamo** di fornire entro 15 giorni dettagliata spiegazione per iscritto dell’accaduto e di comunicarci le iniziative intraprese (es: indagine interna, denunce). In difetto di riscontri soddisfacenti, ci vedremo costretti a formalizzare una richiesta di **risarcimento danni** pari al valore della merce mancante (€45.000) ai sensi dell’art.7 del contratto (Penale per ammanchi) e art.1780 c.c.
Resta salva ogni nostra ulteriore azione a tutela (compresa la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento). Ci auguriamo vogliate attivarVi prontamente per risolvere la questione, anche attivando la Vs. polizza assicurativa se esistente.
Distinti saluti,
[Committente] S.p.A.
Tale lettera serve a “mettere in mora” il depositario e preparare il terreno a un’eventuale causa. Spesso già questo stimola una risposta: il depositario potrebbe replicare ad esempio che effettivamente c’è stato un furto non comunicato o proporre una transazione (es. rimborsare la metà del danno, in base a clausole limitative).
4. Check-list prevenzione e gestione differenze inventariali (per imprese)
- Controlli periodici: Eseguire inventari fisici a intervalli regolari (almeno annuali, meglio se a rotazione ciclica trimestrale su articoli critici). Ciò aiuta a individuare sul nascere eventuali differenze e a circoscriverne le cause temporalmente .
- Documentazione immediata: Ogni volta che si riscontra un ammanco significativo, documentarlo subito. Per furti: sporgere denuncia alle autorità entro 48 ore, allegando elenco dettagliato beni e valore . Per merce danneggiata/distrutta: redigere un verbale con foto, preferibilmente con presenza di un perito terzo o pubblico ufficiale (specie se valore alto), e inviare comunicazione formale all’AdE se richiesto (es. distruzioni programmate).
- Registro delle differenze: Tenere un registro interno delle “differenze inventariali” con causali (furto, scarto, errore, ecc.), utile sia per gestione interna sia come prova da esibire al Fisco per mostrare che il fenomeno è monitorato e trasparente.
- Polizze assicurative: Valutare una copertura assicurativa furto/danni per il magazzino. In caso di sinistro, l’indennizzo vi aiuterà anche a livello fiscale (perché dimostra che il fatto è reale: l’assicuratore ha pagato, quindi la merce è andata persa non venduta). Assicurarsi però di rispettare i termini di polizza (denunce, sistemi antifurto funzionanti, etc.).
- Clausole contrattuali con depositari/vettori: Se vi affidate a logistica esterna o corrieri, inserire contrattualmente obblighi di inventario congiunto e previsione di responsabilità per ammanchi oltre margini concordati. In caso di contestazioni, attivatevi subito con il partner: spesso hanno anche loro assicurazioni per queste evenienze.
- Formazione del personale: I dipendenti vanno sensibilizzati sull’importanza di registrare correttamente carichi/scarichi di magazzino e segnalare tempestivamente errori. I cassieri vanno formati per evitare errori nei resti. Una cultura della precisione riduce gli errori umani (causa notevole di differenze) .
- Sistemi antitaccheggio e vigilanza: Nel retail, investire in barriere antitaccheggio, videosorveglianza e personale di controllo riduce i furti esterni (principale causa di differenze note in GDO) . Nel settore logistico, controlli in ingresso/uscita del personale (borse, metal detector) mitigano furti interni.
- Analisi dati e KPI: Monitorare come KPI aziendale il “shrinkage” (% di differenze su vendite). Se sale oltre la media di settore, indagare subito cause (potrebbe indicare un fenomeno anomalo, es. appropriazioni).
- Contraddittorio con il Fisco: In sede di verifica fiscale, esercitare attivamente i propri diritti: chiedere copia dei documenti esaminati, firmare con riserva i verbali se in disaccordo, far inserire dichiarazioni a vostro favore nel PVC (ad esempio “l’azienda dichiara che l’ammanco rientra nei cali tecnici del 1% noti in letteratura”). Questo vi tornerà utile in seguito per argomentare.
- Assistenza professionale tempestiva: Appena emerge una contestazione o un rilievo, consultare un tributarista o legale esperto. Ad esempio, prima di rispondere ad un questionario dell’AdE su differenze di magazzino, è bene farsi assistere per calibrare le risposte (che saranno prove in caso di lite). Anche per gestire l’eventuale accesso a strumenti come l’adesione o la conciliazione, il supporto tecnico è decisivo per ottenere il miglior risultato.
Seguendo queste best-practices, un’azienda può ridurre la probabilità di contestazioni e, se comunque avvengono, farsi trovare preparata con un dossier difensivo già pronto da esibire.
Esempi pratici (simulazioni)
Per rendere concreti i principi esposti, presentiamo brevemente alcune simulazioni ispirate a casi reali, con indicazione di possibili sviluppi:
Caso 1: “GDO e taccheggio diffuso” – Supermarket Srl opera 5 punti vendita. Nel 2024 registra un ammanco complessivo di €100.000 su un fatturato di €7 milioni (≈1,4%). L’80% dell’ammanco è dovuto a furti (soprattutto liquori, formaggi, cosmetici), il resto a scadenze e rotture. L’azienda ha presentato circa 50 denunce di furto durante l’anno e verbali di distruzione merce scaduta per €10.000. A febbraio 2025 la GdF fa un controllo e contesta l’ammanco come vendite in nero. Supermarket Srl produce immediatamente copia di tutte le denunce e verbali. La GdF inizialmente eccepisce che “non tutte le denunce coprono tutto il valore mancante e che alcune sono contro ignoti”. L’azienda fa notare che il fenomeno è fisiologico nel settore GDO (allega studio Checkpoint che indica 1,38% media nazionale) . Nel PVC finale la GdF, persuasa, riduce la contestazione concentrandosi su una parte (€20.000) di ammanchi ritenuti non giustificati (forse per differenze inventariali minime non coperte da denuncia specifica). L’ufficio AE, recependo il PVC, emette avviso solo su quel segmento (€20k). In sede di adesione, l’azienda ottiene ulteriore sconto riconoscendo che €5k erano forse errori non documentati, chiudendo con adesione su €15k di ricavi (sanzione ridotta 1/3). Lezione: documentare il più possibile ogni fetta di differenza paga; la parte non documentata comunque è stata confinata e negoziata.
Caso 2: “Azienda industriale e sfridi di produzione” – MetalProd SPA produce bulloneria. La contabilità di magazzino nel 2023 risulta confusa perché non hanno tenuto il registro di magazzino (non obbligatorio) e hanno valorizzato a bilancio rimanenze materie prime €500k, ma inventariando nel 2024 risultavano solo €300k: un ammanco di €200k di acciaio. L’AE accerta ricavi non dichiarati per vendita di acciaio. In realtà quell’acciaio mancante è diventato scarto di lavorazione (trucioli e sfridi non più utilizzabili) e in parte bulloni (ma con calo peso). L’azienda in contenzioso porta perizia tecnica: per produrre X bulloni è fisiologico perdere il 5% del peso in trucioli. In primo grado la CGT accoglie il ricorso riconoscendo che gli sfridi spiegano €150k di differenza, restando solo €50k contestabili. L’AE appella, ma nel frattempo esce Cass. 18073/2016 che avalla considerare i cali tecnici . La CTR conferma l’annullamento per €150k e tassa €50k. Entrambi fanno ricorso in Cassazione; la Cassazione nel 2025 rigetta il ricorso AE citando la propria giurisprudenza (l’ufficio deve considerare i cali naturali) e rinvia su €50k per difetto motivazione (da riesaminare se anche quei €50k potevano essere sfrido). Lezione: in settori industriali, quantificare e spiegare tecnicamente gli sfridi convince giudici e Cassazione tende a dare ragione se l’ufficio è stato troppo rigido.
Caso 3: “Differenze in deposito IVA e dogana” – ImportX spa mantiene un deposito IVA per componenti elettronici importati. Nel 2024 dall’inventario emergono 100 componenti in meno rispetto alle entrate dichiarate. ADM e AE fanno accertamento congiunto: ADM chiede dazi 0 (beni hi-tech esenti) ma IVA import €5.000 + sanz. art.303 TULD €6.000; AE chiede sanzione 30% per estrazione non documentata €1.500. ImportX scopre che in realtà quei 100 pezzi erano stati inviati in conto visione a un cliente UE e regolarmente fatturati senza addebito IVA (essendo cessione intraUE) ma per errore non scaricati dal registro deposito. Quindi nessuna evasione in realtà: produce CMR di trasporto e fattura EU. ADM annulla il suo atto (riconoscendo trattarsi di cessione intraUE, quindi merce uscita regolarmente dal deposito sia pur con formalità incomplete). AE però insiste perché formalmente l’estrazione andava comunicata. In giudizio, la CGT annulla anche la sanzione AE per insussistenza di intento evasivo e ottemperanza sostanziale (principio di neutralità IVA). Lezione: tenere allineati registri depositi con movimentazioni reali è cruciale; tuttavia, se c’è prova che la merce non è finita nel mercato nero interno, alla fine la pretesa decade.
Caso 4: “Responsabilità del direttore di negozio” – Moda Srl gestisce boutique e contrattualmente i direttori di negozio hanno un bonus legato anche alla tenuta delle differenze inventariali entro lo 0,5% del venduto. Nel 2024 in un negozio risulta l’1,5% mancante (per furti e qualche errore cassa). La società vorrebbe addebitare €10.000 di differenze al direttore decurtando il bonus. Il direttore si oppone, minacciando azione legale e portando prove di aver seguito procedure, e che la sicurezza (decisa dalla sede) era carente. L’azienda, consultato l’ufficio legale, capisce che un addebito unilaterale sarebbe illegittimo. Decide quindi di non erogare il bonus (che era discrezionale) ma non tocca lo stipendio fisso. Inoltre investe in migliori sistemi antitaccheggio per l’anno seguente. Lezione: sul lavoro conviene agire cautamente rispettando la legge, pena cause di lavoro perse; meglio incentivare i direttori a ridurre i furti con premi, piuttosto che punirli oltre i limiti contrattuali.
Ognuno di questi esempi riflette problemi comuni e soluzioni/tattiche diverse: non sempre si evita di pagare qualcosa, ma una buona difesa riduce di molto gli esborsi ingiusti e le sanzioni.
Parte VII – FAQ: Domande & Risposte frequenti
D1: Cosa si intende esattamente per “differenze inventariali”?
R: Sono gli ammanchi o gli esuberi di merce risultanti confrontando le giacenze contabili con quelle fisiche. In pratica, se facendo l’inventario conti meno pezzi di quanti dovresti avere (ammanco) o più pezzi (eccedenza). Si parla di differenze “negative” (mancanze) o “positive” (surplus). Indicano scostamenti dovuti a errori, furti, cali, ecc. È un fenomeno tipico in molti settori: ad es. nella GDO spesso a fine anno c’è un ammanco complessivo dell’1-2% del valore del venduto dovuto a taccheggi, errori di cassa e scarti . Le differenze inventariali vanno tenute sotto controllo perché, oltre a essere una perdita economica, hanno rilievo fiscale.
D2: Le differenze di magazzino possono far scattare un accertamento fiscale?
R: Sì. La normativa (DPR 441/97) prevede una presunzione legale per cui le merci acquistate/produite e poi sparite dal magazzino senza spiegazione si presumono vendute in nero (e quelle trovate in più si presumono acquistate in nero) . Quindi, se durante un controllo l’Agenzia Entrate o la Guardia di Finanza scoprono ammanchi significativi non giustificati, quasi certamente avvieranno un accertamento, chiedendo IVA e imposte sui ricavi non contabilizzati relativi a quei beni. Da notare che se l’impresa era obbligata a tenere il registro di magazzino e l’ammanco risulta lì, la presunzione è automatica; se invece non c’era obbligo (piccole imprese) la presunzione non è automatica ma comunque l’ufficio potrà usare la differenza come indizio e contestare ugualmente l’evasione con un accertamento induttivo . Quindi in pratica, un grosso ammanco può far scattare controlli in ogni caso.
D3: Come posso difendermi se il Fisco mi contesta ricavi non dichiarati basati su differenze inventariali?
R: Devi fornire una prova contraria convincente di cosa è successo a quei beni mancanti. Le vie principali: – Furto o smarrimento: esibisci la denuncia fatta ai carabinieri/polizia in cui hai denunciato il furto di quei beni . È il documento principe per contrastare la presunzione di cessione: dimostra che la merce non l’hai venduta, ti è stata rubata. Se l’ammanco è dovuto a piccoli taccheggi diffusi difficili da quantificare, mostra una serie di denunce ripetute di furti minori, e magari report della sicurezza o statistiche. – Distruzione/danneggiamento: produci verbali di distruzione, perizie su incidente (es. allagamento magazzino), foto prima/dopo, e comunicazioni eventualmente fatte all’AdE . Se è merce scaduta/eliminata, un atto notorio o verbale con testimoni dell’avvenuta distruzione è utile. – Uso in produzione: se i beni mancanti sono materie prime finite nei prodotti, dimostralo con le distinte base: “abbiamo usato 100 kg materia X per produrre Y, ecco il registro di produzione”. Ci fu un caso in cui mancava carburante dal magazzino, ma l’azienda provò che era stato consumato per far girare i macchinari e non venduto: accertamento annullato. – Errori contabili: può capitare che la differenza sia solo formale (merce spostata ma non registrata). In tal caso, cerca documenti alternativi: DDT di trasferimento, fatture d’acquisto/vendita erroneamente non registrate a magazzino, ecc., che spieghino la discrepanza. – Dimensione fisiologica: argomento sussidiario. Se non riesci a spiegare tutto, almeno evidenzia che la differenza è piccola rispetto al volume d’affari – quindi compatibile con normali fenomeni di settore – e che non hai motivo di fare vendite occulte per importi così modesti. Ci sono state sentenze che su ammanchi minimi hanno dato ragione al contribuente proprio valutando la modestia (ma attenzione, altre recenti dicono che comunque serve prova più formale) . In sintesi, devi convincere l’ufficio (o il giudice) che quei beni non hanno generato un ricavo per te, perché sono andati persi senza tuo utile. Ogni pezzo di carta, testimone, mail interna che lo attesti può servire. Fai valere anche errori procedurali dell’ufficio: ad es. se non ti hanno fatto contraddittorio o se la presunzione non era applicabile (vedi se eri sotto soglia registro magazzino) . In ultima analisi, se restasse qualcosa di non giustificato, prova a negoziare una riduzione sanzioni con adesione.
D4: Se ho subito un furto ma non ho fatto denuncia, posso farmi ascoltare lo stesso dal Fisco?
R: È più difficile, ma non impossibile. Formalmente la norma (art.2 DPR 441/97) richiede la denuncia alle autorità competenti per riconoscere il furto come causa di esclusione della presunzione . Se non l’hai fatta, l’ufficio potrebbe dire “merce rubata? Peccato, dovevi denunciarlo, ora la consideriamo venduta in nero”. Tuttavia, in sede di giudizio molti giudici valutano anche prove diverse: ad esempio testimonianze di dipendenti che confermano che c’erano effrazioni, oppure una lettera all’assicurazione per il furto (magari hai denunciato solo all’assicurazione). Ci sono state pronunce (Cass. n. 14885/2017 ad es.) che hanno chiarito che le procedure del DPR 441 non sono tassative al 100%, e il contribuente può dare prova anche con altri mezzi . Quindi non è persa in partenza: porta quante più evidenze puoi del furto (foto telecamere, allarme scattato, inventari subito dopo, ecc.). Certo, è un po’ in salita: senza denuncia ufficiale manca il pezzo principale. Per il futuro, conviene denunciare sempre: anche per motivi assicurativi e di sicurezza, oltre che fiscali.
D5: Qual è la % di ammanco “normale” accettata dal Fisco?
R: Non c’è una soglia di legge. In passato si pensava che “fino all’1-2% è fisiologico e l’AE chiude un occhio”, ma normativamente ogni ammanco può essere contestato, anche minimo . Alcune circolari interne (31/E/2006) parlavano di grandi distribuzione e lasciavano intendere un certo margine di tolleranza su differenze modeste, ma non è un diritto sancito. Se è proprio minimissimo (0,1%), spesso l’ufficio stesso rinuncia perché economicamente non vale lo sforzo e teme di perdere in giudizio per mancanza di “gravità” del dato. In Cassazione però nel 2024 hanno detto esplicitamente che anche differenze minime mantengono la presunzione legale e vanno giustificate . Quindi, non esiste un numero magico esente. Tuttavia, in concreto, per esperienza: ammanco sotto 1% quasi mai porta a rilievi pesanti se dai almeno qualche spiegazione; oltre 1-2% iniziano a insospettirsi. Oltre 5% certamente accertano. Nel doganale, c’è la soglia 5% nelle norme per far scattare le multe più severe , ma in ambito IVA/redditi no. Quindi meglio ragionare caso per caso e non affidarsi a soglie presunte.
D6: Ho un e-commerce e non faccio inventari fisici frequenti: rischio qualcosa?
R: Se vendi prodotti fisici, dovresti comunque tenere sotto controllo le giacenze. Anche un e-commerce può subire furti (nel magazzino) o errori di imballaggio (pezzi mancanti nelle spedizioni, etc.). Rischi soprattutto di accorgerti tardi di buchi e non avere elementi per giustificarli. Fiscalmente, se non sei obbligato a registro di magazzino, potresti pensare “allora sto tranquillo”: però se mai subisci un controllo (magari perché hanno sospetti da altri indizi, come margini incoerenti), possono farti un inventario a sorpresa e trovare differenze. Se ne saltano fuori tante e tu non hai documentazione storica (denunce, log interni) perché non controllavi, sarà arduo difendersi. Quindi il consiglio è: anche se la legge non ti impone inventari annuali, fai comunque un inventario fisico almeno a fine anno e registra eventuali differenze. Così potrai rilevare a bilancio una perdita su cali di magazzino, con delibera dell’organo amministrativo che ne spiega le cause (già questo aiuta come prova interna). Se l’e-commerce è piccolino magari le differenze sono minime. Se vendi migliaia di pezzi, controlla magari per campioni. Inoltre per e-commerce è importante curare le prove di consegna: a volte differenze percepite sono solo spedizioni smarrite dal corriere – se il corriere rimborsa o dichiara il furto del pacco, tu hai prova che non hai incassato il ricavo (o lo hai stornato al cliente). Documenta quindi ogni reso, ogni spedizione persa (così in verifica potrai dire “questi 50 pezzi risultano mancanti perché spediti ma non consegnati e rientrati come reso distrutto, ecco le pratiche”).
D7: Un accertamento basato su differenze inventariali può portare a reati penali?
R: Sì, se le cifre sono alte. Dal punto di vista penale tributario, se l’accertamento poi definito (o comunque le prove raccolte) evidenziano evasione di imposta oltre soglie, la Procura potrebbe procedere. Tipicamente: se i ricavi non dichiarati (dalle differenze) generano imposte evase > 100.000 € annui, c’è il reato di dichiarazione infedele; oppure se si dimostra che hai falsificato le scritture (tipo hai alterato gli inventari per nascondere il buco), potrebbe essere dichiarazione fraudolenta (mezzi fraudolenti). È accaduto per aziende medio-grandi: vedi caso Brand Loyalty, avevano “giocato” sulle rimanenze finali e sono stati accusati di frode contabile oltre che subire l’accertamento . Inoltre, se poi l’azienda fallisce, quelle differenze possono far accusare gli amministratori di bancarotta fraudolenta (aver distratto beni). Però attenzione: non è automatico. Servono elementi di dolo specifico. Un ammanco può anche non generare condanna penale se il dubbio rimane. Per esempio, se io imprenditore vengo denunciato per infedele dichiarazione perché secondo l’AE ho venduto in nero beni per 300k€, nel processo penale io posso difendermi dicendo “no guardate, me li hanno rubati, ho queste testimonianze” e se non c’è prova certa del contrario potrei essere assolto (mentre in sede fiscale magari ho perso). Quindi può scindersi: sul fiscale paghi, ma penalmente non colpevole. Insomma, il rischio penale c’è quando appare uno schema di frode organizzato. Se è mero “ammanco generico”, spesso il penale si chiude con archiviazione o proscioglimento perché non c’è prova oltre dubbio che tu abbia venduto davvero. In ogni caso, meglio non arrivarci: conviene persuadere il fisco già prima in modo da evitare denunce.
D8: In caso di verifica, i verificatori possono rovistare in magazzino e contare tutto? Devo aprire anche casse sigillate?
R: Sì, hanno ampi poteri. Possono accedere in locali dell’azienda, chiedere di visionare il magazzino e procedere a inventario fisico delle merci (specie la GdF lo fa spesso a fine verifica). Ti conviene collaborare: se opponessi resistenza o rifiuto, possono ipotizzare tu stia nascondendo qualcosa e ricorrere magari a perquisizioni con autorizzazione. Quindi mostrati trasparente. Certo, puoi far presente esigenze operative: es. se contare tutto richiede fermare la produzione, potete concordare un metodo a campione. In genere però, se decidono di contare, conteranno almeno gli articoli di maggior valore. Prepara in anticipo un elenco delle giacenze contabili al giorno della verifica, così da aiutarli a confrontare. Questo è anche un tuo strumento: se sai già di buchi, meglio dichiararlo subito e spiegare le cause piuttosto che farli scoprire dopo (dimostri buona fede). Se ci sono zone inaccessibili immediatamente (es. container sigillati), spiegalo. Loro possono chiedere di aprirli comunque. La presenza tua o di un tuo responsabile al fianco dei verificatori durante l’inventario è importante: controlla che non facciano errori di conteggio e firmate entrambi i risultati. Se poi dopo la verifica emergono errori (ti accorgi che hanno contato male o confuso codici), segnalalo subito con memoria. In sintesi: hanno diritto di ispezionare merci e locali (in orari di lavoro), tu diritto di assistere e controfirmare i verbali, e far mettere per iscritto eventuali tue dichiarazioni integrative (es “questo pallet dichiarato mancante in realtà contiene pezzi difettosi non contati come vendibili”).
D9: Ho scoperto un ammanco consistente nel mio magazzino; cosa devo fare prima, la denuncia o aggiustare la contabilità?
R: Prima la denuncia e gli adempimenti fiscali speciali (se previsti), poi le scritture. Mi spiego: se scopri oggi che mancano 100 unità di un prodotto, in teoria le scritture di magazzino vanno rettificate per avere un inventario reale. Ma non farlo “di nascosto”: prima metti nero su bianco il perché mancano. Esempio: ti accorgi che un dipendente ti ha rubato merce, vai subito dai carabinieri. Con la copia della denuncia in mano, poi fai l’scrittura contabile di scarico magazzino per ammanchi (spesso a fine esercizio si registrano come “costi per differenze inventariali”). Così, se un domani il fisco vede quella scrittura in contabilità, trova riferimento alla denuncia. Se invece “aggiusti” la contabilità senza pezze giustificative, poi quell’ammanco risulta registrato ma senza motivo noto: e in verifica potrebbero dire “hai scaricato magazzino, ma perché? Dov’è la prova della perdita?”. Quindi l’ordine corretto: (1) accertare bene cosa manca e quantificare; (2) se rilevante, sporgere denuncia o quantomeno fare verbale interno con testimoni; (3) comunicare all’Agenzia Entrate se necessario (distruzione programmata, etc.); (4) registrare in contabilità la rettifica (in prima nota e in magazzino). E parallelamente, (5) se c’è assicurazione, avvisare l’assicuratore (spesso lo devi fare entro 3 giorni). Se scopri l’ammanco durante la redazione del bilancio, coinvolgi il revisore (se l’hai) spiegando le cause: sarà più propenso ad accettare la scrittura di perdita se vede che hai elementi oggettivi.
D10: Posso portare in deduzione fiscale il costo delle differenze inventariali?
R: In linea di massima, sì, come rettifica delle rimanenze finali. Mi spiego: se hai merce che sparisce, quella merce l’avevi comprata (o prodotta), quindi il suo costo era nel tuo magazzino attivo. Se la togli dall’attivo (perché non c’è più), diventa un costo deducibile (perdita di esercizio). Non c’è una norma che lo vieti, a condizione che la perdita sia reale e inerente all’attività. Però devi fare attenzione: se il Fisco non crede alla perdita (pensa che hai venduto di nascosto), in sede di accertamento ti toglierà la deduzione di quel costo e anzi ti aggiungerà pure un ricavo. Quindi la deducibilità “resiste” solo se riesci a dimostrare la causa. Ad esempio, se nel bilancio metti “costi per differenze inventariali €50k” senza alcuna spiegazione, è un campanello d’allarme: l’AE potrebbe chiederti conto in sede di controllo. Se invece lo motivi (es. nel verbale di CDA allegato al bilancio, scrivi “si è riscontrato un ammanco a seguito di furti, per cui è stato fatto esposto alle autorità…”), allora quella perdita è fiscalmente deducibile come spese di gestione. In pratica, il costo c’è, ma devi essere pronto a giustificarlo. In caso di furto, oltre a denuncia, magari conserva anche eventuali rimborsi assicurativi: quelli saranno una sopravvenienza attiva (taxable) che compensa in parte il costo, ma danno prova del fatto. Se distruggi beni obsoleti, meglio avere autorizzazione ASL o simili (p.es. farmaci scaduti con verbale distruzione): così la perdita è deducibile. Riassumendo: sì, le differenze di magazzino sono deducibili come normale costo (componente negativo) qualora se ne dimostri la causa naturale; se invece per l’AE sono vendite occulte, non solo non le deducono, ma ci aggiungono pure margine. Dunque tutto torna alla prova. (Piccola nota IVA: se beni rubati, per l’IVA una volta c’era l’obbligo di autofattura, ora con DPR 441/97 se denunci non devi versare IVA su furto; se beni distrutti con autorizzazione, l’IVA non è dovuta. Altrimenti l’AE potrebbe chiederti anche l’IVA come se li avessi destinati a consumo personale).
D11: Ho un contenzioso in corso sulle differenze di magazzino: posso risolverlo con qualche definizione agevolata o devo aspettare le sentenze?
R: Dipende dalle normative vigenti. Nel 2023 c’erano varie definizioni agevolate (rinuncia ai giudizi pendenti col 90% imposte, stralcio sanzioni, ecc.). Sono misure straordinarie. Se ce n’è una attiva, valuta con il tuo consulente: ad esempio, se hai un ricorso in Cassazione solo per sanzioni, potresti definire pagando un forfait ridotto. In mancanza di tali sanatorie, puoi sempre tentare la conciliazione giudiziale: è uno strumento per chiudere la lite in ogni stato di grado con un accordo col fisco (di solito riduzione di sanzioni e magari taglio parziale imponibile). Spesso, su differenze inventariali, se arrivi in appello, l’ufficio potrebbe offrirti sconto sanzioni per chiudere lì. Devi valutare costi/benefici. Se sei convinto di avere ragione piena e importi alti, portala avanti; se la questione è incerta e hai già speso molto in spese legali, una conciliazione potrebbe darti pace pagando magari solo l’imposta (senza sanzioni). Inoltre considera il ravvedimento operoso: se la differenza è venuta fuori internamente e non ti hanno ancora controllato, potresti autodenunciarti all’AdE e integrare la dichiarazione pagando spontaneamente le imposte relative alle merci mancanti (se pensi che in realtà fossero vendute). Così eviti il reato e riduci le sanzioni (il ravvedimento su occultamento non è scontatissimo, ma se fai una dichiarazione integrativa e versi, almeno riduci rischi). È una mossa estrema che pochi fanno, però.
D12: In futuro, come posso prevenire contestazioni su differenze di magazzino?
R: Prevenzione è la parola chiave. Alcuni consigli finali: – Implementa un buon sistema di controllo inventariale interno: inventari a sorpresa, riconcilia contabilità con giacenze fisiche periodicamente, in modo da accorgerti subito di anomalie. – Documenta tutto: ogni anomalia deve avere un file dedicato (furto X, rottura Y) con prove. Così se arriva un controllo, hai già il faldone pronto da mostrare. – Addestra i tuoi: fai formazione ai magazzinieri e cassieri sull’importanza di segnalare qualsiasi differenza appena la notano (es. cassa a fine giornata sballata, magazzino scaffale vuoto inspiegabilmente, etc.). Meglio approfondire subito che scoprire mesi dopo. – Se hai punti vendita, fai in modo che facciano inventari di reparto regolari. Molte catene fanno conte parziali settimanali di articoli sensibili, proprio per isolare sul breve periodo eventuali furti. – Collabora con i revisori: se la tua società è soggetta a revisione, i revisori spesso fanno prove di inventario a campione. Non viverle come un fastidio ma come un test utile a te: se loro trovano differenze, ringraziali pure – ti danno modo di correggere prima che lo faccia il fisco. – Infine, tieni d’occhio la normativa: ad esempio, c’è un disegno di legge delega fiscale (2023) che potrebbe semplificare alcuni adempimenti o rivedere le presunzioni; oppure prassi come la circolare 19/E/2023 hanno aggiornato aspetti sul contraddittorio obbligatorio. Essere informati ti consente di giocare al meglio le tue carte in caso di verifica.
Parte VIII – Fonti e riferimenti normativi/giurisprudenziali
- D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, Regolamento per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, art. 1-4 (presunzioni di cessione/acquisto, prova contraria) .
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Istituzione e disciplina IVA, art.53 (testo previgente, sostituito da DPR 441/97) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.14, co.1 lett.d (obbligo di tenuta scritture ausiliarie di magazzino per imprese oltre soglie) ; art.39, co.1 lett.d (accertamento analitico-induttivo con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti) ; art.39, co.2 lett.d (accertamento induttivo puro per contabilità inattendibile) .
- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, Testo Unico Leggi Doganali (TULD), art.303 (sanzioni per dichiarazioni inesatte su quantità/qualità: multa base €103-516; scaglioni proporzionali oltre 5% differenza dazi) . (Testo modif. da DL 16/2012).
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del Contribuente, art.12, co.7 (diritto del contribuente a presentare osservazioni entro 60gg dal PVC prima che l’accertamento sia emesso) .
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art.6, co.8 (sanzione per mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura: applicata nel caso Brand Loyalty) .
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt.3-5 (dich. fraudolenta, omessa dichiarazione), art.4 (dich. infedele >100k imposta evasa) e art.10 (occultamento/distruzione scritture contabili), rilevanti in caso di differenze inventariali usate per evadere.
- Cass. civ. Sez. Trib. 30/10/2018, n. 27549: conferma operatività presunzioni di cessione/acquisto per differenze registrabili tra merci in magazzino e scritture di carico-scarico . Principio: le differenze inventariali tecnicamente sono fonte di presunzione di vendite/acquisti in nero, ma il contribuente può sovvertirla con qualsiasi mezzo di prova contraria .
- Cass. civ. Sez. Trib. 14/09/2016, n. 18073: ha ritenuto illegittimo l’accertamento basato su differenze inventariali quando l’Ufficio non considera cali naturali e sfridi . Presunzione superata se difetto di materia per cause tecniche.
- Cass. civ. Sez. Trib. 08/03/2017, n. 5995: su incompletezza delle scritture di magazzino e accertamento induttivo puro (contabilità inattendibile) .
- Cass. civ. Sez. V 25/01/2022, n. 2209 (ord.): ribadisce che la presunzione di cessione ex DPR 441/97 è norma sostanziale applicabile solo a soggetti obbligati alle scritture di magazzino; per altri, differenze restano indizi valutabili ex art.39 DPR 600/73 (richiamato in motivazione Cass. 198/2025) .
- Cass. civ. Sez. Trib. 07/01/2025, n. 198 (ord.): ha statuito che “La presunzione di cessione di cui al DPR 441/97 non opera per i soggetti non obbligati alle scritture ausiliarie di magazzino”, restando però applicabili le presunzioni semplici (art.39/600 e 54/633) . (Commentata in Eutekne, 8 gen 2025).
- Cass. civ. Sez. Trib. 07/06/2024, n. 15966: ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che la presunzione legale di ricavi in nero da differenze di magazzino è superabile con prova contraria . (In motivazione: onere ufficio considerare anche elementi di segno contrario, es. lievità ammanchi).
- Cass. civ. Sez. Trib. 12/07/2024, n. 19206: massima ufficiale cita che anche errori di conteggio non significativi “non esonerano il contribuente dalla prova contraria, con le modalità tassative artt.1-2 DPR 441/97, della legittima fuoriuscita/ingresso dei beni” . Caso Brand Loyalty: Cassazione ha dato torto al contribuente sul punto della “esiguità irrilevante”, enfatizzando l’obbligo di prova specifica.
- Cass. civ. Sez. Trib. 13/09/2023, n. 26484: su rimanenze iniziali/finali incongrue in bilancio, considerato artificio contabile evasivo . Conferma che sovrastimare rimanenze finali per occultare ricavi è un comportamento sanzionabile (presunzioni semplici gravi di sottofatturazione).
- Cass. civ. Sez. Trib. 08/01/2002, n. 2891: principio su onere del contribuente di attivarsi a dimostrare l’inaffidabilità degli indizi e confermare con altre presunzioni la validità del proprio operato . (Invocato in temi di ricostruzioni da magazzino).
- CTR Lombardia (Milano) 26/02/2016 n.1073/07/2016 (caso Brand Loyalty in appello): aveva annullato sanzioni ritenendo il valore delle differenze (1,32% su €21,6 mln produzione) non riconducibile ad evasione, conforme a circ.31/E/2006 . Ribaltata poi da Cass.19206/24.
- Circolare AE n.31/E del 2/10/2006: forniva indicazioni sulle differenze inventariali nella GDO, riconoscendo la fisiologicità del fenomeno e la possibilità per l’ufficio di valutare caso per caso (non una franchigia ufficiale ma un invito al buon senso) .
- Studio Giommoni (Euroconference 2019), “La gestione civilistica e fiscale delle differenze inventariali”, BVC 2/2019: analisi cause differenze (furti, errori, cali, scarti) e iter normativo DPR 441/97 (onere denunce, no soglia minima presunzione) .
- Crime&tech – Transcrime Report 2023, “La Sicurezza nel Retail in Italia 2023”: statistiche su differenze inventariali retail/GDO (1,38% fatturato medio 2022, costo 4,6 mld € merce persa + 2,1 mld € spese sicurezza = 6,7 mld €) ; cause (furti esterni ~48% casi noti, furti interni, scarti, errori) ; settori più colpiti (DIY 2,00%, GDO 1,98%).
- Eutekne.info, Rebecca Amato 8/1/2025, “Presunzione di cessione esclusa per i non obbligati alle scritture di magazzino” – commento Cass.198/2025 (non operatività presunzione legale per piccolo contribuente).
- Eutekne.info, 16/10/2018, “Accertamento da differenze inventariali bloccato dagli sfridi”: commento a Cass.18073/2016 (illegittimo accertamento se non considerati cali naturali produzione) .
- Informazione Fiscale, G. Palumbo 1/11/2023, “Rilevanza accertativa delle rimanenze” – analisi Cass.26484/2023 e principi su continuità delle rimanenze (art.92 TUIR) e su incompletezza inventari come base per induttivo puro .
- Il Sole 24 Ore (Telefisco), gen 2018: articolo citato da Studio Piersensini, evidenzia Cassazione su differenze minime come prova contraria valida e necessità di buon senso (sent. importante che “esclude automatismo presunzione legale in favore di valutazione caso concreto”) .
- Cass. pen. (varie): in tema di reati ex D.Lgs.74/2000 per frode mediante artifici contabili (inventari falsi) – es. Cass. pen. sez.III n.11933/2016, e Cass. sez. fer. n.35833/2019 su false rappresentazioni rimanenze come mezzi fraudolenti (concorso di reato tributario e falso in bilancio).
- Codice Civile: art. 2104 (diligenza lavoratore), art.2106 (sanzioni disciplinari proporzionate), art.2118 (divieto di pattuire penali su retribuzioni non dovute), rilevanti per eventuali addebiti a dipendenti; art. 2392 (responsabilità amministratori verso società per omessa diligenza), art. 1218 (responsabilità contrattuale depositario per custodia).
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestate differenze inventariali tra le giacenze dichiarate e quelle rilevate nei controlli? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestate differenze inventariali tra le giacenze dichiarate e quelle rilevate nei controlli?
Vuoi sapere cosa rischi e come predisporre una difesa efficace?
👉 Prima regola: dimostra che le differenze derivano da errori formali, cali fisiologici, resi o movimentazioni non ancora contabilizzate, e non da ricavi occultati.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Scostamenti tra inventari di magazzino e registrazioni contabili;
- Quantità di merce risultante inferiore a quella acquistata, presunta come venduta “in nero”;
- Mancata corrispondenza tra inventario fisico e contabilità ufficiale;
- Irregolarità nei carichi/scarichi di magazzino;
- Resi, scarti o cali naturali non documentati.
📌 Conseguenze della contestazione
- Recupero delle imposte sui presunti ricavi non dichiarati;
- Indeducibilità dei costi riferiti a merci non rintracciabili;
- Sanzioni fiscali per dichiarazione infedele;
- Interessi di mora sulle somme accertate;
- Possibili controlli incrociati con fornitori e clienti.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Le differenze inventariali sono reali o frutto di errori di registrazione?
- Esistono cali fisiologici riconosciuti (deperimenti, evaporazioni, deterioramenti)?
- Sono stati registrati correttamente resi e scarti di produzione?
- Gli inventari fisici sono stati redatti con criteri coerenti e documentabili?
- L’accertamento si fonda su verifiche oggettive o su presunzioni automatiche?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Registri di magazzino e inventari ufficiali;
- Fatture di acquisto e documenti di trasporto;
- Note di reso e registrazioni di scarti;
- Perizie tecniche sui cali fisiologici di magazzino;
- Dichiarazioni fiscali e bilanci degli anni contestati.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la correttezza della gestione inventariale con documentazione completa;
- Contestare la presunzione che ogni differenza equivalga a vendite in nero;
- Evidenziare cali fisiologici o perdite tecniche inevitabili;
- Eccepire errori procedurali o difetti di motivazione nell’accertamento;
- Richiedere l’annullamento in autotutela se le prove erano già agli atti;
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini previsti.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza gli inventari e i registri contabili;
📌 Valuta la fondatezza delle contestazioni e individua i margini difensivi;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta nei procedimenti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione sicura e trasparente del magazzino.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e accertamenti di magazzino;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni fiscali su differenze inventariali e ricavi presunti;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni per differenze inventariali non sempre sono fondate: spesso derivano da errori formali, cali fisiologici o movimentazioni non correttamente registrate.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la regolarità della gestione di magazzino, evitare che le differenze vengano riqualificate come ricavi occulti e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro le contestazioni fiscali da differenze inventariali inizia qui.