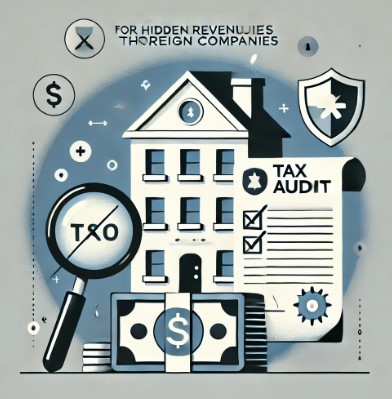Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per presunti ricavi occultati tramite società estere? In questi casi, l’Ufficio presume che società con sede all’estero siano utilizzate per deviare utili prodotti in Italia, al fine di ridurre la base imponibile nazionale. L’uso di società estere – soprattutto in Paesi a fiscalità privilegiata – è uno dei fenomeni più controllati dal Fisco italiano grazie allo scambio automatico di informazioni internazionali. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, sanzioni pesantissime e, nei casi più seri, contestazioni penali per esterovestizione o dichiarazione fraudolenta. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile ridurre le pretese del Fisco o dimostrare la legittimità delle operazioni.
Quando l’Agenzia delle Entrate presume ricavi occultati tramite società estere
– Se la società estera è ritenuta priva di autonomia gestionale e diretta dall’Italia
– Se i contratti di fornitura o consulenza con la società estera sono considerati fittizi
– Se i margini di profitto dichiarati all’estero risultano sproporzionati rispetto all’attività italiana
– Se i movimenti bancari non coincidono con i redditi dichiarati in Italia
– Se l’Ufficio presume l’esistenza di una stabile organizzazione occulta in Italia
Conseguenze della contestazione
– Tassazione integrale in Italia dei redditi ritenuti occultati
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Possibile disconoscimento dei benefici fiscali previsti da convenzioni internazionali
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele, esterovestizione o frode fiscale
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare la reale operatività e autonomia della società estera coinvolta
– Produrre contratti, bilanci, organigrammi, relazioni di attività e prove della gestione all’estero
– Contestare l’automatismo delle presunzioni se basate solo su parametri formali
– Evidenziare la corretta applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
– Richiedere la riqualificazione delle contestazioni per ridurre sanzioni e interessi
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per chiedere l’annullamento totale o parziale della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare i rapporti tra società italiana e società estera contestata
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta applicazione delle norme internazionali
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e giurisprudenza europea favorevole
– Difendere l’impresa e gli amministratori davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio aziendale e personale da richieste fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della legittimità delle operazioni internazionali
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: l’uso di società estere è uno degli ambiti più sorvegliati dal Fisco italiano. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata per evitare gravi conseguenze fiscali, penali e reputazionali.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscale internazionale – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale per ricavi occultati tramite società estere e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.
👉 Hai ricevuto una contestazione per presunti ricavi occultati tramite società estere? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la legittimità dell’accertamento e costruiremo la strategia difensiva più efficace per tutelare i tuoi interessi.
Introduzione
L’utilizzo di società estere per occultare ricavi rappresenta una delle strategie di evasione/elusione fiscale più complesse da accertare e, al contempo, più duramente contrastate dal Fisco italiano. In un mondo globalizzato, imprenditori e privati possono costituire società in paesi a fiscalità agevolata o con normative più “morbide” sperando di sottrarre parte dei redditi alla tassazione italiana. Tuttavia, gli strumenti normativi e investigativi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria si sono evoluti: oggi le autorità fiscali italiane possono contare su presunzioni legali, scambi di informazioni internazionali e sofisticate analisi, rendendo sempre più rischioso celare utili oltreconfine.
In questa guida, aggiornata a settembre 2025, esamineremo in dettaglio come difendersi da un accertamento fiscale in materia di ricavi occultati tramite società estere. Adotteremo un taglio avanzato – adatto a professionisti legali, imprenditori e contribuenti informati – ma con un linguaggio il più possibile chiaro. Il punto di vista è quello del contribuente (debitore) sotto verifica: illustreremo i suoi diritti, le strategie difensive e le ultime novità normative e giurisprudenziali (2024-2025) utili a far valere le proprie ragioni.
Anticipiamo che la materia intreccia normativa italiana (TUIR, DPR 600/1973, D.Lgs. 74/2000, Statuto del Contribuente) e principi internazionali (trattati contro le doppie imposizioni, diritto UE, standard OCSE). Si tratta di un terreno delicato, in cui il confine tra lecito risparmio d’imposta e condotta abusiva o fraudolenta è sottile. Saranno pertanto analizzati: i diversi scenari di ricavi esteri occultati (esterovestizione societaria, stabili organizzazioni occulte, ecc.), le presunzioni fiscali applicabili (es. presunzione di residenza, presunzione di distribuzione utili ai soci), le fasi dell’accertamento e relative tutele procedurali (contraddittorio endoprocedimentale, onere della prova, ecc.), gli strumenti deflativi (interpello, adesione) e il successivo contenzioso tributario, nonché i profili penali (reati tributari connessi) e la cooperazione internazionale. Il tutto sarà arricchito da tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni.
Importante: data la complessità e il continuo aggiornamento della materia, ogni difesa efficace deve basarsi su fatti documentati e su un solido riferimento a norme e precedenti giurisprudenziali. In fondo alla guida è riportata una raccolta delle fonti normative e delle sentenze più autorevoli e aggiornate citate nel testo, che costituiranno la base per evitare rischi di approcci improvvisati e per dimostrare la fondatezza delle proprie argomentazioni. L’obbiettivo è fornire uno strumento avanzato ma comprensibile per orientarsi e tutelarsi al meglio di fronte a un accertamento per ricavi esteri occulti.
Scenario: ricavi occultati tramite società estere e relativi rischi
Prima di entrare nelle difese, definiamo il fenomeno. L’esterovestizione societaria è il caso in cui una società risulta formalmente localizzata all’estero – spesso in un Paese a bassa fiscalità – ma viene di fatto gestita dall’Italia e qui svolge la sua attività sostanziale . In sostanza si apre una sede legale fuori dall’Italia (talora un semplice ufficio di comodo o una casella postale) mentre la direzione effettiva e l’operatività rimangono in Italia. Lo scopo tipico è risparmiare imposte: l’imprenditore conta su aliquote estere ridotte o sull’assenza di tassazione, schermando utili che altrimenti sarebbero tassati dal Fisco italiano.
Un esempio: un contribuente italiano costituisce una società in Svizzera o a Dubai e fa figurare lì i propri profitti o beni, beneficiando di imposte minime e magari di una maggiore segretezza bancaria. Se però la società estera manca di reale struttura operativa locale ed è amministrata dall’Italia, il Fisco la considererà una semplice società “schermo” e, ignorandone la veste estera, la tasserà come soggetto residente in Italia . L’esterovestizione si configura quindi come un’evasione fiscale internazionale (talora un abuso del diritto nei casi più borderline) contrastata con norme specifiche e presunzioni anti-elusive.
Un fenomeno analogo esiste anche per le persone fisiche: si parla di esterovestizione personale quando un contribuente dichiara di risiedere all’estero solo formalmente, mentre la sua vita e i suoi interessi economici restano in Italia . In tali casi l’Amministrazione finanziaria può contestare la residenza estera dichiarata e accertare invece la residenza fiscale in Italia, recuperando le imposte evase più sanzioni e interessi, ed eventualmente procedendo per reati tributari (omessa dichiarazione, infedele, ecc.). In questa guida ci concentreremo sulle società esterovestite, ma molti criteri difensivi sono analoghi per le persone fisiche che trasferiscono fittiziamente la residenza all’estero (ne tratteremo soprattutto nelle tabelle e FAQ).
Ricorrere a società estere per occultare ricavi comporta rischi elevati. In caso di accertamento, le conseguenze possono includere:
- Recupero di tutte le imposte evase in Italia sui redditi non dichiarati, con applicazione del principio del worldwide income (tassazione dell’ovunque prodotto) come se il contribuente fosse sempre stato residente in Italia . Ciò vale sia per società (IRES sugli utili globali, IVA sulle operazioni imponibili, IRAP se attività produttiva in Italia) sia per persone fisiche (IRPEF su tutti i redditi, mondiali) . Se sono state pagate imposte (seppur minime) all’estero, l’Italia riconoscerà un credito d’imposta convenzionale, ma spesso tale credito non copre l’intero divario, specie se il Paese estero aveva tassazione nulla o molto bassa .
- Sanzioni amministrative tributarie molto pesanti: tipicamente viene contestata l’omessa dichiarazione dei redditi esteri, punita con sanzione dal 120% al 240% dell’imposta evasa (minimo €250) . Se invece qualche dichiarazione in Italia vi era ma incompleta, si applicherebbe la sanzione per dichiarazione infedele (90%-180% della maggiore imposta) . A queste si aggiungono sanzioni per violazioni collegate: ad es. mancata compilazione del quadro RW (omessa dichiarazione di investimenti/attività estere) con multa dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (raddoppiata se il Paese è black-list) . Dal 2024, inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da €200 a €1.000 per ogni anno in cui l’AIRE non sia stato aggiornato dopo un espatrio (omessa iscrizione AIRE) . In sede di definizione accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale, tali sanzioni possono essere ridotte (spesso 1/3 in caso di adesione) , ma restano comunque cifre ingenti.
- Profili penali tributari: i casi gravi di esterovestizione si accompagnano spesso a reati tributari. Il reato tipico è l’omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 D.Lgs. 74/2000) quando i redditi della società estera non furono mai dichiarati in Italia e l’imposta evasa supera €50.000 annui . Questo reato è punito con la reclusione da 2 a 5 anni, e la Cassazione penale ha chiarito che l’amministratore di fatto italiano di una società estera fittizia risponde di omessa dichiarazione in Italia “per la società falsamente estera” . Potrebbero inoltre concorrere altri reati: la dichiarazione infedele (art. 4) se solo parte dei redditi era occultata , o addirittura la dichiarazione fraudolenta (art. 3, es. tramite uso di fatture false o doppi bilanci) se per realizzare l’esterovestizione si impiegano artifici documentali . Un ulteriore reato connesso è la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), che scatta quando, per evadere la riscossione di imposte dovute, si compiono atti fraudolenti sui propri beni (es. li si intestano a società estere o trust) rendendoli non aggredibili dal Fisco . Questo è punito con reclusione da 6 mesi a 4 anni. Ad esempio, trasferire beni personali a una società offshore al solo scopo di sottrarli al fisco può integrare l’art. 11, se i beni diventano realmente irraggiungibili. (La Cassazione ha però escluso il reato art.11 in un caso in cui il contribuente aveva conferito immobili in una propria società estera, mantenendone indirettamente la disponibilità: mancando un effettivo spossessamento, non c’era “fumus” di reato . Se invece i beni vengono distratti a terzi o prestanome, il reato sussiste eccome ). In genere, all’accertamento tributario segue la segnalazione alla Procura: è prassi l’emissione di sequestri preventivi per equivalente sui beni dell’indagato fino a concorrenza dell’imposta evasa – conti correnti, immobili, auto possono essere congelati a garanzia del credito erariale futuro.
- Altre conseguenze: danno reputazionale (un’azienda scoperta in uno schema di evasione internazionale perde affidabilità verso banche, partner e clienti, e la notizia può diffondersi sulla stampa), nonché stress finanziario e gestionale dovuto al contenzioso e alle eventuali misure cautelari. Inoltre, l’evasione di questo tipo espone la società o il contribuente a un periodo di accertabilità prolungato: se c’è omessa dichiarazione dei redditi esteri, il Fisco può emettere avvisi fino all’8° anno successivo a quello in cui la dichiarazione omessa andava presentata (ordinariamente sono 5 anni) . Ciò significa, ad esempio, che per redditi del 2018 (dichiarazione 2019) l’azione accertatrice scade al 31/12/2027. Ogni anno omesso apre quindi una “finestra” di possibile accertamento molto lunga, prorogabile di un ulteriore anno se c’è stato un PVC della Guardia di Finanza .
In sintesi, i rischi di un’accertata esterovestizione sono gravissimi: recupero di imposte arretrate (spesso per più anni), sanzioni che possono arrivare a importi pari o doppi rispetto all’imposta evasa, possibili condanne penali con sequestri patrimoniali, e danni permanenti all’attività economica e all’immagine . Questo contesto spiega l’atteggiamento severo del legislatore e dei verificatori, ma evidenzia anche l’importanza per il contribuente di predisporre una difesa accurata e tempestiva. Fortunatamente, come vedremo, se vi è reale sostanza economica all’estero e buona fede, è possibile difendersi ed evitare (o ridurre drasticamente) tali conseguenze . Nei prossimi capitoli analizzeremo dunque le novità normative degli anni 2024-2025 in questo ambito, le categorie di Paesi esteri rilevanti (black list, UE, Svizzera, Emirati, ecc.), le fasi e garanzie del procedimento di accertamento, e le strategie difensive a disposizione del contribuente.
Novità normative 2024-2025 e tendenze internazionali
Gli ultimi anni (2024-2025) hanno portato importanti novità normative in materia di fiscalità internazionale, residenza fiscale e cooperazione, che incidono sul fenomeno dei ricavi occultati tramite società estere. È fondamentale esserne consapevoli per modulare correttamente la difesa. Di seguito riepiloghiamo i punti salienti:
- Riforma fiscale 2023/2024 – Delega e decreti attuativi: la legge delega 9 agosto 2023 n.111 ha previsto la revisione di vari aspetti del sistema tributario, tra cui la fiscalità internazionale. In attuazione, è stato emanato il D.Lgs. 29 dicembre 2023 n. 209 (in vigore dal 1° gennaio 2024), che ha ridefinito i criteri di residenza fiscale per persone fisiche e società. In particolare, per le società è stato modificato l’art. 73 TUIR comma 3: i criteri alternativi di collegamento restano tre (sede legale, sede di direzione effettiva, e – novità – “gestione operativa prevalente”), ma con definizioni più precise . La precedente nozione di “oggetto principale” è stata eliminata e sostituita dal criterio della gestione operativa prevalente, che guarda al luogo in cui si svolge prevalentemente l’attività economica ordinaria dell’impresa (produzione, amministrazione, affari quotidiani) . Anche la “sede di direzione effettiva” – concetto chiave per individuare l’esterovestizione – è stata definita in legge: dal 2024 è il luogo in cui avviene in modo continuativo e coordinato l’assunzione delle decisioni strategiche dell’impresa . Si tratta di una definizione in linea con lo standard OCSE del “place of effective management”, volta a dare certezza interpretativa. Per le persone fisiche, il D.Lgs. 209/2023 ha innovato l’art. 2 TUIR: ha reso l’iscrizione all’AIRE una presunzione solo relativa (prima la mancata iscrizione all’AIRE era considerata presunzione iuris et de iure di residenza in Italia) . Inoltre ha esplicitato che il criterio dei 183 giorni di presenza fisica in Italia vale di per sé a determinare la residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione anagrafica . In parallelo, ha distinto meglio domicilio fiscale (centro prevalente di interessi personali ed economici) e residenza (civile) ai fini tributari . Queste modifiche mirano a contrastare “furberie” come chi lavora da remoto dall’Italia fingendo residenza estera . Ad esempio, dal 2024 un cittadino iscritto AIRE in Portogallo ma presente in Italia oltre 183 giorni sarà comunque considerato residente fiscale italiano e tassato su base mondiale . Anche il mancato aggiornamento AIRE ora comporta sanzioni amministrative (come detto, €200-1000 per anno) per incentivare le comunicazioni tempestive .
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024: per dare attuazione alle novità del D.Lgs. 209/2023, l’Agenzia ha pubblicato la circolare 20/E/2024 con istruzioni operative sulla residenza fiscale di persone fisiche e società. La circolare conferma i nuovi criteri di collegamento (sede legale, direzione effettiva, gestione operativa) e fornisce chiarimenti. Ad esempio, viene ribadito che la sede di direzione effettiva prescinde dalle decisioni prese dai soci se queste non hanno carattere gestionale , e che la “gestione operativa in via principale” va intesa come luogo dove si svolgono le attività correnti e l’ordinaria amministrazione . La circolare puntualizza inoltre aspetti pratici: ad es., per il conteggio dei 183 giorni di presenza fisica si considerano anche le frazioni di giorno (quindi basta essere presenti parte di un giorno perché quel giorno conti) . Tuttavia, la dottrina ha rilevato che la circolare non dissipa tutte le incertezze: alcuni dubbi interpretativi restano aperti (ad es. come individuare esattamente il luogo di gestione in strutture societarie complesse, o come considerare le holding estere di società italiane) . In ogni caso, per la difesa del contribuente è utile conoscere questa circolare, sia perché indica come gli uffici fiscali applicheranno le nuove norme, sia perché in virtù delle modifiche del 2024 non sono più applicabili alcuni vecchi chiarimenti di prassi. Ad esempio, con la nuova normativa decadono alcune interpretazioni superate sui concetti di sede dell’amministrazione e oggetto principale (lo stesso documento di prassi evidenzia che i chiarimenti precedenti non più coerenti con la riforma sono da ritenersi non applicabili dal 2024) .
- Normativa anti-esterovestizione (art. 73 comma 5-bis TUIR): dal 2006 in Italia esiste una presunzione specifica per contrastare l’esterovestizione: l’art. 73 co.5-bis TUIR prevede che una società estera localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata sia presunta fiscalmente residente in Italia se è controllata, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia, o amministrata da soggetti residenti in Italia . È una presunzione iuris tantum (legale relativa): il contribuente può vincerla dimostrando che la direzione effettiva e l’attività economica della società si svolgono realmente all’estero . In pratica, l’onere della prova è invertito a carico del contribuente: se il Fisco individua gli indizi per applicare il 5-bis (es. società in paradiso fiscale controllata da italiani), starà alla società provare di non essere un guscio vuoto . Va notato che la presunzione automatica del 5-bis si attiva tipicamente per società estere che detengono partecipazioni o asset in Italia (come le classiche holding “cassette” all’estero di proprietà di italiani) . Se invece la società estera non possiede partecipazioni o beni in Italia, la presunzione legale non opera; ciò non significa però che non possa esservi un accertamento di esterovestizione – semplicemente, senza 5-bis si ricorre ai criteri generali e il carico probatorio iniziale spetta al Fisco . Questo punto è importante per la difesa: anche una società estera senza investimenti in Italia può essere contestata come residente in Italia (ad es. perché di fatto amministrata da qui), ma in tal caso l’ufficio dovrà fornire solidi elementi indiziari e non potrà giovarsi della scorciatoia presuntiva; il contribuente dal canto suo dovrà comunque fornire le prove contrarie, ma partendo da una posizione leggermente più favorevole sul piano probatorio .
- Disciplina CFC (Controlled Foreign Companies): un altro strumento anti-elusione rilevante è la normativa sulle CFC (art. 167 TUIR, aggiornata al recepimento ATAD). Questa disciplina, distinta dall’esterovestizione, prevede che se un residente italiano controlla una società estera localizzata in Paesi a bassa imposizione (aliquota effettiva inferiore al 50% di quella italiana) e tale società non svolge un’effettiva attività economica (è solo un’entità di interposizione o genera principalmente passive income), gli utili della società estera vengano imputati per trasparenza al socio italiano e tassati in Italia, anno per anno . In altre parole, la CFC tax è un “piano B” del Fisco: se non riesce a dimostrare che la società estera è residente in Italia (esterovestizione), comunque ne tassa gli utili in capo al socio italiano se la società è in paradiso fiscale e priva di sostanza economica . Il contribuente può evitare questa tassazione solo provando che la società estera svolge un’attività economica reale ed autonoma nel proprio Stato (personale, uffici, mercato locale) . La disciplina CFC dunque non va dimenticata: in sede difensiva, può capitare che l’Agenzia, qualora non riesca a far valere l’esterovestizione, ripieghi sulla CFC per tassare comunque gli utili esteri. Ciò è avvenuto ad esempio in alcune contestazioni riguardanti società emiratine: l’Agenzia a volte notifica avvisi di accertamento paralleli ai soci italiani, imputando loro i redditi della società estera come CFC (oltre a contestare alla società la residenza in Italia). Va valutato caso per caso, ma difendersi dall’esterovestizione implica spesso anche essere pronti a difendersi da un’eventuale applicazione della disciplina CFC, dimostrando la sostanza estera della società o che il tax rate estero non è “privilegiato”.
- Abuso del diritto ed elusione fiscale: L’ordinamento italiano (art. 10-bis L. 212/2000, Statuto del Contribuente) prevede che operazioni prive di sostanza economica, volte ad ottenere indebiti vantaggi fiscali, possano essere disconosciute dal Fisco (abuso del diritto), ma tali condotte non costituiscono reato tributario . Tuttavia, attenzione: la giurisprudenza considera l’esterovestizione non una semplice elusione ma un’evasione sostanziale, spesso accompagnata da elementi di frode, e quindi la qualifica fuori dall’ambito di non punibilità penale previsto per l’abuso . In altre parole, se il Fisco contesta che la società estera è “fittizia”, procede come in un caso di evasione a tutti gli effetti, senza possibilità di invocare la protezione dell’art. 10-bis (che si applica a pianificazioni elusive senza elementi di frode o simulazione). Questo orientamento è importante: vuol dire che, di fronte a uno schema di società estera usata per abbattere le tasse italiane, difficilmente l’ufficio lo tratterà come legittimo risparmio d’imposta, bensì attiverà sia le sanzioni amministrative piene sia, se del caso, le denunce penali. Dalla prospettiva difensiva, però, si può argomentare – soprattutto in casi all’interno dell’UE – che la mera scelta di localizzarsi in un Paese a fiscalità più vantaggiosa non costituisce di per sé abuso. La Corte di Giustizia UE lo affermò chiaramente nel caso Cadbury Schweppes (causa C-196/04) e la Cassazione italiana l’ha recepito: aprire società in Stati esteri con tasse agevolate non è abuso di per sé, purché vi sia un insediamento effettivo e genuino in quel Paese . Soltanto quando la società estera risulta una “costruzione di puro artificio” volta ad eludere la normativa, si potrà parlare di abuso e disconoscerla . Ad esempio, la Cassazione con sentenza n. 23842 del 25/08/2025 ha ribadito che non c’è esterovestizione se la società svolge all’estero un’effettiva attività economica; il fatto di aver costituito la società in uno Stato membro per godere di un regime fiscale più leggero non integra di per sé un abuso, in assenza di prove che dietro ci sia solo uno schermo artificioso . Questo principio, di matrice comunitaria, è un caposaldo per difendersi soprattutto nelle situazioni entro l’Unione Europea.
- Direttive UE contro l’uso improprio di entità estere (Unshell): a livello europeo, nel 2022-2023 si è discusso e avanzato il progetto di direttiva cosiddetta “Unshell” (ATAD 3) per impedire l’uso di società di comodo all’interno della UE a fini fiscali. Nel gennaio 2023 il Parlamento UE ha approvato a larga maggioranza la proposta , che prevede criteri per identificare le società prive di sostanza economica e, se confermate tali, nega loro i benefici fiscali (es. esenzioni da ritenute o dalle direttive interessi-royalties) . Si tratta di una misura anti-elusiva “preventiva”, volta a dissuadere i contribuenti dall’allocare redditi in entità vuote create solo per risparmiare tasse. Al 2025, la direttiva non è ancora definitivamente recepita in Italia (ci sono stati rallentamenti in Consiglio UE ), ma è probabile una prossima implementazione. Questo significa che anche a livello UE vi è una stretta in atto contro le società fittizie: chi costituisce società in UE senza personale, uffici né attività reale potrebbe trovarsi, nei prossimi anni, soggetto a reporting obbligatorio e a perdere i vantaggi fiscali comunitari. Ad esempio, se una holding olandese o maltese non supera i “substance requirements” previsti dalla direttiva (dipendenti, costo operativi minimi, ufficio dedicato, etc.), potrà essere trattata fiscalmente in base alle regole del paese del socio controllante, vanificando lo schema. Dal punto di vista del contenzioso attuale, il concetto di “shell company” ha già ispirato alcune pronunce: la Cassazione ha cominciato ad applicare principi europei in materia, ad esempio escludendo correlazioni automatiche tra esiguità di risultati economici di una società e presunzione di evasione, richiamando la necessità di prove più concrete di artificiosità . In definitiva, la tendenza normativa è chiara: sotto la lente ci sono le società prive di sostanza, e difendersi efficacemente implica dimostrare che la propria non lo è. Approfondiremo oltre come documentare la substance.
- Cooperazione fiscale internazionale rafforzata: infine, va sottolineato come dal 2017 in poi si sia entrati nell’era della trasparenza globale. L’adesione di moltissimi Stati (anche ex paradisi fiscali) allo standard OCSE CRS (Common Reporting Standard) di scambio automatico di informazioni finanziarie ha di fatto smantellato il segreto bancario tradizionale . Paesi un tempo opachi come la Svizzera, il Liechtenstein, Monaco, Singapore, gli stessi Emirati Arabi Uniti, hanno firmato accordi e dal 2017-2018 trasmettono alle autorità fiscali straniere i dati dei conti detenuti da non residenti. Ad esempio, gli Emirati Arabi: dal 2017 hanno aderito al CRS e dal 2018 banche e istituzioni finanziarie emiratine inviano all’Italia le informazioni sui conti intestati a residenti fiscali italiani . Di pari passo, l’Italia e altri paesi scambiano liste e dati (es. liste di società, rulings, schemi elusivi DAC6 segnalati da intermediari, ecc.). A livello UE esiste una black list di giurisdizioni non cooperative (periodicamente aggiornata dal Consiglio Ecofin: al febbraio 2025 include 11 Stati ritenuti inadempienti agli standard) ; intrattenere rapporti con tali Paesi comporta controlli particolarmente rigorosi. La Svizzera, un tempo considerata paradiso fiscale, è oggi in white list: dal 2017 scambia dati finanziari con l’Italia e dal 2023 è stata rimossa da ogni lista di non-cooperativi. Gli Emirati Arabi Uniti inizialmente figuravano in alcune “grey list” UE, ma hanno rapidamente implementato standard di scambio info per evitare la blacklist: al 2025 gli EAU non compaiono nella lista UE dei non-cooperativi . Questo significa che, ad esempio, ai fini delle sanzioni RW, gli Emirati sono trattati oramai come Paese collaborativo (sanzione 3% anziché 15%) . In generale, restano pochissimi “rifugi segreti”: l’era dei conti cifrati protetti è praticamente finita, e chi oggi nasconde beni in un Paese non cooperativo rischia molto (oltre alle sanzioni massime già citate, praticamente la certezza di essere scoperto se quell’info emerge in qualsivoglia indagine) . Le amministrazioni fiscali collaborano anche attraverso richieste mirate: l’art. 26 dei trattati contro le doppie imposizioni consente richieste di informazioni su specifici contribuenti. Ad esempio, se durante un accertamento in Italia spunta un conto bancario a Dubai non dichiarato, l’Agenzia può chiedere alle autorità emiratine i dettagli dei movimenti e saldi . La qualità delle risposte è migliorata: gli Emirati, spinti da G20 e FATF, oggi mostrano crescente apertura nel fornire assistenza su richiesta . L’insieme di queste evoluzioni implica che affidarsi alla mancanza di comunicazione tra Paesi è ormai una strategia obsoleta e pericolosa . Un contribuente che finge residenza estera o occulta redditi fuori confine non può più contare sul fatto che l’Italia “non se ne accorga”: se non dichiara spontaneamente e la residenza estera viene disconosciuta, è alta la probabilità che le informazioni emergano via scambio automatico o cooperazione, aggravando la sua posizione debitoria con ulteriori sanzioni .
In sintesi, lo scenario normativo e internazionale 2024-2025 vede un irrigidimento delle regole interne (criteri di sostanza, sanzioni più incisive, riforma reati tributari con D.Lgs. 87/2024 che ha rivisto soglie di punibilità e cause di non punibilità per alcuni reati ) unito a una maggiore pressione esterna (cooperazione globale e iniziative UE anti-avoidance). Questo contesto può avvantaggiare il contribuente onesto – che, se conforme ai criteri di sostanza, potrà più facilmente dimostrare la propria buona fede – ma rende quasi impossibile farla franca per chi nasconde deliberatamente ricavi dietro schermi esterovestiti. Nei prossimi paragrafi analizzeremo concretamente come queste novità si declinano nelle diverse categorie di Paesi e situazioni, per poi passare alle fasi dell’accertamento e alle strategie difensive.
Categorie di giurisdizioni estere e impatto sulle contestazioni (Black list, UE, Svizzera, Emirati, ecc.)
Non tutte le società estere sono viste allo stesso modo dal Fisco italiano: molto dipende dalla giurisdizione in cui risiedono. Storicamente l’ordinamento distingueva i “Paesi a fiscalità privilegiata” (Black List) dai Paesi collaborativi (White List). Oggi il panorama è più fluido, ma permangono differenze sul piano probatorio e sanzionatorio a seconda dello Stato estero coinvolto. Analizziamo le principali categorie citate (Black list in generale, Paesi UE, la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti) con particolare riguardo alle novità 2024-2025 per ciascuna:
Paesi “Black List” (paradisi fiscali non collaborativi)
Per Paesi Black List si intendono quelle giurisdizioni con regime fiscale privilegiato e scarsa trasparenza, tradizionalmente inserite in elenchi normativi per applicare misure antievasive. In passato l’Italia aveva una lista nera fissata dal DM 4 maggio 1999, che elencava decine di Stati considerati paradisi fiscali, dai classici (Panama, Isole Cayman, Monaco, Svizzera – all’epoca) a molti altri . Sebbene la cooperazione internazionale ne abbia “sbiancato” parecchi, la categoria concettuale rimane: ad esempio, ai fini dell’art. 73 co.5-bis TUIR (presunzione anti-esterovestizione) si fa riferimento a Paesi a regime fiscale privilegiato individuati con lista ministeriale (oggi aggiornata, es. Emirati, alcune giurisdizioni caraibiche, etc.) . Anche ai fini del quadro RW e relative sanzioni si distinguono Paesi collaborativi o meno.
Novità 2024-25: come accennato, il D.Lgs. 209/2023 ha eliminato la presunzione ex art. 2 comma 2-bis TUIR che considerava comunque residenti in Italia i cittadini italiani trasferiti in Stati Black List salvo prova contraria . Tale norma (che era stata introdotta nel 1999 proprio per arginare i trasferimenti di comodo) è stata formalmente abrogata o comunque superata dalla nuova formulazione: ora l’iscrizione AIRE in un Paese a fiscalità privilegiata è solo un indizio, non più una condanna presunta. Resta però il fatto che chi si trasferisce in un Paradiso Fiscale è soggetto a esame minuzioso. Già per il 2023 la Cassazione aveva affermato che la presunzione interna può essere superata se c’è di mezzo una Convenzione contro le doppie imposizioni (ne parleremo tra poco). Quindi, dal 2024 il quadro è: non esiste più una presunzione automatica di residenza italiana per chi emigra in Paesi Black List, ma nella pratica il Fisco considererà sempre tali situazioni ad alto rischio e pretenderà prove solide del reale espatrio. A conferma di ciò, la circolare 20/E/2024 include ancora riferimenti alle liste di Stati “non collaborativi” ai fini dello scambio di informazioni, segnalando che questi rimangono sorvegliati speciali .
Sul piano documentale e probatorio, trasferirsi o operare in un Paese Black List significa che l’onere della prova grava in misura aggravata sul contribuente. La Cassazione ha spesso ribadito che il contribuente italiano emigrato in paradiso fiscale deve dimostrare con un quadro coerente di elementi di aver davvero spostato la residenza (per le persone) o l’attività (per le società) all’estero . Occorre provare la rottura dei legami con l’Italia e la formazione di legami stabili altrove (casa, famiglia, interessi economici) . Allo stesso modo, per le società, se la società ha sede in un black-list e amministratori italiani, si presume l’esterovestizione finché non si prova l’effettività della struttura estera . Il contribuente deve fornire prova contraria dettagliata: come vedremo, ciò significa produrre contratti di affitto esteri, utenze, conti correnti locali attivi, personale assunto sul posto, ecc., per convincere che la società non sia un semplice guscio.
Un altro aspetto: i termini di accertamento raddoppiati per attività in Paesi Black List. La legge prevede (DL 78/2009) che in caso di attività finanziarie detenute in paradisi fiscali non dichiarate, i termini di decadenza raddoppino. Su questo la Cassazione ha di recente confermato (ord. n. 2643/2025) che tale raddoppio è procedurale e si applica anche retroattivamente . Ciò significa che se avete occultato conti o trust in un black-list, il Fisco potrebbe contestarli anche a distanza di 10-12 anni. Difendersi: in queste circostanze è cruciale eccepire eventuali prescrizioni se i fatti sono davvero remoti, ma spesso il raddoppio vanifica l’eccezione.
Infine, sul versante sanzionatorio, come detto le sanzioni per omessa dichiarazione di asset in Paesi non collaborativi sono raddoppiate (dal 3-15% al 6-30% nel quadro RW) . Anche le sanzioni penali in caso di reati fiscali commessi con attività in paradisi fiscali possono essere valutate con severità dal giudice (ad es. la transnazionalità può escludere attenuanti generiche). Novità 2024: l’Italia ha introdotto cause di non punibilità per alcuni reati tributari se il debito è estinto prima del giudizio, ma ciò tipicamente non copre l’omessa dichiarazione (copre omessi versamenti); per reati come dichiarazione fraudolenta o omessa dichiarazione rimane la punibilità piena, soprattutto se c’è volontà evasiva aggravata dall’uso di schermi esteri.
In sostanza, se la società estera si trova in un classico paradiso fiscale (es. Panama, Isole Vergini, Cayman, ecc. – molti sono ancora nella lista UE 2023 ), l’Agenzia delle Entrate partirà avvantaggiata: applicherà la presunzione di esterovestizione (art. 73 co.5-bis) e pretenderà che siate voi a dimostrare il contrario, e in generale adotterà la massima diffidenza. La difesa dovrà quindi focalizzarsi sul dimostrare sostanza e realtà commerciale (vedi oltre strategie difensive). Inoltre, in presenza di convenzioni internazionali, non dimenticate di invocare i criteri convenzionali: se c’è un trattato contro doppie imposizioni con quel Paese, i criteri di collegamento del trattato prevalgono sulle presunzioni interne . Ad esempio, come vedremo nel paragrafo sugli Emirati, la Cassazione 35284/2023 ha riconosciuto che anche per Dubai (ex black list) conta di più il fatto che il contribuente abbia la casa, famiglia e affari lì piuttosto che la presunzione di legge italiana .
Paesi UE e casi intra-Unione
Le situazioni che coinvolgono società costituite all’interno dell’Unione Europea (o SEE) hanno peculiarità proprie, perché entrano in gioco le libertà fondamentali UE – in primis la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) – e la relativa giurisprudenza. La UE, come noto, non ostacola la concorrenza fiscale fra Stati membri fintanto che gli schemi non sono puramente artificiosi. Costituire una società in un altro Stato UE per beneficiare di un regime fiscale più leggero è lecito, a patto che la società svolga realmente attività in quel Paese (principio stabilito dalla CGUE nel caso Cadbury Schweppes, C-196/04) . Pertanto l’Italia non può contestare l’esterovestizione a una società in altro Stato membro solo perché lì le tasse sono minori, se l’entità ha sostanza economica effettiva. Questo non significa impunità: significa però che, nel contesto UE, l’onere per il Fisco di provare che si tratta di una “costruzione di puro artificio” è particolarmente stringente .
Novità 2025: la Cassazione, come visto, ha continuato a rafforzare tale orientamento. La sentenza n. 23842/2025 (caso di società portoghese contestata) ha esplicitamente affermato che l’esterovestizione è un fenomeno abusivo contestabile solo in presenza di una costruzione artificiosa e che se la società svolge all’estero un’effettiva attività economica, non v’è esterovestizione . Inoltre ha ribadito che costituire una società in uno Stato UE per godere di un regime fiscale più vantaggioso non è di per sé abuso, in assenza di altri elementi. Questo segna una continuità con la giurisprudenza precedente e con il diritto UE. In pratica, in un contenzioso riguardante una società con sede, ad esempio, in Irlanda, Lussemburgo, Cipro, Malta o altri paesi UE a tassazione favorevole, il contribuente potrà invocare con forza tali principi: “la società esiste ed opera davvero in quello Stato, quindi il fatto che abbia beneficiato di aliquote minori non costituisce evasione”. Ovviamente dovrà anche provare la sostanza (locali, dipendenti, contratti localizzati, ecc.).
Un altro sviluppo a livello UE è come detto la direttiva Unshell (ATAD3). Quando sarà attuata, inciderà direttamente su società nell’UE prive di sostanza, con effetti come la negazione dei benefici convenzionali e l’obbligo di disclosure. Nell’attesa, già alcuni Stati UE hanno introdotto normative interne anti-abuso simili (es. la Danimarca ha regole severe sulle letter-box companies). Dal punto di vista difensivo, se la vostra società è in UE e avete rispettato i requisiti formali e minimi di sostanza, siete in una posizione più solida. Potete argomentare che un eventuale accertamento italiano violerebbe la libertà di stabilimento, richiamando ad esempio il passaggio di Cadbury per cui l’abuso va distinto dal semplice vantaggio fiscale.
Esempio pratico: Alfa Srl a Londra (caso concreto che vedremo anche in simulazione). L’Agenzia contesta la sede effettiva in Italia. La difesa può tra l’altro invocare che, se pure Alfa Srl è stata costituita nel Regno Unito per godere di Corporation Tax minore, ciò non basta a definirla fittizia: bisogna vedere se era “puramente artificiale”. Si evidenzia magari che aveva un ufficio a Londra, qualche cliente UK, e quindi non era un guscio vuoto: invocare la dottrina Cadbury Schweppes e la giurisprudenza italiana che ne discende serve a sostenere che la struttura non era puramente artificiale e che un’applicazione rigida dell’art. 73 TUIR da parte del Fisco italiano rischierebbe di confliggere col diritto UE . In più, se applicabile, c’è il trattato bilaterale: nell’esempio Italia-UK, la convenzione prevede criteri per risolvere la doppia residenza societaria (tie-breaker basato sulla sede di direzione effettiva, da concordare tra autorità) . La difesa potrebbe sottolineare che l’Agenzia italiana, agendo unilateralmente, ha ignorato il meccanismo convenzionale previsto, ponendosi quindi in contrasto col trattato .
In sostanza, nelle contestazioni intra-UE la difesa ha frecce ulteriori: diritto comunitario e trattati, che prevalgono sul diritto interno. La Cassazione, sent. n. 3386/2024, ha riconosciuto che un trasferimento in altro Stato UE può costituire abuso della libertà di stabilimento solo se la società rimane gestita dall’Italia con scopo esclusivo di eludere il fisco, confermando l’importanza dirimente del criterio della sede di direzione effettiva e richiedendo una prova concreta di dove siano prese le decisioni aziendali . In mancanza di prova solida, l’esterovestizione non regge: a parità di situazione, un giudice tributario può essere più propenso ad annullare un accertamento se riguarda una società con una certa operatività in uno Stato UE rispetto ad una società in un paradiso caraibico. Naturalmente, se la società UE è palesemente fittizia (solo un indirizzo di comodo e nulla più), anche la protezione UE viene meno.
Il caso particolare della Svizzera
La Svizzera merita un cenno specifico perché rappresenta un caso di ex-“black list” storicamente rilevante per l’Italia. Fino a pochi anni fa, la Svizzera era considerata a fiscalità privilegiata e non collaborativa: i capitali italiani nascosti nelle banche elvetiche erano un emblema dell’evasione internazionale. Dal 2015 in poi, però, ci sono stati mutui accordi e cambiamenti: la Svizzera ha aderito al CRS OCSE e dal 2017 scambia automaticamente informazioni finanziarie con l’Italia . Inoltre, dal 2016 non figura più nelle black list italiane o UE. Oggi la Svizzera è nella white list italiana degli Stati con scambio info (DM 9 agosto 2016 ha aggiornato l’elenco) e i depositi svizzeri di contribuenti italiani arrivano ogni anno (in forma aggregata) all’Agenzia delle Entrate tramite CRS.
Ciò implica che utilizzare società o conti svizzeri per occultare ricavi non offre più il vantaggio della segretezza. Tuttavia, la Svizzera mantiene un’aliquota societaria moderata in alcuni cantoni e una particolare attrattività. Se un imprenditore italiano ha una società in Svizzera, per difendersi deve mostrare che tale società ha sostanza in Svizzera (ufficio vero, dipendenti locali, ecc.), come per qualsiasi altro paese. Le presunzioni anti-esterovestizione valgono se la Svizzera rientra tra i paesi a fiscalità privilegiata ex DM 4.5.1999: va verificato lo status aggiornato, ma la Svizzera è stata rimossa da quell’elenco grazie agli accordi (ad es. nel 2015 per la voluntary disclosure l’Italia tolse formalmente Svizzera e Monaco dalla black list ai fini della presunzione di residenza fiscale). Dunque ad oggi la Svizzera è considerata “collaborativa”. Ciò non toglie che, se l’Agenzia ravvisa una società elvetica gestita da italiani, contesterà comunque la sede di direzione effettiva in Italia; semplicemente, non avrà il vantaggio della presunzione legale e dovrà portare più prove.
Sul fronte penale: oggi un evasore con soldi in Svizzera rischia alla pari di uno con soldi in Italia (anzi, se non li ha dichiarati in Italia rischia omessa dichiarazione). La cooperazione giudiziaria con la Svizzera è anch’essa migliorata: esistono accordi di assistenza amministrativa e giudiziaria e protocolli di scambio informativo rapido. Non si può più confidare di rifugiarsi dietro la frontiera.
In sostanza, la difesa per società svizzere segue schemi simili a quelle UE, con la differenza che la Svizzera non è UE quindi non c’è la libertà di stabilimento da invocare, ma c’è comunque un trattato bilaterale Italia-Svizzera che disciplina la doppia residenza. Quel trattato (nuovo accordo del 1976, modificato) prevede criteri per individuare la residenza fiscale dei soggetti dual resident (simile al tie-breaker classico: sede direzione effettiva per persone giuridiche). Quindi, se l’Italia e la Svizzera rivendicano entrambe la residenza, occorre applicare il trattato. In un contenzioso, il contribuente può far presente che la decisione unilaterale italiana di considerare residente la società viola il trattato se la Svizzera considera la società residente lì. Sottolineare il rispetto dei criteri convenzionali (es. se la sede effettiva risulta effettivamente in Svizzera) può essere decisivo.
Novità 2024: Va ricordato che nel 2020 Italia e Svizzera hanno firmato un nuovo accordo sul trattamento dei lavoratori frontalieri e altri protocolli, segno di una sempre maggiore integrazione fiscale. Inoltre, la Svizzera sta abolendo gradualmente alcuni regimi privilegiati (status holding, domiciliate) per allinearsi agli standard OCSE. Dunque la differenza di tassazione si assottiglia in alcuni casi.
Riassumendo per la Svizzera: oggi non è più un paradiso fiscale “nero”, ma l’Agenzia comunque guarderà con attenzione a società elvetiche di residenti italiani. La difesa si concentrerà su dimostrare la reale attività in Svizzera e, se necessario, utilizzare il trattato bilaterale come scudo giuridico. Un contribuente che abbia trasferito davvero il suo business in Canton Ticino (con uffici a Lugano, personale locale, tasse pagate lì) ha buone carte per vincere eventuali contestazioni italiane. Viceversa, chi ha solo fatto un trasferimento di nome, lasciando tutto in Italia, difficilmente potrà sfuggire.
Emirati Arabi Uniti e nuove frontiere (Dubai, ecc.)
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU), con Dubai in primis, rappresentano la “nuova frontiera” per molti imprenditori italiani in cerca di tassazione nulla o bassa. Fino a qualche anno fa, Dubai offriva imposte societarie zero (fino al 2022 non aveva imposta sul reddito delle società, salvo per le petrolifere e banche) e segretezza: costituire lì una società o aprire conti significava godere di riservatezza verso gli altri Stati. Oggi lo scenario è cambiato radicalmente . Gli Emirati hanno introdotto dal 2023 un’imposta societaria federale (Corporate Tax) al 9% sui redditi, e hanno sottoscritto numerosi accordi di trasparenza. Come già detto, dal 2018 inviano all’Italia i dati dei conti finanziari dei residenti italiani a Dubai . Inoltre esiste dal 1995 una Convenzione Italia-EAU contro le doppie imposizioni (ratificata con L. 309/1997) che contiene all’art. 26 un robusto meccanismo di scambio informazioni e all’art. 4 i criteri per dirimere i conflitti di residenza . Nel 2020 gli Emirati sono stati temporaneamente inseriti in liste di revisione UE, ma al 2025 non sono nella black list UE (segno che cooperano) . Quindi Dubai non è più l’oasi impenetrabile di un tempo: le banche emiratine applicano KYC stringenti e segnalano le posizioni estere secondo gli accordi .
Questo contesto ha due conseguenze: (1) il Fisco italiano ha ora strumenti per scoprire eventuali redditi/conti occultati a Dubai, e (2) in caso di contenzioso, è possibile giocare la carta del trattato Italia-EAU. Soffermiamoci su quest’ultimo punto, perché la Cassazione nel 2023 ha emanato un precedente rilevantissimo: la sentenza n. 35284 del 18/12/2023. In quel caso un contribuente italiano si era trasferito a Dubai e ne era nato un contenzioso sulla residenza fiscale. La Cassazione ha affermato chiaramente che, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, i criteri convenzionali prevalgono sulla presunzione interna di residenza verso paradisi fiscali . Ciò significa che, anche se prima l’art. 2 comma 2-bis TUIR presumeva residente in Italia un italiano emigrato a Dubai, questa presunzione può essere vinta applicando l’art. 4 della Convenzione Italia-EAU . Nel caso concreto, il contribuente è riuscito a dimostrare – seguendo i criteri del trattato – di avere la dimora permanente, il centro degli interessi vitali e la presenza abituale negli Emirati, e così la sua residenza fiscale è stata attribuita agli EAU e non all’Italia . Questo precedente è fondamentale: sancisce che, anche di fronte a un Paese a fiscalità nulla come Dubai, conta la realtà di fatto e che i trattati vanno rispettati. Non serve nemmeno che vi sia doppia tassazione effettiva (Dubai potrebbe non tassare affatto il reddito) – importa che la persona sia soggetta alla potestà impositiva emiratina in generale . Nel 2024 la Cassazione ha confermato lo stesso principio in altre pronunce (es. Cass. 994/2024, Cass. 1316/2024) per Emirati e altri paesi .
Dunque, in caso di accertamento su società/individui collegati a Dubai, la difesa ha diverse armi: dimostrare la sostanza estera (come sempre), invocare il trattato bilaterale (che prevale sulle regole italiane) e sottolineare l’evoluzione cooperativa degli EAU (che riduce l’allarme di “opacità”). Tuttavia, anche qui, serve concretezza: se un italiano ha aperto una LTD nella Dubai Free Zone ma poi vive a Milano e fattura solo a clienti italiani, difficilmente potrà convincere di avere residenza estera effettiva. Un altro spunto: dal giugno 2023 gli Emirati hanno introdotto la corporate tax 9%. Se la vostra società a Dubai ha pagato, poniamo, il 9% sugli utili, potete evidenziarlo per dire che non c’era un risparmio d’imposta così enorme (è un elemento che, pur non escludendo l’evasione, può supportare la buona fede). Nel nostro esempio Alfa Srl a Londra, la difesa ha usato un argomento simile: Alfa Srl pagava il 19% UK, quindi non un paradiso puro, segno che non era un fine esclusivo di evasione .
Quanto a presunzioni: gli Emirati comparivano nel DM 4/5/1999, quindi l’art. 73 co.5-bis TUIR si applica (società emiratina controllata da italiani → presunzione di residenza in Italia) . Però, come detto, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato inammissibili gli interpelli disapplicativi di tale presunzione su EAU, sostenendo che è una questione di fatto fuori dall’interpello . Ciò significa che un contribuente prima di operare non può chiedere certezza all’Agenzia se la sua società a Dubai sarà considerata residente all’estero o no – deve valutare da solo e, in caso, difendersi a posteriori . Sapendo ciò, chi decide di aprire a Dubai farebbe bene a predisporre fin dall’inizio tutti gli elementi sostanziali (uffici, presenza, documentazione) per reggere a un eventuale controllo. Nella sezione strategie difensive vedremo nel dettaglio quali accorgimenti adottare.
In conclusione, gli Emirati da un lato hanno perso lo scudo del segreto (quindi nascondere lì redditi è sconsigliabile), dall’altro – se si tratta di un trasferimento reale – offrono ora una tutela giuridica in più grazie al trattato e all’allineamento con gli standard internazionali. Un contribuente che effettivamente vive e opera a Dubai potrà far valere i criteri convenzionali per evitare la tassazione italiana . Viceversa, chi finge il trasferimento a Dubai ma mantiene radici in Italia, oggi ha elevatissime chance di essere scoperto (attraverso CRS, richieste mirate, ecc.) e, una volta scoperto, avrà scarse difese. Il messaggio della Cassazione e del legislatore è chiaro: esterovestire in Emirati senza sostanza comporta gli stessi guai che altrove, non è più un porto sicuro.
Altre giurisdizioni degne di nota
Potremmo citare anche altre categorie: ad esempio i paesi “ibridi” come quelli con regimi territoriali (Hong Kong, Singapore – tassano solo redditi locali) o con tasse zero ma cooperativi (Isole Cayman aderisce al CRS). In linea generale, valgono i principi già esposti: se il paese è cooperativo, l’Agenzia può ricevere dati; se è a bassa tassazione, può attivarsi la disciplina CFC; se è un paese extra-OCSE non cooperativo (pochi rimasti, es. qualche isola del Pacifico), allora si applicano tutte le presunzioni negative e massime sanzioni.
Il caso delle holding UE di società italiane: es. un imprenditore italiano crea una holding in Olanda o Lussemburgo che possiede quote di società italiane (esterovestizione di secondo livello). La presunzione art. 73(5-bis) copre anche queste situazioni . Ma con l’eliminazione del criterio “oggetto principale” dal 2024, alcuni commentatori (Assonime) ritengono che se la holding estera si limita a esercitare i poteri di controllo e coordinamento, non automaticamente verrà contestata come prima . Sarà interessante vedere gli sviluppi su questo fronte: per ora cautela, tali schemi restano a rischio contestazione se la holding estera non ha uffici e board effettivo locale.
Conclusione di sezione: conoscere la categoria di paese coinvolto aiuta a capire l’approccio del Fisco e la miglior strategia difensiva. Riepilogando:
- Black list “duri e puri” (ancora tali nel 2025: es. Panama, Isole Vergini, etc.): approccio fisco = presunzioni, onere su contribuente, scarsa collaborazione estera → difesa: caricare prove sostanza, contestare motivazione se basata solo su blacklist, utilizzare convenzioni se esistenti.
- Paesi UE: approccio fisco = analitico (no presunzioni automatiche), focus su sostanza, tentativo di provare sede in Italia → difesa: invocare libertà UE, Cadbury, onere prova in capo a ufficio, dimostrare minimi di operatività estera; citare eventuale direttiva ATAD3 come contesto (per dire: la mia società supera i test substance).
- Svizzera: approccio fisco = come paese cooperativo extra-UE (no presunzioni, ma attenzione alta) → difesa: sostanza più trattato bilaterale, evidenziare tasse pagate in CH, ecc.
- Emirati: approccio fisco = era black list, ora cooperativo ma ancora a bassa tassazione → fisco tenterà presunzione 5-bis e controlli; difesa: trattato Italia-EAU art.4 tie-breaker, provare centro vitali negli EAU, evidenziare eventuali imposte pagate (dal 2023 c’è il 9%), provare che società non è fittizia (uffici a Dubai, ecc.).
Nella prossima sezione, passeremo alle fasi dell’accertamento e alle garanzie difensive procedurali, per poi dettagliare le strategie di difesa sia in sede amministrativa che contenziosa.
Fasi dell’accertamento fiscale e diritti del contribuente
Un accertamento fiscale per ricavi occulti tramite società estere tipicamente si sviluppa attraverso diverse fasi. Conoscerle è fondamentale per esercitare appieno i diritti difensivi in ogni momento. Vediamo le fasi principali di un procedimento accertativo di questo genere e quali strumenti ha il contribuente (debitore) per tutelarsi:
- Analisi e selezione: spesso tutto inizia “dietro le quinte”, con l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza che, incrociando dati, individuano situazioni anomale. Ad esempio, movimenti bancari verso l’estero non giustificati, soci di società estere che risultano residenti in Italia con basso reddito dichiarato, utilizzo di schemi societari noti. Le fonti informative possono essere le banche dati (Anagrafe conti, Archivio RW, scambi CRS), segnalazioni UIF, oppure indagini della GdF su terzi (es. cliente italiano che paga una società estera sospetta). In questa fase il contribuente di norma non sa nulla. Tuttavia, un segnale premonitore può essere la ricezione di questionari o inviti a fornire informazioni. Ad esempio, l’Agenzia può inviare un questionario chiedendo se il contribuente detiene partecipazioni estere, o se ha conti off-shore. Consiglio: non sottovalutare questi segnali. Rispondere in modo preciso (meglio con consulente) è importante; non rispondere affatto può spingere l’ufficio a procedere in modo più aggressivo.
- Verifica fiscale / indagine: qualora si passi alla fase operativa, può avvenire una verifica fiscale sul campo (accesso presso la sede del contribuente) oppure indagini finanziarie mirate. Se parliamo di società estere, spesso la GdF effettua indagini bancarie sui conti italiani dei soci o conti esteri noti: ricordiamo che l’art. 32 DPR 600/73 permette di presumere ricavi non dichiarati da movimenti bancari non giustificati . Ad esempio, se sui conti personali dell’imprenditore arrivano bonifici da una società estera di cui formalmente non risulta proprietario, la GdF può ipotizzare che quella società sia di fatto sua e quei soldi utili a lui distribuiti. Spesso la GdF redige un PVC (processo verbale di constatazione) al termine dell’indagine, in cui dettaglia i rilievi (es: “Società X Ltd con sede alle Isole ABC è amministrata di fatto dal Sig. Rossi dall’Italia, come da email acquisite; si configura stabile organizzazione occulta/esterovestizione”). Il contribuente viene in genere sentito dai verificatori e può rilasciare dichiarazioni. È fondamentale in questa fase collaborare con cautela: fornire i documenti richiesti, ma anche iniziare già a presentare le proprie giustificazioni. Ogni cosa detta o taciuta in verifica potrà influire dopo. Ad esempio, non rispondere alle richieste o ostacolare la verifica è deleterio: se il Fisco fa domande, meglio reagire con trasparenza (sempre assistiti da un fiscalista) . Spostare archivi all’estero o opporre un “muro di gomma” in genere peggiora la posizione, dando l’idea di poca collaborazione .
- Invito al contraddittorio e confronto endoprocedimentale: in molti casi, prima di emettere l’atto, l’ufficio invia un “Invito a comparire” o una comunicazione di fine verifica, aprendo la fase del contraddittorio endoprocedimentale. Questo è un passaggio cruciale: la Corte di Giustizia UE e la Cassazione hanno sancito che, per alcuni tributi (es. IVA) e in caso di accertamenti complessi, il contraddittorio preventivo è un elemento essenziale del diritto di difesa . In Italia non esiste ancora una regola generale per ogni tributo, ma dal luglio 2020 vige l’obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti sui tributi “armonizzati” (IVA, da norme UE) e in alcuni altri casi specifici (per es. gli ISA, ex studi di settore) . Fuori da questi, la Cassazione tende comunque a ritenere che l’omesso contraddittorio possa portare a nullità dell’atto se l’accertamento è complesso e l’assenza di confronto lede i diritti del contribuente . In ogni caso, il contribuente ha diritto di chiedere un contraddittorio: se non viene spontaneamente concesso, si può inviare memoria chiedendo di essere sentiti. E se l’atto viene emesso senza contraddittorio dove era obbligatorio, si potrà eccepire in giudizio la nullità per violazione del diritto di difesa . Pratica difensiva: partecipare al contraddittorio preparati. Questo incontro (o scambio scritto) consente di mettere agli atti le prove a favore prima che l’avviso sia emesso . È utile consegnare una memoria difensiva con documenti in questa fase: ciò costringerà l’ufficio a tenerne conto (o quanto meno a rispondere) nell’eventuale avviso, e se ignora le nostre prove potremo farlo valere in ricorso. Nel caso di ricavi occulti esteri, ad esempio, potremmo già portare contratti di affitto esteri, organigrammi, bilanci esteri certificati – tutto ciò che provi la sostanza. Questo non significa svelare tutte le carte prematuramente (una strategia va pensata), ma generalmente mostrare collaborazione e dare spiegazioni dettagliate aiuta più che il silenzio. Se poi l’ufficio è obbligato al contraddittorio e non lo fa, terremo ben presente l’eccezione da sollevare in ricorso .
- Emissione dell’Avviso di Accertamento: è l’atto formale con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito dichiarato (o non dichiarato) e liquida le maggiori imposte e sanzioni. Nel nostro caso, l’Avviso tipicamente riqualifica la società estera come residente in Italia per determinati anni d’imposta, con conseguente recupero di IRES, IRAP, IVA ecc., oppure (o in aggiunta) contesta al socio italiano utili non dichiarati. Ad esempio, un Avviso potrebbe dire: “Società Alfa LLC con sede a Dubai è considerata fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 73 TUIR, avendo la sede di direzione effettiva in Italia. Pertanto si recuperano €X di IRES per gli anni 2021-2022, con sanzioni per omessa dichiarazione al 150%” . In più, potrebbe aggiungere: “Si presume distribuzione degli utili extrabilancio al socio Sig. Rossi, residente in Italia, per €Y, con recupero di IRPEF e relative sanzioni”. Attenzione: se nell’istruttoria sono emersi elementi di reato, l’avviso conterrà anche la “comunicazione di notizia di reato” (ex art. 12 D.Lgs. 74/2000), ossia sarà specificato che verrà informata la Procura per omessa dichiarazione, ecc. Da quel momento scatterà il procedimento penale (che poi seguirà il suo corso autonomo). L’Avviso deve essere motivatissimo in questi casi: trattandosi di materia complessa, l’ufficio tende a scrivere atti corposi, con elencati tutti gli indizi raccolti (email, movimentazioni, testimonianze, ecc.). Bisogna leggere attentamente l’atto e valutare se la motivazione è adeguata o presenta vizi: ad esempio, se l’Agenzia omette completamente di considerare i documenti difensivi che avevamo presentato nel contraddittorio, si potrà eccepire un vizio di motivazione (motivo di illegittimità). O se l’avviso è emanato prima dei 60 giorni dal PVC senza urgenza (violando l’art. 12 Statuto Contribuente), anche quello è vizio. Sono dettagli procedurali ma importanti.
- Difesa nella fase post-avviso: adesione o ricorso – Una volta notificato l’Avviso (notifica che spesso avviene a mezzo PEC per i soggetti con domicilio digitale, oppure via raccomandata/nulla osta GdF), il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso alla Commissione Tributaria (ora rinominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). Prima di farlo, però, c’è la possibilità di avviare un accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): presentando istanza di adesione, i termini per ricorrere sono sospesi per max 90 giorni e si apre una trattativa con l’ufficio. Accertamento con adesione significa cercare un accordo: tipicamente il contribuente riconosce almeno in parte le maggiori imposte e l’Agenzia riduce le sanzioni di 1/3. In situazioni di esterovestizione, l’adesione può essere una via se la posizione non è chiarissima: ad esempio, ci sono elementi a sfavore e a favore, e si vuole ridurre il danno evitando il contenzioso lungo. L’Agenzia in adesione potrebbe ridurre l’imponibile accertato tenendo conto di costi deducibili o di elementi che il contribuente porta (es. “ok, tassiamo in Italia gli utili ma riconosciamo un credito per le imposte pagate in UK, e applichiamo sanzione solo al minimo”). Nota: l’adesione comporta rinuncia al ricorso e implica il pagamento (anche rateale) di quanto concordato; estingue il giudizio ma non il penale – però il ravvedimento operoso o il pagamento prima del dibattimento può aiutare nel penale. A volte, se l’accordo comporta il pagamento integrale del dovuto, l’ufficio potrebbe anche segnalare alla Procura che il contribuente ha collaborato, il che talora facilita patteggiamenti. In generale, valutare l’adesione è doveroso: se l’avviso è palesemente infondato la si scarterà, ma se c’è margine può risparmiare anni di causa e ulteriori sanzioni (in appello le sanzioni non si riducono più).
In alternativa o fallita l’adesione, si procede col ricorso tributario. Il ricorso va presentato alla Commissione (Corte) entro 60 giorni (o di più se adesione), ed è l’atto con cui si illustrano i motivi di illegittimità o infondatezza dell’accertamento. Nella sezione successiva approfondiremo le strategie difensive in contenzioso, ma anticipiamo che in questa fase è bene farsi assistere da un avvocato tributarista esperto in fiscalità internazionale. Egli potrà esaminare nel dettaglio:
- Vizi formali e procedurali: es. la notifica è regolare? è stato rispettato il termine di decadenza? c’era obbligo di contraddittorio non rispettato? la motivazione dell’avviso è insufficiente o contraddittoria? Eventuali nullità di questo tipo vanno eccepite subito nel ricorso, prima di entrare nel merito .
- Questioni di diritto: es. errata applicazione dell’art. 73 TUIR (magari l’ufficio ha confuso stabile organizzazione con residenza), mancata considerazione del trattato internazionale, violazione di norme UE, etc. Anche queste si allegano al ricorso come motivi (meglio se supportati da richiami giurisprudenziali autorevoli). Esempio: “Violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Emirati: l’avviso non considera i criteri convenzionali e pretende di applicare la sola normativa interna, in contrasto con l’art. 4 della Convenzione e con Cass. 35284/2023” . Oppure: “Violazione art. 41 Carta UE (diritto al buon andamento): l’Ufficio non ha atteso il termine di 60 giorni dal PVC, ledendo il contraddittorio ex art. 12 L.212/2000” (se applicabile).
- Il merito fattuale: qui si contestano i fatti accertati. Occorre esporre la realtà: “La società ha effettivamente operato in Svizzera avendo uffici e dipendenti locali; le decisioni non venivano prese in Italia, come erroneamente sostiene l’Ufficio”, e così via . Si tratta di controbattere punto per punto i rilievi fattuali del Fisco con le nostre prove: se l’avviso dice “non c’è un ufficio vero all’estero”, noi portiamo il contratto di leasing e foto dell’ufficio; se dice “clienti tutti italiani”, noi mostriamo contratti con clienti esteri (o spieghiamo che anche coi clienti italiani si operava dall’estero); se evidenzia “amministratori residenti in Italia”, noi magari proviamo che il board si riuniva all’estero e un consulente locale era attivo. Questo lavoro di confutazione analitica va fatto in ricorso in maniera ordinata e documentata. Spesso conviene allegare al ricorso una memoria integrativa di documenti (nel processo tributario ci sono meno limiti: oggi è ammessa anche la prova testimoniale in forma scritta, introdotta dalla riforma 2022, seppur con cautela). Quindi possiamo allegare dichiarazioni giurate di terzi (ad esempio il fiduciario estero che certifica la presenza degli amministratori tot giorni sul posto).
- Coordinamento col penale: un punto a parte, ma essenziale. Se è in corso (o in procinto di avviarsi) un procedimento penale parallelo, le dichiarazioni rese in un giudizio possono influenzare l’altro. Un avvocato esperto saprà coordinare la strategia fiscale e penale, evitando che magari per vincere in Commissione ci si esponga penalmente e viceversa . Inoltre, se si decide di pagare il dovuto per cercare cause di non punibilità nel penale (vedi art. 13 D.Lgs.74/2000 per alcuni reati), bisogna considerare l’impatto nel processo tributario (ad es. un pagamento in corso di causa tributaria può portare a cessazione parziale della materia del contendere e a sanzioni ridotte). In definitiva, serve un approccio integrato.
- Fase di giudizio: il processo tributario ha tre gradi (primo, secondo – CGT di Secondo grado – e Cassazione). Può durare diversi anni. Durante questo periodo, il contribuente deve sapere che l’avviso di accertamento, se impugnato, non è definitivo ma può essere iscritto a ruolo parzialmente. In particolare, se fa ricorso, deve versare un importo pari a 1/3 delle imposte accertate (al netto di interessi e sanzioni) come “acconto”, salvo chiedere e ottenere la sospensione. Dopo la sentenza di primo grado, se sfavorevole, si versa un ulteriore 1/3 (totale 2/3); dopo la seconda grado, l’eventuale residuo . Questo per dire che, in cause di importi elevati, anche in pendenza di giudizio l’Agenzia può riscuotere parzialmente. Nelle contestazioni di esterovestizione ciò può significare dover versare somme ingenti subito, mettendo pressione. È possibile chiedere alla Commissione la sospensione dell’atto se sussiste un danno grave e se il ricorso è fumus di buon diritto (cioè non infondato): spesso conviene tentare, specie se l’azienda rischia la crisi di liquidità.
Va rilevato che, negli ultimi anni, la giustizia tributaria è stata riformata per renderla più equilibrata: i giudici tributari ora sono professionali e indipendenti, e sono state introdotte novità come la prova testimoniale scritta e il rinforzo del principio del contraddittorio e del giusto processo. Questo dovrebbe favorire decisioni più giuste in temi complessi come questi, dove prima c’era forse un pregiudizio pro-fisco. Inoltre, la presenza di sezioni specializzate in materia internazionale va aumentando.
Dopo questa panoramica procedurale, siamo pronti a focalizzarci sulle strategie difensive specifiche: come impiegare al meglio documenti, argomenti giuridici e giurisprudenza per difendersi da un’accusa di ricavi occulti via società estera.
Strategie difensive del contribuente
Affrontare una contestazione di ricavi occultati tramite società estera richiede un approccio su più fronti. Il contribuente (debitore) dovrà combinare prove fattuali, eccezioni procedurali e argomentazioni giuridiche, adattandole al caso specifico. Di seguito esaminiamo le principali strategie difensive, distinguendo tra la fase amministrativa (verifica e accertamento) e quella giudiziale (ricorso in Commissione), sottolineando le mosse chiave dal punto di vista del contribuente.
1. Documentazione e prove concrete di sostanza estera
Il primo pilastro della difesa è dimostrare che la presenza all’estero non è fittizia, bensì reale e sostanziale. Bisogna raccogliere e presentare tutti i documenti che attestino l’effettiva attività nel paese estero.
Per le società estere (presunte esterovestite), i documenti utili includono ad esempio :
- Contratto di locazione o titolo di possesso di un ufficio all’estero, con relative ricevute di pagamento affitto e bollette intestate alla società presso quell’ufficio. Ciò prova che esiste una sede operativa effettiva (non un mero indirizzo di comodo).
- Contratti con clienti e fornitori locali, fatture emesse verso clienti esteri o ricevute da fornitori esteri. Più è internazionale il business, meno parrà un veicolo vuoto per affari italiani.
- Estratti conto di banche estere operativi: mostrare che la società ha un conto bancario locale utilizzato per incassare e pagare in loco. Se c’è solo un conto a San Marino o a Montecarlo usato per transitare fondi (come nell’esempio Alfa Srl), va spiegato perché; idealmente si esibisce anche il conto locale a supporto (es. dimostrare che i fondi da SM venivano poi trasferiti su un conto UK per spese, come sostenuto nella difesa di Alfa ).
- Libri sociali, verbali del Consiglio di Amministrazione e assemblee svolti all’estero, possibilmente con evidenze: p.e. verbali firmati in originale all’estero, magari con un notaio locale che ne attesta luogo e data . Questo serve per contestare l’argomento “le decisioni le prendevano in Italia”. Se esibiamo verbali di CDA a Londra con timbro notarile UK, diamo sostanza formale alla direzione estera (certo, se li abbiamo redatti solo pro forma a posteriori, rischiano di apparire artefatti; ma se erano tenuti in buona fede, sono preziosi).
- Presenza di personale o collaboratori locali: contratti di lavoro, buste paga di dipendenti assunti in loco, o contratti con un agente/commercialista locale che curava l’azienda. Ad esempio, se uno studio professionale a Dubai gestiva contabilità e segreteria, avere una lettera di incarico e fatture di questo studio può mostrare che c’era vita sociale in EAU.
- Iscrizioni a registri locali: Certificato di iscrizione al registro imprese estero, eventuale certificato camerale, licenze o permessi ottenuti in loco. Se l’azienda ha ottenuto, ad esempio, una licenza in Free Zone, portarla come segno che per l’autorità locale l’azienda era attiva.
- Bilanci esteri (se disponibili) e relativa approvazione locale, meglio ancora se revisionati da auditing locale. Un bilancio depositato all’estero può includere note sulla sede operativa.
- Organigramma societario con persone chiave non tutte residenti in Italia: se possibile, evidenziare che nel management ci sono figure locali. Es: nominare (e coinvolgere realmente) un amministratore o procuratore residente sul posto. Se all’epoca non c’era, oggi è un suggerimento: avere tutti gli amministratori in Italia è un punto debole, meglio inserire figure estere reali .
- Sito web e presenza locale online: anche un dettaglio come il sito internet aziendale con contatti telefonici ed indirizzo estero può essere un tassello (banale ma spesso citato: se il sito indicava come sede solo Milano e nessun riferimento estero, è incoerente; se invece mostra l’ufficio estero e magari è bilingue, ben venga).
- Fotografie e prove fisiche: foto degli uffici, dei dipendenti al lavoro all’estero, biglietti da visita con recapito estero, brochure aziendali locali. Tutto serve a dipingere la società come un’azienda reale e radicata sul territorio straniero .
Per le persone fisiche (in caso di contestazione della residenza estera “fittizia”), analogamente serviranno evidenze che la vita del soggetto è effettivamente all’estero . Ad esempio:
- Contratto di affitto o atto di acquisto di abitazione all’estero, con utenze (luce, gas, internet) intestate e fatture con consumi regolari. Se uno vive davvero in un paese, avrà bollette locali significative. È uno degli indicatori forti in giurisprudenza . All’opposto, se risulta che in Italia il contribuente ha ancora utenze attive (luce, gas di una casa dove magari vive la famiglia), il Fisco lo userà contro di lui .
- Iscrizione dei figli a scuola all’estero, tessere sanitarie, certificati medici esteri, eventuale iscrizione a sistemi previdenziali o assicurazioni sanitarie locali. Dimostrano spostamento del centro di interessi.
- Estratti conto carte di credito: molto rilevante, spesso la GdF li guarda. Se da Visa si vede che 90% delle spese del 2022 erano in Italia (ristoranti, benzinai in Italia), è segno che la persona stava qui. Se invece compaiono spese quotidiane nel paese estero (supermercati, abbigliamento, ecc.), ciò indica presenza fisica. Bisogna produrre quelli che aiutano la nostra tesi.
- Timbri sul passaporto e biglietti aerei: la GdF in controlli li esamina per contare i giorni. È utile presentare un prospetto dei viaggi, magari elaborato. Oggi poi ci sono tabulati telefonici e localizzazioni smartphone: se volessimo, potremmo portare estratti di celle telefoniche o geolocalizzazioni social (rischioso ma fattibile se a favore). Ad esempio, in un caso citato (residenza Montecarlo contestata) emerse che il contribuente firmava rogiti in Italia e stava più qui che lì, smontando la pretesa di residenza monegasca .
- Attività lavorativa svolta all’estero: contratti di lavoro con azienda locale, o licenza per business estero. Far vedere che la fonte di reddito è all’estero, non in Italia, è cruciale. Se uno dice di vivere a Dubai ma continua ad amministrare la società italiana, capite che non regge – e infatti va rassegnata la revoca di cariche italiane in questi casi.
- Conti bancari e investimenti esteri: se il soggetto ha chiuso i conti italiani e ha solo conti nel nuovo Stato, e magari ha venduto casa in Italia e comprato casa fuori, ciò rafforza la tesi di spostamento effettivo. Al contrario, mantenere molti asset in Italia (case, società) è sintomo che l’espatrio è di facciata.
Molti di questi indicatori li abbiamo già riassunti nella tabella sui trasferimenti genuini vs fittizi (vedi sezione Tabelle). Ad esempio, l’iscrizione AIRE tempestiva vs tardiva, casa principale estera vs mantenere la casa in Italia, >183 giorni all’estero vs passare ancora la maggior parte in Italia, famiglia trasferita vs famiglia rimasta in Italia, etc. . Quella tabella evidenzia come ogni elemento di fatto conti. È la somma coerente dei vari elementi che convince il giudice: un certificato di residenza estero da solo vale poco se i fatti contraddicono (Cassazione: “un certificato di residenza all’estero è elemento formale e marginale se i fatti indicano altrove” ). Quindi il contribuente deve costruire un dossier completo e coerente, dove tutti gli aspetti puntino a dimostrare la realtà all’estero . Se emergono evidenze contrarie (es. bollette italiane), deve saperle spiegare (magari l’utenza era per allarme attivo in casa vuota – non convincente, ma si prova).
In giudizio, è bene allegare queste prove già nel ricorso o comunque entro i termini del primo grado. Dal 2023 la riforma consente di presentare testimoni in forma scritta: se ci sono terzi che possono attestare fatti (es. un dipendente estero testimonia che vedeva l’amministratore presente, o un vicino che conferma che lui viveva lì), si può far fare dichiarazioni giurate (affidavit). La Cassazione in passato era restia ad ammettere testimonianze in questi casi (dicendo che il processo tributario è documentale), ma ora c’è apertura: valorizzare anche testimonianze può essere decisivo. Esempio: far testimoniare il commercialista di Londra che Rossi veniva di persona a firmare bilanci e seguiva l’attività in loco. O far fare un affidavit all’agente monomandatario italiano che però dichiara “sì, io operavo in Italia ma sempre su istruzioni finali della sede UK, non concludevo contratti”.
2. Onere della prova e confutazione degli indizi del Fisco
Dal punto di vista giuridico, è importante governare il tema del riparto dell’onere probatorio. Come abbiamo accennato:
- Se l’ufficio ha attivato una presunzione legale (ad es. art. 73 co.5-bis TUIR per società in paradiso fiscale), allora tocca al contribuente fornire la prova contraria. Quindi in sede di contraddittorio e contenzioso la difesa consisterà nel presentare tutti gli elementi idonei a smontare la presunzione . In pratica, se l’Agenzia dice “per legge ti considero residente in Italia se hai società alle Cayman controllata da te”, noi dobbiamo dimostrare attivamente che quella società non è artificiale ma svolge attività reale alle Cayman (cosa ardua, ma per ipotesi). Dobbiamo quindi portare i documenti di cui sopra per convincere che la gestione è lì. Se riusciremo a generare almeno il dubbio, la presunzione potrà essere vinta.
- Se invece la contestazione avviene in assenza di presunzioni specifiche (es. società in paese UE non blacklist, oppure persona fisica in paese non considerato privilegiato), allora l’onere iniziale è dell’ufficio: il Fisco deve indicare elementi, indizi, fatti da cui dedurre la residenza in Italia . Ad esempio, se la società è in Francia (white list), l’Agenzia non può applicare il 5-bis, deve però comunque provare (anche con presunzioni semplici) che la direzione è in Italia. Ciò non la ferma: userà come indizi la residenza dei soci, i flussi finanziari, ecc. Ma tecnicamente, se i suoi indizi non fossero “gravi, precisi e concordanti”, il giudice dovrebbe darle torto. Quindi la difesa in questi casi punterà prima di tutto a contestare che il quadro indiziario del Fisco è lacunoso o contraddittorio. Si può dire: “L’Ufficio basa la contestazione su 3 e-mail e su bonifici da Italia a Francia, ma questo non prova affatto che la società è gestita da qui: anzi, quelle e-mail mostrano che i referenti in Francia davano istruzioni”. Spesso i giudici valutano la complessità e concordanza degli indizi: la Cassazione chiede che siano “gravi, precisi e concordanti” (art. 2729 c.c.) per fondare un accertamento per presunzioni semplici. Quindi il contribuente attaccherà ogni singolo indizio per indebolire la concordanza. Esempio concreto: l’avviso dice “ci sono 10 clienti italiani, ergo attività in Italia”. Noi replichiamo: “Quei clienti italiani interagivano con l’ufficio estero via email/telefono, non con strutture in Italia, quindi non è prova di attività qui” . Altro: “amministratore vive in Italia ergo decide qui”; noi: “Non è vero che basta la presenza fisica del socio per dire che la sede effettiva è in Italia. Serve dimostrare che qui si prendevano decisioni direttive, e non l’hanno dimostrato” (magari citando la Cass. 23842/2025 che dice che la presenza di un amministratore di fatto in Italia non basta a provare esterovestizione senza dimostrare che la società è artificiale ). Questo ribalta la prospettiva: onus sull’ufficio.
In sintesi, in giudizio bisogna far emergere che:
- Se c’è presunzione legale, noi abbiamo portato prova contraria sufficiente (o quantomeno abbiamo neutralizzato la presunzione creando un ragionevole dubbio sulla sua applicabilità).
- Se non c’è presunzione legale, gli elementi del Fisco non raggiungono la soglia richiesta di evidenza e, in ogni caso, i nostri elementi li smentiscono.
Da un punto di vista pratico, nel ricorso conviene impostare delle sezioni ad hoc: ad esempio, una rubrica “Difetto di prova dell’esterovestizione da parte dell’Ufficio”. Lì si argomenta: “Gli elementi addotti dall’Ufficio sono i seguenti: 1)… 2)… 3)… Tali elementi, singolarmente e nell’insieme, non provano quanto sostenuto, per le ragioni seguenti…”. E poi magari un’altra rubrica: “Sussistenza di prova contraria di residenza estera”, dove elenchiamo tutto quello che proviamo noi.
Va segnalato che nel 2023 c’è stata anche un’evoluzione per cui il contribuente può persino cercare di difendersi prima che arrivi l’accertamento, tramite interpello, ma come detto l’Agenzia ha giudicato inammissibili gli interpelli sulla residenza fiscale di società esterovestite . Precisamente, le risposte a interpello (es. interpello n. 956-8/2018 citato in dottrina) dicono che “la determinazione della residenza presuppone valutazioni di fatto non cristallizzabili ex ante”, per cui non danno ruling preventivi. L’unica eccezione potrebbe essere un interpello per nuovi investimenti ex art. 2 DL 147/2015 (cooperative compliance), se la società fa un grande investimento e chiede certezza sulla residenza: ma casi rari. Insomma, bisogna giocare la partita direttamente in sede di controllo e contenzioso, non c’è scorciatoia preventiva.
3. Eccezioni procedurali e vizi dell’accertamento
Oltre a combattere sul fatto, il contribuente deve valutare ogni eventuale errore procedurale commesso dal Fisco, che potrebbe condurre all’annullamento (o almeno a una migliore posizione in giudizio). Le principali eccezioni preliminari in questi casi includono:
- Mancato contraddittorio preventivo, se dovuto: come già detto, se l’ufficio avrebbe dovuto attivare il contraddittorio (perché, ad esempio, trattasi di tributi non armonizzati ma l’accertamento era complesso), si può eccepire la nullità dell’avviso per violazione del diritto al contraddittorio e difesa. La giurisprudenza su imposte dirette è altalenante: alcune sentenze di Cassazione hanno ritenuto che per le imposte dirette non c’è obbligo generale di contraddittorio (diversamente dall’IVA) salvo specifiche previsioni . Ma altre hanno invocato principi costituzionali di leale collaborazione. Dunque, l’eccezione non garantisce vittoria, ma val la pena sollevarla. Al limite, anche se il giudice non annulla per questo, può essere più ben disposto nel merito vedendo che l’ufficio ha agito “di imperio”. Nell’esempio Alfa Srl, la difesa ha eccepito appunto il vizio di omesso contraddittorio sostenendo che trattandosi di accertamento su imposte dirette ma assai complesso, l’ufficio avrebbe dovuto rispettare i principi generali e l’art. 12 co.7 L.212/2000 (60 giorni dal PVC) . Si nota che “la giurisprudenza è oscillante, ma si prova a far leva sul principio di buona fede e Statuto del Contribuente” . Questa è un’espressione realistica: non è detto si vinca su questo, ma tentare è d’obbligo, anche perché se si arriva in Cassazione magari nel frattempo le Sezioni Unite potrebbero fissare un principio (è un tema dibattuto).
- Motivazione insufficiente o per relationem non adeguata: se l’Avviso si limita a richiamare il PVC o a lanciare accuse generiche senza spiegare bene, si può contestare. Nel nostro contesto, dato che l’avviso sarà prolisso, l’eccezione potrà essere: “non ha considerato le prove a discarico”. Ad esempio, se noi in contraddittorio avevamo già fornito alcuni documenti e l’avviso li ha ignorati, si può dire che non ha valutato un elemento decisivo e ciò vizia la motivazione. Oppure se l’avviso equipara totalmente fatturato estero = reddito tassabile senza considerare costi, possiamo richiamare giurisprudenza che impone di dedurre costi anche in accertamento induttivo (Cass. n. 2581/2021, che cita Corte Cost. 225/2005) . In effetti in materia di stabili organizzazioni occulte, la Cassazione ha detto che l’Erario non può tassare il 100% dei ricavi presunti senza riconoscere alcun costo, perché violerebbe il principio di capacità contributiva . Quindi, se l’accertamento fa un “pleno iure” degli importi lordi, eccepire ciò può portare almeno a un parziale accoglimento (riduzione imponibile). Nel caso di Alfa, ad esempio, pare che l’ufficio avesse tassato €300k di utili senza considerare che aveva pagato 19% in UK. La difesa ha evidenziato la cosa e che quindi il risparmio d’imposta non era integrale , un po’ come dire che l’ufficio ha sopravvalutato il vantaggio fiscale.
- Vizi di notifica: se l’avviso è stato notificato a un indirizzo errato o a un soggetto non legittimato (es. a un socio invece che alla società senza che questi fosse coobbligato), c’è vizio. Spesso però l’Agenzia notifica all’estero via raccomandata internazionale o convenzioni: controllare se l’ha fatto correttamente. P.es., se notifica a una società estera presso l’indirizzo in paradiso fiscale, c’è il rischio che non arrivi; ma magari ha notificato anche al rappresentante in Italia come coobbligato. In nota: la Cassazione dice che solo il soggetto passivo d’imposta (società) può impugnare nel merito l’avviso, un coobbligato come un socio può solo contestare di non essere coobbligato, ma non far annullare l’esterovestizione . Quindi se notificano parallelo al socio, quello deve far squadra col ricorso della società ma ha posizione limitata.
- Termini di decadenza: raramente in questi casi sono sbagliati, perché spesso c’è omessa dichiarazione e l’ufficio ha 8 anni. Tuttavia, valutare se proprio hanno preso un anno pre-… Ad esempio, un redditp 2014 dichiarato e contestano nel 2023 = oltre 5 anni, se non c’è omessa, è decaduto. O se doveva applicarsi un raddoppio e non c’erano i presupposti (questioni complesse che han visto contenziosi, ma dal 2015 il raddoppio dei termini è subordinato alla denuncia penale entro termini ordinari, ecc. Ci sono intricati casi: es. se l’esterovestizione è scoperta con reato, i termini di accertamento raddoppiano ex art. 12 D.Lgs. 74/2000? Sì, se la denuncia è presentata entro scadenza dei termini normali. Da verificare nei fatti.
- Violazione di norme sul PVC: l’art. 12, co.7 L.212/2000 dice che dal rilascio del PVC ci sono 60 giorni prima di poter emettere avviso (salvo indifferibilità). Se l’ufficio emette avviso prima di 60 gg dal PVC GdF senza urgenza, l’atto è nullo. Questo è spesso un vizio vincente se esiste, quindi controllare date.
4. Argomentazioni giuridiche sostantive (trattati, diritto UE, ecc.)
Accanto ai vizi procedurali e alle prove fattuali, il contribuente deve sviluppare le sue argomentazioni di diritto sostanziale:
- Prevalenza delle Convenzioni internazionali: come già evidenziato, se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni col paese in questione, va usata. L’art. 4 di queste convenzioni stabilisce i criteri di “tie-breaker” per la doppia residenza (per persone fisiche: dimora permanente, interessi vitali, soggiorno abituale, cittadinanza; per persone giuridiche di solito sede di direzione effettiva o procedura amichevole) . Il contribuente deve spiegare nel ricorso che in base a tali criteri convenzionali risulta residente estero, e pertanto l’Italia non può considerarlo residente. Citare la Cassazione 35284/2023 che afferma la prevalenza del trattato su presunzioni interne è molto utile . Anche altre sentenze come Cass. 1316/2024, 994/2024, CTR Abruzzo 190/2021, ecc., confermano questa linea . Se possibile, allegare al ricorso un certificato di residenza fiscale estero per gli anni in questione (anche tardivo) perché serve ad applicare il trattato . La Cassazione ha ritenuto valido anche un certificato ottenuto tardivamente purché attesti che in quegli anni la persona era considerata residente estero . Quindi, un certificato dall’autorità di Dubai che attesti la residenza fiscale negli EAU 2021-22 è un bel pezzo a favore (non definitivo, ma aiuta a accedere al trattato). Attenzione, la Cassazione ha chiarito che non occorre che vi sia una effettiva doppia tassazione per applicare la convenzione: anche se Dubai tassa zero, conta che la persona sia soggetta alla loro potestà fiscale . Questo smonta l’argomento che a volte il Fisco usava: “il trattato serve a evitare doppie tasse, ma se all’estero non paghi nulla, la convenzione non dovrebbe valere”. No, la Cassazione dice il contrario . Dunque useremo questo punto a nostro vantaggio in difesa: “L’Italia non può ignorare la convenzione nemmeno se l’altra nazione non esercita imposizione, come confermato da Cass. 994/2024 etc.”.
- Richiamo alle libertà comunitarie e assenza di abuso: se è scenario intra-UE, come per Alfa Srl, evidenziare che beneficiare di regime fiscale più vantaggioso in altro Stato membro non è di per sé illecito . Citare Cadbury Schweppes (CGUE) e Cass. 23842/2025 . Argomentare che “la struttura societaria ha ragioni economiche sostanziali e non è costruzione artificiosa, quindi un intervento impositivo italiano sarebbe lesivo della libertà di stabilimento”. Questo potrebbe convincere il giudice a interpretare restrittivamente la norma interna per conformità al diritto UE. Le Commissioni tributarie spesso apprezzano i riferimenti UE, e l’Agenzia fa più fatica a controbattere su quel piano.
- Nozione di stabile organizzazione vs esterovestizione: a volte l’ufficio potrebbe anche contestare che la società estera configurava una “stabile organizzazione occulta” in Italia. Bisogna capire l’approccio: se dicono “la società X è in realtà residente in Italia”, è esterovestizione; se dicono “la società X rimane estera, ma operava in Italia tramite un ufficio o agente non dichiarato”, allora è stabile organizzazione occulta. I due concetti differiscono in diritto: nel primo, la società viene tassata come un’italiana su redditi mondiali; nel secondo, la società estera rimane estera ma la si tassa sui redditi attribuibili alla sua branch occulta italiana. Nel difendersi, bisogna evitare confusioni e magari sfruttare eventuali errori dell’ufficio. Ad esempio, se l’ufficio ha fatto un po’ di confusione (cosa possibile), potremmo eccepire che non è chiaro se contestano esterovestizione o stabile organizzazione, e questa incertezza nuoce alla chiarezza della pretesa (vizio di motivazione). Oppure, se contestano stabile org. occulta, allora la convenzione si applica diversamente (i trattati in art. 7 regolanole stabili org). In ogni caso, giova sapere che in materia di stabile organizzazione occulta vi sono principi come l’obbligo di considerare i costi e non tassare ricavi lordi . La Cassazione (2581/2021) ha cassato decisioni che equiparavano fatturato a reddito, imponendo di dedurre costi per rispettare art. 53 Cost. . Quindi, se fosse il caso, usare quell’argomento.
- Questione coobbligati (soci/amministratori): se (come spesso accade) l’Agenzia notifica l’avviso anche ad amministratori di fatto o soci come responsabili solidali, va gestita anche la loro posizione. Come detto, tali soggetti possono contestare la loro legittimazione passiva (ad es. “io non ero amministratore di fatto, quindi non dovete chiedere a me”). L’ordinanza Sez. Unite 2021 n. 8500 ha chiarito che per far pagare ai soci di società estinta serve un avviso autonomo a loro, e comunque hanno responsabilità pro quota. Nel nostro caso, se la società estera è ancora esistente, potrà essere difficilmente escussa in Italia (se non ha beni qui). L’ufficio quindi punterà ai soggetti in Italia (amministratore, socio). Bisogna quindi difenderli. Una linea è: la Cassazione ha detto che solo la società può discutere il merito , quindi il socio coobbligato può chiedere l’estromissione dal giudizio meramente fiscale (questo è un tecnicismo: a volte si chiede di dichiarare il ricorso inammissibile contro di lui se non ha fatto ricorso la società – qui invece faranno entrambi probabilmente). In sostanza, se il socio viene coinvolto, conviene far sì che anche la società faccia ricorso (se la controlliamo) per avere piena discussione. Nel merito, per i soci c’è la presunzione di distribuzione utili occulti: in società a ristretta base, se emergono utili extra bilancio, li presumono attribuiti ai soci . Il socio può difendersi provando che gli utili non sono stati distribuiti, o che lui non c’entra. Novità giurisprudenziale: Cass. ord. 2464/2025 ha ammesso che il socio può vincere la presunzione semplicemente provando la propria assoluta estraneità alla gestione . Se cioè il socio era solo un prestanome o un quotista formale ma di fatto non partecipava, la presunzione cade anche senza provare che gli utili furono reinvestiti in società (cosa prima richiesta). Questo orientamento “aperturista” rompe un dogma: prima la Cassazione chiedeva comunque di provare che la società non aveva distribuito utili o li aveva accantonati, ora invece dice che basta dimostrare che il socio non esercitava poteri e non era a conoscenza . Allora, se per caso nel nostro scenario c’è un socio di minoranza estraneo alla gestione (o l’amministratore di fatto era un altro socio), quel socio minore può cavarsela dimostrando la sua estraneità. Questo si intreccia con la difesa penale: spesso l’amministratore di fatto è uno, magari il socio di maggioranza, gli altri erano figuranti. Nel tributario questa distinzione è difficile, ma con Cass. 2464/2025 si può fare. Quindi come strategia, il socio non operativo evidenzierà di non aver mai partecipato (magari stava all’estero, non sapeva nulla, etc.).
- Pagamento del dovuto e ravvedimento: se il contribuente nel frattempo (per strategia penale o per chiudere) paga integralmene le imposte evase, può invocare l’attenuante o la non punibilità penale per alcuni reati. Ad esempio, per l’omessa dichiarazione l’art. 13 D.Lgs. 74/2000 prevede non punibilità se prima della dichiarazione dell’anno successivo paga tutto il dovuto. Nella pratica, se paga ad accertamento avvenuto (quindi ben oltre tale termine), non rientra in questa causa di non punibilità, però potrebbe ottenere attenuanti o patteggiamento più favorevole . Nella nostra difesa tributaria, si può sottolineare l’atteggiamento collaborativo e la buona fede (anche se tardiva) per chiedere almeno la riduzione massima delle sanzioni amministrative per “adesione” o per obiettiva incertezza (difficile). Ad esempio, se durante il processo conciliamo e paghiamo, possiamo ottenere sanzioni ridotte al 50% (conciliazione giudiziale).
In conclusione, la strategia vincente si basa su: smontare le accuse fattuali del Fisco punto per punto (con documenti e testimonianze), inquadrare giuridicamente la vicenda a nostro favore (trattati, diritto UE, interpretazioni restrittive delle norme anti-abuso), e sfruttare ogni passo falso procedurale dell’ufficio. Il tutto ricordando che, come diceva la conclusione del caso pratico, se mancano segnali chiari di sostanza, difendersi è arduo . Infatti, se la nostra è una situazione molto borderline (targhetta su porta estera e tutto in Italia), la probabilità di successo è bassa. Mentre se sin dall’inizio avevamo dato sostanza (es. 2-3 dipendenti a Londra, ufficio sempre aperto, metà clienti esteri), magari l’accertamento non sarebbe nemmeno partito; e se partito, avremmo ottime chance di vittoria .
Dunque la miglior difesa è la prevenzione: dare sostanza reale alle proprie operazioni estere e tenere traccia documentale di tutto. Su questo punto chiudiamo con alcuni consigli riassuntivi per prevenire contestazioni.
5. Prevenire le contestazioni: buone prassi
Se un contribuente ha la possibilità di pianificare in anticipo (ad esempio sta pensando ora di aprire una società estera), dovrebbe adottare accorgimenti pratici per ridurre il rischio di esterovestizione. Molti emergono già da quanto detto, ma vale la pena elencarli come regole d’oro :
- Sede estera “vera”: non limitarsi a un indirizzo presso uno studio di consulenza estero. Allestire un ufficio fisico anche piccolo, con targa societaria, linea telefonica locale e magari qualche arredo. Far risultare quell’ufficio come centro direzionale dell’azienda . Evitare assolutamente situazioni di “brass plate” (solo una casella postale).
- Personale o collaboratori in loco: assumere almeno un impiegato amministrativo locale, oppure nominare un procuratore che vive lì e segue le pratiche . Avere tutte le persone chiave in Italia è un red flag; meglio un “mix” nella governance .
- Amministratori residenti all’estero: se possibile, nominare un amministratore che risieda nel Paese estero e che partecipi alle decisioni . Se non fidato per lasciargli tutto, si può optare per un consiglio di amministrazione con membri italiani e locali, e prevedere che alcune riunioni si tengano effettivamente fuori.
- Tenere i verbali e decisioni all’estero: formalizzare con cura i verbali di CDA e assemblee, indicare il luogo estero e far firmare in originale lì. Conservare la minuta e magari allegare biglietti di viaggio per quella data . Questi dettagli possono convincere che non è una finzione.
- Limitare i legami rimasti in Italia: se la società estera interagisce con la controllante o consociate italiane, farlo a condizioni di mercato (transfer pricing corretto) e documentare i contratti. Evitare commistioni di conti, doppie firme su conti, etc. Se l’imprenditore persona fisica ha beni in Italia (casa, auto), valuti di cederli o affittarli, per non dare l’idea che tutto è rimasto come prima .
- Adeguare il lifestyle: per le persone, se si dichiarano expat, comportarsi da expat. Niente transazioni frequenti su carte italiane, niente permanenze lunghe in Italia non giustificate. Se la famiglia non segue, è un grosso problema: l’Agenzia considera la famiglia come indicatore forte del centro di interessi . Quindi, meglio trasferire anche il nucleo familiare se possibile, o quantomeno ridurre la loro presenza in Italia.
- Documentare tutto scrupolosamente: dall’atto costitutivo, ad ogni contratto firmato all’estero, tenere tracce (timbrature, notai, legalizzazioni). Aprire conti correnti esteri e usarli per le spese locali, così rimane evidenza di vita locale.
- Consulenza locale e italiana: farsi seguire da un commercialista/avvocato locale per gli adempimenti esteri (darà sostanza di normalità) e da un fiscalista italiano per controllare che si stiano rispettando le regole italiane (es. compilare quadro RW correttamente, magari presentare interpello se dubbio, etc.).
- Non trascurare gli adempimenti italiani residui: se la società estera ha rapporti con Italia, adempiere: ad es. se ha una stabile org dichiarata, presentare le dichiarazioni di quella; se fa vendite in Italia, assolvere eventualmente l’IVA (identificazione diretta o rappresentante IVA). Mostrare compliance negli obblighi riduce la percezione di frode deliberata.
Insomma, ogni aspetto strutturale e comportamentale deve confermare che attività e interessi sono davvero radicati all’estero . Se invece rimangono evidenti radici in Italia, il Fisco lo contesterà prima o poi.
Nel caso foste già sotto accertamento senza aver adottato questi accorgimenti, la difesa è più difficile ma non impossibile: come abbiamo visto, esistono ancora spazi per far valere i propri diritti, specie quando il Fisco agisce in modo automatico e ignorando la sostanza delle cose . Non scoraggiatevi e attivatevi prontamente: analizzate in dettaglio la contestazione, raccogliete le prove a discarico, verificate il rispetto delle garanzie procedurali, e impostate con esperti una strategia integrata fiscale-penale .
Nei paragrafi seguenti affronteremo alcune domande frequenti per riepilogare concetti chiave e poi proporremo un caso pratico di contestazione e difesa (che abbiamo già in parte anticipato con Alfa Srl) per vedere come il tutto si applica concretamente.
Caso pratico: simulazione di contestazione e difesa
Per concretizzare i principi esposti, consideriamo un esempio pratico di contestazione da parte del Fisco e le possibili strategie di difesa dal punto di vista del contribuente.
Scenario ipotetico: La Alfa S.r.l. è una società costituita a Londra nel 2021, con socio unico e amministratore il sig. Rossi, cittadino italiano residente a Milano. Oggetto sociale: consulenza informatica. Nei fatti, il sig. Rossi svolge consulenze via remoto per aziende italiane; Alfa Srl dispone di un piccolo ufficio in un business center di Londra, usato però sporadicamente. Tutti i clienti pagano su un conto bancario di Alfa Srl a San Marino. Il sig. Rossi si è iscritto all’AIRE dal 2021 come residente nel Regno Unito, ma trascorre gran parte del tempo in Italia (dove ha la famiglia e dove i clienti lo vedono spesso di persona). Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate avvia un controllo e scopre fatture emesse da Alfa Srl a diverse società italiane. Contestazione: Alfa Srl è esterovestita, in realtà gestita e operante in Italia. L’ufficio notifica un Avviso di accertamento per gli anni 2021-22, con queste caratteristiche :
- Residenza fiscale di Alfa Srl in Italia ai sensi art. 73 TUIR (sede di direzione effettiva in Italia).
- Recupero di €300.000 di IRES non versata, oltre IVA su alcune operazioni imponibili interne, sanzione 150% e interessi .
- Segnalazione per omessa dichiarazione (reato art. 5 D.Lgs. 74/2000) all’Autorità giudiziaria .
Difesa del contribuente (sig. Rossi): viene presentato ricorso in Commissione Tributaria. Con l’assistenza di un avvocato tributarista, la difesa è impostata come segue:
- Eccezioni preliminari procedurali: Si contesta che non è stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale prima dell’accertamento . L’ufficio infatti non aveva inviato alcun invito a comparire né concluso la verifica con un PVC notificato: l’avviso è arrivato senza possibilità di replica preventiva. Si eccepisce che, trattandosi di imposte sui redditi (non armonizzate) ma di un accertamento particolarmente complesso e potenzialmente invasivo, l’omissione del contraddittorio viola i principi di buona fede e diritto di difesa sanciti dallo Statuto del Contribuente. Si richiama giurisprudenza oscillante, ma si fa leva sulle pronunce (es. Cass. 701/2019) che hanno affermato la nullità in casi simili. Obiettivo: far rilevare al giudice un vizio procedurale che possa condurre all’annullamento dell’atto o quantomeno spronare l’ufficio a conciliare. (Consapevoli che la giurisprudenza non è univoca, la si pone come questione di illegittimità da esaminare primariamente).
- Difesa di merito – prova della sostanza estera: Si argomenta che Alfa Srl ha una presenza reale a Londra e non è un mero artificio. Vengono prodotti come allegati: copia del contratto di affitto dell’ufficio nel business center di Londra, con relative bollette UK intestate alla società (luce, internet) ; copie di due contratti di consulenza con clienti britannici (anche se generano solo il 10% del fatturato, dimostrano che almeno qualche attività fuori Italia c’era) ; le dichiarazioni fiscali inglesi della società per il 2021 e 2022, attestanti il pagamento della corporate tax UK (19%) su parte degli utili . Questo elemento viene sottolineato per dire che non vi era un risparmio d’imposta così significativo – anzi, Alfa Srl ha pagato imposte in UK, segno che lo scopo non era esclusivamente evasivo (pur ammettendo che l’aliquota UK è inferiore all’IRES, il contribuente enfatizza di aver comunque assolto il 19% di imponibile, riducendo l’illecito vantaggio fiscale). Si fa notare che in caso di buona fede la Cassazione riconosce rilievo a questi aspetti.
- Prova della direzione effettiva all’estero: Per confutare l’affermazione dell’ufficio che “tutte le decisioni venivano prese in Italia dal sig. Rossi”, la difesa presenta una serie di verbali assembleari e di Consiglio di Amministrazione di Alfa Srl, apparentemente redatti nel 2021-22, recanti firma autografa del sig. Rossi apposta a Londra. Tali verbali sono stati vidimati da un notary public inglese con timbro e data in quei giorni . (Nota: in realtà questi verbali potrebbero essere stati predisposti retroattivamente, ma hanno l’apparenza di genuinità). Inoltre si allegano estratti conto del conto bancario UK di Alfa Srl che mostrano spese di vitto e alloggio a Londra in corrispondenza di alcune riunioni (es. ricevute di hotel a Londra per Rossi in date di CDA) . È prodotta anche una dichiarazione giurata del fiduciario londinese che gestisce il business center, il quale attesta che il sig. Rossi è stato presente fisicamente in quell’ufficio varie volte l’anno per svolgere l’attività aziendale. Tutto ciò per contrastare la tesi che l’azienda fosse gestita interamente da Milano: si cerca di dimostrare che Rossi trascorreva tempo a Londra per le decisioni importanti, seguendo le formalità societarie localmente .
- Argomentazione giuridica: La difesa sostiene che Alfa Srl non è una costruzione artificiosa volta unicamente a eludere il fisco italiano, ma un’entità che, pur avendo beneficiato di un regime più leggero, aveva una minima sostanza economica in UK. Si richiama la libertà di stabilimento UE e la sentenza Cadbury Schweppes della Corte di Giustizia UE, affermando che l’operato societario non era “puramente artificiale” e che se c’è un minimo di sostanza economica bisogna rispettare la scelta imprenditoriale del contribuente . Viene sottolineato che la normativa anti-esterovestizione va applicata con bilanciamento nel contesto UE: se una società ha un’effettiva vita sociale all’estero, qualificarla come residente in Italia potrebbe violare il diritto comunitario. Si citano anche Cass. 23842/2025 (esterovestizione non configurabile in assenza di costruzione di puro artificio) e altre pronunce di legittimità per rafforzare il concetto che non ogni risparmio d’imposta estero è abuso, solo le finzioni totali .
- Richiamo alla Convenzione Italia-Regno Unito: Poiché per gli anni 2021 vigeva ancora (nonostante Brexit) la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e UK del 1988, la difesa la invoca. In caso di dual residency di una società, la convenzione prevede che la residenza venga risolta tramite accordo amichevole tra le autorità competenti, tenendo conto della sede di direzione effettiva (tie-breaker rule standard) . La difesa sottolinea che l’Agenzia italiana non ha attivato alcun accordo con HMRC e ha unilateralmente dichiarato Alfa Srl residente in Italia, atto contrario al trattato . Si argomenta che, quantomeno, l’Italia avrebbe dovuto consultarsi con il Regno Unito; in mancanza, la pretesa è viziata da violazione della Convenzione. Si fa notare che Alfa Srl possedeva un certificato di residenza fiscale UK rilasciato nel 2022 (allegato), e dunque agli occhi del Regno Unito era soggetto fiscale locale: imporre la doppia residenza senza accordo è scorretto.
- Confutazione puntuale degli indizi del Fisco: La difesa passa in rassegna gli elementi indicati nell’accertamento e li ribatte uno ad uno :
- Il Fisco afferma: “tutti i clienti sono italiani”. La difesa replica: Non proprio, c’è almeno un cliente UK (contratto allegato) e, in ogni caso, alcuni clienti italiani interagivano con l’ufficio di Londra. Si producono email che mostrano corrispondenza in inglese con tali clienti, inviate negli orari del fuso orario UK. Questo per suggerire che anche i clienti italiani venivano gestiti come se Alfa Srl operasse da Londra (es. le call di lavoro avvenivano secondo gli orari britannici, ecc.).
- Il Fisco evidenzia: “conto bancario a San Marino”, interpretandolo come segno di opacità. La difesa spiega che ciò era dovuto a ragioni operative: Alfa Srl utilizzava un conto a San Marino come clearing internazionale, ma i fondi poi venivano girati sul conto UK per le spese . Si allega un estratto del conto UK mostrando accrediti provenienti da San Marino corrispondenti alle fatture italiane. Questo per dire: non tenevamo i soldi nascosti a San Marino, li trasferivamo a Londra e li spendevamo lì, quindi non c’era volontà di occultamento patrimoniale (si collega al non configurare sottrazione fraudolenta art.11 D.Lgs.74/2000).
- Il Fisco sottolinea: “famiglia di Rossi in Italia”. La difesa cerca di minimizzare: ipotizza (nel ricorso si dichiara) che il sig. Rossi fosse single (anche se era famiglia a Milano, si può sostenere che la moglie non fosse legalmente coniuge o simili, o che fosse separato – dipende dal caso, ma diciamo single). Si afferma che Rossi aveva i suoi interessi principalmente nel lavoro rivolto all’estero e la sua presenza in Italia era legata solo a necessità occasionali (ad esempio la pandemia Covid 2021 che può averlo bloccato alcuni periodi in Italia, o cura di parenti). Si cerca di giustificare i “200 giorni l’anno in Italia” come eccezionali e dovuti a cause di forza maggiore, non alla centralità degli interessi. Non è un argomento fortissimo, ma serve a non lasciare punti scoperti: si prova a convincere che la permanenza in Italia era transitoria o per vacanza, non indice di residenza di fatto .
- Conclusioni difensive: Alla luce di tutto ciò, la difesa chiede l’annullamento totale dell’accertamento per insussistenza dei presupposti (assenza di prova di esterovestizione) e, in subordine, una drastica riduzione dell’imponibile e delle sanzioni riconoscendo la buona fede del contribuente e l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa (data anche la situazione post-Brexit, etc.) . Si invoca l’art. 6, co.2 D.Lgs. 472/97 per la non applicazione di sanzioni in caso di incertezza (sebbene, ammettiamolo, non facile da far valere qui, ma tentano tutto).
Esito possibile (ipotetico): In questo scenario simulato, molto dipende dalla valutazione probatoria del giudice. Se i documenti prodotti dalla difesa appaiono poco convincenti o posticci, e in effetti risulta che il grosso dell’attività era concentrato in Italia, è probabile che l’esterovestizione venga confermata. Alfa Srl verrebbe quindi trattata come residente in Italia nel 2021-22, con obbligo di pagare le imposte e relative sanzioni (forse ridotte al minimo edittale considerando una certa collaborazione in giudizio) . Il sig. Rossi andrebbe incontro anche al procedimento penale per omessa dichiarazione; tuttavia potrebbe puntare ad attenuanti o patteggiamento, specie se nel frattempo paga il dovuto. Si ricorda infatti che pagando tutte le imposte evase prima della dichiarazione dibattimentale si ottiene una causa di non punibilità per alcuni reati tributari, ma per l’omessa dichiarazione attualmente l’esimente opera solo se il pagamento integrale avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, condizione non rispettata qui (quindi Rossi può solo sperare in attenuanti generiche o patteggiamento con pena sospesa se incensurato).
Se invece la difesa riesce a far emergere delle zone grigie – ad esempio che effettivamente Rossi viveva mezza settimana a Londra, che la società sosteneva costi significativi in UK a riprova di attività locale – allora il giudice tributario potrebbe dare ragione al contribuente, annullando l’accertamento per difetto di prova dell’esterovestizione . In tal caso, verrebbe meno il presupposto anche per il penale (perché se Alfa Srl non è soggetto a obblighi fiscali in Italia, Rossi non avrebbe dovuto dichiarare nulla qui), quindi anche il procedimento penale decadrebbe .
Questa simulazione mostra come, in assenza di segnali netti di sostanza all’estero, difendersi sia difficile e incerto . Se Alfa Srl avesse sin dall’inizio avuto 2-3 dipendenti a Londra, un ufficio sempre aperto e metà dei clienti esteri, probabilmente non sarebbe neppure stata contestata; o, se contestata, avrebbe ottime chance di vittoria in giudizio . La lezione appresa è che, per chi vuole operare con società estere lecitamente, la sostanza economica e la trasparenza sono la miglior difesa.
Nel prossimo paragrafo, forniamo alcune tabelle riepilogative dei punti chiave – criteri di residenza fiscale e indicatori di genuinità del trasferimento – per consolidare i concetti discussi.
Tabelle riepilogative
Di seguito proponiamo alcune tabelle riassuntive dei punti chiave in materia di residenza fiscale e di indicatori di esterovestizione vs genuinità del trasferimento, anche alla luce delle novità 2024.
Tabella 1: Criteri di collegamento per la residenza fiscale delle società (prima e dopo la riforma 2024)
| Criterio | Fino al 2023 (normativa previgente) | Dal 2024 (D.Lgs. 209/2023) – Normativa vigente |
|---|---|---|
| Sede legale | Luogo indicato nell’atto costitutivo o statuto sociale (criterio formale). È sufficiente la sede legale in Italia per essere considerati residenti (purché per >183 giorni/anno). | (Invariato): Sede risultante da atto costitutivo/statuto. Resta criterio sufficiente di collegamento se in Italia per la maggior parte dell’anno. |
| Sede di direzione effettiva | Tradizionalmente intesa come “sede dell’amministrazione”, ossia luogo da cui partono le decisioni amministrative e gestionali di vertice. | Definita espressamente come il luogo in cui avviene continuamente e in modo coordinato l’assunzione delle decisioni strategiche sull’impresa (place of effective management). Se tale luogo è in Italia, la società è residente (criterio invariato ma chiarito). |
| Oggetto principale / Attività | “Oggetto principale” dell’attività sociale, determinato dall’atto costitutivo/statuto (o in mancanza, dall’attività effettivamente esercitata). Se l’oggetto principale si realizza in Italia, la società è residente. | Gestione operativa prevalente (nuovo): introdotta dal 2024, guarda all’attività d’impresa quotidiana svolta prevalentemente in Italia. È un criterio più concreto rispetto al generico oggetto sociale. Se la maggior parte dell’attività operativa si svolge in Italia, la società è considerata ivi residente. (Di fatto sostituisce e specifica il precedente “oggetto principale”). |
| Nota | I tre criteri sono alternativi: ne basta uno perché scatti la residenza fiscale italiana. Vige il principio del worldwide income per i soggetti residenti. In caso di doppia residenza con altro Stato, si applicano le regole dei trattati (tie-breaker). | (Immutato): la presenza in Italia di sede legale o sede effettiva o attività prevalente comporta residenza fiscale in Italia. In caso di doppia residenza, restano determinanti le convenzioni internazionali (che per le società tipicamente fanno prevalere la sede di direzione effettiva). |
Interpretazione pratica: Dal 2024 il legislatore italiano ha voluto chiarire e rafforzare il concetto di sostanza economica: se una società svolge in misura prevalente la sua gestione ordinaria in Italia, sarà considerata residente, anche se la sede legale o gli amministratori formali sono all’estero . Ciò impone ai contribuenti di prestare ancora più attenzione: non basta spostare “sulla carta” un’impresa all’estero se poi la produzione, il personale e l’amministrazione restano in Italia. Al contempo, avere la sola sede legale in Italia continua a far scattare la residenza (quindi, ad esempio, una società del Delaware con sede legale a Milano è residente italiana, anche se l’attività è altrove).
Tabella 2: Indicatori di trasferimento “genuino” vs “fittizio” (contribuente persona fisica)
Questa tabella confronta alcuni indicatori tipici per distinguere un espatrio reale da una residenza estera di comodo. (Molti di questi indici valgono anche per le società tramite le persone che le controllano: se soci e amministratori risiedono in Italia e qui hanno famiglia e interessi, la società estera sarà più facilmente ritenuta esterovestita; viceversa, decision-makers stabilmente all’estero indicano sostanza estera) .
| Aspetto | Trasferimento reale (genuino) | Trasferimento fittizio (di comodo) |
|---|---|---|
| Iscrizione anagrafica | Cancellazione dall’anagrafe italiana e iscrizione all’AIRE tempestiva. Comunicazioni formali di espatrio effettuate nei termini. Eventuale mantenimento di conti bancari e utenze all’estero intestati al contribuente. | Iscrizione AIRE tardiva o assente. Il contribuente è rimasto iscritto in Italia per lungo tempo dopo il presunto espatrio. Presenza ancora di conti bancari e utenze attive in Italia a suo nome. |
| Abitazione principale | Abitazione principale all’estero, con contratto di affitto o acquisto regolare, utenze (luce, gas, etc.) intestate e consumi effettivi in loco. Famiglia trasferita nell’abitazione estera, se presente. | Casa di proprietà (o disponibile) in Italia ancora utilizzata regolarmente dal contribuente. L’abitazione estera è solo saltuaria o di facciata (es. casa di parenti, o un Airbnb saltuario). La famiglia (coniuge/figli) è rimasta in Italia. |
| Presenza fisica | Il contribuente trascorre oltre 183 giorni/anno all’estero (anche non continuativi). Viaggi verso l’Italia solo per vacanze brevi o visite occasionali. | Il contribuente continua a passare molti mesi in Italia (sovente più di 183 giorni sommando le permanenze). Esempi: figli ancora a scuola in Italia; lunghi periodi in Italia “non dichiarati” o giustificati. |
| Interessi economici | Attività lavorativa e/o d’impresa svolta prevalentemente nel Paese estero. Conti bancari, investimenti finanziari e patrimonio principalmente localizzati all’estero. Anche la famiglia e le relazioni personali significative si sono trasferite con lui/lei. | Restano in Italia gran parte degli affari e interessi: cariche sociali operative in aziende italiane, proprietà di imprese o immobili in Italia non dismesse, cospicui conti bancari in Italia, etc. La famiglia (coniuge, figli) è rimasta in Italia. In sintesi, il centro degli interessi vitali appare ancora italiano. |
| Documentazione fiscale | Il contribuente presenta dichiarazioni dei redditi nel nuovo Stato e paga lì le imposte dovute sui propri redditi. Dispone di registrazioni/partita IVA locale se necessarie (es. iscritto a previdenza locale). | Il contribuente non risulta attivo fiscalmente all’estero (es. non presenta dichiarazioni nel nuovo Stato, perché magari non aveva realmente redditi colà). In compenso emergono documenti italiani incompatibili con la residenza estera dichiarata (utenze, contratti, spese sanitarie rimborsate in Italia, etc.). |
Questi indicatori sono utilizzati di fatto dall’Amministrazione finanziaria (e dalla Guardia di Finanza) nelle verifiche: ad esempio, controllano i tabulati di ingresso/uscita dal territorio, i consumi elettrici delle case, i social network per vedere dove vive la famiglia, ecc. . Nella sentenza Cass. 35284/2023 citata, emerse che il contribuente che dichiarava residenza a Dubai firmava ancora atti in Italia e aveva la famiglia a Milano: ciò contribuì a qualificare come fittizia la residenza estera .
Viceversa, se la persona riesce a mostrare che la sua vita è coerentemente spostata fuori (contratti, spese, iscrizioni vari), allora il Fisco farà fatica a sostenere la finzione. Nota: come evidenziato, molti di questi indici per le persone fisiche sono valutati anche per le società tramite i soggetti apicali . Se i decision-makers rimangono in Italia, è probabile che anche la società sia considerata residente in Italia.
Con queste tabelle, riassumiamo i criteri tecnici e pratici discussi nel testo, offrendo uno strumento di consultazione rapido. In particolare, dopo la riforma 2024, sarà ancora più importante valutare il luogo di effettivo svolgimento dell’attività di impresa come criterio di collegamento, e i contribuenti dovranno adeguarsi a queste definizioni.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo sinteticamente ad alcune domande comuni in materia di accertamenti per esterovestizione e ricavi esteri occulti, raccogliendo i concetti chiave emersi nella guida:
- D: Una società estera con amministrazione di fatto in Italia può essere accusata di esterovestizione anche se non possiede partecipazioni o beni in Italia?
R: Sì, è possibile. In tal caso non si applica la presunzione automatica dell’art. 73 co.5-bis TUIR (che richiede partecipazioni italiane per attivarsi), ma restano applicabili i criteri ordinari di residenza fiscale . Ciò significa che se di fatto la società è gestita dall’Italia (ad es. amministratore e uffici di fatto in Italia, affari condotti da qui), l’Agenzia Entrate può comunque accertarne la residenza italiana in base al criterio della sede di direzione effettiva. La differenza è che senza la presunzione specifica, l’onere della prova iniziale spetta al Fisco (deve fornire indizi solidi), mentre al contribuente spetterà poi la prova contraria. In sintesi: anche senza partecipazioni in Italia, una società estera rischia l’accertamento se è gestita dall’Italia, solo che il percorso probatorio è quello “generale” anziché basato su presunzioni legali . - D: Posso presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate per avere certezza preventiva sulla residenza fiscale della mia società estera?
R: In generale no, non è possibile ottenere un parere vincolante ex ante sulla propria residenza fiscale. L’Agenzia considera inammissibili gli interpelli su tale materia, in quanto la residenza è un fatto e non una disposizione tributaria da interpretare . Anche il cosiddetto interpello “disapplicativo” (per chiedere di non applicare la presunzione anti-esterovestizione ex art.73 co.5-bis) è stato sempre respinto dall’Agenzia . L’unica eccezione potrebbe essere un interpello nell’ambito di un grande investimento internazionale (ruling di cooperazione e trasparenza), ma parliamo di situazioni particolari e di elevato importo. Pertanto, il contribuente deve valutare da sé la propria situazione in base alle regole e affrontare l’eventuale verifica a posteriori, fornendo allora le prove. Non c’è modo di avere una “certificazione preventiva” di non esterovestizione. - D: Un certificato di residenza fiscale rilasciato dal Paese estero mi mette al riparo da accertamenti in Italia?
R: No, non automaticamente. Il certificato di residenza estero attesta che per lo Stato estero siete lì residenti, ma non vincola il Fisco italiano . Serve certamente per evitare doppie imposizioni (perché per applicare i benefici dei trattati spesso viene richiesto), ma in sede di accertamento l’Italia guarderà alla sostanza: se tutti gli indizi dimostrano che in realtà vivevate/operavate in Italia, il certificato verrà considerato un elemento secondario e superabile. La Cassazione lo ha ribadito: «un certificato di residenza all’estero è solo un elemento formale e marginale» se i fatti concreti indicano una gestione in Italia . Quindi è utile averlo, ma va corroborato con altre prove sostanziali (contratti di affitto, bollette estere, ecc.) per avere peso. Un certificato di residenza all’estero, presentato anche tardivamente, può essere considerato valido ai fini convenzionali purché attesti la soggettività fiscale estera in quegli anni , ma da solo non basta a evitare l’accertamento se la realtà fattuale smentisce. - D: Se la mia società estera viene considerata fiscalmente residente in Italia, rischio di pagare le tasse due volte sugli stessi redditi (estero + Italia)?
R: L’obiettivo del Fisco italiano è tassare in Italia i vostri redditi mondiali; però non può ignorare completamente quanto avete già pagato all’estero. In base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, avete diritto a un credito d’imposta per le imposte estere pagate sui redditi che l’Italia sottopone a tassazione . Ad esempio, se la società ha pagato €10.000 di tasse all’estero e in Italia per quei redditi ne sarebbero dovuti €15.000, l’Italia vi chiederà la differenza (€5.000) . Se invece all’estero non avete pagato nulla (caso tipico dei paradisi fiscali), l’Italia potrà esigere l’intero ammontare come se nulla fosse stato versato. In pratica quindi, non si ha una “doppia tassazione integrale”, ma un’integrazione: si finisce per pagare in totale il più alto tra il livello estero e quello italiano. Attenzione: per ottenere il credito d’imposta dovete documentare accuratamente le imposte pagate fuori (certificati del fisco estero, ricevute) . Inoltre, se il Paese estero non ha un trattato con l’Italia, potrebbe essere più complesso ottenere questo riconoscimento o potreste incorrere nel limite del credito per imposte estere. In sintesi: non subirete una duplice tassazione piena grazie ai meccanismi di credito, ma se all’estero avete pagato poco o nulla, dovrete pagare quasi tutto in Italia. - D: Quali accorgimenti devo adottare per evitare di incorrere in contestazioni di esterovestizione?
R: In generale, dare sostanza reale al trasferimento all’estero. Consigli pratici principali:
– Mantenere un assetto operativo effettivo nel Paese estero: avere un ufficio vero (anche piccolo), con utenze e contratti intestati alla società lì; valutare di avere personale o collaboratori locali .
– Mix nella governance: evitare che tutti gli amministratori siano italiani residenti in Italia; nominare se possibile amministratori o procuratori residenti sul posto che partecipino effettivamente alla gestione .
– Documentare le decisioni all’estero: tenere verbali dettagliati di ogni riunione importante, indicando come luogo di svolgimento l’estero; conservare biglietti di viaggio che provino la presenza fisica degli interessati fuori Italia nelle date delle riunioni .
– Limitare al minimo i legami con l’Italia: es., se la società estera interagisce con aziende italiane del vostro gruppo, fate che i rapporti siano a condizioni di mercato e non “di comodo”; se avete ancora beni personali in Italia, valutate di spostarli all’estero se coerente col trasferimento. Ogni ancora in Italia (casa, famiglia, auto, conti bancari) è un elemento che potrebbe generare sospetti .
In sintesi, ogni aspetto – sia strutturale che comportamentale – deve confermare che attività e interessi sono davvero radicati all’estero . Solo così potrete dimostrare che il trasferimento è genuino e non fittizio. Se invece la vostra vita/business restano in Italia e all’estero c’è solo una targhetta su una porta, sarà questione di tempo prima che il Fisco lo contesti. - D: In caso di verifica fiscale, è consigliabile rispondere e fornire documenti o è meglio tacere?
R: È in genere consigliabile collaborare in modo attivo ma accorto. Durante la verifica (es. questionari, accessi, richiesta documenti), non rispondere affatto o ostacolare i verificatori è controproducente . Mostrarsi collaborativi, fornendo i documenti richiesti e spiegazioni, può persino evitare che l’ufficio assuma posizioni più dure. Ovviamente ogni risposta va calibrata con il supporto di un professionista, per non ammettere fatti inesatti. Ma in linea di massima:
– Se l’ufficio chiede spiegazioni o convoca per contraddittorio, è un’occasione da non perdere: potete mettere agli atti le prove a vostro favore prima che l’atto sia emesso .
– Quando fornite documenti, assicuratevi che siano completi e autentici; se omettete qualcosa di rilevante e il Fisco poi lo scopre, perderete credibilità.
– Memorie difensive: presentare una memoria scritta durante il contraddittorio preventivo può aiutare a fissare la vostra posizione e obbligare l’ufficio a valutarla.
– Unica cautela: nel caso di potenziali reati, attenzione a non auto-incriminarsi inutilmente: va trovato un equilibrio tra collaborazione amministrativa e tutela penale (in certi casi è bene che risponda il consulente per vostro conto, mantenendo voi il silenzio su aspetti rischiosi sul piano penale). In conclusione, il muro di silenzio totale raramente paga: meglio costruire fin da subito la vostra difesa anche in fase pre-contenziosa, fornendo elementi a discarico (documentali) e spiegazioni alternative dei fatti contestati. Ciò potrà essere utile più avanti anche in giudizio. - D: Che succede se, durante il contenzioso, decido di pagare le imposte contestate? Evito il penale?
R: Pagare interamente il dovuto (imposte, sanzioni, interessi) può influire positivamente ma non garantisce di evitare il penale in tutti i casi. Dipende dal reato: per i reati di omesso versamento (ritenute o IVA) esiste una causa di non punibilità se il pagamento avviene prima dell’apertura del dibattimento, ma per reati come omessa dichiarazione o dichiarazione fraudolenta la legge attuale prevede la non punibilità solo se il pagamento integrale avviene entro termini molto anticipati (es. per omessa dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva) . Nella pratica di questi casi, il pagamento tardivo non esclude il reato ma viene valutato come circostanza attenuante e spesso consente di accedere al patteggiamento con pene ridotte (spesso sospese se incensurati). Quindi, pagare durante il contenzioso tributario è comunque consigliabile se si hanno le risorse:
– Si riducono interessi e sanzioni (ad esempio con acquiescenza o conciliazione le sanzioni calano).
– Si mostra buona volontà al giudice penale, che potrebbe concedere attenuanti per condotta riparatoria.
Però, attenzione: se pagate integralmente prima della sentenza tributaria definitiva, rischiate di non poter più proseguire il contenzioso sul merito (perché l’atto verrebbe definito). Potete eventualmente pagare in adesione o conciliazione, chiudendo la lite. In sede penale, la Cassazione penale n.7140/2024 (che riguardava proprio esterovestizione) ha ribadito che l’iscrizione AIRE o il pagamento tardivo non salvano dall’accusa di dichiarazione infedele se in realtà c’era obbligo di dichiarare in Italia . Quindi in sintesi: il pagamento aiuta ma non cancella il penale (salvo casi limitati). È opportuno far valutare da un legale il momento migliore e le modalità (ad es. patteggiare nel penale contestualmente al pagamento).
Abbiamo dunque affrontato i dubbi più comuni. Per concludere, riepiloghiamo i punti essenziali: la contestazione di esterovestizione è insidiosa, ma esistono spazi di difesa basati sul principio di realtà . Dal punto di vista del contribuente, è fondamentale reagire con lucidità e tempestività, raccogliendo prove e sollevando tutte le eccezioni possibili, senza scoraggiarsi.
Conclusione
Le contestazioni per utilizzo di società di comodo all’estero rappresentano una materia complessa e insidiosa, dove il confine tra lecito risparmio d’imposta e condotta elusiva/evasiva è sottile . L’ordinamento italiano, sostenuto dai principi internazionali, mette a disposizione del Fisco strumenti robusti per smascherare esterovestizioni e colpire duramente chi tenta di sottrarsi alle proprie obbligazioni tributarie. D’altro canto, il contribuente ha ancora spazi di difesa importanti, basati sul principio di realtà: se realmente l’attività è svolta altrove, ciò può (e deve) essere provato e riconosciuto.
Dal punto di vista del debitore sotto accertamento, è fondamentale non scoraggiarsi e attivarsi prontamente: analizzare in dettaglio la contestazione, raccogliere le prove a discarico, verificare il rispetto delle garanzie procedurali (contraddittorio, motivazione, termini), e impostare una strategia integrata fiscale-penale . Come abbiamo visto, non tutte le contestazioni sono fondate: in diversi casi i contribuenti sono riusciti a dimostrare la legittimità delle proprie scelte e a far valere i propri diritti, soprattutto quando l’Amministrazione aveva agito in modo troppo automatico o ignorando la sostanza dei fatti .
In definitiva, una contestazione per esterovestizione può essere respinta con solide argomentazioni giuridiche e prove concrete. Una pianificazione preventiva oculata, unita a una difesa tempestiva e competente, permette di tutelare l’impresa o il contribuente, dimostrando la legittimità delle proprie operazioni e riducendo al minimo i rischi fiscali e penali . Sempre meglio agire in anticipo (dotandosi di sostanza economica e consulenza qualificata) che dover correre ai ripari: la miglior difesa contro le contestazioni fiscali internazionali resta una corretta pianificazione e trasparenza sin dall’origine . In ogni caso, se vi trovate a fronteggiare un’accusa di aver usato una società di comodo all’estero, sappiate che esistono strumenti e precedenti per far valere le vostre ragioni – specie quando queste sono supportate dai fatti . Procedete con rigore, fatti alla mano e con l’assistenza di esperti: la vostra difesa comincia da una preparazione solida e informata.
Fonti e riferimenti (normativa, giurisprudenza, prassi)
- Normativa primaria:
– D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), artt. 2 (residenza persone fisiche) e 73 (residenza società) .
– D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32 (presunzioni da indagini finanziarie).
– D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (sanzioni tributarie amministrative).
– D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, artt. 4, 5, 11 (reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta) .
– L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 10-bis (abuso del diritto, non punibilità penale), art. 12 (diritti del contribuente in verifica, contraddittorio).
– Legge delega 9 agosto 2023 n. 111 (riforma fiscale) e D.Lgs. 29 dicembre 2023 n. 209 (attuazione in materia di fiscalità internazionale) .
– D.Lgs. 2 ottobre 2023 n. 123 (attuazione delega processo tributario – introd. prova testimoniale scritta).
– D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 16, c.1-bis (obbligo contraddittorio dal 2020 per alcuni atti). - Liste e decreti Ministeriali:
– D.M. 4 maggio 1999 (individuazione Stati a fiscalità privilegiata ai fini art. 2 co.2-bis TUIR) .
– D.M. 21 novembre 2001 e succ. mod. (individuazione Paesi Black list ai fini CFC, ora abrogati sostituiti da criteri).
– D.M. 30 marzo 2015 (White list Stati collaborativi scambio informazioni, aggiornato con D.M. 5.5.2023 in G.U. n.110/2023) .
– EU list of non-cooperative jurisdictions (black list UE) – Consiglio UE Ecofin, elenco aggiornato al 18 febbraio 2025 (11 Paesi) .
– D.L. 4/2014 conv. L. 50/2014, art. 1 (Voluntary Disclosure 2015) – rimozione Svizzera & co. da black list. - Prassi amministrativa:
– Circolare Ag. Entrate n. 9/E del 1° aprile 2015, §2 (linee guida accertamenti internazionali, deduzione costi in induttivo) .
– Circolare Ag. Entrate n. 38/E del 2018, (esterovestizione persone fisiche, analisi indici – vedi anche Ris. 72/E/2016).
– Circolare Ag. Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024, “Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale di persone fisiche e società” (chiarimenti su criteri sede effettiva e gestione prevalente post D.Lgs.209/23).
– Risoluzione Ag. Entrate n. 340/E del 2008 (interpello art. 73 co.5-bis TUIR – inammissibilità per questione fattuale) .
– Risposta a interpello n. 956-8/2018 DRE Lombardia (residenza societaria – inammissibilità interpello disapplicativo, valutazioni caso per caso). - Giurisprudenza nazionale – Cassazione Civile (Tributaria):
– Cass. civ. Sez. Trib. 25 agosto 2025 n. 23842 – Esterovestizione: è abusiva solo se c’è costruzione di puro artificio; effettiva attività economica all’estero esclude la contestazione .
– Cass. civ. Sez. Trib. 2 febbraio 2025 n. 2464 – Presunzione di distribuzione utili extracontabili ai soci: il socio può vincerla provando la propria assoluta estraneità alla gestione .
– Cass. civ. Sez. VI-5, 18 dicembre 2023 n. 35284 – Contribuente trasferito negli Emirati: criteri convenzionali prevalgono su presunzione interna; sufficienza tie-breaker treaty anche se UAE no tax .
– Cass. civ. Sez. Trib. 7 febbraio 2024 n. 3386 – Trasferimento in Slovacchia (UE): abuso libertà di stabilimento solo se struttura puramente artificiosa; ribadito criterio direzione effettiva da verificare in concreto .
– Cass. civ. Sez. V, 4 febbraio 2021 n. 2581 – Accertamento induttivo su stabile organizzazione occulta: obbligo di dedurre i costi dai ricavi accertati (pena violazione art.53 Cost.), anche in caso di omessa dichiarazione .
– Cass. civ. Sez. V, 25 marzo 2021 n. 07640 (ord.) – Residenza estera fittizia, onere prova a carico contribuente; irrilevanza certificato estero se fatti contrari.
– Cass. SS.UU. 13 marzo 2018 n. 6487 – Esterovestizione: presunzione art.2 co.2-bis TUIR (ante 2024) legittima in chiave cost., i criteri convenzionali prevalgono se individuano residenza estera.
– Cass. pen. Sez. III, 19 novembre 2019 n. 30933 – Reato sottrazione fraudolenta art.11: non sussiste se beni conferiti in società controllata dal debitore (disponibilità indiretta mantiene patrimonio aggredibile) .
– Cass. pen. Sez. II, 23 febbraio 2024 n. 7140 – Esterovestizione e reati: obbligo presentazione dichiarazione in Italia per socio amministratore di fatto società estera fittizia; iscrizione AIRE non esclude reato se redditi imponibili in Italia ; (conferma configurabilità reato omessa dichiarazione).
– Cass. pen. Sez. III, 30 settembre 2020 n. 27555 – Esterovestizione come dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3) se attuata con schermi societari e false rappresentazioni (orient. minoritario). - Giurisprudenza UE:
– Corte di Giustizia UE, causa C-196/04 (Cadbury Schweppes, 12/9/2006) – Libertà di stabilimento: non costituisce abuso costituire società in Stato membro a tassazione favorevole, salvo siano entità fittizie prive di reale attività (concetto di “wholly artificial arrangement”) .
– Corte di Giustizia UE, causa C-115/16 (N Luxembourg 1, 26/2/2019) – Abuso di diritto in ambito direttive madre-figlia: necessità sostanza economica, no benefici a società conduit. (Rif. per concetto sostanza vs artificio). - Altro:
– CTR Abruzzo Sez. Pescara n. 190/2021 – Contribuente a Dubai: riconosciuta esclusiva potestà impositiva Emirati in base a convenzione, annullato accertamento (confermato poi da Cass. 35284/23) .
– Assonime, Circolare n. 15/2024 – Approfondimenti su criteri residenza societaria post-riforma (segnala dubbi interpretativi rimasti aperti) .
– OECD Model Tax Convention art. 4 e Commentaries – Tie-breaker per dual residence (persone fisiche e giuridiche).
– Direttiva (UE) 2022/16XX “Unshell” (ATAD 3) – Proposta di norme per prevenire l’uso improprio di entità di comodo a fini fiscali (approvata Parlamento UE 17/1/2023; in discussione in Consiglio).
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestati ricavi occultati tramite società estere? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestati ricavi occultati tramite società estere?
Vuoi sapere cosa rischi e come impostare una difesa efficace?
👉 Prima regola: dimostra la realtà operativa delle società estere e la legittimità delle operazioni transfrontaliere, per evitare che vengano considerate mere “società schermo”.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Utilizzo di società estere in Paesi a fiscalità privilegiata per fatturare servizi o prodotti;
- Ricavi transitati su conti esteri non riportati nelle dichiarazioni italiane;
- Contestazioni di stabile organizzazione occulta in Italia;
- Operazioni infragruppo ritenute fittizie o non giustificate;
- Utilizzo di società controllate estere solo per ridurre il carico fiscale.
📌 Conseguenze della contestazione
- Recupero delle imposte sui ricavi ritenuti occultati;
- Sanzioni fiscali molto elevate per dichiarazione infedele o omessa;
- Interessi di mora sulle somme accertate;
- Contestazioni di esterovestizione con attribuzione di residenza fiscale in Italia;
- Rischio di procedimenti penali per dichiarazione fraudolenta o riciclaggio.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- La società estera aveva una reale operatività (uffici, personale, attività commerciale)?
- I ricavi erano già tassati nel Paese estero con diritto al credito d’imposta?
- Le operazioni erano giustificate da contratti, fatture e documentazione commerciale?
- L’Agenzia delle Entrate si è basata su presunzioni di comodo o su prove concrete?
- È stata rispettata la normativa sulle Controlled Foreign Companies (CFC)?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Bilanci e dichiarazioni fiscali delle società estere;
- Contratti commerciali e documenti giustificativi delle operazioni;
- Estratti conto bancari e prove dei pagamenti;
- Documentazione su uffici, dipendenti e strutture delle società estere;
- Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la sostanza economica e l’operatività reale delle società estere;
- Contestare la presunzione di occultamento dei ricavi;
- Fare valere il credito d’imposta estero per evitare la doppia imposizione;
- Evidenziare la corretta applicazione delle regole sulle CFC;
- Eccepire vizi di motivazione o errori di calcolo nell’accertamento;
- Richiedere annullamento in autotutela o presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria;
- Difesa penale mirata in caso di contestazioni per frode internazionale.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza i rapporti societari e i flussi finanziari con l’estero;
📌 Valuta la fondatezza della contestazione e individua i margini difensivi;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta nei giudizi fiscali e nei procedimenti penali;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione fiscale sicura delle società estere.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario internazionale;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni su ricavi esteri, CFC ed esterovestizione;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Gli accertamenti fiscali per ricavi occultati tramite società estere non sempre sono fondati: spesso derivano da presunzioni generiche o da interpretazioni restrittive della normativa internazionale.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la legittimità delle operazioni, ridurre drasticamente sanzioni e interessi ed evitare la doppia imposizione.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti fiscali su società estere inizia qui.