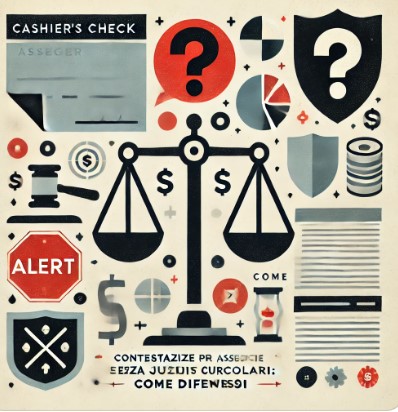Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per assegni circolari senza giustificazione? In questi casi, l’Ufficio presume che l’emissione o l’incasso degli assegni rappresenti compensi occultati, redditi non dichiarati o movimenti finanziari sospetti non collegati a operazioni documentate. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni elevate e, nei casi più complessi, possibili segnalazioni penali. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la natura non reddituale degli assegni contestati.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta assegni circolari
– Se l’assegno circolare non trova riscontro in fatture, contratti o registrazioni contabili
– Se l’importo risulta sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati
– Se vi sono movimenti bancari sospetti collegati all’emissione o all’incasso
– Se mancano giustificazioni documentali sulla provenienza o destinazione delle somme
– Se l’Ufficio presume che l’assegno rappresenti pagamento di operazioni in nero o trasferimento occulto di capitali
Conseguenze della contestazione
– Recupero a tassazione degli importi ritenuti privi di giustificazione
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Possibili accertamenti patrimoniali estesi su altri rapporti bancari e finanziari
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o occultamento di redditi
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare la reale natura degli assegni (prestiti tra privati, donazioni, restituzioni di somme, rimborsi)
– Produrre scritture private, contratti, ricevute e documentazione bancaria a supporto
– Contestare l’automatica presunzione che ogni movimento costituisca reddito imponibile
– Evidenziare errori di calcolo, carenze istruttorie o difetti di motivazione nell’avviso di accertamento
– Richiedere la riqualificazione delle somme per ridurre le sanzioni applicabili
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare i movimenti bancari e gli assegni circolari oggetto di contestazione
– Verificare la legittimità delle presunzioni fiscali utilizzate dall’Agenzia delle Entrate
– Predisporre un ricorso basato su prove concrete e vizi formali dell’accertamento
– Difendere il contribuente davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e familiare da contestazioni fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– Il riconoscimento della natura non reddituale delle somme movimentate
– La riduzione o cancellazione delle sanzioni e degli interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: gli assegni circolari sono tra gli strumenti più monitorati dal Fisco, perché spesso utilizzati per trasferimenti di somme elevate. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata per evitare conseguenze economiche e penali pesanti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – spiega come difendersi in caso di contestazioni per assegni circolari senza giustificazione e quali strategie adottare per tutelare i tuoi interessi.
👉 Hai ricevuto una contestazione per assegni circolari senza giustificazione? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la legittimità della pretesa e costruiremo la strategia difensiva più efficace per proteggere i tuoi interessi.
Cosa si intende per “assegno circolare senza giustificazione”
Un assegno circolare è un particolare titolo di credito emesso da una banca (previa cauzione dell’importo) che contiene la promessa di pagare a vista una somma determinata al beneficiario indicato . Si tratta di uno strumento di pagamento sicuro e garantito, poiché la banca emittente si impegna direttamente al pagamento . In sostanza, l’assegno circolare funziona come contante bancario: chi lo riceve ha la certezza di poterlo incassare . Proprio per questa natura “quasi monetaria”, l’assegno circolare viene spesso utilizzato in transazioni di importo elevato (es. compravendite immobiliari) o in alternativa ai contanti.
“Senza giustificazione” significa che l’operazione finanziaria sottesa all’assegno non presenta una causale o documentazione che la spieghi in modo chiaro e tracciabile. In altre parole, si parla di assegni circolari non collegati a un’obbligazione giustificativa apparente, come ad esempio una fattura, un contratto registrato, una quietanza con causale, ecc. Tipicamente, rientrano in questa categoria:
- Assegni circolari incassati senza titolo: somme ricevute tramite assegno circolare sul proprio conto (o cambiando l’assegno in contanti) senza poter indicare un motivo legittimo (vendita, prestito, donazione formale, etc.). Ad esempio, un professionista che incassa assegni dal cliente senza emettere fattura, o un privato che riceve da terzi importi ingenti senza un contratto scritto. In tali casi il Fisco tende a presumere che siano ricavi in nero .
- Assegni circolari emessi senza causa apparente: somme pagate dal debitore a terzi con assegno circolare in assenza di un debito certo o di una controprestazione. Esempi: donazioni di denaro a familiari non formalizzate, restituzione di somme mai ricevute in prestito, pagamenti fittizi per simulare acquisti. Tali atti possono essere visti come distrazioni patrimoniali a danno dei creditori (se il debitore ha debiti pregressi) oppure come operazioni anomale meritevoli di indagine (specie se il contesto suggerisce tentativi di occultamento di capitali).
- Movimentazioni finanziarie atipiche mediante assegni circolari: l’uso dell’assegno circolare al posto di strumenti ordinari può destare sospetti se ricorre in modo inusuale. Ad esempio, un imprenditore che preleva dal conto grosse somme facendosi emettere assegni circolari intestati a se stesso o a fidati prestanome, cambiati poi in contanti, senza indicarne il motivo. Tale schema potrebbe far pensare a manovre per eludere la tracciabilità (possibile riciclaggio o sottrazione di beni ai creditori).
In tutti questi frangenti, l’assegno circolare “senza giustificazione” diventa oggetto di contestazione da parte di diverse autorità o soggetti: l’Agenzia delle Entrate in ambito tributario, la Procura della Repubblica in ambito penale, oppure i creditori privati (banche, fornitori, ex coniugi, ecc.) in ambito civile. Vediamo nel dettaglio quando scatta la contestazione, quali sono le conseguenze e soprattutto come può difendersi il soggetto coinvolto (in qualità di contribuente, imputato o debitore civile).
⚖️ Perché scatta la contestazione
Le operazioni con assegni circolari prive di giustificazione formale accendono diversi campanelli d’allarme. Ecco le situazioni più comuni che portano a contestazioni:
- Accertamenti finanziari del Fisco – Nel corso di verifiche bancarie, l’Agenzia delle Entrate rileva accrediti da assegni circolari sul conto di un contribuente (professionista, imprenditore o anche privato) non supportati da giustificazioni contabili o documentali. Ad esempio, versamenti sul conto di uno studio legale per decine di migliaia di euro tramite assegni circolari, di cui non v’è traccia nelle fatture o nelle scritture contabili: ciò fa presumere che siano compensi non dichiarati . Analogamente, cambiare un assegno circolare in contanti (senza transitare dal conto) è considerato un movimento “extra-conto” equiparabile a un versamento sul conto stesso , dunque suscettibile di accertamento. In generale, ogni euro incassato senza giustificazione in banca può essere considerato reddito occulto dal Fisco .
- Procedure esecutive e tutela dei creditori – Se un debitore, mentre ha debiti in essere, dispone del proprio patrimonio attraverso assegni circolari senza corrispettivo (tipicamente donando somme a terzi o pagando debiti non ancora esigibili), i creditori possono ritenersi pregiudicati. Un atto di disposizione riduce la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., e se compiuto in frode alle ragioni creditorie può essere attaccato con azione revocatoria o con altre azioni (come la simulazione o, in casi estremi, denunce per sottrazione fraudolenta di beni). Ad esempio, un imprenditore prossimo al default che emette assegni circolari ai familiari “in regalo” potrebbe vedere tali atti contestati dai creditori come donazioni revocabili (se il credito è anteriore) o come atti simulati tesi a sottrarre attivo.
- Indagini per riciclaggio ed evasione fiscale – L’utilizzo di assegni circolari è monitorato anche in ottica antiriciclaggio. Importanti flussi finanziari attraverso assegni circolari, specie se frazionati in importi sotto soglia o girati tramite terzi, insospettiscono la Guardia di Finanza e la magistratura. Un caso tipico: assegni circolari emessi da società fittizie, girati a persone compiacenti e subito incassati in contanti per restituire il denaro “pulito” ai veri beneficiari (spesso evasori). La Cassazione ha qualificato queste operazioni come riciclaggio, perché idonee a ostacolare l’accertamento della provenienza illecita dei fondi . Anche in assenza di complesse triangolazioni, prelevare l’intero saldo dal proprio conto tramite assegno circolare durante una riscossione coattiva può far ipotizzare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000), se si dimostra che era un atto volto a rendere inefficace la riscossione.
In sintesi, la mancanza di una giustificazione trasparente per operazioni con assegni circolari fa scattare presunzioni legali e sospetti di atti illeciti. Il professionista o imprenditore rischia un accertamento tributario per redditi non dichiarati; il privato debitore rischia azioni legali dei creditori per inefficacia degli atti dispositivi; in casi più gravi, possono aprirsi fronti penali per reati tributari o di riciclaggio.
Conseguenze possibili
Le conseguenze della contestazione di assegni circolari senza giustificazione variano a seconda dell’ambito in cui viene mossa la contestazione, ma possono essere molto gravose. Ecco un quadro generale delle potenziali ricadute:
- In ambito tributario (accertamento fiscale): l’Agenzia delle Entrate può recuperare a tassazione le somme contestate come redditi non dichiarati, applicando le relative imposte (Irpef, Ires o Irap, e IVA se pertinente) . A ciò si aggiungono sanzioni amministrative pesanti, tipicamente dal 90% al 180% dell’imposta evasa su ciascun importo non dichiarato (D.Lgs. 471/1997) . Inoltre sono dovuti gli interessi di mora maturati. Se le somme sono consistenti e riferite a più anni, l’ufficio può effettuare accertamenti retroattivi fino a 5 anni (o 7 anni in caso di omessa dichiarazione) precedenti. In casi eclatanti, scatta la segnalazione alla Procura per reati di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione (D.Lgs. 74/2000), ad esempio se l’imposta evasa supera €100.000 annui . Ciò apre un procedimento penale parallelo per evasione fiscale, con rischio di sanzioni penali (multa e reclusione) oltre alle sanzioni tributarie.
- In ambito penale: se l’assegno circolare viene collegato a condotte illecite, le conseguenze possono essere molto serie. Per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ad esempio, sono previste pene detentive da 4 a 12 anni di reclusione (oltre a multe elevate) per chiunque sostituisca o trasferisca denaro di provenienza delittuosa ostacolandone l’identificazione . Nel caso di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., introdotto dal 2015) – quando il denaro proviene da un proprio reato, tipicamente evasione fiscale – le pene vanno da 2 a 8 anni. Vi è poi il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000): esso punisce con reclusione da 6 mesi a 4 anni chi compie atti fraudolenti (come alienazioni simulate o altri artifici) per evitare il pagamento di imposte o sanzioni. Emettere assegni circolari per distrarre attivamente fondi durante una procedura esattoriale può integrare tale reato; se accertato, si rischiano sequestri preventivi e, in caso di condanna, la confisca delle somme equivalenti (oltre alla pena detentiva) . Infine, nell’ipotesi di fallimento, atti come pagamenti o donazioni effettuati prima del fallimento senza giusta causa possono comportare l’incriminazione per bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 L.Fall.), un reato gravissimo con pene da 3 a 10 anni: il fallito che ha regalato beni o denaro pregiudicando la massa attiva risponde penalmente di aver dolosamente dissipato il patrimonio ai danni dei creditori.
- In ambito civile: il principale effetto è la possibile inefficacia degli atti di disposizione compiuti tramite gli assegni contestati. Un creditore che agisce con successo in azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) ottiene una sentenza che dichiara inefficace nei suoi confronti l’atto compiuto dal debitore in frode alle sue ragioni . In pratica, l’assegno circolare elargito senza giustificazione viene “annullato” nei confronti di quel creditore: ad esempio, se Tizio (debitore) ha donato €50.000 a Caio tramite assegno circolare e Caio li ha incassati, il creditore di Tizio potrà aggredire quella somma come se fosse ancora nel patrimonio di Tizio (pretendendo la restituzione da Caio, nei limiti del suo arricchimento). L’atto resta valido fra debitore e terzo, ma non opponibile al creditore vittorioso. Se il terzo (beneficiario dell’assegno) nel frattempo ha speso o nascosto il denaro, il creditore potrà comunque escuterlo sui suoi beni. Inoltre, se l’atto era a titolo gratuito (es. donazione), al creditore non serve provare la malafede del terzo per revocarlo ; ciò rende molto vulnerabili i trasferimenti gratuiti come i regali di somme di denaro, specie tra parenti (dove spesso la scientia fraudis – consapevolezza del danno ai creditori – è presunta dato il rapporto di parentela ). In aggiunta alla revocatoria, in certi casi il creditore può far valere la simulazione di atti che nascondono una donazione: ad esempio, se un assegno circolare è apparentemente il pagamento di un prezzo per un bene, ma in realtà il denaro è rientrato al disponente (pagamento fittizio), il creditore può chiedere di dichiarare simulata la compravendita, con effetti ancor più incisivi (l’atto simulato è nullo ed il bene torna direttamente aggredibile come proprietà del debitore) . Sul piano procedurale, il debitore che subisce tali azioni può dover affrontare cause lunghe e costose: giudizi civili in tribunale, con spese legali e rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza. Inoltre, finché pende la causa, il bene o le somme in questione possono essere cautelati (es. con sequestro conservativo richiesto dal creditore, se ne ricorrono i presupposti).
In ogni caso, le conseguenze sopra descritte evidenziano che la posta in gioco è alta: tassazione retroattiva con sanzioni, processi penali e perdita di denaro o beni trasferiti. È quindi fondamentale, per chi si trova in tali circostanze, approntare una strategia difensiva adeguata per neutralizzare o attenuare queste conseguenze. Passiamo ora ad esaminare dettagliatamente come difendersi nei vari ambiti (tributario, penale, civile), poiché le strategie e gli strumenti variano sensibilmente.
Contestazione in ambito tributario (accertamenti finanziari del Fisco)
In ambito fiscale la questione degli assegni circolari non giustificati rientra nella disciplina degli accertamenti bancari e finanziari. L’ordinamento tributario italiano (art. 32, comma 1, n.2 del D.P.R. 600/1973) prevede una presunzione legale relativa secondo cui i versamenti bancari non giustificati dal contribuente vengono considerati dal Fisco come ricavi o compensi non dichiarati . Questa presunzione – definita iuris tantum – inverte l’onere della prova: è sufficiente, per l’Ufficio, il dato oggettivo del versamento non spiegato, e spetta al contribuente dimostrare che quelle somme non costituiscono reddito imponibile .
Come si applica la presunzione agli assegni circolari? La giurisprudenza ha chiarito che anche le operazioni fatte fuori conto corrente, come l’incasso diretto di un assegno circolare cambiato in contanti, rientrano nella categoria dei “versamenti” presunti reddito . Infatti, benché in tal caso la somma non transiti formalmente sul conto, viene comunque introitata dall’interessato (l’assegno viene cambiato in contanti presso la banca emittente) e quindi rappresenta un incremento patrimoniale per il contribuente . La Cassazione n. 8718/2021 ha enunciato al riguardo un principio di diritto chiaro: le operazioni bancarie extra-conto, quali l’incasso di assegni circolari, sono equiparabili ai versamenti e rientrano tra gli importi presuntivamente imponibili ex art. 32 DPR 600/1973 . Dunque, non esiste un rifugio nel “fuori conto”: anche se l’assegno circolare non è versato sul proprio conto ma riscosso allo sportello, il Fisco – se ne viene a conoscenza – lo tratterà come un ricavo non dichiarato, salvo prova contraria.
Chi è soggetto a tale presunzione? In passato si discuteva se la presunzione valesse solo per imprenditori e professionisti (tenuti alle scritture contabili) o anche per i privati cittadini. La situazione attuale, alla luce delle modifiche normative del 2016 e delle sentenze della Corte Costituzionale, è riassunta nella tabella seguente :
| Contribuente | Versamenti non giustificati | Prelievi non giustificati |
|---|---|---|
| Imprese (società, ditte individuali) | Presunzione di ricavi occulti. Ogni accredito non registrato è imputato a ricavo non dichiarato . | Presunzione di acquisti in nero (conseguente a vendite non fatturate) oltre una soglia di tolleranza introdotta dal 2016: nessuna presunzione per prelievi fino a €1.000 giornalieri e €5.000 mensili; oltre tali limiti, i prelevamenti ingiustificati alimentano la presunzione di costi “in nero” e quindi di ricavi sottratti . (Questa limitazione è rivolta alle imprese; per i versamenti non c’è soglia di esenzione.) |
| Lavoratori autonomi (professionisti) | Presunzione di compensi non dichiarati per accrediti su conti del professionista non giustificati . (Dopo Corte Cost. n.228/2014, i prelievi dei soli professionisti non generano più presunzioni: è irragionevole supporre che un avvocato o medico faccia prelievi per acquistare materie prime in nero. Il legislatore ha recepito eliminando dal 2016 la presunzione sui prelievi per i redditi di lavoro autonomo.) | Nessuna presunzione sui prelievi dai conti dei soli lavoratori autonomi (come sopra). I prelievi dei professionisti non possono più essere contestati come compensi non dichiarati . |
| Privati (es. lavoratori dipendenti, pensionati, soggetti senza P.IVA) | Presunzione di altri redditi non dichiarati (redditi diversi) per versamenti inspiegati . La norma (art. 32) è formulata in termini generali e la giurisprudenza l’ha estesa anche ai non imprenditori, ritenendo la presunzione erga omnes . Ad esempio, un insegnante che versa sul conto somme anomale dovrà giustificarle (il Fisco potrebbe ipotizzare ripetizioni private in nero, affitti non dichiarati, vincite non dichiarate, ecc.) . | Formalmente la legge non prevede presunzione sui prelievi per i privati non esercenti impresa o arte. (Comunque, trattandosi di utilizzi personali di denaro già tassato o esente, questi movimenti di per sé non generano contestazioni fiscali in base all’art.32). |
Nota: la presunzione opera anche per i conti intestati a terzi se l’Amministrazione prova (anche per presunzioni semplici) che il contribuente ne aveva di fatto la disponibilità . Ad esempio, è frequente che il Fisco esamini conti cointestati con familiari, o conti intestati a soci/amministratori in caso di piccole imprese familiari, per verificare se siano stati usati come schermo per entrate non dichiarate . La Cassazione ha ritenuto legittimo imputare a una società familiare i versamenti sul conto personale del socio, se si prova che quel conto serviva a canalizzare ricavi della società non contabilizzati .
In concreto, come avviene la contestazione? L’Agenzia delle Entrate tipicamente invia al contribuente un questionario o invito a chiarimenti sulle movimentazioni sospette. Se le spiegazioni fornite non sono ritenute sufficienti o il contribuente non risponde, viene emesso un avviso di accertamento che ridetermina il reddito imponibile includendo gli importi degli assegni circolari non giustificati. È a quel punto che il contribuente (debitore d’imposta presunto) deve attivarsi per difendersi, sia in via administrativa (richiedendo il contraddittorio, adesione, ecc.) sia in via giudiziale (ricorso alla Commissione/Corte di Giustizia Tributaria).
📄 Esempio reale (Cass. 8718/2021)
Un caso emblematico è quello deciso dalla Cassazione n. 8718/2021 : un avvocato aveva incassato dal proprio studio associato assegni circolari per circa €90.000 complessivi, senza riportarli nelle dichiarazioni dei redditi. L’Agenzia delle Entrate li contestava come compensi in nero e notificava avvisi di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva . L’avvocato sosteneva che fossero distribuzioni di utili pregressi dello studio (quindi redditi già tassati in capo allo studio), ma non riusciva a provarlo con documenti: dalla contabilità dello studio non emergeva nulla e i suoi calcoli erano giudicati inattendibili . La Cassazione, confermando la legittimità dell’accertamento, ha ribadito che spetta al contribuente fornire prova analitica per ogni somma versata che non si tratta di reddito imponibile, non bastando generiche ipotesi . Inoltre, ha enunciato il principio sopra citato: anche l’incasso di assegni circolari fuori conto è un versamento presunto ricavo . In definitiva l’onere probatorio non assolto dall’avvocato comportò la conferma della tassazione di quei €90.000 come compensi non dichiarati.
💡 Come difendersi: onere della prova e strategie difensive
Dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta presunto), difendersi da un accertamento basato su versamenti bancari/assegni significa essenzialmente ribaltare la presunzione legale fornendo la c.d. prova contraria. Poiché la legge dispensa il Fisco dal provare che quei soldi sono reddito (non occorrono “indizi gravi, precisi e concordanti” come per le comuni presunzioni, essendo questa presunzione stabilita per legge ), l’unica via è dimostrare operativamente che ogni assegno contestato aveva una fonte non imponibile. In pratica occorre ricostruire la “storia” di quelle somme, documentando perché non vanno tassate. Ecco alcune strategie e strumenti utili:
- Presentare documentazione dettagliata per ciascun assegno: per ogni accredito derivante da assegno circolare, bisogna fornire prova specifica e analitica della sua natura non reddituale . Ad esempio:
- Se l’assegno era una donazione di un familiare: esibire un atto di donazione (se redatto) oppure una dichiarazione scritta del donante autenticata (o scrittura privata con data certa) in cui attesta di aver elargito spontaneamente la somma a titolo di liberalità. Meglio ancora se accompagnata da documenti che provino la disponibilità finanziaria del donante (es.: estratto conto del padre che preleva la somma dal suo conto per farvi l’assegno). La presenza di un legame familiare stretto e l’assenza di obblighi reciproci può rendere verosimile la tesi della donazione. Si noti che donazioni indirette come queste – fatte tramite assegno o bonifico – non sono soggette a imposta di donazione salvo certe condizioni, e solo se dichiarate espressamente in atti: la Cassazione ha chiarito che l’assenza di un atto registrato impedisce di tassarle come donazioni ai fini tributari . Ciò non toglie che vanno provate per evitare la tassazione come reddito.
- Se l’assegno rappresentava la restituzione di un prestito precedentemente erogato dal contribuente: produrre il contratto di mutuo o una scrittura privata (meglio se con data anteriore certa, ad es. registrata all’Agenzia Entrate o con PEC/timbro postale) in cui il beneficiario riconosce di aver ricevuto quel prestito, più eventuali evidenze del trasferimento originario di denaro. Se ad esempio anni prima avevate effettuato un bonifico o assegno a favore di Tizio, conservatene traccia per dimostrare che l’assegno circolare che Tizio vi ha dato ora è un rimborso del capitale.
- Se l’assegno deriva da risparmi o somme già tassate: il contribuente deve tracciare la provenienza lecita di quei contanti. Ad esempio, se avete prelevato a più riprese contante dal vostro conto (già da redditi dichiarati) e l’avete accantonato, potreste giustificare un successivo versamento con assegno circolare dimostrando il collegamento (magari con estratti conto che mostrano i prelievi di importo simile nei mesi precedenti). Oppure se avete vinto una lotteria o percepito TFR già tassato alla fonte, documentare tali entrate esenti o già tassate per spiegare l’origine della liquidità versata .
- Se l’assegno era legato alla vendita di un bene personale non imponibile: ad esempio la vendita di un’auto usata, o la liquidazione di una polizza assicurativa. In tal caso esibire il contratto di vendita (con atto di passaggio di proprietà auto) o la comunicazione della compagnia assicurativa sul rimborso. Così si dimostra che l’assegno circolare incassato non era un reddito di lavoro, ma il realizzo di un cespite personale (non tassabile se il bene non produce plusvalenza imponibile).
- Se l’assegno era parte di un finanziamento soci a una propria società: spesso gli amministratori versano fondi propri in azienda tramite assegni. Occorre provare che si tratta appunto di apporto di capitale o finanziamento, deliberato o comunque regolarizzato nelle scritture societarie, e non di un ricavo. In mancanza di delibere formali, il Fisco può presumere che siano utili occulti distribuiti (specie se i soci erano incapienti e versano contanti in azienda): Cassazione ha confermato accertamenti induttivi in tali casi . Dunque conviene esibire documentazione societaria (verbali assembleari, bilanci) che qualifichi correttamente il movimento come finanziamento o capitale.
- Se l’assegno proviene da terzi estranei per ragioni specifiche (es. contributo spese, raccolta fondi, pagamento di danni, etc.): presentare eventuali scritture private o dichiarazioni dei terzi spiegando la causale (meglio se con data certa). Ad esempio, “importo versato da amici per aiutarmi nelle spese mediche, raccolto tra loro”: difficile da provare, ma anche solo una serie di dichiarazioni firmate dagli amici e ricevute può aiutare a sollevare il dubbio.
- Controllare la coerenza con le dichiarazioni fiscali passate: Il contribuente può difendersi mostrando che quelle somme contestate erano già state conteggiate nei redditi dichiarati o che comunque non vi è disallineamento reddituale. Ad esempio, se un imprenditore ha incassato un assegno di €20.000 e lo ha regolarmente fatturato (anche se magari versato sul conto dei familiari per motivi interni), può provare che la fattura corrispondente era stata emessa e dichiarata. Oppure se un professionista mostra che nell’anno X ha dichiarato compensi elevati compatibili con quei versamenti, può sostenere che essi erano già inclusi. Cassazione n. 8905/2024 ha ribadito l’obbligo per il giudice tributario di esaminare puntualmente le prove fornite dal contribuente per ogni movimento e motivare l’eventuale rigetto . Quindi, portare elementi di coerenza tra movimenti finanziari e dichiarazioni ufficiali può convincere il giudice a ritenere superata la presunzione, almeno in parte.
- Usare le presunzioni a proprio favore: interessante notare che la presunzione dell’art. 32 non è assoluta. Se il contribuente fornisce anche solo una spiegazione plausibile e supportata da indizi concreti per un movimento, il giudice dovrebbe tenere conto di tali presunzioni semplici difensive. Ad esempio, se su un conto compaiono versamenti annuali costanti di €5.000 sempre a dicembre, il contribuente che provi di aver ricevuto ogni anno un regalo natalizio di pari importo da un genitore (magari mostrando assegni circolari emessi dal padre negli stessi giorni) costruisce una presunzione semplice di liberalità periodica. La Cassazione con ordinanza n. 28719/2024 ha richiamato i giudici tributari a una valutazione rigorosa delle prove contrarie offerte dal contribuente, evitando automatismi sfavorevoli . Ciò significa che se il contribuente produce elementi logici e documentali, il giudice non può ignorarli limitandosi a confermare l’atto fiscale: deve valutarli analiticamente e motivare. Questo orientamento recente “apre spazi alla difesa”, bilanciando meglio la posizione del contribuente nell’ambito di tali accertamenti .
- Non tralasciare gli aspetti procedurali: verificate sempre se l’Ufficio ha rispettato il contraddittorio endoprocedimentale. Per gli accertamenti da indagini finanziarie, non è formalmente obbligatorio per legge (la Cass. continua a ritenere che l’assenza di contraddittorio preventivo non infici l’atto ). Tuttavia, le Circolari dell’Agenzia raccomandano di instaurarlo (es. Circ. 25/E/2014 ), e lo Statuto del contribuente (L.212/2000) prevede il diritto al contraddittorio nei controlli fiscali. Se l’Agenzia vi ha emesso accertamento senza nemmeno chiedervi spiegazioni, potete eccepire la violazione del contraddittorio (specie se siete in ambito comunitario, IVA, dove la giurisprudenza UE lo considera essenziale). Questa eccezione in alcuni casi ha portato all’annullamento di accertamenti bancari viziati. Anche vizi formali dell’atto (es. mancata indicazione dei fondamenti, o utilizzo di dati bancari ottenuti fuori dai termini) possono e devono essere fatti valere nel ricorso. Ad esempio, la Cassazione con ord. n.15021/2025 ha ritenuto valido l’accertamento anche senza indicazione dei numeri di conto corrente, privilegiando la sostanza ; tuttavia, ove l’atto fosse carente di elementi essenziali al diritto di difesa, ciò potrebbe costituire motivo di nullità.
- Valutare l’adesione o il ravvedimento operoso: se vi rendete conto che effettivamente quegli importi erano redditi non dichiarati e le prove contrarie scarseggiano, una via da considerare è limitare i danni. Ad esempio, prima che l’accertamento sia definitivo, si può avviare un procedimento di accertamento con adesione: presentandosi all’ufficio, si può cercare un accordo su una tassazione ridotta e sanzioni minime (di solito con abbattimento a 1/3 delle sanzioni). Oppure, se ancora non è partito l’accertamento ma avete omesso di dichiarare redditi significativi, è possibile usare il ravvedimento operoso (dichiarare tardivamente e pagare sanzioni ridotte). Queste opzioni vanno ponderate con il consulente fiscale: fanno perdere la chance di ricorso ma evitano il contenzioso e possibili segnalazioni penali (perché un’imposta spontaneamente versata con sanzioni riduce il rilievo penale).
- Ricorrere alla giustizia tributaria tempestivamente: se l’accertamento viene emesso e non trovate un accordo soddisfacente, il passo è presentare ricorso davanti alla nuova Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni. Nel ricorso si devono articolare i motivi di opposizione, allegando tutte le prove possibili. È essenziale chiedere eventualmente la sospensione dell’atto (se le somme sono elevate e c’è pericolo di dover pagare prima della sentenza). Nel giudizio tributario, come detto, il giudice valuterà se avete fornito la prova analitica richiesta. Se si perde in primo grado, si può appellare alla CGT di secondo grado e infine in Cassazione. Importante: la pendenza del giudizio tributario non blocca automaticamente l’eventuale procedimento penale per omessa/infedele dichiarazione, ma una decisione favorevole al contribuente (es. annullamento dell’accertamento perché i versamenti erano giustificati) avrà inevitabili riflessi positivi anche nel penale, eliminando il fondamento dell’accusa di evasione.
Riassumendo, come difendersi operativamente in sede fiscale:
- Appena ricevuto un questionario o invito dall’Agenzia: rispondere con documenti entro i termini, cercando il dialogo con il funzionario (anche di persona, magari col proprio commercialista) . Una spiegazione convincente in questa fase può evitare l’atto formale.
- Se arriva l’avviso di accertamento: niente panico, segnare la scadenza di 60 giorni per il ricorso. Valutare l’adesione entro 30 giorni (sospende i termini e può portare a riduzione sanzioni).
- Raccogliere tutta la documentazione possibile su ciascun assegno contestato: estratti conto, ricevute, lettere, ogni cosa utile .
- Predisporre un ricorso ben motivato, preferibilmente con l’assistenza di un tributarista, facendo leva su: illegittimità procedurali (se esistenti), ma soprattutto sulle prove concrete dell’estraneità al reddito delle somme . Citare la giurisprudenza recente che impone di considerare le prove difensive (es. Cass. 15538/2020, Cass. 8905/2024, Cass. 28719/2024, etc. che abbiamo menzionato).
- Nel frattempo, regolarizzare se possibile: se dall’anno in questione avete dedotto costi in nero correlati a quei ricavi, valutate di presentare dichiarazioni integrative, oppure iniziate a mettere da parte liquidità per pagare il dovuto in caso di sconfitta. In alcuni reati tributari, il pagamento integrale del debito tributario (imposte + sanzioni) prima del giudizio penale o entro termini di legge può estinguere il reato o attenuare la pena (ad es. per omessa dichiarazione, il pagamento dei debiti tributari prima dell’apertura del dibattimento evita la pena; per infedele dichiarazione è attenuante). Quindi pagare conviene sempre, se si hanno le risorse.
📌 Modello pratico: estratto di un ricorso tributario (memoria difensiva)
Ricorso del contribuente XYZ avverso Avviso di Accertamento n.12345/2024 – Corte Giustizia Tributaria di I° grado di [Città]
Oggetto: recupero a tassazione di €50.000 quali redditi 2021 da assegni circolari non giustificati.
Motivi:
1. Violazione art. 32 DPR 600/73 – Insussistenza dei presupposti per la ripresa a tassazione. L’Ufficio ha erroneamente qualificato come reddito imponibile la somma di €50.000 incassata dal ricorrente il 10/06/2021 mediante n.2 assegni circolari. Si tratta invece di importo di natura non reddituale, proveniente da donazione paterna esente da imposta. A riprova si allega dichiarazione resa dal padre (donante) autenticata dal notaio, nonché documentazione bancaria attestante il prelievo di pari importo dal conto del padre in data 08/06/2021. Tali prove dimostrano che la somma contestata è frutto di liberalità familiare e come tale estranea ai redditi del ricorrente . L’onere probatorio risulta ampiamente assolto dal contribuente, mentre l’Ufficio non ha fornito elementi idonei a contestare la natura gratuita dell’elargizione.
2. Erronea applicazione della presunzione legale e mancata valutazione delle prove contrarie (art. 32 DPR 600/73 e art. 2729 c.c.). L’Ufficio si è limitato ad applicare meccanicamente la presunzione “versamenti = ricavi” senza considerare le prove documentali prodotte in sede amministrativa. Ciò contrasta con la consolidata giurisprudenza (Cass. n.15538/2020; Cass. n.8905/2024) che impone una valutazione analitica delle giustificazioni fornite dal contribuente . Nel caso di specie, la documentazione allegata in risposta al questionario (cfr. all. 4,5) attestava la natura di donazione delle somme. Il mancato esame di tali elementi configura difetto di motivazione dell’atto impugnato.
3. Violazione dello Statuto del Contribuente (L.212/2000). L’accertamento è nullo per mancato contraddittorio: l’Ufficio ha emesso l’avviso senza previamente invitare il contribuente a fornire chiarimenti specifici sulle operazioni (l’unica comunicazione preventiva è stata un generico questionario, cui peraltro si è risposto, ignorato però dall’Ufficio). La giurisprudenza nazionale e comunitaria riconosce il contraddittorio preventivo come principio fondamentale (Corte Cass. 14105/2010; CGUE causa C-349/07 Sopropè). La notificazione diretta dell’atto impositivo ha precluso al ricorrente la possibilità di spiegare la natura non imponibile dei movimenti, in violazione del diritto di difesa.
Richiesta: In via principale, annullare l’avviso impugnato per insussistenza del presupposto impositivo e/o nullità; in via subordinata, ridurre l’imponibile accertato espungendo la somma di €50.000; con vittoria di spese.
(Il modello sopra è semplificato: andrebbero aggiunte intestazioni di rito, indicazione delle parti, dei fatti, delle norme, ecc. Si focalizza qui sui motivi principali di difesa in un caso tipico.)
Contestazione in ambito penale (reati finanziari e patrimoniali)
Quando si parla di assegni circolari senza giustificazione in sede penale, generalmente il contesto è quello di reati economico-finanziari. L’assegno circolare può infatti fungere da strumento o indizio di condotte illecite quali il riciclaggio di denaro, l’autoriciclaggio (se l’origine illecita è propria), la sottrazione fraudolenta al fisco o, in situazioni di insolvenza, la distrazione fraudolenta di beni (bancarotta fraudolenta). Esaminiamo le principali fattispecie penali che possono essere contestate e le relative strategie difensive dal punto di vista dell’accusato (debitore):
Riciclaggio di denaro (art. 648-bis c.p.)
Il riciclaggio consiste nel sostituire, trasferire, o impiegare in attività economiche denaro o altri beni provenienti da delitto, in modo da ostacolare l’identificazione della loro origine illecita. Nel nostro contesto, uno schema tipico di riciclaggio è il seguente: denaro “sporco” (derivante ad esempio da evasione fiscale, frodi, corruzione) viene depositato su un conto e convertito in assegni circolari intestati a persone fisiche o giuridiche “pulite”; questi assegni vengono poi incassati in contanti o reintrodotti nel circuito formalmente lecito, restituendo così ai reali beneficiari denaro ripulito. La Cassazione ha affermato chiaramente che integra il delitto di riciclaggio la monetizzazione del provento di evasione fiscale tramite versamento di assegni circolari seguito da prelievo di contanti, poiché tale modus operandi rende difficile rintracciare la provenienza del denaro . Non importa che vi sia comunque una traccia formale (numero di serie dell’assegno, etc.): basta che le operazioni rendano più arduo l’accertamento perché sia riciclaggio . In aggiunta, la Cassazione ha sottolineato che per il riciclaggio non serve il fine di lucro – è sufficiente la consapevolezza dell’origine illecita del denaro e l’uso di espedienti idonei a celarla . Nel caso di specie (Cass. 10746/2015), l’imputato era l’amministratore di una società di San Marino che aveva ricevuto assegni circolari da una società italiana inesistente, ciascuno sotto i 20 milioni di lire (all’epoca soglia per anonimato), li aveva versati su conti a San Marino e in Italia, e subito dopo prelevato contanti per oltre 1 miliardo di lire, restituendoli ai veri evasori . La Suprema Corte confermò la condanna per riciclaggio, sostenendo che anche operazioni frammentarie e progressive rientrano nel reato, se ostacolano l’identificazione dell’origine delittuosa .
Difendersi da un’accusa di riciclaggio legata ad assegni circolari implica principalmente dimostrare la mancanza di uno degli elementi chiave: la provenienza illecita dei fondi o la consapevolezza/volontà di occultarla. Alcune possibili linee di difesa:
- Contestare l’origine delittuosa: se l’accusa di riciclaggio si basa su una presunta evasione fiscale (reato presupposto), la difesa può argomentare che quei fondi non erano frutto di reato. Ad esempio, se i soldi originavano da redditi non dichiarati ma sotto soglia penale (quindi evasione amministrativa, non reato), o da condotte non ancora accertate come reato (magari oggetto di contenzioso tributario in corso), si può sostenere che manca il presupposto di “denaro proveniente da delitto”. In pratica, se cade l’accusa a monte, viene meno il riciclaggio. Esempio: Tizio viene accusato di riciclaggio perché ha incassato assegni dal socio occulti. Se Tizio dimostra che quell’evasione non c’è stata o non costituisce reato (perché l’importo evaso era inferiore alle soglie penali), la base del riciclaggio vacilla.
- Negare la “dissimulatorietà” della condotta: se Tizio ha incassato assegni circolari sul proprio conto e li ha prelevati, la difesa potrebbe sostenere che non vi è stato alcun concreto ostacolo all’identificazione dei flussi: tutto è avvenuto tramite canali tracciati (banca) e i soldi sono rimasti nella sua disponibilità. Certo, la Cassazione ritiene comunque configurato il reato anche solo col rendere difficile l’accertamento , ma situazioni borderline potrebbero convincere il giudice che la condotta è stata troppo rudimentale per costituire riciclaggio. Ad esempio, se l’imputato ha incassato su un conto personale e speso quei soldi per beni a lui intestati, senza schermi, si può argomentare che non c’è stato un vero “occultamento” (semmai evasione fiscale, ma non riciclaggio separato).
- Mancanza di consapevolezza (dolo): l’art. 648-bis c.p. richiede quantomeno il dolo generico di riciclare, ossia la consapevolezza dell’origine delittuosa e la volontà di ostacolarne la scoperta . Se l’imputato ha un ruolo periferico (ad es. un dipendente di banca o un terzo incassatore inconsapevole), la difesa può puntare sull’assenza di consapevolezza. Nel caso citato, la Cassazione dedusse la consapevolezza anche solo dalla mancanza di un titolo giuridico giustificativo delle somme trasferite, combinata con l’entità e modalità dei movimenti . Quindi, l’assenza di giustificazione in sé fu indice di dolo. La difesa potrebbe però cercare di fornire una spiegazione alternativa: es. “pensavo fossero fondi leciti di cui l’amico voleva la disponibilità in contanti per ragioni personali lecite”. Se plausibile, crea dubbio sul dolo. In casi di “money mule” (prestanome), spesso la linea è ritrarre l’imputato come ingenuo strumento, ignaro della provenienza.
- Tentare la derubricazione: qualora l’imputato non abbia agito per profitto personale ma solo come tramite, e magari non vi sia stata un’attività sofisticata di occultamento, si può chiedere la derubricazione in ricettazione (art. 648 c.p.), reato meno grave. Nella vicenda del 2015, la difesa tentò proprio di far qualificare la condotta come ricettazione (che richiede fine di profitto e presuppone solo ricezione di proventi illeciti per tenerli o rivenderli), ma la Cassazione lo negò perché nel riciclaggio non serve scopo di lucro e l’attività di reimmissione era chiaramente volta a celare l’origine . Tuttavia, in situazioni borderline, può essere un risultato ottenere la condanna per ricettazione invece che riciclaggio (pene più basse: 2–8 anni vs 4–12, e magari sospensione condizionale se circoscritto).
- Collaborare e risarcire: va detto che in materia di riciclaggio, se l’imputato collabora a recuperare i proventi o ad individuare i complici, può avere attenuanti significative. Anche il risarcimento o la restituzione delle somme ai danneggiati (ad es. allo Stato se sono proventi da reato fiscale) può aiutare in sede di determinazione della pena.
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
L’autoriciclaggio è un reato introdotto nel 2015 che punisce chi, avendo commesso o contribuito a commettere un reato presupposto, impiega, sostituisce o trasferisce il denaro proveniente da tale reato in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. In pratica, è il caso di chi ricicla da sé i proventi dei propri crimini. Prima del 2015, paradossalmente, l’evasore fiscale che ripuliva da sé i suoi soldi non rispondeva di riciclaggio (perché non c’è concorso nel riciclaggio se si è autore del reato base); ora invece sì, se compie attività di occultamento.
Nel nostro contesto, l’autoriciclaggio può essere contestato ad esempio all’evasore fiscale che, dopo aver occultato ricavi, li movimenta tramite assegni circolari per farli emergere puliti. Oppure all’imprenditore che distragga fondi dalla società e li veicoli altrove tramite assegni. Le modalità operative che integrano autoriciclaggio sono in sostanza le stesse del riciclaggio, con la differenza che qui soggetto che ricicla coincide (in tutto o in parte) con quello che ha generato i proventi illeciti.
Esempio tipico: un professionista non dichiara €200.000 di compensi (reato di dichiarazione infedele, art.4 D.lgs 74/2000, se supera le soglie), e per godere di quei soldi senza destare sospetti, non li tiene sul proprio conto. Fa emettere al cliente assegni circolari, magari intestati a un familiare o collaboratore; questi li incassa e restituisce il contante al professionista, che così può spenderlo liberamente. Oppure, l’imprenditore stacca assegni circolari dall’azienda a favore di una società estera compiacente e fa rientrare il denaro su conti personali all’estero.
Le pene per l’autoriciclaggio variano a seconda della gravità: base 2–8 anni di reclusione (multa €5.000–25.000), ridotte se il reato presupposto è colposo o di particolare tenuità (fino a minimo 1 anno). Non si applica se il denaro viene destinato solo all’uso o godimento personale dell’agente (clausola di esenzione: spendere i soldi per sé senza operazioni di schermatura non è punibile). Questo significa che non ogni condotta dell’evasore con i soldi evasi è autoriciclaggio: se, ad esempio, l’evasore si limita a depositare i contanti sotto il materasso o a spenderli in beni di lusso a lui intestati, potrebbe non scattare il reato (perché non li ha reimmessi in circolazione per celarne l’origine, ma li ha solo goduti).
Difesa nell’autoriciclaggio: buona parte delle strategie sono analoghe al riciclaggio, con in più alcune peculiarità:
- Negare l’intento di occultamento: enfatizzare se la condotta contestata era finalizzata al semplice utilizzo personale. La legge esenta l’uso per bisogni personali non configurabile come impiego in attività economiche. Ad esempio, se con gli assegni “sporchi” l’imputato ha pagato spese mediche per sé, o comprato un’auto a suo nome, la difesa può sostenere che non c’era scopo di mascherare la provenienza, bensì solo spendere i soldi (ciò rientrerebbe nell’uso personale, non punibile). Naturalmente, questa linea ha successo se effettivamente le operazioni non avevano artificiosità: se invece ha comprato una casa intestandola a un prestanome, è un occultamento a tutti gli effetti.
- Attaccare il reato presupposto: come per il riciclaggio, se cade l’accusa fiscale principale (es. perché il fatto non è reato, o non c’è prova dell’evasione), viene meno anche l’autoriciclaggio. Quindi, un’assoluzione in sede di reato tributario comporterà l’assoluzione nell’autoriciclaggio (non potendo esistere provento illecito senza reato base).
- Evidenziare la collaborazione o resipiscenza: se l’imputato, una volta scoperto, provvede a sanare il debito fiscale e a far emergere i fondi, ciò può giocare a favore. Nel 2019 è stata introdotta una causa di non punibilità per alcuni reati fiscali in caso di integrale pagamento del debito tributario (non per il dichiarativo però, solo per omesso versamento); ma nel caso di dichiarazione infedele o autoriciclaggio non c’è esimente totale, c’è però la possibilità di attenuanti generiche forti. Mostrare di aver pagato tutte le imposte evase e le sanzioni prima della sentenza potrebbe convincere il giudice a essere clemente nella quantificazione della pena o a concedere la sospensione condizionale.
- Profili processuali: spesso i reati tributari e il relativo autoriciclaggio vengono contestati insieme. È importante coordinare le difese: ad esempio, valutare se chiedere la riunione dei procedimenti (per trattare tutto in un unico processo) o se conviene separarli. Unificare può evidenziare meglio l’eventuale duplicazione; separare potrebbe evitare che la prova dell’evasione (magari molto tecnica) influenzi il giudizio sul riciclaggio. È una scelta strategica da fare con il legale penalista.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)
Questo reato fiscale, spesso meno noto al grande pubblico, punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte o relativi interessi/sanzioni, alieni simulatamente o compia atti fraudolenti sui propri beni tali da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. In pratica è il reato di “frode ai danni del Fisco in fase di recupero crediti”. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 4 anni (fino a 6 anni se l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi superati sottratti supera €100.000).
Un esempio tipico: un contribuente ha cartelle esattoriali o un accertamento esecutivo pendente; temendo pignoramenti, trasferisce i soldi dal suo conto altrove, vende immobili a terzi compiacenti, svuota l’azienda. Se queste operazioni sono simulate o fraudolente e pregiudicano la riscossione, integra il reato. Nel nostro caso, l’uso di assegni circolari per spostare disponibilità può costituire un mezzo di tale reato. Ad esempio, un imprenditore, durante una verifica fiscale, chiude il conto bancario prelevando tutto con un assegno circolare intestato magari a un familiare o al proprio avvocato, per evitare che il Fisco vi iscriva fermo o pignoramento. Oppure emette un assegno circolare a favore di un socio per restituirgli fittiziamente un finanziamento, sottraendo liquidità dall’azienda indebitata col Fisco.
La giurisprudenza, però, distingue le situazioni lecite da quelle fraudolente: non tutto ciò che impoverisce il patrimonio è reato. Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che non integra il reato ex art.11 chi, pur pendendo la riscossione, si limita a disporre dei propri beni prelevando integralmente le somme dal proprio conto, se ciò non si inserisce in un disegno più ampio di sottrazione . Una sentenza (Cass. 25677/2012, citata in un caso del 2022) afferma che semplicemente ritirare il saldo dal conto non è di per sé atto fraudolento punibile . Serve un quid pluris: la callidità (furbizia) dell’atto, ad es. l’averli intestati a terzi, aver simulato un diritto di pegno, averlo fatto in presenza di altri beni già distratti.
Nel caso concreto discusso in un contributo del 2022, all’imputato si contestava di aver chiuso il conto societario prelevando il saldo con un assegno circolare non trasferibile durante la riscossione esattoriale. La difesa ha dimostrato che: – il conto aveva saldo esiguo; – l’operazione era tracciata (assegno non trasferibile a sé stesso, poi incassato); – quasi tutti i movimenti precedenti erano leciti e tracciati, senza anomalie; – soprattutto, l’ultimo grosso pagamento uscito dal conto era destinato proprio al pagamento di imposte! (quindi l’imputato stava pagando le tasse, non fuggendo); – non c’erano altri atti di spoliazione (l’imputato da anni non aveva immobili né altri beni su cui agire) .
Di conseguenza, è emerso che mancava il dolo specifico di voler sottrarre quei beni al Fisco . L’imputato è stato assolto perché la chiusura del conto non era parte di una “callida strategia di dismissione” patrimoniale, bensì spiegabile con la cessazione dell’attività e il saldo modesto .
Come difendersi se accusati ex art.11 per aver usato assegni circolari? Le linee difensive sono:
- Assenza di atti simulatori o fraudolenti: evidenziare che le operazioni erano realmente dovute o di natura ordinaria. Ad esempio, se avete emesso un assegno circolare per restituire un debito vero (non simulato) a un fornitore o per pagare stipendi, allora non c’è simulazione. La legge esclude espressamente dalla revocatoria civile l’adempimento di un debito scaduto ; analogamente, penalmente, pagare debiti veri anche se riduce il patrimonio non è “fraudolento” (a meno di collusione). Quindi se l’assegno contestato era un pagamento legittimo, insistere su questo.
- Mancanza del dolo specifico: l’art.11 richiede che l’atto sia finalizzato a sottrarsi al pagamento di imposte. Se l’imputato aveva altri motivi o circostanze plausibili, la difesa li sottolineerà. Nel caso sopra, il fatto che il conto fosse chiuso per fine attività e il denaro servito anche a pagare tasse ha distrutto l’ipotesi di dolo evasivo . Se potete dire: “Ho emesso l’assegno circolare per spostare fondi al sicuro da un imminente pignoramento illegittimo o perché stavo cambiando banca, non per non pagare le tasse”, e lo provate con elementi (ad es. subito dopo avete comunque pagato quelle imposte), allora manca l’intento fraudolento.
- Lieve entità e nessun danno concreto: se la somma è modesta rispetto al debito fiscale e comunque il Fisco non avrebbe potuto soddisfarsi (es. c’erano già ipoteche o debiti maggiori), si può invocare l’assenza di “effettiva idoneità a rendere inefficace la riscossione”. La norma punisce atti idonei a vanificare la riscossione. Se di fatto il Fisco non avrebbe comunque recuperato nulla (perché patrimonio quasi inesistente), quell’atto isolato può apparire non decisivo. Non è una difesa fortissima, ma aiuta a invocare magari la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p., se il danno è lieve e il comportamento non abituale).
- Restituzione o ravvedimento: se l’imputato ha nel frattempo pagato le imposte dovute (ad esempio aderendo alla rottamazione cartelle, o saldando il debito), farlo presente: pur non estinguendo il reato automaticamente, è un fattore di attenuazione. Dimostra che non c’era volontà definitiva di sottrarsi al Fisco.
Va ricordato che l’art.11 punisce anche la simulazione di vendite o altri atti (non solo assegni). Dunque, se l’assegno circolare è servito per fingere un pagamento (es. vendere un’auto al parente per finta, ricevendo assegno circolare poi restituito in contanti), si può incorrere sia in art.11 che in possibili contestazioni di truffa ai creditori (in generale art.641 c.p. per chi froda i creditori diversi dallo Stato, se c’è titolo esecutivo) o bancarotta se fallisce.
Bancarotta fraudolenta e altri reati fallimentari
Quando un imprenditore fallisce, tutti gli atti lesivi del patrimonio compiuti prima del fallimento possono assumere rilevanza penale come bancarotta fraudolenta per distrazione (se beni o denaro sono stati sottratti ai creditori) o preferenziale (se ha favorito alcuni creditori a scapito di altri). Se un debitore – poi fallito – aveva emesso assegni circolari senza giustificazione (ad es. trasferendo fondi a familiari poco prima del crac), il curatore fallimentare può denunciarlo per bancarotta. In quel caso, la difesa è molto difficile perché la bancarotta è un reato di evento: basta che il fallito abbia arrecato un danno ai creditori distraendo attivo. L’assegno circolare, come mezzo di pagamento, qui rileva solo come modo in cui la distrazione è avvenuta.
Difendersi significa cercare di provare che: – L’atto non costituiva una distrazione dolosa, ma era un’operazione giustificata (es. pagamento di un debito, investimento in scorte – anche se poi persi, ma non dolosamente). – Oppure che il fallimento aveva altre cause e il danno di quell’atto è irrilevante (tentativo spesso vano, perché se l’atto c’è stato ed è gratuito, la bancarotta si configura anche se fosse “goccia nel mare”).
In generale, un assegno circolare donato nel periodo sospetto del fallimento (due anni prima per atti a titolo gratuito) è quasi certamente revocabile in sede fallimentare e penalmente contestabile. Il consiglio è prevenire: evitare assolutamente spostamenti di fondi senza causa quando l’azienda è in dissesto.
🛡️ Domanda: procedimento penale vs accertamento tributario?
Un aspetto importante: il processo penale è indipendente da quello tributario. L’eventuale ricorso vinto davanti al giudice tributario non vincola automaticamente il giudice penale, e viceversa. Tuttavia, in pratica, molti elementi probatori si sovrappongono. Un esempio positivo per il contribuente: nel penale vige l’onere della prova a carico dell’accusa e il principio oltre ogni ragionevole dubbio. Quindi, se siete imputati di dichiarazione infedele per quegli importi, la Procura dovrà provare che erano effettivamente redditi evasi e che eravate consapevoli. Questo può giocare a vostro favore: magari in sede tributaria non siete riusciti a fornire prova analitica (e avete perso l’accertamento), ma in sede penale la vostra spiegazione – pur non provata al 100% – potrebbe bastare a creare un ragionevole dubbio. Ad esempio, se dite “quei €50k erano un regalo di nozze”, il giudice tributario vi ha chiesto i documenti e non li avevate, quindi vi ha tassato. Ma il giudice penale, anche senza prova certa, può assolvervi se il dubbio resta (non essendoci prova oltre dubbio che fossero reddito). Insomma, l’assoluzione penale è possibile anche se il fisco vi ha contestato l’importo, perché i criteri di prova differiscono . Naturalmente, anche il contrario: la condanna penale per evasione (o riciclaggio) aggrava la posizione nel tributario.
📌 Modello pratico: estratto di memoria difensiva in un procedimento penale per riciclaggio
Memoria ex art. 121 c.p.p. – Difesa di Mario Rossi (imputato di riciclaggio)
Oggetto: Precisazioni probatorie sulla mancanza dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio contestato.
Si intende richiamare l’attenzione del Giudice su alcuni elementi emersi in atti che escludono la consapevolezza in capo a Rossi della provenienza illecita delle somme oggetto di contestazione e l’idoneità delle sue condotte a ostacolare l’identificazione. In particolare:
1) Assenza di consapevolezza dell’origine illecita. Rossi ha incassato n.3 assegni circolari emessi da Alfa Srl per complessivi €90.000, versandoli sul proprio conto bancario personale. Tali assegni recavano come causale “restituzione finanziamento soci”. Dalle testimonianze (si veda dich. del teste Bianchi, direttore di banca, udienza 1/9/2024) risulta che Alfa Srl era società amministrata dal fratello di Rossi e che quest’ultimo era convinto trattarsi effettivamente di restituzione di un prestito familiare, non di proventi da reato. Rossi, dunque, ignorava che la somma potesse avere origine illecita, avendogli il fratello rappresentato trattarsi di fondi leciti della società. Manca pertanto il dolo richiesto dall’art.648-bis c.p., difettando la coscienza della provenienza delittuosa .
2) Condotta non finalizzata a ostacolare l’identificazione dei flussi. Si evidenzia che Rossi ha versato gli assegni su un conto a lui intestato (conto n.12345 Banca XYZ), dal quale ha poi disposto bonifici a proprio nome verso un investimento immobiliare (acquisto di un terreno). Tutti i passaggi sono stati compiuti alla luce del sole mediante strumenti tracciabili (assegni non trasferibili, bonifico nominativo). Tale condotta non presenta quell’“espediente atto ad aggirare la normale tracciabilità” che caratterizza il riciclaggio . Anzi, l’identità economica delle somme è rimasta evidente (dai c/c di Alfa Srl al c/c personale di Rossi, e da qui al pagamento del terreno). Non c’è stato frazionamento né schermatura con interposti soggetti di comodo. Si tratta al più di impiego di denaro altrui in un’acquisizione patrimoniale personale, eventualmente censurabile sotto altri profili ma non riconducibile allo schema del riciclaggio tipizzato dalla norma. 3) Insussistenza di reato presupposto accertato. Si segnala infine che il supposto reato presupposto (dichiarazione infedele di Alfa Srl per occultamento di ricavi) è tuttora sub iudice in sede tributaria e, allo stato, non vi è una pronuncia definitiva di commissione di illecito fiscale. In dubio pro reo, non si può dare per provata la provenienza criminosa del denaro in mancanza di accertamento giurisdizionale al riguardo. Conclusione: Gli elementi sopra esposti integrano quantomeno una situazione di dubbio ragionevole circa la colpevolezza di Rossi in ordine al reato contestato. Si chiede che tali considerazioni vengano valutate ai fini di un’assoluzione ex art.530 c.p.p. (“il fatto non sussiste” o quantomeno “l’imputato non ha commesso il fatto”). In subordine, si chiede la riqualificazione in fattispecie di minor gravità (ricettazione) stante l’assenza di attività concretamente dissimulatorie poste in essere dall’imputato, e la concessione delle attenuanti generiche prevalenti.
(Anche qui, il modello è abbreviato rispetto a una vera memoria, volto a mostrare possibili argomenti difensivi. In un atto reale si aggiungerebbero riferimenti agli atti del fascicolo, giurisprudenza di supporto, ecc.)
Contestazione in ambito civile (azioni dei creditori: revocatoria, simulazione, ecc.)
Dal punto di vista civilistico, l’interesse primario è quello dei creditori (privati o bancari) del debitore che ha compiuto atti dispositivi “anomali” tramite assegni circolari. Un creditore – attuale o futuro – che si ritenga pregiudicato da tali atti può agire giudizialmente per ottenerne l’inefficacia o la nullità verso di sé, in modo da poter comunque soddisfarsi sui beni o sulle somme uscite dal patrimonio del debitore. La principale azione a disposizione è l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., affiancata dall’azione di simulazione (artt. 1414 ss. c.c.) in caso di contratti fittizi e da alcuni rimedi specifici (es. azione revocatoria fallimentare se c’è procedura concorsuale, azione di nullità di donazione per difetto di forma, etc.). Analizziamo questi strumenti, le condizioni perché il creditore vinca la causa e come il debitore (o il terzo beneficiario) può difendersi.
Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)
L’azione revocatoria ordinaria consente al creditore di far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto di disposizione del debitore che rechi pregiudizio alle sue ragioni . Non annulla l’atto in assoluto, ma lo rende inopponibile al creditore attore: in pratica, il bene o la somma uscito dal patrimonio del debitore viene considerato come ancora facente parte di esso, ai fini dell’esecuzione forzata da parte di quel creditore. Le condizioni richieste dalla legge (art. 2901 c.c.) sono, in sintesi :
- eventus damni: l’atto deve arrecare pregiudizio al creditore, ovvero diminuire la garanzia patrimoniale su cui questi può contare. Basta anche che renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito . Per esempio, se Tizio aveva €100.000 in conto e dona €80.000 a Caio (assegno circolare senza causa), la garanzia generica per i creditori di Tizio è diminuita e l’atto è potenzialmente pregiudizievole. Non serve che il debitore sia già insolvente; è sufficiente che, senza quell’atto, il creditore avrebbe avuto maggiore facilità di soddisfazione .
- scientia fraudis del debitore: il debitore, nel compiere l’atto, deve aver conosciuto il pregiudizio che arrecava alle ragioni del creditore . Se l’atto è anteriore al sorgere del credito, si richiede addirittura la dolosa preordinazione, cioè che sia stato fatto proprio allo scopo di frodare futuri creditori . In pratica:
- se il credito del querelante era già sorto (es. debito esistente) al momento dell’atto, basta provare che il debitore era consapevole che quell’atto avrebbe potuto danneggiare il creditore. Data la situazione, spesso questa consapevolezza si presume se il debitore conosceva l’esistenza del debito.
- se il credito è nato dopo l’atto (creditore futuro), è molto più difficile: bisogna dimostrare che il debitore aveva già in mente di sottrarre beni ai futuri creditori, ossia che l’atto era preordinato ex ante per frodarli .
- consilium fraudis (partecipazione del terzo) per gli atti a titolo oneroso: se l’atto è oneroso (cioè il debitore ha ricevuto qualcosa in cambio, es. una vendita), serve anche che il terzo contraente fosse consapevole del pregiudizio ai creditori. Se l’atto è anteriore al credito, il terzo deve addirittura essere partecipe della dolosa preordinazione . Se invece l’atto è a titolo gratuito, la partecipazione del terzo non è richiesta – il terzo può essere all’oscuro di tutto, ma il creditore può comunque revocare (perché la legge tutela meno chi riceve doni rispetto a chi paga per avere qualcosa).
Nel contesto degli assegni circolari “senza giustificazione”, frequentemente si tratta di atti a titolo gratuito (regali, liberalità) – quindi basta provare che c’è pregiudizio e che il debitore era consapevole di danneggiare i creditori. La scientia damni nel debitore è abbastanza semplice da desumere se il debito era già esistente (chi ha un debito e regala soldi ad altri, in genere sa che ciò pregiudica il creditore). Per il terzo non serve dimostrare mala fede (ma spesso è implicita se c’è parentela: p.es. coniuge o figlio che riceve la somma sapeva verosimilmente delle difficoltà, e ciò può essere indice di collusione ).
Se invece l’assegno circolare “ingiustificato” veniva formalmente dato come corrispettivo di qualcosa (es. vendita di un bene a prezzo inferiore al valore o addirittura simulata), siamo in presenza di atto oneroso: qui il creditore deve provare anche la collusione del terzo. Tuttavia, la giurisprudenza tende a considerare alcune operazioni come di fatto gratuite se il corrispettivo è simbolico o irrisorio (vendita a prezzo vile). Ad esempio, vendere un immobile da €100k al figlio per €10k (pagati magari con un assegno circolare giusto per parvenza) può essere considerato un atto a titolo gratuito di valore eccedente la modica quantità e quindi revocabile senza bisogno di provare il consilium fraudis, essendo il prezzo sproporzionato .
Effetti della revocatoria: come detto, se il creditore vince la causa, l’atto è dichiarato inefficace verso di lui. Ciò significa che può aggredire il bene come se fosse ancora del debitore. Con un esempio sul nostro tema: Tizio deve €50k a Banca X; Tizio un anno fa ha regalato (atto gratuito) €40k al fratello Caio tramite assegno circolare. Banca X fa revocatoria, la ottiene; ora Banca X potrà pignorare presso Caio quella somma (o i suoi beni fino a €40k) perché la sentenza stabilisce che, rispetto a Banca X, la donazione è inefficace. Caio, per evitare l’esecuzione, dovrà restituire i €40k (se li ha) oppure subire il pignoramento dei suoi beni. Tizio e Caio restano libero di considerare valida tra loro la donazione (Tizio non può chiederli indietro, l’atto non è annullato in sé), ma ciò non rileva per il creditore.
Difese del debitore (e del terzo) in una causa revocatoria:
- Negare l’eventus damni: far emergere che l’atto non ha pregiudicato il creditore perché il debitore aveva ancora un patrimonio sufficiente per soddisfarlo malgrado quell’uscita. Ad esempio, “Sì ho dato €40k a mio fratello, ma avevo altri €500k in immobili liberi da vincoli, quindi il creditore non era in pericolo”. Se il debitore prova che il suo patrimonio residuo era ampiamente capiente per pagare il debito, viene meno il pregiudizio (sebbene la legge parli di pregiudizio anche solo come maggiore difficoltà, in pratica se c’è abbondante patrimonio a garanzia l’azione può essere respinta). La Cassazione ha chiarito che è onere del convenuto in revocatoria (cioè debitore o terzo) provare l’assenza dell’eventus damni, in virtù del principio di vicinanza della prova . Ciò significa che il debitore deve dimostrare di avere altri beni sufficienti: se non lo fa, il giudice presume il danno. Dunque la difesa qui è fattuale: portare inventario di beni, perizie, ecc., a dimostrazione che il credito poteva comunque essere soddisfatto.
- Dimostrare una causa lecita dell’atto: se l’assegno circolare non aveva all’apparenza giustificazione, la difesa può cercarne una ex post per opporsi alla revocatoria. Ad esempio, sostenere (e provare) che non era una donazione ma il pagamento di un debito che il debitore aveva verso il terzo. La legge infatti esclude espressamente dalla revocatoria l’adempimento di un debito scaduto (cioè pagare un proprio debito dovuto non è revocabile ). Dunque, se il debitore riesce a dimostrare che quell’assegno circolare trasferito a Caio era per saldare un debito che lui aveva verso Caio, allora l’art.2901 c.c. ultimo comma lo protegge: “Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto” . Attenzione, però: il debito deve essere effettivo e preesistente. Non vale se era un debito simulato (es. una finta ricognizione di debito creata ad hoc con Caio). Però, se c’era veramente un mutuo fra fratelli per €40k, con scadenza in quella data, pagarlo con assegno è legittimo e il creditore di Tizio non può revocarlo salvo provi la collusione (ma anche la norma di salvaguardia è chiara). Questa difesa quindi comporta presentare prove del rapporto sottostante: un contratto, una promessa scritta di pagamento, ricevute, qualsiasi cosa provi che Caio vantava un credito proprio verso Tizio. Se riesce, l’azione viene rigettata perché l’atto era doveroso.
- Assenza di scientia fraudis: il debitore può sostenere di non aver affatto pensato ai creditori quando ha fatto l’atto. Ad esempio: “Ho donato i soldi a mio figlio per aiutarlo, ignoravo di avere problemi coi creditori o pensavo di farcela a pagarli lo stesso”. Questa difesa è psicologica e difficile, ma può funzionare in alcuni scenari. Se il credito era futuro (non ancora sorto all’epoca), si può argomentare che non c’era alcuna preordinazione dolosa perché il debitore non poteva prevedere di contrarre quel debito (caso di debiti da fatto illecito o simili). Se il credito era presente, dire “non sapevo di pregiudicare” è arduo se il debito era certo, ma si può tentare di far passare che l’importo donato era modesto rispetto al patrimonio (quindi il debitore credeva in buona fede di non danneggiare il creditore, perché si sentiva comunque solvibile). In ogni caso, la prova della scientia è a carico del creditore attore, che di solito la dimostra anche tramite presunzioni (es. vicinanza temporale fra atto e intimazione di pagamento = presunzione che il debitore agì scienter). Il debitore può provare circostanze che facciano dubitare di ciò: per esempio, se l’assegno circolare è stato donato molto tempo prima che il debito col creditore emergesse, o se c’erano motivi personali cogenti (es. urgenza medica del donatario) che rendono plausibile che il debitore abbia agito non per frodare ma per necessità familiare.
- Buona fede del terzo (negli atti onerosi): se l’assegno è stato dato in cambio di qualcosa (es. acquisto bene), il terzo beneficiario potrà difendersi provando di essere stato in buona fede, cioè inconsapevole dei debiti del disponente. Esempio: “Io Caio ho venduto l’auto a Tizio per €20k (ricevuti con assegno circolare). Come potevo sapere che Tizio lo faceva per frodare un creditore? Io non sapevo nulla dei suoi affari, per me era una compravendita genuina”. Se il terzo prova di essere terzo di buona fede (nessuna parentela magari, atto fatto a valori di mercato, etc.), il creditore attore non soddisfa il requisito del consilium fraudis e la revocatoria dev’essere respinta. Questo sposta l’attenzione sul terzo: spesso il terzo è parente o amico stretto, quindi è difficile crederlo totalmente all’oscuro (la parentela stretta è considerata indizio grave di consapevolezza e anche di simulazione ). Ma se il terzo è realmente estraneo e l’affare era normale, la difesa di solito regge.
- Questioni formali/procedurali: qui il debitore può verificare se il creditore ha rispettato termini e condizioni per l’azione. La prescrizione della revocatoria è di 5 anni dal compimento dell’atto . Se il creditore ha aspettato troppo, l’azione è prescritta: eccezione da sollevare subito. Inoltre, accertarsi che il creditore abbia la legittimazione: serve un credito anche solo eventuale o litigioso, non necessariamente definitivo , ma se ad esempio il presunto credito è totalmente fittizio o inesistente, si può contestare la sua qualità di creditore. Tuttavia, la soglia è bassa (anche un credito contestato in giudizio può bastare per agire in revocatoria ).
In definitiva, la difesa migliore del debitore è non farsi trovare con atti del genere… Ma se sono stati fatti, occorre puntare su mancanza di pregiudizio, atto dovuto o mancanza di malafede. La sorte della causa dipenderà molto dalle prove e da come appaiono i fatti al giudice: se è evidente che il debitore ha svuotato il conto ai figli e poi non ha pagato i creditori, difficilmente eviterà la revoca. Se invece l’atto è isolato e il contesto ambiguo, c’è spazio di manovra.
Simulazione dell’atto (art. 1416 c.c.)
Un’altra azione a disposizione dei creditori (spesso proposta cumulativamente alla revocatoria, in via alternativa) è l’azione di simulazione. Il codice consente ai creditori del finto alienante di far valere la simulazione di un contratto che li pregiudica . Nel nostro scenario, la simulazione tipicamente riguarda vendite o pagamenti fittizi. Ad esempio: Tizio “vende” un immobile a Caio, ma in realtà è una finta vendita per togliere l’immobile dalla portata dei creditori. Un indizio classico di simulazione è il pagamento fittizio del prezzo: spesso viene inscenato con assegni circolari che poi tornano al disponente. Proprio la circostanza che “gli assegni circolari possono essere bancati (incassati) e le somme restituite” ha portato i giudici a considerare possibile la fittizietà dei pagamenti . Nell’esempio: Caio consegna a Tizio un assegno circolare di €100k come prezzo della casa; Tizio lo incassa e gli restituisce i €100k in contanti di nascosto. Risultato: l’immobile è passato a Caio, ma il denaro non è rimasto a Tizio (tornato a Caio). Dunque, nessun vero corrispettivo è stato pagato: la vendita era simulata (in realtà era una donazione camuffata, oppure un trust occulto).
I creditori preferiscono far valere la simulazione quando riescono a raccogliere prove sufficienti, perché la simulazione se accertata annulla l’atto tra le parti: l’immobile dell’esempio sarebbe considerato ancora di Tizio a tutti gli effetti (non solo per il creditore attore, ma per tutti). Ciò permette di pignorare l’immobile direttamente come bene di Tizio. La simulazione richiede però prova forte dell’accordo simulatorio tra le parti (c.d. controdichiarazione) o per presunzioni gravi, precise e concordanti . I creditori possono avvalersi di una probatio facilitata: per costoro, terzi rispetto al contratto, è ammessa anche la prova per testimoni e presunzioni senza limiti .
Nel caso degli assegni circolari, come visto, un fatto che può convincere il giudice della simulazione è la prova che il prezzo è tornato al compratore. A volte emergono movimenti bancari sospetti: Caio deposita l’assegno, poi il giorno dopo preleva la stessa somma e Tizio versa contanti altrove, ecc. Oppure testimonianze: Caio era nullatenente e non poteva avere €100k, l’assegno glieli fornì lo stesso Tizio prima per poi fingere di riceverli. Insomma, seguire i soldi è la chiave: se i soldi non restano al venditore, la vendita è finta.
Difendersi da un’azione di simulazione è arduo se i fatti sono contro. Il debitore e il terzo dovrebbero: – Mostrare che il contratto è stato genuino: ad esempio, se vendi un bene a un figlio, far vedere che tuo figlio ha pagato davvero, attingendo a risorse sue (mutuo, risparmi) che sono rimaste nel tuo patrimonio (e magari usate per pagare altri debiti). Se i soldi sono spariti, la vendita appare finta. – Oppure far qualificare la vicenda non come simulazione assoluta (falsa vendita) ma come vendita a prezzo vile o donazione indiretta. Questo dipende: se c’è un atto pubblico di vendita, non lo si può “convertire” in donazione regolare (sarebbe nulla per mancanza di forma). Però i giudici a volte, di fronte a un prezzo irrisorio, parlano di donazione dissimulata dietro una vendita simulata. In ogni caso per il creditore va bene lo stesso, anzi meglio: se è donazione, la revoca è facile. – Attaccare la legittimazione del creditore: qui però se aveva già un credito, l’ha. Al limite dire che quell’atto non lo pregiudica perché il debitore aveva comunque altri beni (questo rientra più nel discorso eventus damni, che rileva di solito nella revocatoria ma indirettamente anche in simulazione: se l’atto non lede i creditori, manca interesse ad agire in simulazione). – Eccepire la prescrizione: l’azione di simulazione, a differenza della revocatoria, non ha termine di prescrizione breve (vale quello ordinario di 10 anni, se non di più, a seconda dell’atto). Quindi è difficile farla franca per decorso di termini se il creditore è diligente.
In sintesi, simulazione è per il debitore la spada di Damocle più pericolosa: se il creditore riesce a provare l’inganno, l’atto viene spogliato della sua facciata e considerato nullo. Ciò può avere effetti a catena (es. se Caio ha ipotecato l’immobile che credeva suo, quell’ipoteca cade perché l’immobile era in realtà di Tizio e Caio non poteva ipotecarlo).
Altre azioni e tutele
Oltre a revocatoria e simulazione, val la pena menzionare brevemente: – Nullità della donazione per difetto di forma (art.782 c.c.): le donazioni di non modico valore richiedono atto pubblico notarile, altrimenti sono nulle. Dunque, se Tizio ha donato €50k a Caio con un semplice assegno circolare, quell’atto di donazione è nullo (non essendoci atto pubblico). Il problema è che spesso un tale trasferimento viene considerato una donazione indiretta, la quale non richiede forma notarile (perché il mezzo usato produce già l’effetto, es. assegno, bonifico). La giurisprudenza considera l’assegno circolare consegnato e incassato come donazione indiretta perfezionata – quindi valida . Il creditore non può far dichiarare nullità di quella liberalità eccependo la mancanza di atto pubblico, perché è “indiretta” e quindi valida (salvo eventualmente obblighi in materia successoria). Pertanto, raramente la difesa può appellarsi alla nullità formale: i giudici guardano alla sostanza. Ci sono state pronunce (Cass. 18725/2017) in cui una donazione di €300k via assegni è stata considerata nulla per mancanza di forma, ma il più delle volte prevale la tesi dell’indiretta. Il debitore, paradossalmente, potrebbe usare la nullità di donazione come escamotage per chiedere la restituzione al donatario – ma a farlo sarebbe il debitore stesso (non il creditore), e spesso il debitore non lo fa perché la donazione era voluta (vuole favorire il donatario). Un creditore può surrogarsi al debitore per far valere la nullità? In teoria sì, come atto di esercizio di un diritto del debitore (azione surrogatoria), ma se il debitore non collabora può essere complicato. – Fondo patrimoniale: a volte i coniugi costituiscono un fondo patrimoniale e vi fanno affluire denaro (anche tramite assegni circolari depositati su conti cointestati in fondo). Il fondo patrimoniale è revocabile se fatto in pregiudizio dei creditori (atto gratuito se senza corrispettivo) e comunque i creditori per debiti estranei ai bisogni familiari possono chiedere di ignorarlo. È un tema vasto a parte. Se l’assegno circolare “senza giustificazione” è confluito in un fondo patrimoniale o trust, ci sono azioni specifiche (revocatoria del fondo, azione di inefficacia ex art.2929-bis c.c. se fatta con formalità e debito precedente). – Actio Pauliana vs procedure concorsuali: se il debitore entra in concordato preventivo o fallimento, i creditori individuali non agiscono più, ma il curatore esercita l’azione revocatoria fallimentare (art. 66 L.F. e art.67 L.F.). Le regole sono un po’ diverse (presunzioni legali per atti a titolo oneroso entro 1 anno se consapevoli dello stato d’insolvenza, gratuiti entro 2 anni etc.). Un assegno circolare donato 1 anno prima del fallimento verrebbe revocato ipso iure come atto gratuito entri 2 anni. Il fallito/donatario come difesa può solo provare che quell’atto rientra in qualche esenzione (poche: es. atti a titolo gratuito di modico valore, pagamenti di beni e servizi nei limiti dell’ordinario, etc.). Nel fallimento insomma la difesa è ancora più limitata. Conviene citare, per completezza, che l’art.67 L.F. pone distinzioni: il pagamento di un debito scaduto con mezzi normali non è revocabile (simile a 2901 c.c.), mentre se il pagamento è effettuato con mezzi anormali (es. dare in pagamento un immobile o titoli di credito inusuali) entro 1 anno, è revocabile. Gli assegni circolari sono considerati mezzo normale di pagamento (sono equiparati al denaro contante). Pertanto, se il debitore fallito aveva pagato un debito certo con assegno circolare alla scadenza, quel pagamento non si revoca in sede fallimentare (salva mala fede del creditore in concorso con insolvenza conclamata). Diverso se l’assegno circolare è usato per un pagamento anticipato di debito non ancora scaduto: allora potrebbe essere atto anormale e revocabile entro 6 mesi. – Azione di arricchimento senza causa o ripetizione d’indebito: infine, consideriamo un caso particolare. Se una persona riceve un assegno circolare senza una causa legale e chi lo ha emesso poi se ne pente, può cercare di recuperare i soldi con altri strumenti. Ad esempio, Tizio consegna a Caio un assegno circolare di €10.000 “in regalo”. Nessun atto formale di donazione. Successivamente Tizio, in difficoltà, chiede indietro i soldi; Caio rifiuta. Tizio potrebbe citare Caio per ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), sostenendo che quell’assegno era privo di causa debendi e fu dato per errore, quindi va restituito. Caio di contro affermerà che era una donazione indiretta valida, quindi lui ha diritto a tenerli. I giudici in questi casi guardano all’intento delle parti: se risulta che Tizio voleva donare, non si può parlare di indebito (non c’è errore), anche se la forma non c’è stata. Quindi vince Caio (donazione indiretta riuscita). Se invece Tizio riesce a far credere che li diede pensando a qualcos’altro (es. un prestito a interesse zero, o un pagamento per un’attività che poi Caio non ha svolto), allora potrebbe configurarsi indebito (mancata controprestazione) e Caio viene condannato a restituire. Ma è un percorso tortuoso: normalmente, chi regala non può riprendersi il regalo a meno di problemi formali seri. In ogni caso, questa è una lite tra le stesse parti del rapporto, non coinvolge creditori terzi, quindi esula dalla “contestazione” che trattiamo (che è invece da parte di Fisco/creditori). L’abbiamo citata solo per chiarire che dare o ricevere soldi senza giustificazione può generare contenziosi anche interni (il famoso “poi te ne approfitti e non me li ridai”).
Ricapitolando la prospettiva civile: il debitore che ha compiuto atti con assegni circolari senza giusta causa e viene chiamato in giudizio dal creditore dovrà preparare una difesa su più fronti: in fatto (provare che quell’atto non lo ha reso insolvente o era per un debito vero), in diritto (invocare le esenzioni di legge: adempimento debito scaduto, ecc.), ed eventualmente transare. Già, perché una soluzione pratica è trovare un accordo col creditore: se possibile, restituire volontariamente parte di quanto trasferito per soddisfare il creditore, evitando la causa o chiudendola con rinuncia agli atti. Molti creditori accettano transazioni (es. ottengono dal terzo donatario che paghi una cifra per evitare esecuzioni, magari rateizzando). Dal punto di vista del debitore, questo può essere preferibile a lunghe cause.
📌 Modello pratico: estratto di “comparsa di risposta” del debitore in una causa di revocatoria
Tribunale di _ – RG _ – Atto di citazione ex art.2901 c.c. promosso da Banca X contro Tizio (debitore) e Caio (terzo beneficiario)
Comparsa di costituzione e risposta per Tizio – convenuto
…
In fatto: L’attore chiede la revocatoria dell’atto di disposizione consistente nel trasferimento a Caio della somma di €30.000 in data 10/01/2023 mediante assegno circolare n.12345. Si deduce che tale atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie di Banca X, creditrice di Tizio per €25.000 derivanti da finanziamento. Si deduce inoltre la malafede di Tizio e Caio (padre e figlio) nell’operazione.
In diritto: Si contesta integralmente la fondatezza della domanda attorea, per le seguenti ragioni.
1. Insussistenza del pregiudizio (eventus damni) – All’epoca del trasferimento contestato (gennaio 2023), il patrimonio del convenuto Tizio era ampiamente sufficiente a garantire il debito verso Banca X. In particolare, Tizio era (ed è tuttora) proprietario di un immobile (valore perizia €80.000) libero da ipoteche e di un veicolo (valore €10.000), oltre ad avere saldo attivo su conto corrente superiore a €20.000. La cessione di €30.000 al figlio non ha impedito né reso difficile il soddisfacimento del credito di €25.000 vantato da Banca X, credito peraltro non ancora scaduto al gennaio 2023. Si richiama giurisprudenza secondo cui spetta al creditore provare il pregiudizio e, una volta allegata la capienza patrimoniale del debitore, la domanda va rigettata se il creditore non dimostra che quel patrimonio residuo fosse insufficiente . Nel caso di specie, il patrimonio residuo di Tizio superava il debito, dunque manca l’eventus damni.
2. Trasferimento a titolo di adempimento di debito scaduto – In via gradata, si deduce che il trasferimento di €30.000 verso Caio costituiva pagamento di un debito certo, liquido ed esigibile che Tizio aveva nei confronti di Caio. Precisamente, Tizio aveva ricevuto da Caio in prestito l’importo di €30.000 in data 10/01/2020 (cfr. doc.1: contratto di mutuo infruttifero fra le parti) con obbligo di restituzione entro 36 mesi. La scadenza era il 10/01/2023. Pertanto, l’assegno circolare consegnato a Caio in tale data rappresenta l’adempimento di detto debito. Ai sensi dell’art. 2901 co.3 c.c., “non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto” . L’azione revocatoria non può dunque colpire tale atto solutorio, in quanto espressione di un dovere legale del debitore. Banca X non ha provato né potrebbe provare che il mutuo tra Tizio e Caio sia fittizio, trattandosi di accordo genuino documentato per iscritto (doc.1) e corroborato da estratti conto (doc.2: bonifico di Caio a Tizio del 12/01/2020, originante il debito). Non vi è collusione con Caio, bensì un normale rapporto creditore-debitore tra padre e figlio, conclusosi con regolare rimborso. Conseguentemente, la domanda attorea è da rigettare in quanto diretta contro un atto non revocabile ex lege.
3. Insussistenza della scientia fraudis – Ad abundantiam, si rileva che Tizio all’epoca dell’atto non aveva la consapevolezza di arrecare pregiudizio a Banca X. Infatti, quest’ultima aveva concesso a Tizio una moratoria fino a giugno 2023 per il rimborso del finanziamento (doc.3: piano di rientro accordato), e Tizio era in bonis. Egli confidava, in buona fede, di poter adempiere al debito verso Banca X attingendo alle altre sue risorse (come poi avvenuto: doc.4, quietanza di pagamento integrale rilasciata da Banca X in data 30/06/2023). Non sussiste dunque l’elemento psicologico del consilium fraudis: Tizio non ha agito “sapendo di nuocere” ai creditori, avendo soddisfatto integralmente il creditore nei termini concordati. Manca inoltre la prova di un accordo fraudolento con Caio, il quale ha semplicemente ricevuto quanto di suo diritto.
Conclusione: Per tutto quanto esposto, Tizio chiede il rigetto della domanda di Banca X, con conferma della piena efficacia dell’atto di pagamento impugnato, vittoria di spese e onorari.
(Anche questa comparsa è sintetica e finalizzata a mostrare alcune difese concrete, quali: prova di capienza patrimoniale, eccezione di pagamento debito scaduto, buona fede. Andrebbe adattata ai dettagli di ciascun caso.)
Domande frequenti (FAQ)
D: Ho versato sul mio conto un assegno circolare senza indicare la causale. Il Fisco lo verrà a sapere?
R: Sì, molto probabilmente. Le banche, su richiesta dell’Agenzia Entrate o Guardia di Finanza, forniscono gli estratti conto con tutti i movimenti. Un assegno circolare versato appare come operazione in accredito (talora con descrizione “Ass. Circ.”). Inoltre, nell’ambito delle indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/73, l’Ufficio può richiedere alla banca dettagli anche sugli assegni negoziati. Dunque l’Agenzia può scoprirlo. Se l’importo è consistente e non giustificato, scatterà la presunzione di reddito occulto . L’assenza di una causale scritta non aiuta a nasconderlo; anzi, è il contribuente che deve poi fornirne una giustificazione.
D: Ho incassato in contanti un assegno circolare invece di versarlo sul conto. È più sicuro ai fini fiscali?
R: Incassare in contanti un assegno circolare (cambiarlo allo sportello) evita che il movimento risulti nell’estratto conto, ma non garantisce impunità fiscale. Infatti, se il Fisco scopre quell’operazione (ad esempio, attraverso controlli incrociati sulla banca emittente, o trovando la matrice dell’assegno presso chi l’ha emesso), la considererà ugualmente un versamento “extraconto” e la presunzione di imponibilità si applicherà lo stesso . Cassazione ha equiparato l’incasso extra-conto al versamento su conto . Inoltre, monetizzare assegni per non farli transitare sul conto è visto molto male: può insospettire anche come comportamento da riciclaggio. Quindi, sul piano fiscale, incassare fuori conto non elimina il problema della giustificazione (lo sposta solo sul piano della prova: dovrete conservare ancor più documenti visto che in conto non c’è traccia).
D: Sono un privato cittadino senza partita IVA. Vale anche per me la regola che i versamenti bancari si presumono redditi?
R: Sì, vale per tutti i contribuenti, sebbene sia nata per imprese e professionisti. La Cassazione ha affermato più volte che la presunzione legale dell’art. 32 DPR 600/73 opera verso chiunque percepisca redditi, quindi anche lavoratori dipendenti o pensionati . In pratica, se un privato versa assegni o contanti di molto superiori al suo stipendio e non li giustifica, l’Ufficio può presumere che derivino da redditi diversi non dichiarati (es. un secondo lavoro in nero, affitti non dichiarati, vincite non denunciate). Naturalmente il privato avrà vari modi per difendersi (donazioni, risparmi, ecc.), ma l’onere è a suo carico . L’unica differenza è sui prelievi: per i privati non c’è presunzione sui soldi usciti.
D: Ho ricevuto come regalo dai miei genitori un assegno circolare di €20.000. Devo dichiararlo al Fisco?
R: In linea di massima no come reddito, se è effettivamente una donazione. Le donazioni tra genitori e figli sono esent da imposta di donazione fino a 1 milione di euro (franchigia), quindi non paghi imposte su quella somma e non devi indicarla in dichiarazione dei redditi (perché non è un reddito prodotto). Tuttavia, attenzione: se in futuro subisci un accertamento sul tuo conto, dovrai provare che quei €20k erano un regalo. È bene tenere traccia scritta: ad esempio, fai sottoscrivere ai tuoi genitori una dichiarazione di donazione indiretta, con data e importo, meglio se autenticata o registrata (per dare data certa). Questo documento ti aiuterà a giustificare la provenienza esente . Senza un qualche pezzo di carta, l’Agenzia potrebbe contestarti quei €20k come “ricavo in nero” finché non dimostri il contrario. Quindi il consiglio è formalizzare il più possibile anche le liberalità in famiglia (oltre ad usare preferibilmente bonifico o assegno non trasferibile nominativo, così che la provenienza familiare sia chiara).
D: Ho emesso un assegno circolare a favore di mia moglie per metà dei miei risparmi, senza motivo commerciale. Un anno dopo alcuni creditori mi hanno fatto causa. Mia moglie rischia di perdere quei soldi?
R: Potrebbe, purtroppo. Se i creditori ottengono una sentenza a loro favore (un decreto ingiuntivo, una condanna) e scoprono che un anno prima hai trasferito una somma ingente a tua moglie senza causa apparente, quasi certamente avvieranno un’azione revocatoria. Trattandosi di atto a titolo gratuito verso il coniuge (presumibilmente a creditore già esistente o comunque conoscibile), è uno scenario da manuale per l’art. 2901 c.c.: il giudice molto probabilmente dichiarerà inefficace la donazione . Ciò significa che tua moglie dovrà restituire la somma (o subirne il pignoramento). Nel migliore dei casi, se i creditori non agiscono entro 5 anni, l’azione si prescrive; ma difficilmente lasceranno correre. L’unica speranza è che tu abbia ancora altri beni per soddisfarli (così da sostenere che l’atto non li ha danneggiati). Ma se quell’assegno ha prosciugato i tuoi risparmi, tua moglie è ex lege tenuta a cedere ai creditori. Tieni presente che, essendo coniugi, i creditori nemmeno devono provare che tua moglie sapesse del pregiudizio: negli atti gratuiti non serve , e comunque la consapevolezza è implicata dal rapporto (scientia fraudis spesso presunta tra coniugi). In conclusione, sì: se la somma è rilevante e i creditori procedono, tua moglie rischia di perderla. Per evitarlo, l’unica sarebbe stato non fare quel trasferimento – oppure avere fatto un atto formale di fondo patrimoniale (che però li protegge solo per debiti estranei ai bisogni familiari, ed è anch’esso revocabile entro 5 anni).
D: Cosa succede se emetto assegni circolari senza clausola “non trasferibile” sopra la soglia consentita?
R: In Italia vige una normativa antiriciclaggio che impone il limite di €1.000 per assegni trasferibili. Ciò vuol dire che assegni (bancari o circolari) di importo pari o superiore a €1.000 devono essere emessi con l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile” . È vietato emetterli in forma libera. Se lo fai, incorri in una sanzione amministrativa elevata: attualmente da €3.000 fino a €50.000 per ogni violazione (D.Lgs. 231/2007, art.63). Non c’è tolleranza: anche assegno di €1.500 senza clausola è sanzionabile. Inoltre, se cerchi di aggirare facendo tanti assegni < €1.000 per dividere l’importo (c.d. frazionamento artificioso), rischi comunque sanzioni cumulabili . Queste sanzioni le irroga il Ministero dell’Economia (UIF), spesso segnalate dalla banca stessa. Quindi, mai emettere assegni (anche circolari) sopra soglia senza clausola: chiedi sempre quelli “non trasferibili” (tanto le banche ormai li rilasciano di default così). In sintesi: oltre ai rischi di contestazioni come riciclaggio etc., c’è proprio un illecito amministrativo formale.
D: Un assegno circolare versato sul conto di un professionista è sempre considerato “in nero” dal Fisco?
R: Non sempre, ma la presunzione è molto forte. La Cassazione ha più volte affermato che quando un libero professionista incassa assegni circolari e non li giustifica nelle scritture contabili, l’Ufficio può riprenderli a tassazione come compensi non dichiarati . Spetta al professionista provare che non sono reddito (es. che erano anticipazioni, rimborsi spese, utili già tassati, ecc.), altrimenti la presunzione resta . In una frase efficace: “per il Fisco, l’assegno circolare versato sul conto dell’imprenditore o del professionista si presume sempre ricavo in nero” . Questa è la linea dura. Ovviamente puoi difenderti, ma devi avere ottime pezze d’appoggio. Quindi, se sei un professionista, ogni assegno (circolare o no) che incassi deve avere dietro una ricevuta, fattura o documentazione. Altrimenti rischi moltissimo in caso di verifica.
D: In caso di contestazione penale di riciclaggio, è utile la circostanza che i flussi erano comunque tracciabili (assegni nominativi, bonifici)?
R: Può sembrare intuitivo dire “ma ho usato assegni, non valigie di contanti, quindi non volevo riciclare”; tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che la tracciabilità formale non esclude il riciclaggio, se comunque l’operazione è fatta per rendere più difficile seguire i soldi . Ad esempio, nel caso di assegni circolari frazionati e incassati in contanti, c’era la traccia degli assegni con numero di serie, ma ciò non ha impedito la condanna: la Corte disse che il reato sussiste “indipendentemente dalla tracciabilità dei flussi finanziari” . L’obiettivo infatti era spezzare il collegamento tra soldi illeciti e beneficiario finale, e questo era riuscito pur usando strumenti bancari. Quindi, in tribunale penale non basta dire “ho lasciato tracce, quindi non volevo occultare”: servirà dimostrare, ad esempio, che non c’era intenzione fraudolenta o che credevi quei fondi leciti. Certo, se hai usato solo canali ufficiali (assegni non trasferibili, bonifici) e non hai fatto movimenti strani tipo girare assegni a terzi, la tua posizione è migliore rispetto a chi ha fatto operazioni opache. Potrai argomentare che non c’era dolo dissimulatorio perché hai messo tutto su conti nominativi. Però non c’è garanzia che basti: dipende dal contesto. In sintesi: la tracciabilità aiuta la difesa ma non esclude di per sé il riciclaggio, se la finalità era comunque mascherare l’origine.
D: Un creditore privato può scoprire che ho fatto assegni circolari a qualcuno? Come fanno i creditori a trovare queste tracce?
R: Se parliamo di creditori privati (non il Fisco), per scoprire movimenti finanziari devono o avere già un titolo esecutivo e procedere con mezzi legali (pignoramenti, istanza al giudice), oppure ottenere informazioni con investigazioni autorizzate. Ad esempio: – Dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo o sentenza, il creditore può chiedere al giudice di autorizzare la ricerca telematica dei tuoi conti correnti (art. 492-bis c.p.c.), e lì vedere movimenti. Oppure, se già sa con che banca lavori, può pignorare il conto e chiedere alla banca di dichiarare che movimenti ci sono stati. – Spesso però scoprono certe cose tramite raccolta documentale in altre cause o da altri creditori, o controllando bilanci se sei socio di società. Gli assegni circolari in sé non hanno una “pubblicità” (non c’è un registro pubblico degli assegni). Però lasciano tracce nei conti. – Un’altra via: se il creditore ti ha fatto un atto di pignoramento dei crediti presso la banca, la banca deve dichiarare se detiene cose tue. Nel farlo, alcune banche indicano anche assegni circolari in deposito o altri movimenti. Oppure il creditore convoca la banca in tribunale come terza pignorata e può farle domande (ad esempio: “La scorsa estate il Sig.X ha ricevuto assegni circolari?” – domanda specifica, non detto che il giudice la ammetta, ma possibile). – Inoltre, consideriamo che se si arriva a una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione), il curatore ha accesso a tutti gli estratti conto e così vede eventuali assegni circolari emessi/incassati.
In sintesi, un creditore prima di avere un titolo esecutivo non può facilmente conoscere i tuoi movimenti bancari (tutela privacy). Ma appena lo ottiene, ha vari poteri per indagare. Pertanto, contare sul segreto bancario ormai è ingenuo: di solito, se c’è stata una transazione sospetta, viene fuori con il tempo. L’uso di assegni circolari può ritardare la scoperta (perché se l’assegno è incassato in contanti e non appare in conto, il creditore deve fare più fatica, chiedendo ad esempio i movimenti del conto di chi l’ha emesso), ma non la impedisce.
D: Quando l’assegno circolare è considerato “mezzo anormale di pagamento” in una possibile revocatoria fallimentare?
R: Di regola l’assegno circolare non è mezzo anormale. È un mezzo di pagamento considerato del tutto regolare, equivalente al contante garantito. La legge fallimentare (art. 67) elenca come atti revocabili quelli a titolo oneroso fatti nell’anno precedente il fallimento “se il curatore prova che la controparte conosceva lo stato d’insolvenza”, e tra essi i pagamenti di debiti liquidi e scaduti compiuti con mezzi anormali nel semestre precedente. Esempi di mezzi anormali: cessione di un credito in pagamento, datio in solutum non in denaro, pagamento in contanti di ingenti somme fuori dagli usi, ecc. Un assegno circolare invece è considerato pagamento per contanti in forma bancaria, del tutto usuale, quindi non è anomalo. Se paghi un fornitore con assegno circolare a scadenza, anche se fallisci entro 6 mesi il pagamento non è revocabile (perché rientra nell’esenzione “pagamento di debito scaduto con mezzi normali” ). Diverso sarebbe se usassi un assegno circolare postdatato (ma non esiste formalmente, essendo sempre a vista; se lo postdati diventa un illecito amministrativo come assegno bancario postdatato). Oppure se staccassi assegni circolari a raffica prima del fallimento per pagare anticipatamente alcuni creditori privilegiati in danno di altri: se li hai pagati prima della scadenza o in misura non conforme, potrebbe configurarsi bancarotta preferenziale (penale) e revoca di quei pagamenti. Quindi la normalità non dipende tanto dallo strumento (assegno circolare è normale) ma dal contesto: pagare debiti non scaduti, o accordarsi per incassare l’assegno dopo il fallimento, ecc., sono condotte fraudolente.
D: Come possono i miei familiari (o soci) tutelarsi se ricevono soldi da me e temono azioni dei miei creditori?
R: La situazione ideale è evitare proprio transazioni non giustificate. Se però i tuoi familiari hanno già ricevuto somme da te, possono: – Conservarne la prova dell’eventuale causa (prestito, restituzione, ecc.). Se un domani un creditore attacca, poter esibire un contratto di mutuo, o una scrittura di divisione, aiuta molto la difesa (come visto sopra). – Non mischiare quei soldi con altri o dissiparli: se tua moglie, ad esempio, ha ricevuto €50k e li spende tutti, quando arriva il creditore lei non li ha più ma potrebbe subirne comunque la rivalsa (diventando debitrice verso di lui). Se invece li tiene investiti in qualcosa di tracciabile (es. acquista un immobile a suo nome), almeno può negoziare col creditore offrendo ipoteca o vendendo l’immobile per pagare. – Dimostrare la propria buona fede: se sono parti estranee (non familiari stretti) possono dire di non sapere delle tue difficoltà. Ma se parliamo di familiari è difficile sostenere ignoranza totale. Comunque, comportamenti trasparenti (tipo: far risultare nei propri conti l’entrata come “regalo da Tizio”) paradossalmente aiutano a mostrare che non c’era malizia; anche se giuridicamente poi l’azione revocatoria parte lo stesso. – Valutare strumenti protettivi: ad esempio, se marito e moglie trasferiscono denaro tra loro, anziché farlo “liberamente” potrebbero formalizzarlo in un contratto (es. costituzione di un fondo patrimoniale con quei soldi destinati a bisogni famiglia – questo vincolo però non difende da debiti precedenti se non per quelli non legati a bisogni; oppure stipulare una polizza vita a favore del coniuge con quei soldi – le polizze vita in certi limiti sono impignorabili se anteriori ai debiti e non manifestamente sproporzionate). Questi strumenti vanno valutati caso per caso con un legale esperto, perché hanno pro e contro e se fatti in extremis possono anch’essi essere invalidati (es. trust o fondi creati sotto insolvenza = revocabili).
D: Un assegno circolare ricevuto senza giustificazione può comportare problemi anche con il Fisco come potenziale donazione da tassare?
R: Sotto il profilo dell’imposta sulle donazioni, come accennato, in Italia si tassa solo oltre certe franchigie e in certe condizioni. Ma c’è un dettaglio: le cosiddette liberalità indirette (regali fatti con mezzi come assegni, bonifici, intestazioni di beni) non scontano imposta di donazione se non emergono da atti pubblici o dichiarazioni dell’interessato in sede fiscale . L’Agenzia delle Entrate non può tassare di sua iniziativa tali liberalità a meno che: a) tu stesso, in un accertamento, dichiari “questi soldi erano una donazione” – allora potrebbe applicare l’imposta (7% oltre franchigia) se supera i limiti ; b) la donazione indiretta emerga in atti notarili (es. compri casa al figlio con i tuoi assegni e lo dichiarate nell’atto: quell’atto va registrato e lì potrebbero chiedere l’imposta). Quindi, il rischio principale con il Fisco per i soldi regalati non formalmente non è tanto l’imposta di donazione (che spesso non viene richiesta), quanto la tassazione come reddito occulto se non riesci a dimostrare la provenienza. Curiosamente, a volte per evitare la tassazione come reddito, il contribuente dichiara che era una donazione… e se è molto grande, l’Agenzia prova a fargli pagare l’imposta di donazione! Ma solo se supera soglie (es. > €1 mio tra padre-figlio) e se la donazione è accertata con certezza documentale . In pratica, per ora il Fisco usa la leva dell’IRPEF più che andare a colpire con imposta donativa (anche perché se è sotto franchigia, comunque non la paga). Quindi la preoccupazione immediata è l’IRPEF da presunzione, non l’imposta sulle donazioni.
Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono imputati assegni circolari senza giustificazione come redditi occulti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono imputati assegni circolari senza giustificazione come redditi occulti?
Vuoi sapere cosa rischi e come difenderti in modo efficace?
👉 Prima regola: dimostra la provenienza lecita delle somme e chiarisci se gli assegni circolari rappresentano redditi imponibili o semplici movimentazioni patrimoniali.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Emissione o incasso di assegni circolari senza causale chiara;
- Somme accreditate su conti correnti ritenute ricavi non dichiarati;
- Utilizzo di assegni circolari per trasferire denaro tra soggetti senza contratto scritto;
- Collegamenti con operazioni immobiliari o patrimoniali non documentate;
- Assegni circolari intestati a persone fisiche ma usati in ambito aziendale.
📌 Conseguenze della contestazione
- Presunzione di ricavo occulto delle somme prive di giustificazione;
- Recupero delle imposte su importi considerati imponibili;
- Sanzioni per dichiarazione infedele fino al 90% della maggiore imposta;
- Interessi di mora sulle somme accertate;
- Possibili contestazioni penali se gli importi sono rilevanti e ritenuti frutto di evasione.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Gli assegni circolari si riferiscono a redditi o a semplici trasferimenti patrimoniali?
- Esiste documentazione (contratti, scritture private, atti notarili) che spieghi il movimento?
- Le somme erano già tassate in Italia o all’estero?
- L’accertamento si basa su prove oggettive o solo su presunzioni?
- I termini per l’accertamento sono stati rispettati?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Copia degli assegni circolari e delle relative quietanze;
- Contratti di compravendita, prestiti o donazioni che giustificano l’operazione;
- Estratti conto bancari con la movimentazione;
- Dichiarazioni fiscali degli anni contestati;
- Atti notarili o scritture private collegate ai trasferimenti.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la non imponibilità delle somme (donazioni, restituzioni, prestiti, trasferimenti familiari);
- Contestare la riqualificazione automatica come reddito occulto;
- Evidenziare la tracciabilità e la liceità delle operazioni;
- Richiedere annullamento in autotutela per contestazioni basate solo su presunzioni;
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni;
- Difesa penale mirata se l’accusa riguarda riciclaggio o evasione fiscale.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza i movimenti bancari e la natura degli assegni circolari contestati;
📌 Valuta la legittimità della contestazione e costruisce la linea difensiva;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti assiste nei giudizi fiscali e, se necessario, nei procedimenti penali;
🔁 Suggerisce strategie preventive per evitare futuri problemi legati all’uso di assegni circolari.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in accertamenti fiscali e movimentazioni bancarie;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni su assegni circolari e trasferimenti sospetti;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sugli assegni circolari senza giustificazione non sempre sono fondate: spesso derivano da presunzioni e da mancanza di documentazione chiara.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la provenienza lecita delle somme, evitare la riqualificazione come reddito occulto e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti fiscali sugli assegni circolari inizia qui.