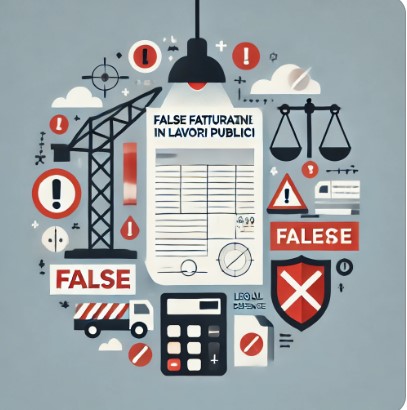Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per presunte false fatturazioni in lavori pubblici? In questi casi, l’Ufficio presume che le fatture emesse o ricevute non corrispondano a reali prestazioni o forniture, ma siano state utilizzate per gonfiare i costi, ridurre il reddito imponibile o creare indebite detrazioni IVA. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, pesanti sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, procedimenti penali per frode fiscale e truffa ai danni dello Stato. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: con una difesa solida e documentata è possibile dimostrare la reale esistenza delle operazioni o ridurre sensibilmente le sanzioni.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta false fatturazioni in lavori pubblici
– Se le fatture non sono supportate da contratti, ordini o documentazione di cantiere
– Se le prestazioni fatturate risultano sproporzionate rispetto all’avanzamento dei lavori
– Se emergono incongruenze tra contabilità di cantiere, certificati di pagamento e fatture emesse
– Se l’Ufficio presume la creazione di fatture per operazioni inesistenti o parzialmente fittizie
– Se vi è collegamento tra l’impresa appaltatrice e soggetti emittenti fatture irregolari
Conseguenze della contestazione
– Recupero a tassazione dei costi dedotti e dell’IVA detratta indebitamente
– Applicazione di sanzioni amministrative fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Inserimento dell’impresa in liste di controllo per future verifiche fiscali
– Denuncia penale per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare la reale esecuzione dei lavori con documentazione di cantiere, stati avanzamento e collaudi
– Produrre contratti, ordini, certificazioni e prove di pagamento a supporto delle fatture contestate
– Contestare la qualificazione come operazioni inesistenti se si tratta di errori formali o di contabilizzazione
– Evidenziare vizi di motivazione, difetti istruttori o errori di calcolo nell’accertamento
– Richiedere la riqualificazione della contestazione per ridurre le sanzioni applicabili
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, difendersi anche in sede penale
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare i rapporti contrattuali e la documentazione tecnica e contabile dei lavori pubblici
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta qualificazione delle operazioni fatturate
– Redigere un ricorso fondato su prove concrete e vizi procedurali dell’accertamento
– Difendere l’impresa e i suoi amministratori davanti ai giudici tributari e penali
– Tutelare il patrimonio aziendale e personale da conseguenze fiscali e penali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della legittimità di parte delle fatture contestate
– La certezza di pagare solo quanto realmente dovuto per legge
⚠️ Attenzione: le contestazioni su fatturazioni in lavori pubblici rientrano tra le verifiche più gravi, perché possono avere anche rilevanza penale. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata per evitare conseguenze irreversibili.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e penale tributario – spiega come difendersi in caso di contestazioni su false fatturazioni in lavori pubblici e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.
👉 Hai ricevuto una contestazione per presunte false fatturazioni in lavori pubblici? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la legittimità dell’accertamento e costruiremo la strategia difensiva più efficace per tutelare i tuoi interessi.
Introduzione
Le contestazioni relative a false fatturazioni nell’ambito di lavori pubblici rappresentano una questione complessa e delicata nell’ordinamento italiano. Si tratta di accuse che possono coinvolgere contemporaneamente profili penali, tributari e amministrativi, richiedendo un approccio difensivo multidisciplinare. In sostanza, l’autorità contesta che alcune fatture emesse o utilizzate nell’esecuzione di appalti pubblici siano “false”, ovvero riferite a operazioni mai avvenute (fittizie) o diverse da quelle reali. Tali accuse possono portare a gravi conseguenze: procedimenti penali per reati di truffa ai danni dello Stato o reati fiscali, recuperi d’imposta e sanzioni fiscali, nonché provvedimenti amministrativi come l’esclusione dalle gare pubbliche o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Affronteremo sia i profili penali (es. art. 640-bis c.p., 479 c.p., 483 c.p. e reati tributari come la dichiarazione fraudolenta), sia quelli fiscali (frodi IVA e indebite detrazioni) e amministrativi (effetti sulle gare pubbliche, interventi di ANAC e altre autorità). Inoltre, proporremo uno schema di difesa tipo, con la cronologia degli eventi tipici e un “fascicolo processuale” simulato, per dare un quadro concreto di come si sviluppa un caso del genere e come il difensore può intervenire in ogni fase.
Importanza della difesa coordinata: le accuse di false fatturazioni in ambito pubblico richiedono una difesa coordinata su più fronti. Ad esempio, una fattura contestata come falsa potrebbe dare avvio a un’indagine penale per frode ai danni dello Stato e contemporaneamente a un accertamento fiscale per recuperare l’IVA detratta indebitamente. Inoltre, la notizia dell’indagine penale potrebbe portare una stazione appaltante ad escludere l’azienda dalla gara in corso per “grave illecito professionale”. È evidente dunque che bisogna agire tempestivamente e in maniera strategica in ogni sede: penale, tributaria e amministrativa.
Nei paragrafi seguenti chiariremo innanzitutto cosa si intende per false fatturazioni nei lavori pubblici, poi esamineremo il quadro normativo di riferimento (con particolare attenzione ai reati ipotizzabili e alle sanzioni previste, alla luce delle novità normative e giurisprudenziali degli ultimi anni). Successivamente, tratteremo le strategie difensive possibili, distinguendo tra il procedimento penale (dalla fase delle indagini fino all’eventuale esecuzione della pena), il procedimento tributario (dinanzi all’Agenzia delle Entrate e alle Commissioni Tributarie) e i rimedi in ambito amministrativo (tutela dell’azienda nelle procedure di gara e nei confronti di ANAC/MEA).
Ricordiamo che in caso di contestazioni per false fatturazioni, il diritto di difesa è garantito dalla legge ed è possibile – anzi doveroso – far valere le proprie ragioni: ad esempio, dimostrando che i lavori fatturati sono stati effettivamente eseguiti, che non vi era intenzione di frodare il fisco o l’ente pubblico, o che l’azienda ha adottato misure per prevenire irregolarità (c.d. self-cleaning). Le sezioni successive forniranno gli strumenti per impostare una difesa efficace, con riferimenti a casi pratici e pronunce recentissime della Corte di Cassazione e di altre autorità.
False fatturazioni nei lavori pubblici: definizioni e contesto
Cosa si intende per “false fatturazioni”: Nel gergo giuridico-fiscale, le false fatturazioni sono quelle relative a operazioni inesistenti, cioè vendite, prestazioni o forniture che in realtà non sono mai avvenute, oppure che sono avvenute in modo diverso da come riportato. La legge distingue due categorie principali:
- Operazioni oggettivamente inesistenti: quando la transazione indicata in fattura non è mai avvenuta nella realtà (es. viene fatturata la fornitura di materiali che non sono mai stati consegnati, o lavori mai eseguiti). La fattura è del tutto fittizia.
- Operazioni soggettivamente inesistenti: quando l’operazione c’è stata, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura. Tipicamente, ciò avviene tramite società interposte o cartiere: ad esempio, i lavori vengono eseguiti da Tizio, ma la fattura viene emessa da Caio, che funge solo da “schermo”. L’operazione è reale, ma il fornitore indicato non è quello effettivo.
Nell’ambito dei lavori pubblici, queste situazioni possono sorgere in varie forme. Ad esempio, un’impresa appaltatrice potrebbe concordare con un’altra società (magari compiacente) l’emissione di fatture per prestazioni mai effettuate, al fine di gonfiare i costi dell’appalto o creare fondi neri. Oppure, si può simulare un subappalto: l’impresa principale finge di subappaltare dei lavori a una cooperativa o società di comodo, la quale emette fatture (gravate da IVA) per servizi che in realtà consistono solo nel mettere a disposizione manodopera già impiegata dall’appaltatore stesso. In questo caso, le fatture formalmente si riferiscono a un contratto di appalto di servizi, ma sostanzialmente servono solo a mascherare un’illecita somministrazione di manodopera . Come ha affermato la Cassazione, l’uso di tali fatture fittizie nelle dichiarazioni fiscali integra il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, perché si tratta di elementi passivi fittizi creati al solo scopo di ottenere indebiti benefici fiscali (come la detrazione IVA su costi che in realtà sono retribuzioni) .
Va sottolineato che le false fatturazioni nei lavori pubblici spesso sono collegate ad altre condotte illecite. In passato, indagini su grandi appalti pubblici hanno rivelato sistemi di frode sistematica in cui le fatture false servivano a creare provviste occulte (c.d. fondi neri) con cui pagare tangenti o finanziare attività illecite. In altri casi, le fatture per opere mai eseguite sono state utilizzate per percepire indebitamente contributi pubblici o incentivi fiscali (si pensi alle frodi legate al Superbonus 110% e altri bonus edilizi). Ad esempio, emettere fatture relative a lavori in realtà non realizzati, al solo scopo di maturare crediti d’imposta da utilizzare o cedere, configura sia una frode ai danni dello Stato sia reati fiscali. La Cassazione penale ha chiarito che la mera creazione di un credito d’imposta fittizio basato su lavori mai eseguiti può integrare il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., senza che occorra il successivo effettivo utilizzo o vendita del credito . Analogamente, dal lato fiscale, è stato ribadito che emettere fatture false per generare crediti d’imposta inesistenti rientra nell’ambito dell’art. 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture false) in quanto “il fine di consentire a terzi l’evasione include anche il riconoscimento di un credito d’imposta inesistente” .
Perché le false fatturazioni sono usate negli appalti pubblici? I motivi possono essere diversi:
- Gonfiare i costi rimborsabili: In alcuni appalti, specie quelli a misura o con prezzi unitari, presentare fatture per lavori mai svolti o materiali mai forniti consente all’impresa disonesta di ottenere pagamenti maggiorati dall’ente appaltante, realizzando un profitto indebito a danno dell’Amministrazione.
- Creare fondi illeciti: Come accennato, pagando fatture fittizie l’impresa appaltatrice fa uscire legalmente denaro dalle proprie casse (giustificandolo come costo), denaro che poi rientra “in nero” dall’emittente compiacente (che spesso trattiene solo l’IVA o una percentuale). Questi fondi occulti possono poi essere usati per corrompere funzionari, finanziare altri illeciti o arricchimento personale.
- Evasione fiscale e indebite detrazioni: Le fatture false permettono anche di abbattere il reddito imponibile (aumentando i costi deducibili) e di detrarre indebitamente l’IVA sugli acquisti mai avvenuti. Ad esempio, se fatturo lavori mai fatti per 100.000 € + IVA, posso detrarre 22.000 € di IVA che in realtà non ho diritto a detrarre, riducendo i versamenti all’Erario. Questa pratica configura il reato di dichiarazione fraudolenta e comporta sanzioni fiscali molto elevate.
- Aggirare vincoli o qualificazioni: Talvolta le fatture fittizie tra imprese collegate vengono utilizzate per simulare volumi di attività, requisiti o passaggi di denaro che servono ad aggirare norme (es. i limiti al subappalto, o per far figurare esperienze pregresse non veritiere ai fini della qualificazione SOA).
Va da sé che tali condotte, quando scoperte, vengono perseguite con decisione dalle autorità. Negli ultimi anni, complice anche la digitalizzazione dei controlli fiscali e l’attenzione dell’ANAC sulla trasparenza negli appalti, le frodi con false fatture sono state oggetto di numerose operazioni investigative. Il legislatore, da parte sua, ha inasprito le pene per i reati fiscali connessi (nel 2019) e ha introdotto normative speciali per il contrasto alle frodi nei bonus edilizi, mentre la giurisprudenza di legittimità ha affinato i criteri per valutare queste situazioni. Affrontare un’accusa di false fatturazioni oggi richiede dunque un aggiornamento costante sulle ultime novità normative e sulle pronunce giurisprudenziali più recenti, che spesso chiariscono aspetti chiave per l’esito dei procedimenti.
Nel prossimo capitolo delineeremo il quadro normativo di riferimento – penale, tributario e amministrativo – in cui si inseriscono le contestazioni di false fatturazioni in lavori pubblici, prima di passare alle strategie difensive specifiche.
Quadro normativo: reati e sanzioni applicabili
In caso di contestazione di false fatturazioni connesse a lavori pubblici, le norme potenzialmente rilevanti appartengono a diversi ambiti:
- Codice Penale (reati comuni e contro la P.A., come la truffa aggravata ai danni dello Stato e i falsi in atti);
- Legislazione penale tributaria (D.Lgs. 74/2000 sui reati fiscali, in primis quelli relativi a fatture per operazioni inesistenti);
- Normativa sugli appalti pubblici (in particolare il D.Lgs. 50/2016, oggi sostituito dal D.Lgs. 36/2023, per quanto riguarda cause di esclusione e provvedimenti di autorità come ANAC);
- Altre leggi speciali (es. D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società per reati commessi da dirigenti, che dal 2019 include anche alcuni reati tributari; norme anticorruzione; Codice della Corte dei conti per il danno erariale).
Di seguito esaminiamo i principali reati e istituti giuridici coinvolti, con focus sugli articoli di legge più frequentemente contestati e le relative sanzioni, alla luce delle modifiche legislative recenti e della giurisprudenza fino al 2025. Le tabelle riepilogative forniranno una visione d’insieme di questi illeciti.
Profili penali nel Codice Penale
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Si tratta di uno dei reati chiave in queste vicende. L’art. 640-bis c.p. punisce chi, con artifizi o raggiri, inducendo in errore un ente pubblico, si procura un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto riguarda “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche”. È in sostanza la truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico per ottenere indebitamente denaro pubblico. Le pene previste sono elevate: reclusione da 2 a 7 anni, e si procede d’ufficio (quindi non serve una querela per avviare il procedimento). Questo reato si configura tipicamente quando un soggetto ottiene pagamenti non dovuti dall’amministrazione pubblica attraverso mezzi fraudolenti.
Nel caso delle false fatturazioni in appalto pubblico, l’ingiusto profitto consiste nei pagamenti ottenuti dall’ente per lavori mai eseguiti o sovrafatturati. Gli artifizi o raggiri possono consistere proprio nella presentazione di documenti falsi (es. fatture, stati di avanzamento lavori falsati, certificazioni mendaci) per far credere all’ente appaltante che le opere siano state eseguite e giustificare l’esborso. La Cassazione ha più volte confermato che l’utilizzo di documentazione fiscale ideologicamente falsa (come le fatture per operazioni inesistenti) per accedere a incentivi o fondi pubblici integra gli estremi del reato di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. . Ad esempio, nel contesto dei bonus edilizi (Superbonus 110%, bonus facciate, ecc.), presentare fatture false per lavori non eseguiti al fine di generare crediti d’imposta è stato ricondotto a questo reato: la Suprema Corte (sent. n. 40015/2024) ha affermato che il riconoscimento di un credito d’imposta su lavori mai svolti documentati da fatture false costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato .
Un aspetto importante, emerso proprio nei casi dei bonus fiscali, riguarda il momento di consumazione della truffa: secondo la Cassazione, la truffa aggravata si perfeziona già con la creazione del credito o con l’ottenimento dell’atto di erogazione, anche se poi il credito non viene effettivamente usato o ceduto . In pratica, nel momento in cui, grazie agli artifici (documenti falsi), il soggetto si assicura il diritto al beneficio pubblico (il credito fiscale nel cassetto, o la determinazione di liquidazione del SAL da parte dell’ente appaltante), il reato è consumato. Non occorre attendere che il denaro sia effettivamente incassato o il credito monetizzato; la messa in pericolo del denaro pubblico è sufficiente. Ciò comporta che anche tentativi molto avanzati vengono puniti come reato consumato. Per la difesa, questo significa che non basta dimostrare di non aver incassato nulla: se il meccanismo fraudolento ha messo in moto il processo di erogazione, la truffa è configurabile.
Va aggiunto che l’art. 640-bis c.p. è formulato in modo da assorbire altri reati strumentali eventualmente commessi. Ad esempio, se la frode è stata attuata presentando false dichiarazioni o attestazioni all’ente, queste condotte possono costituire di per sé reati di falso (come vedremo a breve, art. 479 o 483 c.p.). Tuttavia, secondo i principi generali, quando la falsa dichiarazione è il mezzo per commettere la truffa ai danni dello Stato, il reato di falso può rimanere assorbito dalla più grave truffa aggravata, configurando un concorso apparente di norme. In pratica, il soggetto viene punito solo per la truffa aggravata, che è il reato principale, e il falso viene considerato una modalità esecutiva. Ad esempio, presentare un SAL falso con firme contraffatte da un pubblico ufficiale per farsi liquidare lavori non fatti comporterà in genere la contestazione della truffa aggravata, senza ulteriore condanna per il falso, in quanto quest’ultimo è servito a realizzare la frode. Analogamente, nel rapporto tra truffa aggravata (640-bis) e indebita percezione di erogazioni (316-ter c.p.) – che è un reato minore di cui diremo –, la giurisprudenza esclude il concorso tra i due: se ricorrono gli artifizi e raggiri propri della truffa, si applica 640-bis e non 316-ter. Viceversa, 316-ter assorbe i falsi semplici (art. 483) funzionali a ottenere contributi .
Per completezza, ricordiamo che l’art. 640-bis c.p. comporta anche pene accessorie: una eventuale condanna definitiva può comportare l’interdizione dai pubblici uffici e soprattutto l’incapacità di contrattare con la P.A. per un certo periodo. Quest’ultima è una sanzione accessoria prevista dall’art. 32-quater c.p. per i reati come la truffa ai danni dello Stato (elencati nell’art. 32-quater stesso). Di regola ha durata fino a 5 anni, salvo che ricorrano circostanze aggravanti particolari che la rendono perpetua (non frequenti in questi casi) . Il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) stabilisce all’art. 94 che, se il giudice penale non fissa la durata della pena accessoria, valgono i termini massimi di legge (per es., 5 anni) come automatica causa di esclusione dalle gare . Dunque, una condanna per 640-bis c.p. produrrà quasi certamente l’esclusione da appalti per 5 anni, salvo riabilitazione. Questo rende la difesa penale ancora più cruciale, data la posta in gioco per l’attività dell’impresa.
Differenza con l’indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.): Spesso in questi casi la difesa cerca, se possibile, di ottenere una riqualificazione dell’accusa da 640-bis (più grave) in 316-ter c.p. (più lieve). L’art. 316-ter punisce chi, senza artifici o raggiri, mediante dichiarazioni o documenti falsi, ottiene indebitamente erogazioni pubbliche. La pena è più bassa (reclusione fino a 3 anni, se l’importo supera 3.999,96 €; sotto tale soglia il fatto è solo illecito amministrativo). In pratica è il reato di percepire fondi pubblici con false dichiarazioni ma senza la “macchinazione fraudolenta” tipica della truffa. La linea di confine tra 316-ter e 640-bis sta proprio nell’uso degli artifizi o raggiri: secondo la Cassazione, quando la condotta fraudolenta è più insidiosa del semplice mendacio documentale – ad esempio quando c’è un complesso sistema di false fatture, imprese fantasma, simulate gare o collusioni – si ricade nell’art. 640-bis . Il solo presentare un’istanza con dati falsi, invece, potrebbe rientrare in 316-ter. Inoltre, come detto, il falso ideologico (art. 483 c.p.) resta assorbito in 316-ter quando l’ottenimento del contributo pubblico si fonda su quel falso . In alcune pronunce, la Cassazione ha dichiarato che “il reato di cui all’art. 316-ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 c.p. in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione” .
In sintesi, 640-bis c.p. vs 316-ter c.p.: il primo è contestato quando c’è una condotta fraudolenta più strutturata e un danno maggiore, mentre il secondo è riservato a condotte più semplici e di minore allarme. Per l’imputato, essere giudicato ex 316-ter è molto preferibile (pena minore, soglie di punibilità, niente artifizi). Dunque è una linea difensiva talora percorribile: ad esempio, sostenere che non vi fu un raggiro attivo verso l’ente, ma solo un’indebita percezione basata su una dichiarazione inesatta. Tuttavia, nella prassi, appena emergono fatture false o collusioni, la giurisprudenza propende per qualificare il fatto come truffa aggravata. Nel paragrafo sulle strategie difensive vedremo come eventualmente valorizzare gli argomenti per una derubricazione.
Falsità in atti pubblici: articoli 479 e 483 c.p.
Accanto al reato di truffa (o indebito contributo), spesso nelle contestazioni di false fatture compaiono anche i reati di falso in atto pubblico, sia a carico di pubblici ufficiali sia di privati. Nel contesto di un appalto pubblico, infatti, vi sono numerosi atti ufficiali (stati di avanzamento lavori, certificati di collaudo, verbali, dichiarazioni sostitutive, etc.) che possono essere falsificati se qualcuno attesta il falso per coprire le fatture mendaci.
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: punisce il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. In parole semplici, se un pubblico funzionario redige un atto pubblico (es. un certificato di regolare esecuzione lavori, un verbale di collaudo, un SAL) contenente informazioni false, commette questo reato. La pena è la reclusione fino a 6 anni. Nel caso delle false fatturazioni, se un funzionario pubblico (ad esempio il RUP – responsabile unico del procedimento – o il direttore dei lavori) “chiude un occhio” e attesta che certi lavori sono stati eseguiti quando non lo sono, oppure valida fatture che sa essere gonfiate, può rispondere di falso ideologico ex art. 479 c.p. (oltre eventualmente ad altri reati come il concorso in truffa o la corruzione se c’è un accordo illecito). Esempio: Il direttore dei lavori firma un SAL certificando posa di tubazioni per 1000 metri, ma in realtà ne sono state posate 500; ciò permette all’impresa di fatturare il doppio. Questo è un falso ideologico in atto pubblico. Se però il funzionario era ignaro dell’inganno (ossia è stato tratto in errore dall’impresa, ad esempio con prove artefatte), allora lui non ha dolo di falso – semmai ne risponde l’impresa come truffa. Dunque, la posizione del pubblico ufficiale dipende dalla sua consapevolezza: un accordo collusivo impresa-funzionario spesso porta a contestare 640-bis c.p. in concorso e il 479 c.p. per quest’ultimo.
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: punisce il privato che attesta il falso in un atto pubblico. In pratica ricorre quando un soggetto privato rilascia dichiarazioni o certificazioni a un pubblico ufficiale, le quali vengono poi trasfuse in un atto pubblico, risultando false. La pena è più bassa (fino a 2 anni). Un esempio tipico nel nostro contesto: l’imprenditore presenta all’Amministrazione una dichiarazione sostitutiva (ex D.P.R. 445/2000) in cui afferma che le forniture sono state effettuate regolarmente, sapendo che non è vero. Oppure compila il registro di cantiere con dati fittizi, che poi verranno recepiti in un atto pubblico ufficiale. Se tali false dichiarazioni erano lo strumento per ottenere il pagamento, come detto, spesso vengono assorbite dalla truffa o ricondotte al 316-ter c.p. qualora non vi siano altri raggiri . Infatti, la Cassazione a Sezioni Unite già nel 2011 chiarì che il reato di falso ideologico ex art. 483 c.p. è assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni statali (art. 316-ter) in tutti i casi in cui l’uso di dichiarazioni/documenti falsi sia modo tipico di realizzazione di quest’ultimo reato . Analogamente, dottrina e giurisprudenza riconoscono che anche in presenza di una truffa aggravata ex 640-bis, i falsi strumentali possono considerarsi consumati all’interno della truffa stessa (reato complesso). Dunque, non è insolito che in sede di giudizio i reati di falso vengano assorbiti o dichiarati in concorso apparente.
Tuttavia, bisogna fare attenzione: le procure talvolta contestano inizialmente anche i reati di falso separatamente, per poi eventualmente lasciarli assorbire in sentenza. Per la difesa può essere utile argomentare sin dall’inizio l’assorbimento, al fine di evitare un cumulo di imputazioni (ad esempio chiedendo al GIP di non rinviare a giudizio per i falsi in presenza della contestazione principale di truffa). In altri casi, se la truffa non è provata, il giudice potrebbe comunque ritenere integrato il reato di falso: quindi mantenere un capo di imputazione di falso può essere una sorta di “rete di sicurezza” per l’accusa. Una strategia difensiva è dimostrare che manca l’elemento soggettivo del falso (es. l’imprenditore credeva che i dati fossero veri, o ha riportato informazioni ricevute da altri, o esiste un equivoco interpretativo sull’atto). In particolare, per il privato (art. 483), spesso si può sostenere che la dichiarazione resa non era effettivamente destinata a un atto pubblico in senso tecnico, oppure che non verteva su un “fatto del quale l’atto è destinato a provare la verità” – requisiti stringenti richiesti dalla norma.
Riassumendo, i reati di falso in atti pubblici sono un tassello importante del quadro normativo: tipicamente i funzionari infedeli risponderanno del 479 c.p., i privati mendaci del 483 c.p., salvo confluire tutto nella truffa/indebita percezione. Le sanzioni per i falsi, pur non altissime (massimo 2 anni per il privato, 6 per il pubblico ufficiale), sono però rilevanti in ambito penale e, in caso di condanna, comportano macchie indelebili a carico di professionisti e imprenditori (si pensi alla fedina penale e alla reputazione). Senza contare che una condanna per falso di un pubblico ufficiale può implicare il suo licenziamento e l’interdizione dai pubblici uffici.
Profili penal-tributari: reati del D.Lgs. 74/2000 (frode fiscale mediante fatture)
Parallelamente ai reati del codice penale, l’utilizzo di fatture false genera anche responsabilità penali tributarie, disciplinate dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (come modificato più volte, da ultimo dalle riforme del 2019 e interventi successivi). In particolare, due fattispecie centrali sono:
- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Possiamo considerarli come i reati “gemelli” dal lato di chi utilizza le fatture false (art. 2) e di chi le emette (art. 8). Entrambi sono delitti di natura fiscale molto gravi, introdotti per colpire le frodi IVA e in generale le frodi relative alle imposte sui redditi mediante creazione di costi fittizi.
Di seguito una tabella riepilogativa dei principali reati tributari rilevanti:
| Reato (D.Lgs. 74/2000) | Condotta punita | Pena (reclusione) | Note (soglie, particolarità) |
|---|---|---|---|
| Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta con fatture false | Indicare in una dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture/documenti falsi. | Da 4 a 8 anni (se passivi fittizi > 100k €) <br>Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (se passivi ≤ 100k €) | – Soglia 100.000 €: sopra tale importo di fatture false, pena aumentata (4-8 anni) .<br>– Causa di non punibilità: integrale pagamento debito tributario prima di sapere dell’indagine (vedi sotto) .<br>– Configurabile anche se operazioni soggettivamente inesistenti . |
| Art. 8 – Emissione di fatture false | Emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (allo scopo di far evadere terzi). | Da 4 a 8 anni (pena aumentata dalla riforma 2019) | – Pena unica (4-8 anni) indipendentemente dall’importo.<br>– Obiettivo di far evadere altri (es. società cartiera).<br>– Anche qui, non punibile se si paga tutto prima di indagine (vedi sotto). |
| Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici | Frode fiscale senza fatture false, con artifici (es. conti doppi, altri mezzi fraudolenti). | Reclusione da 3 a 8 anni . | – Non richiede fatture false, ma condotta fraudolenta.<br>– Pena < art.2 ma comunque alta.<br>– Pagamento integrale estingue reato (come art.2) . |
| Art. 4 – Dichiarazione infedele | Dichiarare meno redditi o IVA senza usare fatture false (errori volontari). | Reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi . | – Soglie di punibilità: imposta evasa > 100k €, attivi sottratti > 2 mln € .<br>– Reato meno grave (no fatture false). |
| Art. 5 – Omessa dichiarazione | Non presentare la dichiarazione dovuta (oltre soglie). | Reclusione da 2 a 5 anni (dopo riforma). | – Non implica fatture false di per sé, ma spesso coesiste con art.8 per chi emette e poi non dichiara. |
Concentrandoci su art. 2 e art. 8, che più specificamente riguardano le fatture per operazioni inesistenti:
- Dichiarazione fraudolenta (art. 2): è il reato contestato all’impresa (o al suo legale rappresentante) che utilizza le fatture false in sede fiscale, ossia le registra in contabilità e le riporta in dichiarazione annuale per abbattere l’utile o detrarre l’IVA. Per configurarlo occorre: (a) uso di fatture/documenti falsi; (b) indicazione nella dichiarazione di elementi passivi fittizi (costi inesistenti o IVA a credito fittizia) derivanti da quei documenti; (c) dolo specifico di evadere le imposte. Non ci sono vere soglie di punibilità (basta anche 1 € di utilizzo indebito), ma come visto c’è una soglia di gravità a 100.000 € di elementi fittizi per l’aumento di pena. Quindi se un’azienda ha usato 500.000 € di fatture false per gonfiare i costi di un appalto pubblico, la pena edittale sarà 4-8 anni.
La giurisprudenza tributarista e penale ha più volte ribadito cosa si intende per “operazioni inesistenti”: sia la totale inesistenza oggettiva, sia l’inesistenza soggettiva (fittizia interposizione di soggetti). Abbiamo già citato la sentenza Cass. 34407/2024, che in un caso di appalto di servizi fittizio (schermo per somministrazione di manodopera) ha confermato che inserire quelle fatture in dichiarazione costituisce reato ex art. 2 . In generale, per la difesa contestare questa accusa significa provare che le operazioni invece esistevano (vedi strategie difensive più avanti).
Un elemento importante introdotto nel 2019 (D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019) è la causa di non punibilità per integrale pagamento del debito tributario. Essa prevede che, se l’imputato (o chi per esso) paga tutte le imposte evase, gli interessi e le sanzioni amministrative prima che gli venga formalmente notificato di essere indagato, il reato si estingue . Questa norma, inizialmente non chiara, è stata interpretata estensivamente: anche per i reati di frode fiscale (artt. 2 e 3) è ammessa la non punibilità via pagamento . Tuttavia, occorre che il ravvedimento sia spontaneo: se uno viene a sapere di un’indagine (perquisizione, informazione di garanzia) non può più usufruirne. Nella pratica, quindi, è raro poterla applicare in pieno per le frodi scoperte dalla Guardia di Finanza, ma può accadere ad esempio se, dopo un accertamento fiscale, l’azienda versa tutto ancor prima che la Procura si muova. In tal caso, la difesa potrà far valere questa causa di non punibilità in giudizio. Anche un pagamento effettuato dopo l’avvio del procedimento non è inutile: benché non estingua il reato, è valutato come attenuante e, come vedremo, incide sulla concessione della particolare tenuità o di altre misure.
- Emissione di fatture false (art. 8): è il reato speculare, imputabile tipicamente ai titolari delle società “cartiere” o comunque a chi emette i documenti falsi per aiutare altri a evadere. Nell’ambito dei lavori pubblici, immaginiamo una ditta subappaltatrice fantasma che emette fatture all’appaltatore per lavori mai fatti: l’amministratore di quella ditta risponde di art. 8. La pena, dopo la riforma del 2019, è stata alzata a 4-8 anni di reclusione , senza soglie di importo (ogni condotta è gravissima di per sé). Anche qui si prevede la non punibilità per pagamento integrale, simile all’art. 2 (pagare il debito tributario in questione, che nel caso dell’emittente consiste nell’IVA eventualmente dovuta sulle fatture emesse, prima dell’indagine, estingue il reato) . Va notato che l’emittente di solito non detrae nulla (anzi dichiara quelle fatture e dovrebbe versare l’IVA, ma spesso non lo fa e viene accusato anche di omessa dichiarazione o simili): comunque l’art. 8 si configura già solo con l’emissione di fatture fittizie, indipendentemente dall’uso che ne fa il destinatario.
Un tema particolare è emerso con le frodi sui crediti fiscali (es. bonus edilizi): in alcuni casi le fatture false venivano emesse non per far evadere un’imposta, ma per generare un credito d’imposta da cedere. Ci si è chiesti se ciò rientri nel “fine di evadere le imposte” dell’art. 8. La risposta è stata sì: la Cassazione nel 2025 (sent. n. 10400/2025) ha confermato che il fine di consentire a terzi l’evasione di imposta comprende anche il far ottenere un credito d’imposta inesistente , equiparando sostanzialmente la creazione indebita di un credito fiscale all’evasione di imposta. Quindi l’art. 8 copre anche queste condotte più sofisticate. Inoltre, non è richiesto che il credito fittizio venga effettivamente utilizzato: è sufficiente la finalità e l’emissione della fattura falsa per integrarlo .
Altre previsioni da evidenziare: Le pene per art. 2 e 8 comportano spesso che l’imputato, se condannato a più di 2 anni, non possa beneficiare della sospensione condizionale (salvo patteggiamenti ridotti sotto i 2 anni, cosa possibile a volte). Sono reati per cui, tra l’altro, oggi è ammesso il patteggiamento anche senza aver prima pagato il debito (prima del 2019 c’erano restrizioni, ora eliminate) . Inoltre, per importi particolarmente rilevanti, si applica la confisca allargata (se i profitti illeciti superano 200.000 €, il giudice può confiscare beni di valore sproporzionato rispetto al reddito del condannato) . E la competenza per territorio spesso segue criteri particolari (ad es., Cass. ha stabilito che per il reato di emissione fatture false la competenza non è per forza dove ha sede la società cartiera, ma può essere altrove a seconda del luogo di utilizzazione; son dettagli tecnici sfruttabili in eccezioni procedurali) .
Reati tributari e responsabilità delle società (D.Lgs. 231/2001): Da segnalare che, dal 2019, alcuni reati fiscali – inclusi art. 2 e art. 8 D.Lgs. 74/2000 – sono stati inseriti nel novero dei reati-presupposto che fanno scattare la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Ciò significa che, se ad esempio i dirigenti di una società commettono una frode fiscale nell’interesse o a vantaggio della società, quest’ultima può essere sanzionata con pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive (tra cui il divieto di contrattare con la P.A.). Questo aggiunge un ulteriore livello di rischio per l’impresa coinvolta: nei procedimenti penali verrà valutato se la società aveva modelli organizzativi adeguati a prevenire quei reati. Una adeguata difesa 231 può talvolta evitare la condanna della società, ma bisogna attivarsi presto (es. implementando o aggiornando il modello organizzativo, cooperando con le indagini, ecc.). Vista la complessità, in questa sede ci limitiamo a segnalare il punto, perché se un’azienda appaltatrice viene accusata di frode fiscale con false fatture, potrebbe dover affrontare anche un procedimento 231 parallelo.
Profili amministrativi e conseguenze nei contratti pubblici
Le contestazioni di false fatturazioni, pur emergendo spesso in ambito penale/fiscale, hanno ricadute immediate sul piano amministrativo, in particolare sul rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di partecipare a gare future. Gli istituti chiave da considerare sono:
- Cause di esclusione dalle gare e risoluzione dei contratti in essere.
- Interventi dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
- Danno erariale e Corte dei Conti.
- Altre misure anticorruzione e di prevenzione (white list antimafia, commissariamento ex art. 32 d.l. 90/2014, ecc.).
Vediamoli in dettaglio:
1. Esclusione dalle gare pubbliche (pregresse e future): Il vecchio Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016, art. 80) e il nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023, in vigore dal 2023) prevedono che una impresa può essere esclusa da una procedura di gara se a suo carico ricorrono certe situazioni. Tra queste:
- Condanne penali definitive per reati gravi: L’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 elencava una serie di reati la cui condanna, se definitiva e relativamente recente (ultimi 5 anni), comporta l’esclusione obbligatoria. Fra questi figurano: associazione mafiosa, corruzione, frode ai danni dello Stato, riciclaggio, reati gravi in danno dello Stato. La truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. è generalmente considerata in questo novero (è una forma di frode ai danni dello Stato). Anche i reati tributari non erano esplicitamente menzionati nel comma 1, ma una condanna per frode fiscale può rientrare indirettamente come indice di grave illegalità (e ora con il d.lgs. 36/2023 potrebbe trovare collocazione in analoghe previsioni). Dunque, se l’impresa subisce una condanna definitiva per 640-bis c.p. o per reati di fatture false, verrà esclusa automaticamente da qualsiasi gara per un certo periodo (fino a 5 anni di regola, salvo durata diversa indicata dal giudice) .
- Gravi illeciti professionali (esclusione discrezionale): Anche in assenza di condanna definitiva, l’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (ripreso in sostanza dall’art. 94 del nuovo Codice) consente di escludere un operatore economico se la stazione appaltante dimostra con mezzi adeguati che questo si è reso colpevole di “gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità o affidabilità”. Le Linee Guida ANAC n. 6/2017 (ora superate ma indicative) chiarivano che rientrano tra tali illeciti, ad esempio, anche le violazioni gravi in materia fiscale e le condanne non definitive per reati rilevanti ai fini della moralità professionale . In particolare, ANAC elencava i reati tributari ex D.Lgs. 74/2000 tra quelli che, se oggetto di una condanna (anche non definitiva), possono costituire motivo di esclusione . Dunque, già l’imputazione o una condanna in primo grado per emissione di fatture false (art. 8), o per dichiarazione fraudolenta (art. 2) o per truffa, può legittimare una stazione appaltante a escludere discrezionalmente l’azienda dalla gara, ritenendo ciò indice di inaffidabilità . Ad esempio, se durante una gara la stazione appaltante viene a sapere che l’azienda X è sotto processo per frode fiscale con false fatture, potrebbe valutarlo come grave illecito professionale e disporre l’esclusione, previa contestazione e valutazione del caso. Questo strumento è molto insidioso, perché prescinde dall’attesa dell’esito penale: basta la “dimostrazione” di elementi sufficienti (come un rinvio a giudizio o misure cautelari).
Dal punto di vista difensivo, quando ci si trova in questa situazione, l’impresa deve attivarsi per esercitare il diritto al contraddittorio con la stazione appaltante e possibilmente invocare il “self-cleaning”. Il self-cleaning (previsto già dall’art. 80 comma 7 del vecchio codice, ora ripreso dal nuovo) consiste nell’adozione di misure di riparazione e organizzative tali da convincere la P.A. che l’impresa è di nuovo affidabile nonostante l’illecito commesso. Misure tipiche includono: risarcire il danno causato (ad esempio, restituire somme indebitamente percepite o pagare i debiti tributari), collaborare con le autorità, prendere provvedimenti disciplinari verso i responsabili interni, migliorare i propri sistemi di controllo (modello 231, procedure anticorruzione), ecc. . Se l’impresa riesce a dimostrare di aver fatto ciò, la stazione appaltante potrebbe decidere di non escluderla nonostante l’illecito (valutando che l’integrità è ristabilita). In caso contrario, l’esclusione può essere impugnata davanti al TAR. I TAR e il Consiglio di Stato in questi anni hanno esaminato diversi casi di esclusione per false dichiarazioni o reati fiscali: generalmente riconoscono ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, ma richiedono che sia data all’impresa la possibilità di giustificarsi e di far valere il self-cleaning.
In un contesto di false fatturazioni, misure di self-cleaning efficaci potrebbero essere: regolarizzare la propria posizione col fisco (pagando tasse evase, sanzioni), rimuovere o sospendere i dirigenti coinvolti, implementare un codice etico che condanni espressamente certe pratiche, chiedere una consulenza ad ANAC sull’idoneità delle misure, e ovviamente astenersi dal partecipare a gare finché la questione non è chiarita, se l’ombra è troppo grave.
2. Interventi ANAC e anticorruzione: L’ANAC può entrare in gioco principalmente in due modi:
- Annotazione nel Casellario Informatico: ANAC gestisce un registro delle imprese con annotazioni relative a illeciti professionali. Provvedimenti di esclusione, anche non definitivi, o informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti su comportamenti scorretti (es. presentazione di documenti falsi in gara) vengono iscritti. Questo può pregiudicare la reputazione dell’impresa su scala nazionale. ANAC stessa può decidere, nei casi più gravi di false dichiarazioni o documenti in gara, l’iscrizione di annotazioni con effetto escludente (una sorta di ban temporaneo). Ad esempio, se un’impresa presenta in gara un DURC falsificato o certificati falsi, l’ANAC irroga la sanzione del divieto di partecipare per 1 anno ai sensi del vecchio art. 80 co. 12. Nel caso di fatture false, se queste costituiscono falsa documentazione presentata in una gara, potrebbe scattare un meccanismo simile (anche art. 213 d.lgs. 50/2016, poteri sanzionatori ANAC).
- Segnalazione obbligatoria e vigilanza: Le stazioni appaltanti, quando riscontrano irregolarità, segnalano all’ANAC. Se durante l’esecuzione del contratto un RUP scopre che l’impresa ha prodotto fatture per lavori non fatti, può segnalarlo sia alla Procura sia all’ANAC. ANAC potrebbe avviare un’istruttoria e anche proporre il c.d. “commissariamento” dell’appalto o dell’impresa (ex art. 32 d.l. 90/2014) nei casi di grave frode o sospetta corruzione. Tale misura, raramente applicata, permette di affidare la gestione dell’impresa a commissari per completare i contratti pubblici in corso, quando l’impresa è coinvolta in gravi scandali (tipicamente mafia o corruzione, ma possibili in frodi rilevanti).
- Anticorruzione interna: Le pubbliche amministrazioni hanno piani anticorruzione e trasparenza. Un funzionario coinvolto in falsi sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria e anche al responsabile anticorruzione interno. Questo esula un po’ dalla difesa dell’impresa, ma se l’illecito coinvolge un funzionario pubblico, l’ente adotterà misure disciplinari e correttive.
3. Risoluzione contrattuale e danno erariale: Sul piano del contratto di appalto in essere, la scoperta di false fatturazioni costituisce di norma un grave inadempimento che legittima la risoluzione per inadempimento dell’appalto da parte dell’ente (ex art. 108 D.Lgs. 50/2016, per grave illecito professionale emerso in fase esecutiva). L’ente appaltante potrebbe cioè rescindere il contratto con l’impresa e escutere la cauzione. Inoltre, se sono stati pagati importi non dovuti, l’amministrazione vorrà recuperare le somme: potrà emettere un atto di ingiunzione di pagamento, oppure iscrivere il credito a ruolo (se deriva da sanzioni amministrative), oppure attendere la quantificazione del danno in sede di Corte dei Conti.
Il danno erariale è infatti l’altro fronte: la Procura regionale della Corte dei Conti può citare sia l’impresa sia eventuali funzionari infedeli per il risarcimento del danno allo Stato. Ad esempio, se grazie a fatture gonfiate l’impresa ha ottenuto 200.000 € in più, la Corte dei Conti potrà chiederne la restituzione a titolo di danno all’erario, con maggiorazioni (interessi, rivalutazione) e sanzioni pecuniarie. Il procedimento contabile è separato dal penale, ma una condanna penale definitiva costituisce una prova schiacciante anche in quella sede. Dal punto di vista difensivo, è importante evitare duplicazioni di pagamento: se l’impresa ha già risarcito l’ente pubblico in via stragiudiziale o durante il processo penale (magari per attenuanti), questo va evidenziato alla Corte dei Conti per ridurre o azzerare il risarcimento dovuto. La difesa dinnanzi alla Corte dei Conti può puntare su: contestare l’entità del danno (ad es. i lavori erano in parte eseguiti, quindi il danno netto è minore della fattura), far valere concausa di altri, o chiedere la compensazione con penali contrattuali già incamerate dall’ente. Notare che la Corte dei Conti giudica col parametro soggettivo della colpa grave: se l’imprenditore ha dolosamente truffato lo Stato, sarà sicuramente ritenuto responsabile. Piuttosto, l’ente pubblico potrebbe avere concorso (ad es. il RUP negligente) e dunque l’impresa cerca di non farsi carico integrale.
4. Altre implicazioni amministrative: In contesti di criminalità organizzata, false fatturazioni possono emergere come strumento di infiltrazione mafiosa negli appalti. In tali casi, possono scattare le informative antimafia interdittive da parte delle Prefetture (che impediscono all’impresa di contrattare con la P.A. per tentativi di infiltrazione mafiosa). Anche se non siamo nel caso tipico, se l’indagine rivelasse legami con clan o sistemi corruttivi su vasta scala, l’impresa rischia di essere interdetta per mafia. Inoltre, se l’impresa è certificata ISO o ha attestazioni, potrebbe subire la revoca di certificazioni etiche o di rating di legalità.
Infine, citiamo la possibilità di commissariamento giudiziario ex art. 34 D.Lgs. 231/2001: se la società è imputata come ente e ci sono esigenze cautelari, il giudice può nominare un commissario per gestire l’azienda al posto degli amministratori (alternativo alla sospensione dell’attività). Questo per assicurare che continui l’attività legale evitando ulteriori illeciti. È misura rara ma da sapere.
Riepilogo in tabella – Effetti amministrativi e relative difese:
| Effetto/Provvedimento | Descrizione | Base Normativa | Strategie difensive |
|---|---|---|---|
| Esclusione da gara – obbligatoria | Esclusione per condanna definitiva a reati gravi (truffa Stato, ecc.) | Art. 80 co.1 D.Lgs. 50/2016 (ora art. 94 co.1 D.Lgs.36/2023) | – Non applicabile finché non c’è condanna definitiva.<br>– Dopo condanna, l’unica via è attendere riabilitazione o fine periodo. |
| Esclusione da gara – discrezionale (illecito prof.le) | Esclusione per grave illecito professionale (es. imputazione per reati tributari) | Art. 80 co.5 lett. c) D.Lgs.50/2016 (ora art. 94 co.2-3 D.Lgs.36/2023) | – Esercitare diritto di difesa nel procedimento di esclusione (memorie al RUP).<br>– Attuare self-cleaning (risarcire danni, riorganizzazione) .<br>– Impugnare esclusione al TAR se arbitraria. |
| Annotazione ANAC/Casellario | Iscrizione nel casellario di notizie su reati o esclusioni. Può avere effetto escludente. | Art. 213 D.Lgs. 50/2016; Regolamenti ANAC | – Presentare osservazioni ad ANAC prima dell’annotazione (quando notificato).<br>– Chiedere aggiornamento annotazione dopo misure riparative. |
| Incapacità di contrattare con P.A. (pena accessoria) | Divieto di stipulare contratti pubblici per X anni a seguito di condanna penale. | Art. 32-quater c.p.; Art. 94 co.8 D.Lgs.36/2023 | – In sede penale, chiedere al giudice di determinare durata minima se possibile.<br>– Richiedere riabilitazione post-condanna per cessare anticipatamente l’interdizione. |
| Risoluzione contratto in corso | Recesso dell’ente dal contratto per inadempimento/frodi. | Art. 108 D.Lgs. 50/2016 | – Negoziato con l’ente: eventualmente offrire risarcimenti per evitare risoluzione.<br>– Impugnare risoluzione se ingiustificata (ma in caso di frode è difficile). |
| Danno erariale – citazione Corte dei Conti | Azione contabile per recuperare il danno subito dall’erario. | Art. 55 Cod. giust. contabile, art. 194 TU Corte Conti | – Dimostrare minor danno (lavori eseguiti parzialmente, etc.).<br>– Evidenziare pagamenti già effettuati dall’impresa a titolo di risarcimento.<br>– Se coinvolti funzionari, evidenziare loro corresponsabilità per ripartire il danno. |
| Interdittiva Prefettizia (antimafia) | Divieto di contratti pubblici per infiltrazioni mafiose sospette. | D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) | – Difendersi nel procedimento prefettizio (memorie, evidenza di legalità).<br>– Ricorso al TAR contro l’interdittiva (entro 30 gg). |
| Commissariamento straordinario | Nomina di commissari per gestire l’impresa coinvolta in illeciti gravi su appalti. | Art. 32 d.l. 90/2014 conv. L.114/2014 | – Collaborare con ANAC per evitarlo, mostrando capacità di gestione pulita.<br>– In caso applicato, cooperare col commissario per ridurre durata. |
In definitiva, sul piano amministrativo, il punto di vista del debitore/imprenditore deve essere orientato a limitare i danni reputazionali ed economici collaterali: se c’è stata una contestazione, occorre mettere in sicurezza l’azienda per quanto possibile (regolarizzare la posizione fiscale, segregare eventuali responsabili, cooperare con le autorità). Questo potrà essere valorizzato sia nel penale (come condotta susseguente virtuosa) sia di fronte all’ANAC e alle stazioni appaltanti per continuare ad operare. Nei paragrafi successivi, quando parleremo di strategie difensive pratiche, riprenderemo alcuni di questi concetti in chiave operativa (ad es. come presentare un piano di self-cleaning, o come coordinare difesa penale e tutela nei confronti dell’ANAC).
Strategie di difesa in sede penale
Affrontare un procedimento penale per false fatturazioni in lavori pubblici richiede una strategia ben pianificata, che inizia fin dalle prime fasi delle indagini e prosegue attraverso l’eventuale processo di merito e oltre (fino alla fase esecutiva della pena, se vi è condanna). Di seguito analizziamo le principali fasi del procedimento penale e i corrispondenti strumenti difensivi a disposizione dell’indagato/imputato (il debitore in senso lato), con riferimenti specifici alle peculiarità di questi casi.
Fase delle indagini preliminari
Avvio delle indagini: Nella gran parte dei casi, un’indagine per false fatturazioni in appalti pubblici nasce da una delle seguenti situazioni: – un controllo fiscale della Guardia di Finanza che scopre operazioni sospette (incrociando fatture emesse e ricevute, o tramite una verifica nelle aziende coinvolte); – una segnalazione dall’ente appaltante (ad es. un nuovo responsabile che si accorge di anomalie nei conti del cantiere e denuncia); – una denuncia di terzi (un concorrente escluso, un dipendente, un socio dissociato, ecc., che fornisce elementi agli inquirenti); – un’indagine più ampia su corruzione/appalti che porta alla luce anche false fatture connesse.
Spesso la Procura della Repubblica competente delega subito la Guardia di Finanza per accertamenti: si può arrivare a perquisizioni e sequestri presso la sede dell’impresa, gli uffici contabili, le abitazioni di amministratori e direttori dei lavori. È in questa fase che l’imprenditore spesso scopre di essere indagato (ricevendo il verbale di perquisizione o un’informazione di garanzia). Sin da questo momento è fondamentale tutelare i propri diritti: – Durante la perquisizione, assicurarsi che i documenti sequestrati vengano elencati correttamente; far presente se tra essi vi sono materiali coperti da segreto professionale (es. corrispondenza con l’avvocato) per attivare le garanzie. – Se viene notificato un decreto di sequestro preventivo (ad esempio delle somme considerate profitto del reato, o delle fatture false trovate), valutare con il legale la possibilità di fare riesame al tribunale del riesame entro 10 giorni, se il sequestro appare ingiustificato o eccessivo.
Misure cautelari personali: Nei casi più gravi, soprattutto se si ipotizza anche corruzione o associazione a delinquere, la Procura può chiedere misure cautelari personali (es. arresti domiciliari per l’amministratore, oppure misure interdittive tipo il divieto di esercitare imprese per un certo tempo). Ad esempio, nell’ambito delle frodi sui bonus edilizi, dirigenti di società sono finiti ai domiciliari con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e reati fiscali connessi . Dal lato difensivo, se ciò accade: – Presentare subito, tramite l’avvocato, una richiesta di riesame al tribunale o un’istanza di revoca sostitutiva, contestando i presupposti della misura (ad es. mancanza di gravi indizi o attenuazione delle esigenze cautelari). – Eventualmente proporre misure meno afflittive: es. invece degli arresti, la sospensione dall’attività imprenditoriale (se l’indagato si dichiara disposto a farsi da parte temporaneamente), per eliminare il pericolo di reiterazione e ottenere la libertà.
Indagini tecniche e consulenti: Spesso in queste indagini la GdF effettua una consulenza tecnica contabile o una verifica incrociata delle contabilità. È cruciale che il difensore nomini, quando opportuno, un consulente tecnico di parte (CTP) per analizzare la documentazione sequestrata. Ad esempio, se la tesi accusatoria è che una certa società è “cartiera” priva di mezzi, il CTP della difesa può raccogliere evidenze del contrario (contratti, buste paga di operai, mezzi e attrezzature possedute) per confutare che le operazioni fossero inesistenti. Già durante le indagini si possono depositare in Procura memorie difensive (ex art. 415-bis o anche spontaneamente) con elementi che smontino le ipotesi accusatorie.
La memoria difensiva in questa fase può ad esempio evidenziare che: i lavori fatturati sono stati eseguiti (allegando foto, registri di cantiere, dichiarazioni dei subappaltatori reali); oppure che l’amministratore non aveva consapevolezza di eventuali false fatture emesse da un subfornitore (mostrando ad esempio che era stato fatto tutto regolarmente per selezionare il subappalto, fidandosi di documenti apparentemente regolari – quindi mancanza di dolo). Tali memorie vanno ben documentate con allegati, e se possibile corredate di giurisprudenza favorevole che orienti la Procura a valutare diversamente i fatti.
Pagamenti e condotte riparatorie durante le indagini: Una volta ottenuto un quadro delle accuse, una mossa strategica può essere valutare la regolarizzazione fiscale e i risarcimenti: – Se l’azienda ha IVA non versata o crediti d’imposta indebiti oggetto di contestazione, pagare spontaneamente (o iniziare a rateizzare) può essere visto positivamente. Ad esempio, se l’Agenzia Entrate ha contestato 100.000 € di IVA detratta indebitamente, provvedere al versamento (magari avvalendosi di un ravvedimento operoso) è utile. Questo perché, come ricordato, ai fini della particolare tenuità del fatto o della concessione delle attenuanti generiche, i giudici tengono conto dell’adempimento. Anzi, con la riforma 2022-2024, il legislatore impone al giudice di valorizzare prevalentemente l’avvenuto pagamento integrale o quasi del debito tributario quando valuta la tenuità (art. 12 comma 3-ter D.Lgs. 74/2000) . La Cassazione nel 2025 ha applicato questa norma affermando che se i pagamenti rateali coprono una percentuale elevata del debito, ciò deve essere considerato come indice di tenuità del fatto . Quindi, pagare conviene. – Se l’ente pubblico ha subìto un danno (pagamenti per lavori non fatti), considerare di restituire (in tutto o in parte) tali somme può essere utile per dimostrare pentimento e ridurre il danno. Ovviamente ciò va ponderato perché può equivalere ad ammettere la propria responsabilità civile; tuttavia, a volte una transazione con l’ente (ad esempio l’azienda rinuncia ai pagamenti residui e restituisce un importo a saldo) può mettere l’ente dalla parte meno aggressiva anche in sede penale e contabile.
Chiusura indagini e 415-bis: Verso la fine delle indagini, l’indagato riceverà l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., con la possibilità in 20 giorni di presentare memorie o chiedere di essere interrogato. Questo è un momento chiave per la difesa. Qui bisogna decidere se: – Presentare una memoria difensiva dettagliata, riassumendo le prove a discarico raccolte. Può includere perizie tecniche di parte (es. un ingegnere che attesta che i lavori risultano eseguiti in cantiere per una certa percentuale, contraddicendo l’accusa che fossero zero). – Chiedere interrogatorio per fornire la propria versione. È un’arma a doppio taglio: se il cliente è credibile e ha spiegazioni forti, un interrogatorio può persino portare a una richiesta di archiviazione per alcune accuse. D’altra parte, se c’è il rischio di autodichiarazioni dannose, meglio tacere. – Valutare se chiedere riti alternativi già ora (es. patteggiamento). In alcuni casi, di fronte a prove schiaccianti, il difensore può contattare la Procura per esplorare un patteggiamento già nella fase pre-imputazione, ottenendo magari un accordo su pena contenuta. Patteggiare prima dell’udienza preliminare evita il giudizio pubblico e dà lo sconto di 1/3 sulla pena.
Udienza preliminare: Se il PM chiede il rinvio a giudizio, all’udienza preliminare la difesa ha un’ultima chance di ottenere un proscioglimento o una derubricazione. Strategicamente: – Insistere su eventuali nullità o inutilizzabilità di atti raccolti (perquisizioni svolte fuori orario? sequestri carenti di motivazione? intercettazioni oltre i limiti? ecc.). – Riproporre al GUP la tesi di riqualificare i fatti: ad esempio, chiedere il non luogo a procedere per 640-bis perché il fatto semmai è un 316-ter e sotto soglia (se c’è margine per sostenerlo). Un caso concreto: l’impresa ha ottenuto solo €3.000 prima che la truffa fosse scoperta; la difesa potrebbe dire: non è truffa consumata, ma tentata oppure indebito percepimento amministrativo perché sotto soglia, e quindi chiedere il proscioglimento penale (Cassazione ha in effetti stabilito che se il contributo ottenuto è sotto €4.000, il falso e l’eventuale truffa restano assorbiti e non c’è reato ). – Se le prove appaiono in equilibrio, valutare se chiedere un rito abbreviato (magari condizionato a perizia su qualche aspetto) per ottenere lo sconto di 1/3 e giocarsela sul materiale già acquisito.
Fase del giudizio e dibattimento
Se si va a processo, la difesa processuale dovrà attaccare sia sul piano fattuale (dimostrare che le fatture non erano false, o comunque ridimensionare il fatto) sia su quello giuridico (contestare la sussistenza degli elementi dei reati).
Prova dell’esistenza delle operazioni: È spesso il cuore di questi processi. Secondo la giurisprudenza, l’onere di provare che una fattura è falsa spetta inizialmente all’accusa, ma una volta forniti indizi (es. società senza dipendenti, flussi finanziari anomali), tocca alla difesa dimostrare la reale esistenza dell’operazione . Quindi la difesa deve portare testimoni e documenti: – Testimoni: operai che hanno lavorato effettivamente in cantiere (anche se formalmente di un’altra ditta), fornitori che hanno consegnato materiali, direttori dei lavori (se non indagati) che possano confermare che almeno parte dei lavori furono eseguiti. Bisogna preparare bene i testi, perché se emergesse che mentono potrebbe peggiorare la situazione (falsa testimonianza). – Documenti: ad esempio, bolle di consegna, foto geolocalizzate dei cantieri, e-mail scambiate tra appaltatore e subappaltatore in cui si pianificano le attività (indizio di genuinità del rapporto). Anche estratti conto: se l’impresa subappaltatrice ha poi bonificato indietro i soldi all’appaltatore, accusa dice “è giro di soldi fittizio”; difesa potrebbe replicare “erano pagamenti per noleggio attrezzature” o “restituzione cauzioni” – servono pezze d’appoggio credibili.
Elementi soggettivi – dolo: Spesso la difesa punta a negare il dolo specifico. Ad esempio, per i reati fiscali si richiede la volontà di evadere. Se l’imprenditore può far credere di essere stato negligente ma non fraudolento, potrebbe evitare la condanna per frode e al più incorrere in sanzioni amministrative. Tuttavia, con fatti così connotati, è difficile sostenere l’ignoranza: servono situazioni particolari (es. “mi sono fidato del consulente che mi ha assicurato che era tutto legale”). Anche il dolo della truffa: potrebbe contestarsi dicendo “non avevo l’intenzione di ingannare, credevo di avere diritto a quei soldi per compensare altre voci” – argomento debole se i lavori non ci sono.
Questioni giuridiche specifiche: La difesa potrebbe sollevare questioni di diritto, ad esempio: – Ne bis in idem tra 640-bis e 316-ter o 483 c.p.: ma come visto, di solito uno assorbe l’altro. Comunque, vigilare che non vi sia condanna sia per 640-bis sia per 483 per lo stesso fatto materiale (ci sarebbe doppia pena per il medesimo falso); eventualmente chiederne la fusione in un unico reato complesso. – Competenza territoriale: se la competenza è dubbia (es. appalto eseguito in luogo A, fatture emesse in luogo B, incasso in luogo C), la difesa può eccepire l’incompetenza territoriale se ritiene di spostare il processo in sede più favorevole. – Circostanze attenuanti da far valere: ad esempio, se l’imputato ha risarcito il danno all’ente e pagato i tributi, invocare l’attenuante del ravvedimento operoso (art. 13-bis D.Lgs. 74/2000) o l’attenuante comune del risarcimento del danno (art. 62 n.6 c.p.). Queste possono portare a riduzioni di pena significative. Attenzione: l’art. 13-bis premiale fiscale richiede pagamento integrale del debito tributario prima del dibattimento di primo grado per avere fino a 1/2 di sconto di pena. – Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): È difficilmente applicabile a reati con pene massime così alte come 640-bis (7 anni) o art. 2 (6 o 8 anni). Tuttavia, se il fatto concreto è di modesta offensività (ad es., importo esiguo, condotta episodica, danno riparato), la difesa può provare a invocarla. La Cassazione 2025 citata ha sottolineato che con le nuove norme il giudice deve dare peso ai pagamenti effettuati: se rimane poco debito, c’è un argomento per dire che il fatto è tenue . Ad esempio, un imputato che aveva evaso 97k di IVA ma pagato quasi tutto fu escluso dalla tenuità in appello; la Cassazione però ha detto di riconsiderare perché ora la legge 87/2024 dà prevalenza al pagamento effettuato . Quindi, la difesa in arringa finale può fare leva su questo: “il mio cliente ha estinto il 90% del debito, dunque ai sensi dell’art. 12 c.3-ter va considerato indice di particolare tenuità e merita l’esclusione della punibilità” .
Scelte processuali: Durante il dibattimento, la difesa potrebbe ancora optare per riti alternativi se la situazione evolve (es. un patteggiamento anche in appello è possibile, magari a seguito di riqualificazione del reato). Oppure puntare a ottenere almeno la sospensione condizionale: se si riesce a contenere la pena entro i 2 anni (magari con attenuanti generiche valutate prevalenti), si può ottenere la sospensione della pena detentiva. A tal fine risultano preziosi i comportamenti post-fatto: versamento dei tributi, incensuratezza, collaborazione.
Fase successiva al giudizio (esecuzione pena e impugnazioni straordinarie)
Se il processo termina con un’assoluzione, fine (salvo eventuale appello del PM). Ma se c’è condanna, si apre la fase delle impugnazioni: – Appello: in appello si possono rinnovare alcune prove se cruciali. La difesa può cercare di ottenere almeno una riduzione di pena o una riqualificazione in reati meno gravi. Ad esempio, magari puntare a far derubricare da truffa consumata a truffa tentata (riduzione di un terzo), sostenendo che il profitto non fu realmente incassato. Oppure contestare il calcolo del profitto confiscato (spesso dispongono la confisca delle somme indebitamente percepite, la difesa può argomentare che va detratto l’eventuale lavoro eseguito o le spese sostenute). – Ricorso per Cassazione: qui ci si limita ai motivi di legittimità. Ad esempio, denunciare violazione di legge se la sentenza ha condannato per 640-bis e 483 insieme (violando il principio di assorbimento). O errore di diritto nel non applicare la nuova normativa più favorevole (come l’art. 12 c.3-ter introdotto nel 2024, che è retroattivo in melius). Infatti, un aspetto importantissimo: se durante il procedimento la legge cambia in meglio per l’imputato, va applicata la norma più favorevole. Nel 2024 è avvenuto con D.Lgs. 87/2024 che ha inserito criteri più favorevoli per la tenuità: Cass. 2025 ha detto che si applica anche ai fatti antecedenti, essendo norma di natura sostanziale favorevole . Quindi la difesa deve sempre monitorare le novità normative e giurisprudenziali (ad es. le Sezioni Unite se intervengono su questioni interpretative controverse).
Una volta definitiva la condanna, fase di esecuzione: – Se la pena detentiva è da espiare (niente sospensione), verificare se ci sono i presupposti per misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare). Per reati fiscali e truffa generalmente sì, se la pena è entro 4 anni, specie considerando sconti indulto o liberazione anticipata. – Incidente di esecuzione: È il rimedio per far valere in fase esecutiva questioni sopravvenute o errori di esecuzione. Per esempio, se dopo la condanna interviene una legge di abolitio criminis o mitigazione, si può chiedere al giudice dell’esecuzione di applicarla. Un esempio nel nostro campo: se per assurdo il legislatore alzasse ulteriormente la soglia di punibilità di 316-ter, o declassasse certi fatti a illecito amministrativo, i condannati potrebbero chiedere revoca della condanna. Al momento non vi sono abolizioni in vista, ma il legislatore potrebbe in futuro modificare (già nel 2019 alzò certe soglie per dichiarazione infedele, ma non per la frode). – Un incidente spesso rilevante è il cumulo di pene: se l’imprenditore ha avuto più condanne (es. una per frode fiscale e una separata per altro), durante l’esecuzione può chiedere al giudice di unificarle e applicare eventualmente la continuazione tra reati, riducendo il totale. – Riabilitazione: dopo aver scontato la pena e pagato quanto dovuto, a distanza di almeno 3 anni si può chiedere la riabilitazione per cancellare gli effetti penali (tra cui l’interdizione dai contratti pubblici).
Coordinamento con difesa tributaria e amministrativa: Mentre il penale va avanti, parallelamente ci sarà il procedimento tributario (avvisi di accertamento, giudizi in Commissione Tributaria) e possibili procedimenti amministrativi (esclusioni da gare, etc.). È fondamentale che la strategia sia unitaria: ad esempio, una tattica può essere usare l’esito di un giudizio per influenzarne un altro. Se in sede tributaria la Commissione Tributaria Regionale dovesse riconoscere che le operazioni non erano inesistenti (magari per insufficienza di prova da parte del Fisco), tale sentenza può essere allegata nel processo penale per instillare dubbi. Per contro, se in penale viene assolto perché “il fatto non sussiste” (quindi fatture ritenute genuine), quell’esito vincola l’amministrazione finanziaria a restituire quanto eventualmente riscosso. C’è un principio di giudicato penale favorevole che fa stato nel tributario, se accerta l’insussistenza del fatto costitutivo dell’illecito tributario . La difesa deve quindi comunicare tra avvocati penalisti e tributaristi, condividendo prove e strategie (senza contraddirsi: non si può in Commissione dire “sì l’ho fatto ma speravo nella prescrizione” e in penale dire “non l’ho fatto”).
Riassumiamo i punti salienti delle strategie difensive penali in una prospettiva temporale (cronologia difensiva):
- Prima fase (indagini):
- Comprendere subito l’ipotesi accusatoria e sequestri effettuati.
- Attivare consulenti tecnici (contabili, ingegneri) per analisi indipendente.
- Fornire spiegazioni e memorie al PM durante le indagini se si hanno elementi convincenti a proprio favore.
- Iniziare eventuali riparazioni (pagamenti, cooperazione) che possano mitigare.
- Preparare l’indagato per un possibile interrogatorio: decidere se restare in silenzio (spesso prudente se non si hanno giustificazioni solide) o fornire una versione (solo se ben supportata).
- Udienza preliminare:
- Valutare patteggiamento se conviene (ad es. quando la prova è schiacciante, patteggiare può portare pena sotto 2 anni e evitare carcere).
- Se si va a giudizio, eventualmente rito abbreviato se il quadro probatorio è principalmente documentale (così si sfrutta lo sconto di pena del 1/3 e si può ancora giocare su interpretazioni).
- Insistere su eventuali derubricazioni: convincere GUP a non mandare a giudizio per reato più grave ma per uno minore (magari convincendolo a emettere sentenza di non luogo per 640-bis e procedere solo su 316-ter o su reati fiscali minori).
- Dibattimento:
- Curare la fase istruttoria: controesaminare i testi dell’accusa (spesso finanzieri) per far emergere eventuali incertezze, e presentare testimoni a discarico credibili.
- Produrre documenti inoppugnabili (es. fatture di acquisto di materiali coerenti con i lavori dichiarati, foto dei lavori).
- Se emergono fatti nuovi (es. il PM non era a conoscenza di certe prove a favore), depositarli subito e magari chiedere che vengano valutati da un perito neutrale.
- Enfatizzare nelle conclusioni finali eventuali dubbî ragionevoli: se c’è incertezza fattuale (es. “non è pienamente provato che quei 100mila euro siano tutti indebitamente percepiti, perché lavori per 80mila furono fatti”), chiedere almeno l’assoluzione parziale o la non applicazione di aggravanti (ad esempio la quantificazione del profitto è inferiore).
- Post sentenza di primo grado:
- Se condanna, studiare motivazione per identificare punti deboli da attaccare in appello (es. se il giudice ha ignorato una prova o sbagliato un calcolo).
- Se assoluzione, prepararsi a difenderla in appello se il PM ricorre, consolidando ancora di più i punti favorevoli.
- Esecuzione:
- Utilizzare benefici di legge: affidamento in prova (presentare un’istanza ben documentata di ammissione magari già subito dopo la condanna definitiva).
- Seguire da vicino la questione interdizioni: ad esempio, se la sentenza penale definitiva non esplicita la durata del divieto di contrattare con PA, fare incidente di esecuzione per far specificare e ridurre nei limiti.
- Presentare istanza di riabilitazione quando possibile per togliere le preclusioni e ripulire la reputazione.
Strategie di difesa in sede tributaria
In parallelo al procedimento penale, l’azienda (o il professionista coinvolto) dovrà verosimilmente affrontare un procedimento tributario per le stesse fatture contestate. Infatti, l’Agenzia delle Entrate (spesso su input della Guardia di Finanza) emetterà avvisi di accertamento per recuperare le imposte evase: tipicamente, IVA detratta indebitamente e IRES/IRAP su costi fittizi. Inoltre, verranno irrogate sanzioni amministrative tributarie (che per utilizzo di fatture false sono molto salate: 90% o 100% dell’imposta non versata, con raddoppio in caso di frode).
La difesa in sede tributaria ha logiche proprie, ma deve essere coordinata col penale. Alcune azioni chiave:
Contestare la ripresa fiscale: L’avviso di accertamento basato su operazioni inesistenti può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP). Gli argomenti difensivi ricalcano il fatto: dimostrare che le operazioni c’erano, o che l’azienda era in buona fede. Ad esempio: – Sostenere che l’onere della prova spetta all’Ufficio: la giurisprudenza tributaria afferma che il Fisco deve provare la frode con elementi oggettivi (es. la controparte era una cartiera) prima di negare la detrazione. Se tali prove sono insufficienti o contraddittorie, chiedere l’annullamento dell’accertamento. – Far valere la buona fede dell’acquirente: in linea con la giurisprudenza UE, se l’impresa appaltatrice non sapeva né poteva sapere che le fatture del subappaltatore erano irregolari, avrebbe diritto a mantenere la detrazione IVA. Occorre però dimostrare di aver preso precauzioni: es. verifica del DURC, delle certificazioni SOA, pagamenti tracciati. Se si riesce a convincere la Commissione che l’azienda fu ingannata dal fornitore (che sembrava regolare), potrebbero annullare le sanzioni e in parte l’imposta. – Conciliazione e adesione: Spesso, se le prove di frode sono forti, è pragmatico cercare un accordo col Fisco. L’istituto dell’accertamento con adesione consente di chiudere la vertenza con uno sconto sulle sanzioni (1/3 in meno) e pagamento rateale. Questo evita anche il raddoppio sanzioni per frode. Una conciliazione giudiziale in Commissione può ridurre ulteriormente le sanzioni. Dal punto di vista penale, definire il debito tributario non è un’ammissione diretta di reato (viene visto come scelta fiscale), e come già detto può aiutare in penale come attenuante o causa di non punibilità se fatto tempestivamente.
Sospensione della riscossione: Se l’importo accertato è elevato, l’azienda potrebbe ricevere una cartella esattoriale a breve. Si può chiedere la sospensione dell’esecutività in pendenza di giudizio tributario, allegando che l’accertamento è gravato da ricorso e potrebbe causare grave danno pagare subito. Le Commissioni spesso la concedono se il ricorso ha fumus non infondato (qualche possibilità di vittoria).
Esito del giudizio tributario: Se la Commissione Tributaria annulla l’accertamento, sarà un punto a favore nel penale: significherebbe che per il giudice tributario non è provato che fossero false fatture. Tale sentenza può essere prodotta al giudice penale. Non lo vincola formalmente (i due giudizi sono autonomi), ma di certo è persuasiva, soprattutto se motivata nel merito. Viceversa, se in sede tributaria viene confermato che erano false, la difesa penale dovrà ancor di più cercare altre vie, perché avrà contro un’autorità giudicante (sia pur civile) che ha riconosciuto la frode.
Rapporti tra pagamento e sanzioni penali: Attenzione: se il contribuente definisce in via agevolata o concilia la pretesa fiscale, paga magari sanzioni ridotte, ciò non incide direttamente sul penale (non è un’ammissione di colpevolezza penale), ma neanche lo estingue salvo il caso della causa di non punibilità che richiede pagamento prima di avere notizia di indagine . Se il pagamento avviene durante il processo, sarà valutato come detto come attenuante. In alcuni casi, la Procura può attendere l’esito del contenzioso tributario per chiudere il penale: se ad esempio la Commissione di appello annulla tutto per difetto di prova, è possibile che il PM chieda l’archiviazione del penale (accade se le prove erano le stesse). D’altro canto, il PM non è obbligato: potrebbe sostenere che hanno standard diversi e portare avanti il penale.
Sanzioni amministrative e doppio binario: Notare che le sanzioni tributarie (amministrative) si sommano alle penali, non c’è “ne bis in idem” su questo (la Corte Europea ha ammesso il doppio binario in materia fiscale fraudolenta). Quindi anche se uno patteggia il penale, deve comunque pagare le sanzioni fiscali (salvo siano state condonate).
In conclusione, la difesa tributaria deve: – O evitare del tutto che sia accertata la frode (vittoria in Commissione). – Oppure minimizzare l’impatto economico (accordi, rate, transazioni). – E sfruttare ogni passo a proprio vantaggio nel penale (ad esempio, una perizia giurata prodotta in Commissione che attesta la regolarità di lavori può essere usata come prova nel penale).
Simulazione pratica: caso di studio e fascicolo processuale
Per concretizzare i principi esposti, presentiamo una simulazione pratica di un caso di false fatturazioni in lavori pubblici, seguendo una cronologia di eventi tipica e evidenziando le possibili azioni difensive in ciascun passaggio. Questo schema di difesa tipo aiuterà a comprendere come combinare gli strumenti giuridici nelle diverse sedi.
Scenario ipotetico: L’impresa Alfa S.r.l. ha un appalto pubblico per la costruzione di una scuola. Subappalta informalmente parte dei lavori di impiantistica a Beta S.r.l. (che in realtà è una piccola società priva di operai, gestita da un ex dipendente di Alfa). Beta emette ad Alfa fatture per 300.000 € + IVA, ma si scopre poi che Beta non aveva mezzi per fare quei lavori e si è limitata a fatturare, mentre i lavori li hanno fatti gli operai di Alfa. Alfa ha usato le fatture di Beta per farsi rimborsare dal Comune quelle somme e ha detratto l’IVA (66.000 €). Beta, a sua volta, ha omesso di versare l’IVA incassata e dopo poco è risultata irreperibile.
Cronologia degli eventi e difesa:
- 2022, gennaio – Esecuzione dell’appalto: Alfa inizia i lavori. Il direttore lavori firma i SAL includendo i lavori di impiantistica come eseguiti da Beta (presentati documenti Beta). Tutto appare regolare all’ente pubblico.
- 2022, dicembre – Fine lavori e pagamenti: Alfa riceve tutti i pagamenti dal Comune, inclusi i 300k€ per impiantistica, e paga Beta con bonifici (300k + IVA). Beta versa indietro ad Alfa, in contanti, una parte (ad es. 250k), trattenendo 50k per coprire l’IVA e un margine. Questo fatto avviene di nascosto (classico giro di false fatture).
- 2023, marzo – Verifica fiscale: La Guardia di Finanza esegue una verifica presso Beta (che risulta non aver dichiarato nulla). Scoprono fatture emesse a Alfa e segnalano il caso alla Procura per sospetta emissione di fatture false. Allo stesso tempo, segnalano l’utilizzo ad Agenzia Entrate.
- 2023, aprile – Perquisizioni: La Procura indaga Beta per art. 8 D.Lgs.74/2000 e Alfa (amministratore sig. Rossi) per art. 2 D.Lgs.74/2000 e truffa aggravata. Scatta perquisizione alla sede di Alfa e casa di Rossi. La difesa qui: collaborare senza intralciare, far trovare i documenti contabili. L’avvocato di Alfa consiglia a Rossi di non rilasciare dichiarazioni a caldo. Al termine, Rossi riceve informazione di garanzia con reati 640-bis c.p., 2 e 8 D.Lgs.74, 483 c.p. (per aver dichiarato il falso nei SAL).
- 2023, maggio – Misura interdittiva: Il GIP, su richiesta PM, applica a Rossi la sospensione dall’esercizio di imprese per 12 mesi, ritenendo che potrebbe reiterare frodi in altri appalti. Difesa: immediato riesame al tribunale della Libertà, sostenendo che Alfa ha allontanato Beta, che Rossi non intende partecipare a gare nel frattempo, quindi la misura è eccessiva. (Possibile esito: il Tribunale accoglie parzialmente e riduce la durata a 6 mesi, grazie all’impegno di non operare in appalti pubblici nel frattempo).
- 2023, giugno – Accertamento fiscale: Agenzia Entrate notifica ad Alfa un avviso: recupero di 66.000 € IVA + 90% sanzione, e indeducibilità dei 300k costi con sanzione 100%. Totale molto elevato. Difesa fiscale: Alfa presenta istanza di adesione (sospendendo termini) e parallelamente raccoglie documenti: contratti con Beta (c’era un contratto? magari simulato), evidenze che Beta qualcosa ha fatto (forse fornito materiali?). Punta a ridurre la pretesa.
- 2023, luglio – Strategia integrata: Riunione di coordinamento tra il penalista e il tributarista di Alfa. Decidono:
- In sede penale, provare a smontare la truffa: suggeriscono a Rossi di raccogliere prove che il Comune non ha avuto danno (per es., magari Alfa, pur fatturando via Beta, quei lavori li ha eseguiti correttamente, quindi la scuola è stata costruita a regola d’arte, non c’è “danno qualitativo”; il Comune ha pagato il giusto valore di mercato).
- Far emergere la buona fede di Alfa sul fronte IVA: mostrare che Beta era una ditta con DURC regolare, iscritta SOA per impianti, quindi Alfa poteva ragionevolmente ritenerla idonea (anche se di fatto era una complicità, ma formalmente risultava idonea).
- Avviare contatti con il Comune: Alfa propone di rinunciare a 50k€ ancora a saldo (se c’è un collaudo pendente) e offre ulteriori lavori compensativi gratuiti, in cambio di non essere segnalata ad ANAC. Il Comune, scottato, comunque segnala tutto ma apprezza il gesto.
- 2023, settembre – Memoria difensiva al PM: Il difensore deposita una memoria dove sostiene che non vi è stata alcuna induzione in errore: il Comune ha ottenuto i lavori, Beta era semplicemente un subappaltatore non autorizzato (illecito amministrativo, semmai) ma non c’è profitto ingiusto perché Alfa non ha guadagnato extra (tesi un po’ ardita, in realtà Alfa si è tenuta 250k in nero…). Comunque, evidenziano che Beta aveva rilasciato DURC e certificati falsi che hanno ingannato Alfa e il Comune (spostando la colpa su Beta). Allegano documenti su Beta (visura, certificati) che la mostravano affidabile.
- 2023, ottobre – Fine indagini e 415-bis: La Procura chiude indagini e mantiene accuse: per Rossi (legale rappr. Alfa) art. 2 D.Lgs.74, art. 640-bis c.p., art. 483 c.p.; per titolare di Beta art. 8 D.Lgs.74, art. 640-bis c.p. in concorso. Difesa di Rossi chiede interrogatorio per chiarire. Rossi, preparato, dice: “Ho sbagliato a fidarmi di Beta. Pensavo lavorassero loro, invece ho scoperto tardi che non avevano operai. Ho comunque completato i lavori a mie spese. Non volevo frodare il Comune né il Fisco, ho solo gestito male il subappalto”. Ammette insomma l’irregolarità amministrativa ma nega il dolo di frode fiscale (“credevo Beta poi pagasse l’IVA, non so se l’hanno fatto”) e minimizza il profitto (“non ho guadagnato nulla in più, anzi Beta mi ha costretto a sconti”).
- 2023, dicembre – Udienza preliminare: PM chiede rinvio a giudizio. La difesa eccepisce che il fatto semmai è subappalto non autorizzato (illecito amministrativo) e dichiarazione infedele (reato minore) ma non truffa: non c’è artificio secondo loro, Beta era dichiarata come subappalto (anche se non autorizzato). Il GUP però ritiene che l’artificio c’è (creazione ad hoc di Beta) e rinvia a giudizio. La difesa rinuncia a patteggiare in questa fase perché spera di vincere almeno sul fronte truffa.
- 2024, marzo – Processo penale in primo grado: Durante il dibattimento:
- Vengono sentiti i finanzieri, che spiegano come Beta fosse priva di sede operativa e soldi tornati a Rossi (hanno tracciato prelievi di Beta in contanti poco dopo i bonifici). Questo è molto negativo.
- Il direttore lavori testimonia che “i lavori di impiantistica li hanno fatti operai di Alfa, su indicazione di Rossi, perché Beta era in ritardo”. A domanda se Rossi lo informò, dice di sì. Ciò prova la consapevolezza.
- Un operaio di Alfa conferma che fu pagato straordinario per fare impianti che dovevano essere di Beta.
- Difesa chiama un consulente che illustra che il margine di guadagno complessivo di Alfa sull’appalto non è aumentato dalle fatture Beta (in pratica Alfa ha solo spostato costi da manodopera a prestazione di terzi). Ne risulta che il profitto ingiusto è dubbio.
- In Commissione Tributaria, intanto (a febbraio 2024) c’è stata udienza: non ancora decisione, ma l’adesione non è stata raggiunta perché Alfa non voleva ammettere la frode. La difesa penale decide allora di far pagare ugualmente l’IVA contestata (66k + interessi) per mostrare buona condotta.
- Al dibattimento, si produce quietanza del pagamento IVA dovuta e si fa testimoniare il commercialista che attesta: “Alfa ha fatto bonifico F24 di €80k a luglio 2024 coprendo interamente l’IVA e sanzioni, perché vogliono sanare la posizione col fisco.” Questo per mitigare.
Nelle conclusioni, il difensore evidenzia: – Il Comune non ha subito un danno patrimoniale concreto (ha avuto la scuola funzionante al costo pattuito). – Rossi ha già pagato le imposte, quindi lo Stato non ha perso gettito (tesi non del tutto vera, Beta ha evaso margine e IRES, ma la difesa insiste sull’IVA almeno). – Chiede assolta la truffa perché manca l’elemento di inganno (il DL ha firmato SAL consapevole, il Comune quindi non è stato “indotto in errore” – interpretazione sottile) e semmai riqualificare in 316-ter c.p. se si ritiene indebito (tra l’altro l’importo pubblico percepito è €300k > soglia, quindi comunque reato, ma punito meno severamente). – Sul reato fiscale art.2 chiede il minimo della pena con attenuanti prevalenti, evidenziando appunto il pagamento effettuato (art. 13-bis D.Lgs.74 e condotta susseguente) e magari la particolare tenuità (cercando di dire che residuo debito è nullo, azienda in crisi etc). – Per il falso in atto (483) chiede assorbimento in 316-ter o comunque il minimo.
- 2024, giugno – Sentenza primo grado: Ipotizziamo l’esito: il Tribunale assolve dall’art. 640-bis c.p. (“il fatto non costituisce reato” ritenendo manchi l’elemento del raggiro, magari comprando in parte la tesi del difensore che era un illecito amministrativo di subappalto non autorizzato, punibile in altra sede). Condanna invece Rossi per dichiarazione fraudolenta (art.2) ritenendo provato l’utilizzo di fatture false per evasione, e per falsità ideologica (483) limitatamente alle dichiarazioni rese al Comune (ma forse lo assorbe in 316-ter). Diciamo che condanna per art. 2 e 8 (quest’ultimo in concorso con titolare Beta). Pena: 1 anno e 8 mesi, grazie alle attenuanti generiche e dell’aver pagato (riduzione significativa). Sospensione condizionale concessa perché incensurato e ha pagato debito. Dispone confisca di 50k (ritenendo profitto illecito limitato al margine in nero ottenuto).
– Per Alfa come società 231, il tribunale dichiara non doversi procedere (magari perché l’ente ha adottato un modello organizzativo dopo i fatti e si è discusso che non c’era interesse specifico, scenario complesso che tralasciamo).
- 2024, luglio – Dopo la sentenza: Rossi è sollevato per aver evitato la condanna per truffa aggravata (che sarebbe stata infamante e forse più severa). Però il PM appella l’assoluzione sul 640-bis, ritenendo la truffa sussistente. La difesa incrocia le dita sperando regga.
Intanto, ANAC aveva sospeso Alfa dalla white list per un anno in via cautelare quando è uscita la notizia del processo (inserendo nota di illecito professionale). Dopo la sentenza, la difesa invia all’ANAC la copia della sentenza di primo grado che esclude la truffa: chiede l’annotazione che “il reato contro la PA non sussiste”. ANAC valuterà, ma tendenzialmente l’impresa rimane con macchia per i reati fiscali.
- 2025, marzo – Appello: La Corte d’Appello, sulla base anche delle nuove linee normative (Cartabia e D.Lgs.87/2024), potrebbe confermare l’assenza di truffa e ridurre ulteriormente la pena fiscale applicando l’art. 12 c.3-ter: essendo il debito estinto, considera particolare tenuità e dichiara non doversi procedere per la dichiarazione fraudolenta (ipotizziamo, anche se su 66k evasi non è proprio tenue, ma supponiamo indulgenti). Quindi Rossi viene prosciolto in appello per tenuità. In tal caso, fu vincente aver pagato e impostato la difesa su quel punto . Resterebbe la condanna per il reato minore di falso (483) con pena magari già coperta dalla condizionale.
- 2025, aprile – Conseguenze finali: Alfa S.r.l. può cercare di riprendere a partecipare a gare. Non ha condanne per 640-bis, quindi evita l’esclusione automatica perpetua. Ha però una condanna (anche se forse estinta per tenuità) per frode fiscale: agli occhi di stazioni appaltanti è un illecito professionale grave. Dovrà fare self-cleaning: adotta un modello 231 anticorruzione e antievasione, licenzia Rossi (o Rossi si defila per un periodo), assume un monitoraggio esterno. ANAC verrà informata di queste misure. Probabilmente per qualche anno Alfa farà fatica a vincere appalti per la reputazione scossa, ma con il tempo e nessun’altra macchia potrà riabilitarsi.
Questo caso simulato mostra come una vicenda di false fatture si dipana su più binari e come la difesa deve adattarsi dinamicamente: inizialmente contestare tutto, poi eventualmente puntare a ridurre i capi, pagare il dovuto, patteggiare su alcuni aspetti, ecc., sempre valutando rischi e benefici.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo ad alcune domande comuni che imprenditori e professionisti possono porsi quando si trovano ad affrontare contestazioni di false fatturazioni in appalti pubblici. Le risposte richiamano quanto esposto nella guida, fungendo da rapido riepilogo pratico.
- Domanda: Cosa si intende esattamente per “fattura falsa” in questo contesto?
Risposta: Una fattura si considera falsa (per operazione inesistente) quando documenta un’operazione commerciale che in realtà non è avvenuta oppure non è avvenuta con quelle modalità o tra quei soggetti. Ad esempio, fatturare forniture mai consegnate, lavori mai eseguiti, oppure fatturare da parte di una società che non ha realmente effettuato i lavori (magari svolti invece dall’impresa stessa che “compra” la fattura). Nel contesto dei lavori pubblici, tipicamente sono fatture fittizie emesse da imprese compiacenti (senza struttura) per gonfiare i costi di un appalto o creare fondi illeciti. La Cassazione considera inesistenti anche le operazioni soggettivamente tali: se un’azienda fattura lavori che in realtà ha eseguito un’altra, la fattura è equiparata a falsa . In sintesi, conta la realtà sostanziale: se la fattura non rispecchia una prestazione effettiva corrispondente, è una falsa fatturazione. - Domanda: Quali sono le pene previste se vengo condannato per aver usato/emesso fatture false?
Risposta: Sono previste pene detentive significative. Per la dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art. 2 D.Lgs. 74/2000) la reclusione va da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni, elevabile a 4–8 anni se l’ammontare dei costi fittizi supera 100.000 € . Per l’emissione di fatture false (art. 8) la pena è da 4 a 8 anni . La truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.) comporta 2–7 anni di reclusione . Inoltre, possono aggiungersi reati di falso in atto pubblico (fino a 6 anni per il pubblico ufficiale, 2 anni per il privato). Oltre alle pene detentive, ci sono confische (dei profitti illeciti) e pene accessorie: ad esempio, l’interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contrattare con la P.A. fino a 5 anni o più . In sede fiscale, a queste si sommano le sanzioni tributarie pecuniarie (generalmente pari al 90%-100% dell’imposta evasa, quindi economicamente molto rilevanti). Va detto che in concreto la pena dipenderà dalla gravità specifica e dalle attenuanti: ad esempio, pagando il dovuto e con circostanze attenuanti, spesso la pena può essere contenuta entro 2 anni (sospendibile). Ma per casi seri (frode di grande importo, recidiva) non sono esclusi anni di carcere effettivo. - Domanda: Se il fisco mi contesta l’indebita detrazione IVA su fatture false, come posso difendermi?
Risposta: In ambito tributario, la difesa tipica è dimostrare che le operazioni esistevano davvero oppure che la tua azienda era in buona fede. Se hai elementi per provare che i lavori o le forniture indicate in fattura sono stati effettivamente svolti (anche magari da un soggetto diverso, ma c’è stata una prestazione reale utile all’azienda), portali a sostegno. Il fisco tende a negare la detrazione se prova che il fornitore era una “cartiera” (inesistente di fatto): in tal caso, devi ribaltare la presunzione mostrando, ad esempio, documenti di trasporto, foto dei materiali, testimonianze di operai, ecc., che confermino la realtà della transazione. Se non riesci su questo, punta sulla buona fede: ossia che non sapevi che la fattura fosse connessa a un’operazione irregolare. Per convincere, devi mostrare di aver fatto controlli ragionevoli sul fornitore (richiesta di DURC, verifica iscrizioni, pagamenti tracciati). La normativa italiana è severa, ma la giurisprudenza UE tutela chi prova di essere stato inconsapevole: se riesci a dimostrarlo, potresti ottenere l’annullamento dell’accertamento . In alternativa, valuta una definizione agevolata: ad esempio un accertamento con adesione, pagando il dovuto con sanzioni ridotte, specie se la controparte fiscale ha forti evidenze. Ciò almeno limita il danno economico e può aiutarti poi penalmente (il pagamento spontaneo è visto bene in sede penale ). Ricorda però che in caso di frode organizzata, difendersi in campo IVA è difficile: spesso l’Agenzia ha già robusti elementi (es. la controparte è risultata fantasma). In tali casi una transazione può essere la via meno onerosa. - Domanda: La mia azienda rischia l’esclusione dalle gare pubbliche per questa vicenda?
Risposta: Sì, esiste questo rischio sia immediato che a medio termine. Se sei sotto indagine o processo, la stazione appaltante può valutare la tua situazione come sintomo di “grave illecito professionale” e quindi escluderti discrezionalmente da una gara in corso . Devono però darti modo di difenderti (memoria) e considerare eventuali misure correttive che hai preso (vedi self-cleaning). In caso di condanna definitiva per reati gravi (come la truffa ai danni dello Stato, o anche alcuni reati fiscali se qualificati come tali), scatta l’esclusione automatica per legge per un certo periodo (fino a 5 anni di solito) . Inoltre, una condanna del legale rappresentante per delitti di frode o fiscali di solito implica l’incapacità di contrattare con la P.A. come pena accessoria . Anche senza condanna, il tuo nome può finire annotato nel Casellario ANAC, il che rende le P.A. molto caute nell’aggiudicarti appalti. Quindi, in pratica, appena la notizia trapela, potresti essere escluso da nuove gare o subire la risoluzione di contratti in essere (la P.A. può risolvere un contratto se scopre gravi irregolarità come queste, per giusta causa). Per difenderti, oltre a far valere l’eventuale insussistenza dei fatti, dovresti mettere in atto misure di self-cleaning: ad esempio, allontanare le persone coinvolte, risarcire il danno all’ente (se c’è), implementare procedure di controllo interne, e presentare tutto ciò all’ANAC e alle stazioni appaltanti . Dimostra di aver fatto pulizia e prevenzione: ciò potrebbe convincere che meriti comunque fiducia, o almeno attenuare la durata dell’esclusione (nei casi discrezionali). Ma se la condanna è definitiva su reati del codice penale rilevanti, purtroppo l’esclusione per legge è inevitabile, e l’unica è attendere gli effetti riabilitanti (o chiedere la riabilitazione dopo aver scontato la pena, per anticipare la fine del divieto). - Domanda: Quali difese ho se mi accusano di truffa ai danni dello Stato nell’ambito di un appalto?
Risposta: Bisogna focalizzarsi sugli elementi costitutivi della truffa aggravata ex art. 640-bis c.p.: artifizi o raggiri, induzione in errore dell’ente pubblico, ingiusto profitto con altrui danno . Le possibili difese sono: - Negare l’esistenza di artifizi/raggiri: sostenere che non c’è stata alcuna manovra fraudolenta, ma al più un’irregolarità formale. Ad esempio, argomentare che tutte le informazioni fornite all’ente erano note e non manipolate, e che l’ente non è stato ingannato ma ha pagato volontariamente ciò che riteneva dovuto. In pratica, provare a far scivolare il caso nell’alveo meno grave dell’indebita percezione (316-ter), che punisce solo la presentazione di dichiarazioni false senza inganno elaborato. Se riesci a farla qualificare come 316-ter, eviti la pesante cornice di pena della truffa e forse – se l’importo indebito è modesto – anche il penale (sotto 4000 € è illecito amministrativo) .
- Negare l’errore indotto nell’ente: dimostrare, ad esempio, che i funzionari pubblici erano consapevoli della situazione o che comunque l’ente non ha subito un inganno vero e proprio. Se il pubblico ufficiale colluso sapeva, formalmente l’ente come vittima c’è, ma si può argomentare che manca l’“errore” perché c’era consapevolezza interna (difesa tecnica difficile, ma a volte addotta).
- Negare l’ingiusto profitto e il danno altrui: far vedere che, nonostante le irregolarità, non hai ottenuto un profitto indebito. Ad esempio, se hai fatturato lavori non eseguiti ma poi hai comunque svolto altri lavori extra senza chiederli, potresti dire che non c’è danno erariale netto. Oppure che i prezzi erano congrui, per cui l’ente ha pagato il giusto valore (quindi niente danno). La Cassazione ha però chiarito che anche solo ottenere un credito d’imposta fittizio integra il reato, quindi il profitto può essere anche potenziale . Tuttavia, ridimensionare il danno può aiutare per escludere l’aggravante o per le attenuanti.
- Dimostrare l’assenza di dolo specifico: la truffa richiede la volontà di procurarsi un ingiusto profitto. Se puoi sostenere che pensavi di avere diritto a quei fondi (anche se erroneo), magari perché c’è stata un’interpretazione controversa di norme, ciò potrebbe escludere il dolo. Ad esempio, dire “ero convinto che quella spesa fosse ammissibile a rimborso, non volevo ingannare” – funziona poco se hai falsificato documenti, ma se la questione è tecnico-contabile potrebbe colpire.
In pratica, per difendersi dall’accusa di 640-bis, spesso la strategia è ottenere una riqualificazione in 316-ter c.p. (che comporta al max 3 anni e scenari più gestibili) . Ciò può avvenire convincendo che non c’è stata quell’elaborata messa in scena fraudolenta ma solo l’uso di false dichiarazioni (documenti falsi presentati) . Ad esempio, se l’unica cosa falsa è una dichiarazione allegata alla domanda di contributo, potrai dire: “questo è lo schema tipico di 316-ter, non di truffa aggravata”, perché manca l’artificio ulteriore. La difesa può citare giurisprudenza: “il reato di falso di cui all’art. 483 c.p. resta assorbito in quello di indebita percezione ex art. 316-ter in tutti i casi in cui l’utilizzo di documenti falsi sia elemento essenziale di questo” . Ciò per far emergere che siamo nel 316-ter. Se il giudice accetta, la differenza è notevole: niente interdizione perpetua, pena molto più bassa, e se importo sotto soglia pure solo sanzione amministrativa . Naturalmente ciò vale se lo scenario è effettivamente “soft”; se invece c’erano piani truffaldini complessi (società fittizie, collusioni), è difficile farlo passare per semplice indebita percezione. In tal caso, l’approccio è mitigare la pena mostrando condotte riparatorie (risarcimento) e puntare alle attenuanti.
- Domanda: Conviene pagare le imposte contestate (IVA, ecc.) prima del processo penale?
Risposta: Sì, conviene, per vari motivi. Primo, la legge prevede una sorta di “perdono” in caso di pagamento integrale tempestivo: se paghi tutto il debito tributario, con interessi e sanzioni, prima di avere formale conoscenza di indagini penali, il reato tributario può dichiararsi non punibile . Questo è applicabile anche alle frodi fiscali come l’uso di fatture false . Nella pratica, spesso vieni a sapere dell’indagine con la perquisizione o l’informazione di garanzia, quindi è difficile pagare prima. Ma anche pagare dopo ha benefici: - Dimostra la tua volontà di ravvedimento. I giudici penali lo considerano per le attenuanti generiche e può essere decisivo per applicare la particolare tenuità del fatto . Ad esempio, la Cassazione ha detto che se un imputato ha quasi estinto il debito con rate, questo elemento deve avere peso prevalente nel valutare la tenuità .
- Riduce l’incentivo punitivo: una ragione della sanzione penale è recuperare il dovuto; se hai già pagato, è più facile ottenere un patteggiamento ad una pena bassa o una sospensione condizionale.
- Evita aggravi economici ulteriori: col tempo maturano interessi e arrivano cartelle. Pagare presto (anche a rate) limita i danni e ti fa apparire collaborativo.
Inoltre, dopo la riforma del 2022 (Cartabia) e il D.Lgs. 87/2024, il pagamento del debito è stato formalizzato come criterio rilevante per il giudice . Quindi un imputato che abbia pagato ha una posizione molto migliore di uno che non l’ha fatto. Ricorda però: per usufruire completamente della causa di non punibilità, il pagamento deve essere spontaneo e integrale prima di sapere di essere indagato . Se già hai ricevuto un 415-bis o se è noto che sei sotto processo, allora il reato non si estingue automaticamente, ma avrai comunque una forte attenuante (riduzione di pena fino alla metà ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000, se paghi tutto prima della sentenza di primo grado). In sintesi: sì, paga il dovuto appena puoi permettertelo (o concorda un piano di rientro) – è un investimento sulla tua difesa.
- Domanda: Come funziona il “self-cleaning” e posso evitare così l’esclusione dalle gare?
Risposta: Il self-cleaning è un concetto introdotto dalle direttive UE sugli appalti e recepito in Italia: consiste nella possibilità per un operatore economico, macchiatosi di illeciti, di adottare misure di pentimento e riorganizzazione tali da “ripulire” la propria affidabilità. In pratica, se hai commesso un illecito (ad esempio una frode con false fatture), puoi cercare di evitare o ridurre l’esclusione dalle gare dimostrando di aver preso provvedimenti come: - Risarcire o eliminare il danno causato: ad esempio restituire i soldi indebitamente percepiti all’ente pubblico, oppure pagare le sanzioni correlate. Ciò mostra che non vuoi lucrare sull’illecito.
- Collaborare con le autorità: fornire informazioni utili alle indagini, magari facilitare l’individuazione di altri responsabili. Se la tua collaborazione aiuta a fare pulizia, è un punto a favore.
- Allontanare i responsabili: se nella tua azienda le condotte illecite sono riconducibili a determinati dirigenti o dipendenti, prendere provvedimenti disciplinari seri (licenziamento o sospensione) contro di loro.
- Adottare modelli di organizzazione e controllo: ad esempio implementare un modello 231, nominare un organismo di vigilanza, introdurre procedure di doppio controllo sulle fatture e sugli appalti. Anche aderire a programmi di compliance fiscale. L’ANAC e la legge appalti si aspettano misure efficaci per prevenire recidive .
- Formazione e codice etico: formare il personale su legalità e anticorruzione, adottare un codice etico che condanni espressamente certe pratiche, e impegnarsi a rispettarlo.
Una volta fatte queste cose, devi preparare un dossier e presentarlo alle stazioni appaltanti o all’ANAC quando c’è in ballo un’esclusione. Ad esempio, se vieni convocato perché la tua vicenda è emersa in gara, porti tutta la documentazione: attestazioni di pagamento, copia del nuovo modello organizzativo, lettera di licenziamento del dirigente colpevole, ecc., e magari anche una relazione di un soggetto terzo (tipo un auditor) che certifichi la bontà delle misure. Se riesci a convincere la stazione appaltante che ora sei un soggetto affidabile, potrebbero non escluderti nonostante l’illecito. L’ANAC stessa nella linea guida n.6 elenca i reati tributari fra quelli dove il self-cleaning è rilevante .
Tieni presente che il self-cleaning non cancella il passato: se hai una condanna definitiva, il codice appalti (nuovo o vecchio) prevede comunque l’esclusione obbligatoria per un tot anni. Però in quei casi puoi almeno chiedere dopo 3 anni al giudice la “riabilitazione” e usare il self-cleaning come argomento per ottenerla, così da rientrare prima nel mercato. In caso di esclusione discrezionale (quando ancora sei solo indagato o condannato non definitivo), il self-cleaning può davvero salvarti: diverse sentenze TAR hanno reintegrato imprese escluse perché l’ANAC o l’ente non avevano considerato sufficientemente le misure di self-cleaning presentate dall’impresa. Quindi prepara bene questa parte con l’aiuto di legali esperti di appalti. È la tua chance di dimostrare: “Ho sbagliato, ma ho fatto di tutto per rimediare e assicurare che non accadrà più”. Se credibile, potresti evitare di dover chiudere l’azienda per mancanza di commesse pubbliche.
Fonti:
- Sentenza n. 45868 del 2024: Truffa aggravata e Superbonus 110%
- sentenza n. 10400/2025 la Cassazione delinea i confini dell’art. 8 D.Lgs. 74/2000
- Cassazione penale Sez. II sentenza n. 38794 del 13 ottobre 2022
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 22076 del 12 giugno 2025
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate o un verbale della Guardia di Finanza per presunte false fatturazioni in lavori pubblici? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate o un verbale della Guardia di Finanza per presunte false fatturazioni in lavori pubblici?
Vuoi sapere cosa rischi e come difenderti da accuse così gravi?
👉 Prima regola: dimostra la reale esecuzione delle opere e dei servizi fatturati, con prove concrete e documentazione tecnica.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Emissione o utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (lavori mai eseguiti);
- Fatturazioni gonfiate rispetto alle opere realmente svolte;
- Subappalti fittizi o catene di società cartiere coinvolte nei lavori pubblici;
- Difformità tra lo stato avanzamento lavori (SAL) e gli importi fatturati;
- Mancanza di documentazione di supporto (contratti, collaudi, certificazioni).
📌 Conseguenze della contestazione
- Recupero delle imposte e indeducibilità dei costi;
- Sanzioni fiscali per dichiarazione fraudolenta o utilizzo di fatture false;
- Interessi di mora sulle somme contestate;
- Rischio di denunce penali (reato di emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000);
- Possibili interdittive negli appalti pubblici e responsabilità patrimoniale degli amministratori.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- I lavori fatturati sono stati effettivamente eseguiti?
- Esistono contratti, stati avanzamento lavori e collaudi a supporto?
- Le fatture contestate corrispondono a prestazioni reali e documentabili?
- I subappalti erano regolarmente autorizzati e registrati?
- L’accertamento si fonda su prove oggettive o su presunzioni?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Contratti di appalto e subappalto;
- Stati avanzamento lavori (SAL) e certificati di collaudo;
- Fatture e relative quietanze di pagamento;
- Relazioni tecniche, giornali dei lavori e documentazione fotografica;
- Comunicazioni ufficiali con stazioni appaltanti e direttori dei lavori.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare l’effettività dei lavori eseguiti e la correttezza delle fatture;
- Contestare la riqualificazione come operazioni inesistenti se vi erano prestazioni reali;
- Evidenziare errori formali che non incidono sulla sostanza dell’appalto;
- Eccepire eventuali vizi di motivazione e di procedura nell’accertamento;
- Richiedere annullamento in autotutela se i documenti erano già agli atti;
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini;
- Difesa penale mirata in caso di contestazioni ex art. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza le fatture, i contratti e la documentazione tecnica dei lavori pubblici;
📌 Valuta la fondatezza delle contestazioni fiscali e penali;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti assiste nei giudizi fiscali e nei procedimenti penali collegati;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione trasparente e sicura degli appalti pubblici.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e diritto penale tributario;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni su false fatturazioni e appalti pubblici;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni per false fatturazioni nei lavori pubblici sono tra le più gravi, ma non sempre fondate: spesso derivano da presunzioni, errori nei controlli o difformità formali.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la realtà delle prestazioni, ridurre le pretese fiscali e contenere i rischi penali.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti e le indagini sui lavori pubblici inizia qui.