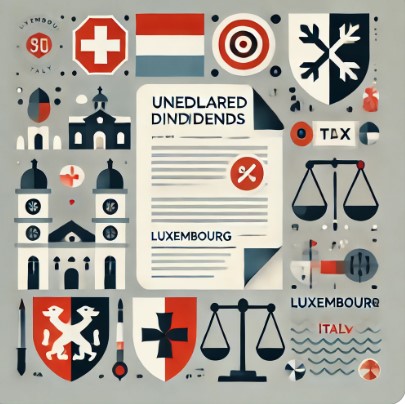Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per dividendi percepiti da società lussemburghesi non dichiarati in Italia? In questi casi, l’Ufficio presume che i redditi da partecipazioni estere siano stati occultati e che non siano stati riportati nella dichiarazione dei redditi e nel quadro RW per il monitoraggio fiscale. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni proporzionali e rischio di controlli patrimoniali più estesi. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la corretta tassazione o ridurre in modo significativo l’impatto delle sanzioni.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i dividendi da Lussemburgo
– Se i dividendi non sono stati dichiarati in Italia come redditi di capitale
– Se manca la compilazione del quadro RW per il monitoraggio degli investimenti esteri
– Se non è stata applicata correttamente la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Lussemburgo
– Se emergono incongruenze tra gli accrediti bancari e quanto dichiarato
– Se l’Ufficio presume che i dividendi percepiti siano stati intenzionalmente occultati al Fisco italiano
Conseguenze della contestazione
– Tassazione integrale dei dividendi percepiti non dichiarati
– Applicazione di sanzioni fino al 30% per la mancata compilazione del quadro RW
– Interessi di mora sulle somme dovute
– Accertamenti patrimoniali estesi su altri conti e investimenti all’estero
– Possibile denuncia penale nei casi più gravi di omessa dichiarazione
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare che i dividendi sono già stati tassati correttamente in base alla convenzione Italia-Lussemburgo
– Produrre certificazioni della società estera e documentazione bancaria
– Contestare l’applicazione di doppia tassazione in assenza di corretta interpretazione della normativa internazionale
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o vizi di notifica nell’accertamento
– Valutare l’adesione a strumenti deflattivi del contenzioso per ridurre sanzioni e interessi
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per chiedere l’annullamento totale o parziale della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la natura dei dividendi percepiti e la relativa documentazione estera
– Verificare la corretta applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e vizi procedurali
– Difendere il contribuente davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e familiare da contestazioni fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione delle sanzioni tramite la corretta qualificazione fiscale dei dividendi
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– L’eliminazione del rischio di doppia tassazione
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: i dividendi da società estere, in particolare da Lussemburgo, sono sotto stretta vigilanza del Fisco italiano grazie allo scambio automatico di informazioni tra Stati. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata per evitare gravi conseguenze fiscali e penali.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscale internazionale – spiega come difendersi in caso di contestazioni per dividendi da Lussemburgo non dichiarati in Italia e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.
👉 Hai ricevuto una contestazione per dividendi da Lussemburgo non dichiarati? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la legittimità della pretesa e costruiremo la strategia difensiva più efficace per tutelare i tuoi interessi.
Introduzione
Perché l’Italia contesta i dividendi esteri non dichiarati?
– Perché se sei fiscalmente residente in Italia, sei tassato sui redditi ovunque prodotti, quindi devi dichiarare anche i dividendi percepiti in Lussemburgo .
– Perché l’Agenzia delle Entrate può ritenere che tu non abbia interrotto la residenza fiscale italiana (es. hai ancora famiglia o interessi economici in Italia), anche se vivi/lavori in Lussemburgo .
– Perché la mancata dichiarazione dei redditi esteri (dividendi inclusi) e l’omessa compilazione del Quadro RW per le attività finanziarie estere configurano violazioni fiscali gravi. Il Fisco può quindi accertare tali redditi e sanzionare l’omissione.
Cosa può contestarti l’Agenzia delle Entrate?
– Omessa o infedele dichiarazione di redditi esteri: non aver indicato in dichiarazione annuale i dividendi percepiti all’estero . Se non hai presentato affatto la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo, si parla di omessa dichiarazione; se l’hai presentata ma senza includere i dividendi esteri, si configura dichiarazione infedele.
– Violazione del monitoraggio fiscale (Quadro RW): se non hai dichiarato nel quadro RW del Modello Redditi le partecipazioni, conti o investimenti detenuti in Lussemburgo da cui provengono i dividendi .
– Mancato pagamento delle imposte italiane sui dividendi esteri imponibili: in sostanza, il Fisco recupera l’IRPEF (o IRES) dovuta sui dividendi non dichiarati in Italia, oltre a interessi e sanzioni .
– Sanzioni amministrative elevate: possono arrivare fino al 240% delle imposte non versate, in caso di omessa dichiarazione con intenti fraudolenti . Inoltre, sono previste sanzioni sul valore dell’attività estera non dichiarata (3%–15% o 6%–30% in base allo Stato, v. oltre).
Come puoi difenderti da un accertamento su dividendi esteri?
– Verificando la residenza fiscale: puoi difenderti dimostrando che eri residente fiscale in Lussemburgo (e non più in Italia) nei periodi d’imposta contestati, così che l’Italia non aveva titolo per tassare quei redditi .
– Invocando la Convenzione contro le doppie imposizioni: se i dividendi sono stati già tassati in Lussemburgo, puoi chiedere che l’Italia applichi il credito d’imposta estero o esenti il reddito secondo la Convenzione Italia-Lussemburgo . Devi esibire la prova della tassazione estera subita e far valere le norme della Convenzione per evitare doppie tasse.
– Contestando errori materiali nell’accertamento: ad esempio, dimostrando che l’Agenzia ha interpretato male i dati ricevuti dal Lussemburgo (capita che dividendi esteri vengano confusi con altri movimenti già tassati altrove) . In tal caso, il reddito potrebbe non essere imponibile nuovamente in Italia e l’avviso va annullato.
– Utilizzando gli strumenti deflattivi e il contenzioso: puoi presentare memorie e documenti in risposta a una lettera di compliance o impugnare formalmente l’avviso di accertamento davanti al Giudice Tributario, chiedendo eventualmente la sospensione della riscossione. Procedure come l’adesione all’accertamento, la mediazione/reclamo o la conciliazione giudiziale permettono spesso di ridurre sanzioni e trovare un accordo .
Quando i dividendi da Lussemburgo non sono imponibili in Italia?
– Se non sei fiscalmente residente in Italia (cioè risulti residente all’estero per la maggior parte dell’anno, senza mantenere domicilio/interessi in Italia). In tal caso i redditi esteri non rientrano nella base imponibile italiana .
– Se la Convenzione Italia–Lussemburgo stabilisce che quel reddito è tassabile solo in Lussemburgo. Ad esempio, alcuni redditi d’impresa o immobiliari possono essere tassati esclusivamente nello Stato della fonte: in tali casi l’Italia deve esentare quel reddito . (NB: I dividendi in genere sono tassabili in entrambi gli Stati, ma con credito per le imposte estere, v. oltre).
– Se hai già pagato le imposte in Lussemburgo e hai diritto al credito d’imposta in Italia. Il sistema del credito evita la doppia imposizione: in dichiarazione italiana indichi l’imposta estera definitiva pagata sui dividendi e la detrai dall’imposta italiana dovuta su quegli stessi redditi .
– Se la distribuzione estera in realtà non costituisce reddito imponibile secondo la legge italiana. Ad esempio, se ciò che hai ricevuto non è un dividendo ma una restituzione di capitale o riserve societarie già tassate, potrebbe non dover essere tassato come reddito. In un caso, l’Agenzia delle Entrate aveva qualificato come “dividendi esteri” importi che in realtà erano interessi già soggetti a ritenuta in Italia: dimostrato l’equivoco, non c’è doppia imposizione . Situazioni del genere vanno provate con documenti.
Errori da evitare assolutamente:
– Ignorare l’avviso di accertamento. Se non presenti ricorso entro 60 giorni, l’atto diventa definitivo e l’imposta (più sanzioni) sarà iscritta a ruolo esecutivo . Inoltre, non rispondere alle comunicazioni del Fisco (es. lettera di compliance) aggrava la posizione: il silenzio può essere interpretato come mancanza di difesa ed ostacola possibili soluzioni bonarie .
– Supporre che aver pagato tasse in Lussemburgo ti esenti dal dichiarare in Italia. Se sei residente in Italia devi comunque dichiarare il reddito estero e indicare le imposte estere pagate per ottenere il credito. Il solo pagamento alla fonte (es. ritenuta 15% in Lussemburgo) non ti esonera dagli obblighi dichiarativi in Italia .
– Confondere residenza anagrafica e residenza fiscale. Anche se ti sei iscritto all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) o hai trasferito formalmente la residenza, il Fisco può considerarti residente fiscale in Italia se hai qui il centro effettivo degli interessi di vita (famiglia, affari) . È fondamentale valutare i criteri di residenza fiscale (vedi sotto) prima di presumere di non dover dichiarare in Italia.
– Affrontare la contestazione senza esaminare le Convenzioni internazionali e la normativa italiana. La difesa si basa su norme complesse (TUIR, D.Lgs. 74/2000 sui reati tributari, D.L. 167/1990 sul monitoraggio, Convenzione Italia-Lussemburgo, etc.). È consigliabile farsi assistere da esperti per individuare le argomentazioni giuridiche corrette da opporre all’Ufficio.
Un dividendo estero non dichiarato può essere difeso e – in certi casi – non essere dovuto in Italia. Ma va dimostrato con documentazione e facendo leva sulle regole fiscali appropriate. Nei paragrafi seguenti esaminiamo in dettaglio la disciplina applicabile e le strategie difensive, con riferimenti normativi (aggiornati ad agosto 2025), giurisprudenza recente e strumenti pratici di tutela dal punto di vista del contribuente (debitore). Il taglio sarà giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti (avvocati tributaristi, consulenti) sia a privati cittadini e imprenditori coinvolti in queste contestazioni. Troverete tabelle riepilogative, sezioni di domande & risposte e simulazioni pratiche per chiarire i punti chiave e fornire esempi concreti di difesa.
Quadro normativo italiano: residenza fiscale e tassazione mondiale
Principio della “worldwide taxation” e obbligo dichiarativo dei redditi esteri. L’Italia adotta il principio della tassazione mondiale del reddito: i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti (worldwide income), mentre i non residenti sono tassati in Italia solo sui redditi di fonte italiana . Questo principio è sancito dall’art. 3, co.1, del TUIR (D.P.R. 917/1986). Dunque, un contribuente residente in Italia deve dichiarare anche i dividendi esteri (ad esempio quelli distribuiti da società lussemburghesi), salvo applicazione di accordi internazionali che evitino la doppia imposizione.
Criteri di residenza fiscale (persone fisiche e società). La residenza fiscale si determina in base a criteri stabiliti dall’art. 2 TUIR per le persone fisiche e dall’art. 73 TUIR per le società. Per le persone fisiche, è residente chi per almeno 183 giorni l’anno: (a) è iscritto all’Anagrafe residente in Italia, oppure (b) ha in Italia il domicilio (centro principale di interessi), oppure (c) la residenza civile (dimora abituale) . Basta che uno di questi criteri si verifichi perché la persona sia considerata fiscalmente residente in Italia. Per le società o enti, è residente in Italia chi ha: (a) sede legale in Italia (per la maggior parte dell’anno), oppure (b) sede dell’amministrazione in Italia (luogo di direzione effettiva), oppure (c) oggetto principale dell’attività in Italia . Anche qui, è sufficiente uno dei criteri perché scatti la residenza fiscale italiana (sempre riferito a più di metà anno) .
Tabella 1 – Criteri di collegamento della residenza fiscale (art. 2 e 73 TUIR)
| Persone Fisiche (>=183 giorni/anno) | Società/Enti (>=183 giorni/anno) |
| :———————– | :—————————– |
| Iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (AIRE/non-AIRE) | Sede legale in Italia |
| Domicilio in Italia (centro degli interessi vitali, ex art.43 c.c.) | Sede dell’amministrazione in Italia (direzione effettiva) |
| Residenza (abitazione) in Italia (dimora abituale) | Oggetto principale in Italia (attività prevalentemente svolta in Italia) |
Per le persone fisiche, la compresenza di legami personali ed economici in Italia fa spesso prevalere la residenza italiana. Ad esempio, la Cassazione ha confermato casi in cui un contribuente che lavorava in Lussemburgo ma manteneva famiglia e casa in Italia è stato considerato residente in Italia ai fini fiscali . Inoltre, attenzione: se un cittadino italiano trasferisce la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata (black list), l’art. 2 co.2-bis TUIR prevede una presunzione che egli resti residente in Italia, salvo prova contraria. Il Lussemburgo, tuttavia, non è considerato paradiso fiscale ai fini di questa presunzione (è Stato UE collaborativo) . Ciò significa che il trasferimento in Lussemburgo non attiva automaticamente la presunzione di residenza fittizia; ciononostante, l’onere di dimostrare di aver veramente trasferito il centro degli interessi fuori dall’Italia ricade comunque sul contribuente in caso di verifica. In pratica, se l’Agenzia rileva che hai ancora la famiglia o affari in Italia, potrà sostenere la tua residenza italiana, e starà a te provare il contrario (esibendo iscrizione AIRE, contratto di lavoro estero, locazione/abitazione stabile all’estero, ecc.).
Dividendi esteri imponibili in Italia e credito d’imposta. In base al principio generale, un residente in Italia deve includere nella propria dichiarazione i dividendi percepiti da società estere (come quelli da società lussemburghesi). Tali dividendi esteri, se imponibili, concorrerebbero alla formazione del reddito imponibile IRPEF (o IRES per le società). Tuttavia, per evitare doppie imposizioni internazionali, l’Italia aderisce a un sistema di tassazione concorrente con credito d’imposta estero: in pratica, i dividendi possono essere tassati sia nello Stato estero (via ritenuta alla fonte) sia in Italia, ma l’imposta pagata all’estero viene poi scomputata da quella dovuta in Italia . Ciò è previsto sia dall’art. 165 TUIR (credito per imposte estere) sia dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Ad esempio, i dividendi pagati da una società lussemburghese a un residente italiano sono di regola soggetti a una ritenuta alla fonte in Lussemburgo (solitamente 15% secondo la Convenzione) e sono tassati in Italia secondo le regole italiane (es. al 26% come reddito di capitale per le persone fisiche – v. infra) . L’Italia dovrà però riconoscere un credito per la ritenuta del 15% pagata in Lussemburgo, così che il contribuente italiano non paghi due volte la stessa imposta . In altre parole, l’imposta italiana complessiva sui dividendi esteri sarà ridotta (fino a zero, se l’aliquota estera è pari o superiore a quella italiana) grazie allo scomputo del credito. Nota: per ottenere il credito, il contribuente deve indicare in dichiarazione (quadro CE/CR del Modello Redditi) l’ammontare delle imposte estere pagate definitivamente , ed è necessario che il dividendo estero sia effettivamente tassato nel reddito complessivo (non in regime sostitutivo separato). Dal 2018, i dividendi esteri percepiti da persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa sono soggetti a imposta sostitutiva 26% in Italia, senza concorso al reddito complessivo; in tali casi, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, non spetterebbe il credito per le imposte estere (in quanto l’imposta italiana è “sostitutiva”). Tuttavia, una recente evoluzione giurisprudenziale ha messo in dubbio questa limitazione: la Cassazione ha aperto alla possibilità di credito d’imposta convenzionale anche sui dividendi esteri soggetti a imposta sostitutiva, ritenendo prevalente la norma convenzionale sul diritto interno . In pratica, se un dividendo estero è stato tassato alla fonte e poi assoggettato a imposta sostitutiva 26% in Italia, il contribuente può rivendicare il credito per evitare doppia tassazione economica. Questo orientamento (v. Cass. n. 25698/2022; Cass. n. 21302/2022) rafforza la posizione difensiva del contribuente che, pur tardivamente, dichiari il dividendo: le imposte estere pagate devono essergli riconosciute in detrazione.
La Convenzione Italia–Lussemburgo (1981, Prot. 2015). Italia e Lussemburgo hanno stipulato una Convenzione bilaterale per eliminare le doppie imposizioni (in vigore dal 1983, aggiornata nel 2015) . Per i dividendi (art. 10 Convenzione): lo Stato della fonte (Lussemburgo) può prelevare un’imposta limitata (max 15% sulla somma lorda, ridotta a 5% per partecipazioni societarie qualificate), mentre lo Stato di residenza del percettore (Italia) tassa il dividendo secondo la propria legislazione, concedendo un credito d’imposta pari all’imposta pagata in Lussemburgo . Quindi il percettore italiano paga in totale l’aliquota più alta fra i due Paesi, senza duplicazione. Esempio: supponiamo aliquota effettiva italiana 26% e ritenuta lussemburghese 15%; su 1.000 € di dividendo, 150 € vengono trattenuti in Lux, e in Italia si pagheranno 110 € (26% di 1000 meno credito 150 €, quindi di fatto altri 11%). Se invece il contribuente prova che, ai sensi della Convenzione, è residente solo in Lussemburgo (ad esempio perché lì ha l’abitazione permanente e il centro degli interessi, e non in Italia), allora l’Italia non può tassare affatto i suoi redditi esteri . Stabilire la residenza “convenzionale” in caso di doppia residenza implica l’applicazione dei criteri tie-breaker dell’art. 4 della Convenzione: abitazione permanente, interessi vitali, dimora abituale, cittadinanza, ecc. . È un aspetto cruciale nelle difese: se riesci a qualificarti come residente estero secondo la Convenzione, l’avviso di accertamento italiano sui redditi esteri dev’essere annullato in toto.
Obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW). Oltre a dichiarare i redditi esteri, i residenti in Italia devono rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale riguardanti gli investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero. In pratica, il Quadro RW della dichiarazione dei redditi va compilato per indicare: conti correnti esteri, partecipazioni in società estere, titoli depositati all’estero, immobili esteri, quote di fondi esteri, criptovalute detenute su exchange esteri, trust esteri di cui si è beneficiari/disponenti effettivi, ecc. Devono essere dichiarate sia le attività produttive di reddito imponibile, sia quelle che non generano redditi (il monitoraggio serve a tracciare ricchezze detenute offshore). Ci sono soglie di esonero solo per conti correnti e depositi bancari a consistenza bassa (giacenza media sotto 5.000 € e saldo sotto 15.000 €) – altrimenti tutte le attività estere vanno indicate . Nel caso di partecipazioni in società estere, vanno monitorate indipendentemente dalla percentuale di possesso, e occorre prestare attenzione alle regole CFC (Controlled Foreign Companies): se detieni più del 50% di una società localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, scattano regimi di tassazione per trasparenza sugli utili non distribuiti (artt. 167 e 167-bis TUIR) . Il Lussemburgo, essendo paese UE e non considerato a fiscalità privilegiata in generale, di norma non rientra nel campo delle CFC automatiche (salvo regimi speciali con tassazione pressoché nulla: in tal caso conta il livello effettivo di tassazione < 50% di quello italiano).
Sanzioni per omissione del quadro RW. La mancata indicazione in RW di un’attività estera (conto, partecipazione, investimento) comporta una sanzione amministrativa proporzionale: dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato, se l’attività è in un Paese collaborativo (quale il Lussemburgo); dal 6% al 30% se l’attività è in un Paese black-list (paradiso fiscale) . La sanzione si applica in base al valore massimo dell’attività nell’anno (es. saldo massimo del conto, valore iniziale o finale della partecipazione). Importante: questa sanzione RW si applica anche se l’attività non ha prodotto redditi imponibili, perché il fine è punire l’occultamento dell’attività stessa . Tuttavia, non si somma due volte la sanzione per la medesima violazione sostanziale: secondo la Cassazione, se un’attività estera non dichiarata viene sanzionata con la pena da monitoraggio (3-15% del capitale) e con la pena per infedele dichiarazione (per il reddito corrispondente), ciò costituirebbe una duplicazione. In giurisprudenza si è affermato infatti che il Fisco non può “punire due volte lo stesso fenomeno” . In pratica, l’orientamento (Cass. ord. n.6752/2023; Cass. n.40916/2021) è di applicare o la sanzione patrimoniale RW o quella per mancata dichiarazione del reddito, evitando il cumulo eccedente. Sarà compito della difesa eccepire l’eventuale bis in idem sanzionatorio se l’Agenzia pretendesse entrambe le sanzioni.
| Violazione | Sanzione (min – max) | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Omessa dichiarazione di redditi (nessun Modello Redditi presentato, con imposta evasa > €50.000) | 120% – 240% dell’imposta dovuta (minimo €250); raddoppio a 240% – 320% se redditi da paradisi fiscali (abrogato dal 2015) | D.Lgs. 471/1997 art. 5, co.1; art. 12 DL 78/2009 (raddoppio termini, ora limitato) |
| Dichiarazione infedele (dividendi esteri non dichiarati in una dichiarazione presentata) | 90% – 180% dell’imposta evasa (se imposta evasa > €5.000 e redditi non dichiarati > 10% di quelli dichiarati) | D.Lgs. 471/1997 art. 1, co.2–4; art. 1, co.5 (attenuanti) |
| Omessa indicazione in Quadro RW – paese collaborativo (es. Lussemburgo) | 3% – 15% del valore non dichiarato (per ogni anno) | DL 167/1990 art. 5, co.2; D.Lgs. 90/2017 (adeguamento antiriciclaggio) |
| Omessa indicazione in Quadro RW – paese non collaborativo (black list) | 6% – 30% del valore non dichiarato (per anno) | DL 167/1990 art. 5, co.2 (raddoppio in black list) |
| NB | Le sanzioni RW possono essere ridotte se l’attività è stata oggetto di Voluntary Disclosure o collaborazione spontanea | — |
Come si vede, le sanzioni per il monitoraggio (RW) sono scollegate dall’entità del reddito e colpiscono il patrimonio estero non dichiarato; le sanzioni per dichiarazione infedele/omessa colpiscono invece l’imposta evasa. In generale, se ometti dei dividendi esteri dalla dichiarazione, ti verrà contestata almeno la sanzione per dichiarazione infedele pari al 90%–180% della maggiore imposta dovuta su quei dividendi (in assenza di intenti fraudolenti specifici). Se addirittura non hai presentato alcuna dichiarazione pur dovendo, si applica la sanzione più severa da omessa dichiarazione (120%–240% dell’imposta). Le sanzioni possono poi essere ridotte avvalendosi di procedure come il ravvedimento operoso, l’acquiescenza o la definizione agevolata, di cui diremo tra poco.
Accertamento fiscale: come il Fisco scopre i dividendi esteri e cosa può fare
Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria italiana ha potenziato i controlli sui redditi esteri dei residenti, complice l’entrata a regime dello scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati. Il Lussemburgo, in quanto paese UE aderente al Common Reporting Standard (CRS) e alle direttive comunitarie (DAC), trasmette all’Italia dati relativi a conti correnti, dividendi, interessi e altri redditi finanziari pagati a soggetti fiscali italiani . Ciò significa che se hai percepito dividendi su un conto in Lussemburgo, o da una società lussemburghese, è molto probabile che tali informazioni siano arrivate all’Agenzia delle Entrate (incluso l’ammontare, la tua identificazione, l’anno di pagamento, ecc.). Il meccanismo è analogo a quello già attivo per i conti svizzeri e di altri Paesi: le banche estere comunicano i dati alle autorità locali, che li inoltrano all’Italia tramite CRS/FATCA, e l’Agenzia li incrocia con le nostre banche dati.
Lettera di compliance (invito a regolarizzare). Quando emergono discrepanze tra i dati esteri ricevuti e la dichiarazione dei redditi presentata, l’Agenzia spesso invia una comunicazione bonaria, la cosiddetta lettera di compliance. In essa si segnala al contribuente che risultano, ad esempio, dividendi esteri non dichiarati, e lo si invita a fornire spiegazioni o a presentare una dichiarazione integrativa per regolarizzare . Questa fase è pre-accertamento: non è un atto impositivo formale, ma un’opportunità per sistemare le cose con sanzioni ridotte. Infatti, fintanto che non viene notificato un accertamento vero e proprio, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, versando le imposte dovute sui dividendi esteri con sanzioni significativamente ridotte (un decimo o un nono del minimo, a seconda del tempo trascorso) . È altamente consigliato rispondere alle lettere di compliance entro il termine indicato (di solito 30 giorni) , fornendo la documentazione richiesta (es. attestati delle ritenute subite in Lussemburgo) e, se necessario, presentando una dichiarazione integrativa per includere i dividendi. In molti casi, ciò evita l’emissione dell’avviso di accertamento e limita le sanzioni. Ignorare la lettera, invece, quasi certamente porterà all’accertamento d’ufficio e precluderà le riduzioni sanzionatorie, oltre a interrompere i termini di decadenza a sfavore del contribuente .
Avviso di accertamento analitico. Se il contribuente non si attiva spontaneamente, l’Ufficio può procedere con un vero e proprio avviso di accertamento, atto impositivo motivato in cui calcola le imposte evase sui redditi esteri e irroga le sanzioni. Nel caso di dividendi da Lussemburgo non dichiarati, l’accertamento analitico quantificherà con precisione l’importo dei dividendi percepiti (risultante dalle evidenze bancarie o dalle informazioni scambiate) e ricalcolerà le imposte italiane dovute su di essi, applicando le aliquote corrette (es. 26% se dovuto) e detraendo l’eventuale credito per imposte pagate all’estero, se documentato. Sul maggior imponibile verranno applicate le sanzioni amministrative descritte (tipicamente 90%–180% della maggiore imposta, se dichiarazione infedele) oltre agli interessi legali maturati . L’accertamento analitico richiede che l’Ufficio abbia elementi concreti: ad esempio copie di estratti conto esteri, o comunicazioni ufficiali dalle autorità lussemburghesi, che attestino il pagamento dei dividendi.
Accertamento sintetico (redditometrico). In alcuni casi, se non ci sono dati certi sui redditi esteri ma emergono indizi (es. ingenti spese sostenute in Italia incompatibili coi redditi noti), il Fisco può ricorrere a un accertamento sintetico (il cosiddetto “redditometro”). In questo metodo, il Fisco non determina specificamente i dividendi percepiti, ma assume che, dato il tuo tenore di vita/patrimonio, tu abbia avuto redditi non dichiarati di un certo ammontare. È una presunzione basata sulle spese sostenute (case, auto, investimenti). Se hai conti o ricchezze estere, l’accertamento sintetico può sommariamente imputarti un reddito “figurativo” per giustificare quelle disponibilità non spiegate . Ovviamente è una metodologia meno accurata, che viene spesso contestata nel merito, ma va citata come potenziale strumento usato dall’AE nei casi di evasione estera diffusa.
Garanzie procedurali e diritti del contribuente. In ogni caso, prima di emettere un avviso, l’Agenzia deve rispettare alcune fasi: se si tratta di un accertamento “parziale” su singoli redditi esteri, potrebbe inviarti un invito al contraddittorio (soprattutto dopo il 2020, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per gli accertamenti “non a tavolino”). Avrai modo di far pervenire osservazioni e documenti. Una volta emesso l’avviso, hai 60 giorni per pagarne le somme (eventualmente con sanzioni ridotte per adesione/acquiescenza) oppure per presentare ricorso. Il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) competente per territorio. Per importi fino a €50.000, il ricorso contiene anche un’istanza di reclamo/mediazione: l’ufficio può eventualmente annullare/ridurre l’atto in autotutela o proporre un accordo transattivo. In pendenza di ricorso, puoi chiedere al giudice la sospensione dell’atto se dal pagamento deriverebbe un danno grave e irreparabile. Durante tutto il procedimento, hai diritto di accesso agli atti, di difesa tecnica (avvocato o commercialista abilitato) e di vederti motivata compiutamente ogni pretesa fiscale.
Termini di accertamento. Le contestazioni sui redditi esteri devono rispettare precise finestre temporali. La legge (D.P.R. 600/1973, art.43, modificato dal DL 193/2016) fissa la decadenza dell’accertamento al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o dell’anno in cui la dichiarazione andava presentata, se omessa). Ad esempio, per dividendi 2019 non dichiarati (dichiarazione 2020 omessa o infedele), il termine ordinario di accertamento è il 31/12/2025. Se la dichiarazione fu presentata ma incompleta, il termine è di quattro anni successivi (ora cinque dopo la riforma 2016). In caso di omessa dichiarazione, il termine è più lungo: fino al 31 dicembre del settimo anno successivo (quindi 6 anni completi dopo l’anno d’imposta). In passato esisteva un raddoppio dei termini automatico per i redditi esteri non dichiarati, ma dal 2015 tale raddoppio è stato abolito salvo che intervenga una denuncia penale per reati fiscali entro i termini ordinari . Ciò significa che, se l’Agenzia intende avvalersi di tempi più lunghi, deve aver trasmesso entro il quinto (o settimo) anno una notizia di reato alla Procura (ad esempio per dichiarazione fraudolenta); in tal caso i termini si estendono di ulteriori 2 anni. In assenza di denuncia penale tempestiva, l’accertamento oltre i termini ordinari sarebbe nullo. È bene quindi controllare sempre la data di notifica dell’atto e l’anno d’imposta contestato: se l’atto arriva fuori termine, va fatto valere nel ricorso come motivo di annullamento.
Difendersi nell’accertamento: strategie e strumenti. Dal momento in cui ricevi una contestazione (compliance o avviso), è cruciale adottare un approccio proattivo e documentato. Di seguito i principali strumenti deflattivi del contenzioso e difensivi a disposizione del contribuente:
- Autotutela e istruttoria con l’Ufficio: già in sede di contraddittorio o risposta a inviti, puoi fornire all’Agenzia chiarimenti e prove. Ad esempio, se dimostri di aver già sanato spontaneamente l’irregolarità prima dell’accertamento (con dichiarazione integrativa e pagamento), l’avviso può essere annullato in autotutela . Oppure se emerge un errore palese (e.g. non eri residente in Italia quell’anno, o il dividendo non era imponibile), puoi presentare un’istanza motivata chiedendo l’annullamento/revoca dell’atto in via di autotutela. L’Ufficio ha facoltà di accogliere l’istanza se riconosce l’errore, sebbene non sia obbligato.
- Ravvedimento operoso: se l’accertamento non è ancora stato notificato (magari sei ancora alla fase della compliance), puoi regolarizzare pagando il dovuto con sanzioni ridotte. Il ravvedimento operoso ordinario (art.13 D.Lgs. 472/1997) consente, ad esempio, di pagare una sanzione pari a 1/8 o 1/5 di quella minima se ci si ravvede con qualche anno di ritardo. Nel caso dei dividendi esteri non dichiarati, però, c’è un ostacolo: la sanzione RW per quadro omesso, secondo l’Agenzia, non è ravvedibile se non si presenta contestualmente una dichiarazione tardiva (difficile a distanza di anni) . Ci si può comunque ravvedere sul mancato pagamento dell’IVAFE/IVIE (imposte patrimoniali estere) e sui redditi non dichiarati, riducendo le relative sanzioni. In sintesi, prima arriva la contestazione, più alto è il rischio di dover pagare sanzioni piene; muoversi prima con ravvedimento limita i danni.
- Accertamento con adesione: dopo aver ricevuto un avviso, puoi chiedere entro 30 giorni un colloquio (“istanza di adesione”) per cercare un accordo con l’Ufficio (D.Lgs. 218/1997). L’adesione consente di discutere l’an e il quantum: ad esempio, potresti far valere il credito per imposte lussemburghesi non considerato inizialmente, o contestare parzialmente l’importo dei dividendi. Se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto di adesione con le somme dovute concordate. I vantaggi: la sanzione viene ridotta a 1/3 del minimo (in luogo della misura piena) , e puoi rateizzare fino a 8 rate trimestrali. L’adesione evita il contenzioso e chiude ogni pendenza per quell’anno e materia. Va valutata quando la pretesa è fondata ma si vuole mitigare l’impatto sanzionatorio.
- Acquiescenza e definizione agevolata: se non vuoi impugnare l’accertamento e intendi pagare, hai comunque diritto a una riduzione delle sanzioni a 1/3 applicando l’acquiescenza (art.15 D.Lgs. 218/97). Occorre pagare (o iniziare a pagare in rate) entro 60 giorni dalla notifica. In alternativa, il legislatore spesso introduce misure di “tregua fiscale”: ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto un ravvedimento speciale per le violazioni fino al 2021, con sanzioni ridotte a 1/18, pagabili in 8 rate trimestrali . Questa misura straordinaria (una sorta di voluntary disclosure interna) è scaduta il 31 maggio 2024 per presentare le dichiarazioni integrative speciali. Ha consentito di sanare anche omissioni RW e IVIE/IVAFE con sanzioni ultraridotte (1/18 del minimo) . Purtroppo, dopo quella data non vi sono (ad agosto 2025) ulteriori condoni aperti per redditi esteri; quindi resta solo la via ordinaria (ravvedimento o adesione). Tieni presente che la voluntary disclosure internazionale in senso proprio (quella del 2015-2017) non è più ripetibile, ma chi vi ha aderito gode di benefici penali e fiscali: ad esempio, la voluntary del 2015 azzerava le sanzioni penali e applicava sanzioni amministrative molto ridotte (3% sul capitale emerso più imposte). Chiuse quelle finestre, oggi eventuali nuove misure dipendono da scelte legislative future.
- Reclamo e Mediazione tributaria: per importi non eccedenti €50.000 di tributo, il ricorso in Commissione (ora Corte di Giustizia Tributaria) contiene anche un reclamo. L’Agenzia, ricevuto il reclamo, può accoglierlo in toto annullando l’atto, oppure formulare una proposta di mediazione con riduzione delle sanzioni (fino al 50%). Se il contribuente accetta la mediazione, la lite si chiude. Dal 2023 la mediazione tributaria è stata potenziata (L. 130/2022) estendendone l’ambito e rendendo la procedura più snella: l’accordo di mediazione comporta sanzioni dimezzate e pagamento in 20 rate trimestrali. È una strada da tentare quando ci sono elementi equitativi da far valere (es. buona fede, incertezza normativa) e importi non troppo elevati.
- Ricorso e contenzioso: se non si giunge a un accordo, si procede col giudizio tributario. Nel ricorso scritto dovrai articolare motivi di impugnazione: ad esempio, (i) difetto di residenza fiscale italiana in quell’anno; (ii) violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni; (iii) omesso riconoscimento del credito d’imposta estero; (iv) decadenza dei termini; (v) errore sul fatto (i dividendi non erano redditi tassabili); (vi) sproporzione o duplicazione di sanzioni, ecc. È fondamentale supportare ogni argomento con documenti (attestati fiscali esteri, certificati di residenza, estratti conto, copie delle dichiarazioni estere, giurisprudenza di Cassazione pertinente). Il giudice tributario valuterà sia la legittimità formale dell’atto che il merito della pretesa fiscale. In caso di soccombenza in primo grado, si può appellare in secondo grado (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, ex CTR) e poi eventualmente in Cassazione. Il contenzioso può durare anni, dunque spesso conviene cercare soluzioni transattive nelle prime fasi se la posizione non è solidissima. Viceversa, se si hanno buone prove (es. status di non residente, o pagamento già effettuato all’estero) vale la pena insistere nel far valere i propri diritti fino in fondo.
Profili penali: omessa dichiarazione, reati fiscali e autoriciclaggio
La vicenda dei dividendi esteri non dichiarati può comportare, oltre alle sanzioni tributarie, anche conseguenze penali tributarie per il contribuente, qualora ricorrano certe condizioni di gravità previste dal D.Lgs. 74/2000. Vediamo i reati potenzialmente configurabili e le relative soglie:
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): si verifica se il contribuente, obbligato a presentare la dichiarazione annuale dei redditi, non lo fa affatto, con imposta evasa superiore a €50.000. In uno scenario di dividendi esteri non dichiarati, questo reato potrebbe configurarsi se nessuna dichiarazione è stata presentata in Italia per quell’anno e le imposte evase sui redditi (non solo i dividendi) superano la soglia. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 4 anni . Ad esempio, un contribuente che nel 2022 ha percepito €200.000 di dividendi in Lussemburgo (evadendo circa €52.000 di IRPEF) e non ha presentato la dichiarazione 2023 in Italia, rischia l’imputazione per omessa dichiarazione.
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): è il reato di chi presenta la dichiarazione omettendo elementi attivi di reddito o indicando elementi passivi fittizi, superando specifiche soglie: imposta evasa > €100.000 e elementi non dichiarati > 10% del totale dichiarato (o comunque > €2 milioni). Se un contribuente ha presentato la dichiarazione includendo magari alcuni redditi italiani ma tralasciando grandi dividendi esteri, può integrarsi questo reato. La pena va da 2 anni a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Nel nostro contesto, potrebbe accadere per importi molto elevati di dividendi non dichiarati. Ad esempio, se in dichiarazione risultavano €10.000 di imposta dovuta ma in realtà altri €150.000 erano evasi per via di dividendi occultati, la soglia penale è superata. Da notare che l’intento di evasione è presunto dal superamento delle soglie, non occorre provare ulteriori artifici fraudolenti (a differenza degli articoli 2 e 3 sui falsi documentali).
- Dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000): ipotesi più gravi in cui si usano mezzi fraudolenti per evadere (fatture false, artifizi contabili). Nel caso dei dividendi esteri, potrebbe configurarsi se il contribuente ha messo in atto artifici per occultarli, ad esempio schermandoli con società esterovestite o documentazione fittizia. La soglia di punibilità è più bassa (imposta evasa > €30.000 per l’art.3) ma deve esserci un dolo specifico con mezzi fraudolenti. La pena è più alta (fino a 6 anni). Questi casi sfumano nelle situazioni di pianificazione fiscale illecita (es. trust simulati, conti cifrati non dichiarati, ecc.) che vediamo tra poco.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): reato diverso dai precedenti, perché riguarda il momento della riscossione. Si ha quando, dopo aver accumulato un debito fiscale, il contribuente compie atti simulati o fraudolenti per rendersi insolvente verso il Fisco (ad es., aliena beni a prestanome, svuota conti, trasferisce patrimoni a un trust fittizio, ecc.). La Cassazione ha chiarito che la sola costituzione di un trust o l’omessa compilazione del quadro RW, di per sé, non bastano a integrare questo reato in assenza di un formale accertamento e di atti concreti di sottrazione patrimoniale . In altre parole, fino a che l’imposta evasa sui dividendi non è accertata e il contribuente non compie operazioni per evitare di pagarla, non c’è reato ex art.11. Però se, ad esempio, una volta ricevuto il PVC o l’accertamento, il contribuente trasferisce tutti i soldi su conti impignorabili o li esporta, allora potrebbe configurarsi sottrazione fraudolenta. Anche intestare le proprie partecipazioni a un trust subito prima che parta la riscossione coattiva può essere letto come atto fraudolento (e spesso il Fisco agisce in via revocatoria per far dichiarare inefficace quel trasferimento di beni).
- Reimpiego di proventi illeciti / autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): l’autoriciclaggio è un reato introdotto dal 2015, che punisce chi impiega, trasferisce, o ostacola l’identificazione di denaro proveniente da un proprio reato al fine di “ripulirlo”. L’evasione fiscale non dichiarativa (omessa/infedele) non era originariamente considerata reato presupposto di riciclaggio, ma oramai la giurisprudenza tende a ricomprendere le somme evase tra i proventi illeciti rilevanti se accompagnate da comportamenti decettivi. Per esempio, se i dividendi non dichiarati venissero occultati tramite conti cifrati, o reinvestiti in attività economiche per mascherarne la provenienza, ciò potrebbe far scattare l’autoriciclaggio. Un caso tipico: il contribuente crea una società estera o un trust in Lussemburgo e vi canalizza i dividendi evasi, poi rimpatria i fondi come “prestito” o altro; questo schema può integrare autoriciclaggio. La pena prevista va da 2 a 8 anni di reclusione (variabile con l’entità) e pesanti multe. Da notare che l’autoriciclaggio non si applica se il denaro viene semplicemente tenuto nascosto (mero godimento personale dei proventi): serve un’attività successiva di impiego in operazioni economiche atte a ostacolare la tracciabilità. Anche per questo reato la soglia di punibilità dell’evasione sottostante gioca un ruolo: solitamente viene contestato insieme a reati tributari rilevanti (frodi IVA, false fatture, ecc.). Nel contesto dei dividendi lussemburghesi, potrebbe emergere in casi estremi di elaborate manovre di occultamento internazionale.
- Responsabilità amministrativa dell’ente (D.Lgs. 231/2001): se il contribuente coinvolto è una società, occorre menzionare che dal 2019 anche alcuni reati fiscali (tra cui la dichiarazione fraudolenta e l’omessa dichiarazione) possono attivare la responsabilità dell’ente. Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, infatti, l’azienda può essere sanzionata (multe, interdittive) se un suo dirigente o dipendente commette reati tributari nell’interesse o vantaggio della società e questa era priva di modelli organizzativi idonei a prevenirli . Dunque, se parliamo di una società italiana che non ha dichiarato dividendi provenienti da una controllata lussemburghese (magari per mantenere liquidità offshore), gli amministratori rischiano il reato di dichiarazione infedele, e la società stessa rischia sanzioni 231. Ciò rende ancora più importante, per imprese con operatività internazionale, dotarsi di procedure di compliance fiscale e monitoraggio dei flussi esteri.
Da ricordare: la voluntary disclosure o il ravvedimento integrale delle imposte prima che il reato sia scoperto possono escludere la punibilità. In base all’art. 13 D.Lgs. 74/2000, il pagamento di tutti i debiti tributari (imposta, sanzioni amministrative e interessi) prima che l’autore del reato abbia formale conoscenza di indagini a suo carico, estingue i reati di omessa e infedele dichiarazione. Dunque, se un contribuente – anche dopo aver ricevuto la lettera di compliance ma prima che parta la denuncia penale – versa tutto il dovuto sui dividendi esteri, non potrà più essere punito per quei reati (resteranno le sole sanzioni amministrative). Le procedure di collaborazione volontaria del 2015-2017 prevedevano espressamente l’esclusione dei reati dichiarativi e di riciclaggio per i partecipanti. Anche la nuova regolarizzazione 2023, pur non offrendo un condono penale automatico, di fatto evita l’insorgere di una notizia criminis se completata con successo (non essendoci più evasione dopo il pagamento). In ogni caso, è fondamentale affrontare tempestivamente la situazione: ignorare a lungo i rilievi o perseverare nell’occultamento aumenta il rischio di escalation penale, mentre attivarsi per regolarizzare o difendersi con trasparenza può circoscrivere la vicenda all’ambito tributario amministrativo.
Società estere, esterovestizione e trust lussemburghesi: focus su figure giuridiche correlate
Spesso i dividendi esteri non dichiarati non provengono da investimenti personali diretti, ma da strutture societarie o fiduciarie estere create ad hoc: holding, società controllate, trust familiari, fondazioni, ecc. Vediamo alcuni scenari tipici riguardanti il Lussemburgo e il loro trattamento fiscale/difensivo:
1. Società di diritto lussemburghese controllata da residente italiano. Il Lussemburgo è noto per ospitare holding e sub-holding di gruppi societari. Un imprenditore italiano può aver costituito (o ereditato) una S.à r.l. in Lussemburgo che detiene partecipazioni o asset; i dividendi distribuiti da tale società al proprietario italiano andavano comunque dichiarati in Italia. L’omessa dichiarazione di tali dividendi comporta gli effetti già descritti. Ma c’è di più: l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la “esterovestizione” della società lussemburghese, ossia sostenere che essa era di fatto residente in Italia (per sede di direzione effettiva) e usata al solo scopo di delocalizzare profitti. La Cassazione ha ripetutamente affermato che, se il centro decisionale di una società estera è in Italia, la società è considerata fiscalmente residente in Italia . Ciò comporterebbe che tutti gli utili della società lussemburghese andavano tassati in Italia (anche se non distribuiti). È uno scenario ancora più grave per il contribuente: oltre ai dividendi non dichiarati, il Fisco pretenderebbe le imposte sull’intero utile societario come se la società fosse italiana. In difesa, andrebbe provato che la società aveva una reale sostanza economica in Lussemburgo (uffici, dirigenti locali, autonomia decisionale) e non era una scatola vuota. In mancanza, l’esterovestizione può essere confermata e allora la contestazione da semplice omessa dichiarazione di dividendi si trasforma in una tassazione integrale per trasparenza.
2. Dividendi esteri in capo a società italiane (partecipation exemption). Se il contribuente non è persona fisica ma una società italiana che ha ricevuto dividendi da una controllata lussemburghese e non li ha dichiarati, la questione fiscale può essere diversa. Le società di capitali italiane beneficiano, per i dividendi da partecipazioni qualificate, della cosiddetta participation exemption: il 95% del dividendo estero è esente da tassazione IRES, a certe condizioni (art. 89 TUIR). Quindi dichiarare il dividendo avrebbe comportato una tassazione solo sul 5% (aliquota effettiva circa 1.2%). Talvolta però si verificano controversie sull’applicabilità dell’esenzione (ad es. se la società estera era black list o non rispettava il requisito della commercialità). Se una S.p.A. italiana ha omesso di indicare dividendi esteri pensando fossero integralmente esenti, l’Agenzia potrebbe invece tassarli pienamente (se ritiene non spettante l’esenzione) con aliquota 24% sul 100%. Anche senza intenti fraudolenti, è dichiarazione infedele. La difesa consisterà nel dimostrare che la participation exemption era applicabile (es. la società lussemburghese non era di mero investimento passivo o non era paradisiaca). In ogni caso, l’azienda dovrà probabilmente pagare il 5% o 100% a seconda dell’esito, ma potrebbe far valere il credito d’imposta per eventuali ritenute subite in Lussemburgo sul dividendo (le convenzioni spesso riducono la ritenuta a 0% per dividendi a società, in presenza di holding EU che soddisfano la direttiva madre-figlia). Un’altra argomentazione difensiva, che però non incide sulle sanzioni, è la seguente: “il dividendo estero era già stato tassato sugli utili societari esteri, quindi tassarlo di nuovo è doppia imposizione economica”. Purtroppo, l’art. 165, co.8 TUIR esplicitamente chiarisce che le sanzioni non sono eliminate dalla circostanza che vi sia già stata tassazione estera . Quindi, l’azienda può chiedere di evitare la doppia imposta (col credito), ma non di evitare la sanzione per l’omessa dichiarazione: aver pagato all’estero non giustifica la mancata indicazione in Italia. Più proficuo sarà, per la società, valutare l’adesione o altre definizioni per ridurre almeno le sanzioni pecuniarie e chiudere il caso rapidamente.
3. Trust lussemburghese con beneficiario/disponente italiano. I trust di diritto lussemburghese (spesso assimilabili ai trust anglosassoni, data la Convenzione dell’Aja 1985) possono essere utilizzati per detenzione di partecipazioni e distribuzione di utili. Se un contribuente italiano trasferisce le proprie azioni a un trust estero “opaco” (ossia senza imputazione di redditi ai beneficiari) sperando di schermare i dividendi, l’Agenzia delle Entrate può contestare una interposizione fittizia. In altri termini, sostiene che il trust è un mero schermo e che i redditi in realtà vanno attribuiti al disponente o al beneficiario italiano. La normativa italiana (art. 37, co.3 D.P.R. 600/1973) consente di ignorare l’interposta persona se il controllo sostanziale dei beni resta al contribuente. E la giurisprudenza recente lo ha applicato spesso ai trust: la Cassazione n.9096/2025 ha affermato che trasferire azioni a un trust estero mantenendone il controllo di fatto implica che i redditi (dividendi, plusvalenze) restano imponibili in capo al disponente . Analogamente, la Cass. n.9445/2025 ha ribadito che conta la realtà effettiva: se il settlor impartisce istruzioni al trustee o sussiste coincidenza di ruoli, il trust viene considerato inesistente ai fini fiscali e tutti gli obblighi dichiarativi (RW incluso) e reddituali ricadono sul contribuente . Dunque, nel nostro caso, Giovanni che ha creato un trust in Lussemburgo e non dichiara i dividendi delle sue azioni ivi conferite, si vedrà contestare che quel trust è fittizio e gli utili andavano dichiarati come suoi redditi personali . Il risultato: imposizione piena in Italia di dividendi e plusvalenze, sanzioni amministrative (anche RW 6–30% sul valore delle partecipazioni occultate) e, se le cifre sono alte, anche responsabilità penale per dichiarazione infedele/autoriciclaggio. La difesa in tali situazioni è complessa: occorre provare la genuinità del trust, ossia che fu istituito per ragioni reali (es. passaggio generazionale, tutela patrimoniale) e gestito in autonomia dal trustee senza ingerenze del disponente. Se il trust è genuino e residente all’estero in paese non black list (Lux è cooperativo), allora le distribuzioni ai beneficiari potrebbero non essere imponibili in Italia come reddito (ma semmai soggette a imposta di donazione). Anzi, la normativa (art. 44 TUIR, lett. g-sexies) prevede che solo i trust opachi in Paesi a regime fiscale privilegiato fanno tassare i beneficiari sulle somme ricevute . Un trust opaco lussemburghese, se reale, non comporterebbe tassazione diretta in capo ai beneficiari italiani (lo sottolinea anche la Circolare AE 34/E/2022). Tuttavia, provare l’autenticità è arduo se il disponente/beneficiario aveva ancora potere sui beni. In pratica, la strategia difensiva qui può percorrere due vie alternative: (a) accettare la riqualificazione (trust fittizio) ma allora cercare un accordo sull’accertamento (magari con adesione, evitando il penale) per definire l’evasione; oppure (b) contestare la riqualificazione portando evidenze dell’indipendenza del trust (es. verbali del trustee, discrezionalità effettiva, investimenti fatti a vantaggio di altri beneficiari, ecc.). La seconda via, se credibile, potrebbe portare a escludere la tassazione dei dividendi in capo alla persona (vincendo sul piano giuridico), ma resta un percorso incerto. Molti casi recenti mostrano che i giudici tendono a smascherare i trust costituiti con finalità elusive (soprattutto se creati post-factum, in prossimità di accertamenti).
4. Altri veicoli: fondi d’investimento esteri, polizze e fiduciaria statica. Un individuo potrebbe aver ricevuto “dividendi” tramite strumenti alternativi: ad esempio investendo in un fondo comune lussemburghese (SICAV) o in una polizza assicurativa estera con sottostanti titoli che generano utili. In tali casi, la fiscalità italiana prevede regimi differenti: i proventi di fondi UE armonizzati sono tassati tramite una ritenuta italiana al realizzo, mentre le polizze fino a scadenza differiscono la tassazione. Se però il contribuente ha investito direttamente via banca estera senza dichiarare nulla, l’Agenzia può contestare sia i redditi di capitale non dichiarati sia l’omesso RW. Un caso particolare: l’uso di una società fiduciaria estera (o nominee). Se i dividendi erano formalmente percepiti da una fiduciaria lussemburghese per conto dell’italiano, dal punto di vista italiano il titolare effettivo era comunque quest’ultimo, con obbligo di dichiarazione. Lo standard antiriciclaggio vigente (D.Lgs. 231/2007) e il CRS puntano proprio a far emergere i titolari effettivi dietro fiduciari e trust. Quindi difendersi dicendo “il dividendo l’ha incassato la fiduciaria X” non esime affatto dall’imposizione: occorre dichiarare lo stesso (caso analogo ai trust).
In sintesi, strutture societarie o fiduciarie estere non dichiarate aggiungono complessità alle contestazioni. Il contribuente deve essere pronto a fronteggiare non solo il recupero d’imposta sul dividendo, ma anche possibili riqualificazioni aggressive del Fisco (esterovestizione, CFC, interposizione fittizia) che ampliano la base imponibile. La cooperazione volontaria in questi casi è spesso la soluzione meno rischiosa: ad esempio aderire a un accertamento con adesione su dividendi di una società estera potrebbe evitare al Fisco di approfondire ulteriormente e contestare l’esterovestizione dell’intera società (ciò va valutato strategicamente con l’avvocato). Se invece si ritiene di aver ragione (ad es. società realmente lussemburghese o trust valido), allora la controversia verterà su questioni di diritto internazionale e prove documentali, con prevedibile necessità di arrivare in giudizio e magari fino in Cassazione per vedere riconosciute le proprie ragioni.
Simulazioni pratiche: casi ed esempi di difesa
Vediamo ora alcuni casi pratici (ipotetici ma basati su situazioni frequenti) per capire l’impatto concreto delle norme e come ci si può difendere:
Caso 1: “Piccoli dividendi esteri non dichiarati, rimediabili con ravvedimento”. Mario, residente in Italia, possiede un piccolo portafoglio titoli in Lussemburgo dal quale nel 2023 ha percepito €2.000 di dividendi. Non avendo intermediari italiani, avrebbe dovuto inserirli nel quadro RM della sua dichiarazione 2024 e pagarci il 26%, ma se ne è dimenticato. Nel 2025 riceve una lettera di compliance che segnala tali redditi esteri non dichiarati. Mario, prudente, non ignora la lettera: presenta subito una dichiarazione integrativa per il 2023 includendo i €2.000, paga la relativa imposta (€520) e una sanzione ridotta per ravvedimento (1/8 del 90%, ossia 11.25% = €58.5, invece di €52090%=€468) più gli interessi di mora nominali. L’Agenzia, ricevuta la prova dell’integrativa e del pagamento, archivia la posizione senza emettere accertamento. Mario inoltre compila il quadro RW per il conto titoli (il valore modesto gli comporta semmai una sanzione simbolica ravveduta). Morale:* per importi modesti e prima che scatti l’accertamento, conviene sanare subito, beneficiando del ravvedimento e della clemenza dell’Ufficio.
Caso 2: “Dividendi esteri significativi su più anni, società italiana sotto accertamento”. La S.r.l. Alfa (italiana) detiene due partecipazioni in società estere e tra il 2019 e il 2021 ha incassato dividendi per €50.000, che l’amministratore ha ritenuto non imponibili (in realtà lo erano al 5%, ma per errore non li hanno dichiarati affatto). Nel 2025 un’indagine finanziaria sui conti esteri rivela gli accrediti. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento recuperando l’IRES dovuta sul 5% di quei dividendi e (ritenendo non spettante l’esenzione) anche sull’intero importo, con imposta circa €12.000. A ciò aggiunge sanzioni da dichiarazione infedele pari al 100% dell’imposta evasa (€12.000) e interessi. La società Alfa contesta che così si ha doppia tassazione, perché quei utili erano già tassati all’estero sugli utili societari; ma, come detto, ciò non evita l’imposizione italiana né le sanzioni (l’Agenzia cita l’art.165 co.8 TUIR) . Allora Alfa valuta due strade: (a) presentare ricorso chiedendo almeno l’applicazione del credito per eventuali ritenute estere subite (che l’ufficio non aveva considerato) e sostenendo la buona fede (forse il commercialista aveva male interpretato la legge); (b) aderire all’accertamento, ottenendo il terzo delle sanzioni, e chiudere la vicenda. Dato che c’è un rischio penale (l’imposta evasa totale supera €50k sommando tre anni, potenzialmente configurando dichiarazione infedele continuata), l’amministratore propende per l’adesione: versa il dovuto con sanzione ridotta (€4.000), evitando di esporre la società a un procedimento penale e a ulteriori costi di lite. Morale: per le aziende, spesso l’accordo è preferibile, soprattutto se il contenzioso potrebbe portare alla scoperta di maggiori evasioni (qui l’ufficio avrebbe potuto approfondire e contestare anche altre annualità).
Caso 3: “Trust estero e utili occultati – contestazione e onere della prova”. Giovanni, facoltoso imprenditore italiano, nel 2018 ha istituito un trust in Lussemburgo trasferendovi il 100% delle quote di una sua S.p.A. italiana. Formalmente, quindi, dal 2019 i dividendi della S.p.A. sono percepiti dal trust lussemburghese e reinvestiti all’estero. Giovanni non indica nulla in RW né dichiara redditi, sostenendo che quei dividendi non sono suoi ma del trust. Nel 2025 la Guardia di Finanza conclude un controllo accertando che Giovanni inviava istruzioni al trustee e usava i soldi del trust per fini personali (acquisto di immobili tramite società controllate dal trust, ecc.). L’Agenzia riqualifica il tutto come interposizione fittizia: il trust è ignorato e gli utili della S.p.A. dal 2019 in poi (pari a €5 milioni) sono imputati a Giovanni. Gli viene contestato il mancato pagamento di IRPEF su tali utili (aliquota 43% su €5M = €2,15M di imposta evasa), sanzioni per dichiarazione infedele aggravata (120% dell’imposta) e omesso RW su un patrimonio di vari milioni (sanzione 6-30% annuo, data la struttura societaria estera potenzialmente black-list). Inoltre, scatta la denuncia penale per infedele dichiarazione (superate di gran lunga le soglie) e forse per sottrazione fraudolenta (per aver schermato l’incasso tramite trust) e autoriciclaggio. In sede di ricorso, Giovanni prova a difendersi sostenendo che il trust era legittimo e che non si trattava di redditi suoi; ma le prove contro di lui (email, bonifici verso conti personali) sono schiaccianti. La Corte di Giustizia Tributaria conferma l’imputazione a lui dei redditi, citando la giurisprudenza di Cassazione sulle interposizioni fittizie . Giovanni a questo punto decide di patteggiare sul penale versando tutte le somme evase più una pena concordata ridotta. Morale: utilizzare trust opachi esteri per occultare utili propri è una strategia altamente rischiosa; se smascherata, le conseguenze economiche e penali sono severissime. L’onere di provare la sostanza economica ricade su chi ha scelto di usare il trust, e se non si dispone di evidenze molto forti d’indipendenza, difficilmente si vince su questo terreno.
Caso 4: “Residenza contestata e convenzione: vittoria del contribuente.” Chiudiamo con un caso positivo per il contribuente. Luigi, cittadino italiano, si trasferisce a Lussemburgo nel 2021 per lavoro, si iscrive all’AIRE e lì acquista casa. Mantiene però una piccola casa di proprietà in Italia dove risiede la compagna. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate gli notifica un accertamento per redditi 2022 sostenendo che era ancora residente in Italia (dato che aveva l’immobile e la compagna in Italia) e che non ha dichiarato €30.000 di dividendi su investimenti lussemburghesi. Luigi fa ricorso producendo la documentazione: contratto di lavoro a Lussemburgo, bollette e mutuo sulla casa lussemburghese, certificato di residenza fiscale emesso dall’administration des contributions luxemburghese, iscrizione AIRE, dichiarazione dei redditi presentata in Lussemburgo per il 2022. Sostiene quindi, in base alla Convenzione, di essere residente solo in Lussemburgo nel 2022, avendo lì l’abitazione permanente e il centro degli interessi (il lavoro altamente remunerato, mentre in Italia c’era solo la compagna con redditi propri). La Commissione Tributaria (oggi Corte) applica i criteri convenzionali tie-breaker e gli dà ragione: Luigi era residente lussemburghese nel 2022, pertanto l’Italia non può tassare i suoi redditi esteri . L’accertamento viene annullato integralmente. Morale: se realmente si è trasferita la residenza all’estero, è fondamentale tenere documenti probatori e non farsi scoraggiare da contestazioni iniziali del Fisco: i trattati internazionali prevalgono e proteggono chi rispetta le regole.
Domande frequenti (FAQ)
D: Quanto tempo ho per rispondere a una lettera di compliance o a un invito dell’Agenzia?
R: Tipicamente 30 giorni dalla ricezione. È importante non far scadere il termine: rispondere tempestivamente, magari chiedendo una breve proroga se servono documenti dal estero, mostra cooperazione e può evitare che l’Agenzia emetta subito un avviso formale . Se servono più di 30 giorni per reperire documenti (es. certificati dal Lussemburgo), si può provare a contattare l’ufficio e richiedere un’estensione, che a volte viene concessa.
D: La voluntary disclosure 2023/24 è ancora accessibile se voglio regolarizzare ora?
R: No, la finestra straordinaria prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (cosiddetto ravvedimento speciale con sanzioni 1/18) si è chiusa il 31 maggio 2024 . Dopo tale data non ci sono programmi di regolarizzazione di massa per i capitali esteri. Puoi comunque utilizzare il ravvedimento operoso ordinario (con sanzioni ridotte ma più elevate rispetto a 1/18) o tentare un accordo via accertamento con adesione se sei già stato intercettato. In futuro, tieni d’occhio eventuali nuove iniziative legislative perché periodicamente vengono varate (ma non sono garantite).
D: Se ignoro l’accertamento cosa succede?
R: Non devi ignorarlo. Trascorsi 60 giorni senza impugnazione né pagamento, l’accertamento diventa definitivo . L’importo verrà iscritto a ruolo e l’Agente della Riscossione (AdER) potrà procedere a misure esecutive: fermo amministrativo auto, pignoramento conti, stipendi, ipoteca su immobili, ecc. Inoltre, non avendo contestato nulla, perderai la chance di far valere in sede giudiziaria eventuali tue ragioni (es. credito d’imposta, residenza estera). Ignorare anche solo la lettera di compliance è sconsigliato: come detto, il silenzio spesso spinge il Fisco ad aggravare la posizione, mentre una risposta collaborativa può portare a soluzioni più miti .
D: C’è una soglia minima di dividendi esteri sotto cui non serve dichiarare?
R: No. Per i redditi esteri, anche pochi euro andrebbero teoricamente dichiarati. Non esiste una “franchigia” generale. L’unica soglia riguarda l’obbligo di monitoraggio per conti correnti con giacenze medie sotto €5.000 (e saldi < €15.000): in quel caso se il conto non produce redditi (interessi), si può omettere RW . Ma i dividendi stessi, anche se piccoli, sono redditi di capitale e come tali andrebbero indicati nel quadro RM e tassati. È vero che importi minimi spesso non generano accertamenti per ragioni di economicità (il Fisco non spreca risorse per recuperare poche decine di euro), ma formalmente l’obbligo sussiste sempre.
D: Ho pagato già il 15% di tassa in Lussemburgo sui dividendi: posso evitare di pagare in Italia?
R: Devi comunque dichiararli in Italia. Ciò che puoi fare, e devi fare in dichiarazione, è calcolare il credito d’imposta per la ritenuta estera del 15% . In pratica versi in Italia solo l’eventuale differenza. Ad esempio, se sei un privato soggetto al 26%, pagherai un altro 11% in Italia (26 – 15). Se sei una società con dividendi esenti al 95%, pagherai un’aliquota effettiva dell’1.2% in Italia e quel poco sarà probabilmente azzerato dal credito (perché in Lux hai già pagato 15% sull’intero importo, che supera l’1.2% sul totale). Non puoi ottenere il rimborso dell’eccedenza estera se la tassa estera è più alta di quella italiana su quel reddito (la Convenzione prevede solo il credito fino a concorrenza). Dunque, se hai pagato 15% estero e in Italia quel reddito sarebbe tassato 15% o meno, non avrai rimborso del surplus. In sintesi: dichiara sempre il reddito estero e indicane la relativa imposta estera pagata, così otterrai il credito ed eviterai doppia imposizione.
D: Quali rischi penali corro effettivamente per i dividendi non dichiarati?
R: Dipende dall’ammontare e dalla condotta. Se i dividendi erano di entità modesta (e l’imposta evasa < €50.000 annui), in genere nessuno: l’illecito rimane amministrativo . La maggior parte delle persone che dimenticano di dichiarare qualche migliaio di euro all’estero non sarà perseguita penalmente. Il rischio penale sorge per somme importanti: se l’imposta evasa supera €50.000 in un anno e non hai presentato la dichiarazione, scatta il reato di omessa dichiarazione; sopra €100.000 evasi (e altri criteri) scatta la dichiarazione infedele. Inoltre, se hai compiuto manovre fraudolente (documenti falsi, trust finti) potresti incorrere in reati più gravi. L’autoriciclaggio entra in gioco solo per comportamenti di reimpiego sofisticati dei fondi evasi. Quindi, realisticamente, il contribuente medio con dividendi non dichiarati corre sanzioni pecuniarie, ma non il carcere – a meno che le cifre non siano ingenti o non emergano condotte dolose evidenti. In caso di dubbio sulla tua posizione, è prudente valutare una regolarizzazione anticipata: se sistemi tutto prima che partano indagini, hai la certezza di non subire conseguenze penali (grazie all’art.13 D.Lgs.74/2000 sulla non punibilità a pagamento effettuato).
D: In conclusione, cosa devo fare se ricevo un accertamento per dividendi esteri non dichiarati?
R: Analizza la situazione con calma e fatti consigliare da un esperto. Verifica innanzitutto se eri effettivamente tenuto a dichiarare (esamina residenza fiscale e Convenzioni). Poi raccogli la documentazione: importi dei dividendi, imposte pagate all’estero, eventuali errori commessi in buona fede. Prepara una strategia: rispondere subito se sei in fase di invito, oppure presentare ricorso se l’accertamento è infondato o eccessivo. Considera anche soluzioni transattive (adesione, mediazione) per chiudere con sanzioni ridotte. Ogni caso è a sé: se la legge è dalla tua parte (es. residenza estera comprovata) punta sul contenzioso; se hai effettivamente evaso ma vuoi evitare guai peggiori, meglio negoziare il dovuto col Fisco. In tutte le fasi, non sottovalutare gli aspetti formali (termini, notifiche regolari, motivazione dell’atto) perché anche lì si trovano talvolta vizi che possono annullare l’accertamento. Infine, una volta risolta la contestazione, assicurati per il futuro di dichiarare correttamente i redditi esteri e di compilare il quadro RW: l’esperienza insegna che il monitoraggio fiscale internazionale è ormai capillare e le probabilità di essere scoperti in caso di omissione sono altissime.
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestata la mancata dichiarazione di dividendi provenienti dal Lussemburgo? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestata la mancata dichiarazione di dividendi provenienti dal Lussemburgo?
Vuoi sapere quali sono i rischi e come impostare la difesa?
👉 Prima regola: chiarisci se i dividendi sono già stati tassati alla fonte in Lussemburgo e dimostra il corretto trattamento fiscale previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Dividendi incassati tramite banche o intermediari esteri non dichiarati nel quadro RW e nel quadro RL della dichiarazione dei redditi;
- Omissione della tassazione sostitutiva o IRPEF sui dividendi percepiti;
- Dividendi da società lussemburghesi imputati come redditi di capitale in Italia senza prova dell’avvenuta ritenuta estera;
- Mancata compilazione del quadro RW per il monitoraggio delle partecipazioni;
- Disallineamenti tra dati trasmessi da istituti esteri (scambio automatico CRS) e dichiarazione italiana.
📌 Conseguenze della contestazione
- Recupero delle imposte non versate su dividendi esteri;
- Applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione e per omessa compilazione del quadro RW;
- Interessi di mora sulle somme dovute;
- Rischio di contestazioni penali per omessa dichiarazione di redditi esteri di importo rilevante;
- Responsabilità patrimoniale personale del contribuente.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- I dividendi erano stati già tassati alla fonte in Lussemburgo?
- È stata applicata correttamente la convenzione Italia–Lussemburgo sulle doppie imposizioni?
- Le somme rientravano in un regime di esenzione parziale (es. participation exemption)?
- Sono stati rispettati gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW?
- La contestazione si basa su dati concreti o su presunzioni generiche?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Certificazioni di pagamento dei dividendi rilasciate dalla società lussemburghese;
- Prove delle ritenute fiscali operate alla fonte;
- Estratti conto bancari esteri e report dell’intermediario;
- Copia delle dichiarazioni fiscali italiane degli anni interessati;
- Convenzione Italia–Lussemburgo e documenti di prassi applicabili.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare che i dividendi sono stati già tassati in Lussemburgo, chiedendo il credito d’imposta in Italia;
- Contestare la doppia imposizione se non è stato applicato il regime convenzionale;
- Evidenziare la buona fede e l’affidamento in prassi e documentazione bancaria;
- Richiedere la riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso o definizione agevolata;
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni;
- Difesa penale mirata in caso di contestazioni per omessa dichiarazione di attività estere.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza i flussi di dividendi e la documentazione fiscale;
📌 Verifica la fondatezza della contestazione e la corretta applicazione della convenzione internazionale;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti assiste in giudizio e, se necessario, nei procedimenti penali;
🔁 Suggerisce strategie preventive per la gestione corretta dei redditi da partecipazioni estere.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in fiscalità internazionale e contenzioso tributario;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni su dividendi e redditi esteri;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sui dividendi da Lussemburgo non dichiarati non sempre sono fondate: spesso derivano da errori formali, mancata applicazione delle convenzioni internazionali o da informazioni incomplete.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la corretta tassazione, evitare la doppia imposizione e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti sui dividendi esteri inizia qui.