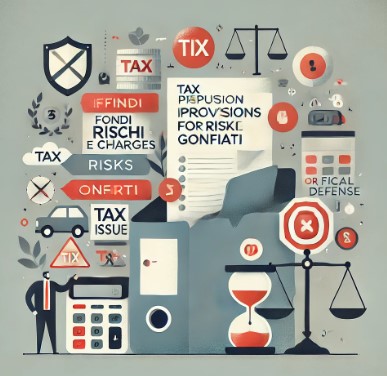Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per presunti fondi rischi e oneri gonfiati? In questi casi, l’Ufficio presume che la società abbia accantonato somme eccessive o non giustificate nei fondi di bilancio, con l’unico scopo di ridurre il reddito imponibile e abbassare il carico fiscale. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, sanzioni elevate e possibili rilievi anche in sede civilistica. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la correttezza degli accantonamenti o ridurre sensibilmente l’impatto delle sanzioni.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i fondi rischi e oneri
– Se l’accantonamento non è supportato da documentazione probatoria (contratti, contenziosi, obbligazioni future)
– Se i fondi appaiono sproporzionati rispetto al rischio effettivo da coprire
– Se vengono iscritti a bilancio oneri futuri incerti o privi di ragione giuridica
– Se emergono incongruenze tra bilancio civilistico, nota integrativa e dichiarazione dei redditi
– Se l’Ufficio presume che l’accantonamento sia stato utilizzato in modo elusivo per ridurre l’utile imponibile
Conseguenze della contestazione
– Recupero a tassazione degli importi ritenuti indebitamente accantonati
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Rettifica del bilancio e possibili rilievi di responsabilità degli amministratori
– Nei casi più gravi, contestazioni penali per falso in bilancio o dichiarazione infedele
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare l’effettiva esistenza e concretezza del rischio o dell’onere accantonato
– Produrre contratti, corrispondenza legale, pareri tecnici e relazioni che giustifichino il fondo
– Contestare la qualificazione come “gonfiati” se gli accantonamenti sono prudenziali e civilisticamente corretti
– Evidenziare eventuali errori di calcolo, difetti istruttori o vizi di motivazione dell’accertamento
– Richiedere la riqualificazione della contestazione per ridurre sanzioni e interessi
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la natura dei fondi rischi e oneri contestati e la documentazione collegata
– Verificare la legittimità della contestazione rispetto alla normativa fiscale e civilistica
– Redigere un ricorso fondato su prove concrete e vizi formali dell’accertamento
– Difendere la società e i suoi amministratori davanti ai giudici tributari
– Tutelare il patrimonio aziendale e personale da conseguenze sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– Il riconoscimento della correttezza degli accantonamenti effettuati
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– La certezza di pagare solo quanto effettivamente dovuto per legge
⚠️ Attenzione: i fondi rischi e oneri sono tra le voci più frequentemente analizzate dal Fisco durante le verifiche. È fondamentale predisporre una difesa solida e documentata per evitare contestazioni sproporzionate.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e societario – spiega come difendersi in caso di contestazioni per fondi rischi e oneri gonfiati e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.
👉 Hai ricevuto una contestazione per fondi rischi e oneri? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la legittimità dell’accertamento e costruiremo la strategia difensiva più efficace per tutelare i tuoi interessi.
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono poste passive del bilancio destinate a fronteggiare costi o perdite future di competenza di esercizi successivi, la cui occorrenza o ammontare non sono ancora certi al momento della chiusura dell’esercizio. In pratica, la società accantona parte degli utili o delle risorse disponibili per far fronte a passività potenziali o oneri futuri probabili, secondo i principi di prudenza contabile. Un esempio tipico è il fondo rischi per cause legali in corso, oppure il fondo oneri per manutenzioni programmate.
Quando però tali accantonamenti risultano eccessivi o “gonfiati”, possono sorgere contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (in sede di verifica fiscale), di soci o terzi interessati (in sede civile), nonché profili di responsabilità penale a carico degli amministratori o dei contribuenti. Un fondo rischi gonfiato significa che l’importo accantonato eccede il livello giustificabile secondo le normative, risultando quindi in bilanci non veritieri (perché si occultano utili o si altera la rappresentazione finanziaria) e in possibili vantaggi fiscali indebiti (riduzione artificiosa dell’utile tassabile).
Le conseguenze per chi viene accusato di aver gonfiato un fondo rischi possono essere rilevanti: sul piano tributario si rischia un recupero a tassazione delle somme, con sanzioni amministrative; sul piano civilistico il bilancio potrebbe essere impugnato dai soci e dichiarato nullo per difetto di veridicità, con possibili azioni di responsabilità verso gli amministratori; sul piano penale, infine, si possono configurare reati come le false comunicazioni sociali (falso in bilancio) o, in ambito fiscale, la dichiarazione infedele o fraudolenta.
In questa guida approfondita (aggiornata ad agosto 2025 con le normative e giurisprudenza più recenti) esamineremo dettagliatamente come difendersi da contestazioni relative a fondi per rischi e oneri ritenuti eccessivi o illegittimi. Adotteremo un punto di vista pratico dal lato del debitore (ossia della società o contribuente che subisce la contestazione), fornendo riferimenti normativi italiani, sentenze aggiornate delle Corti più autorevoli, e indicando possibili strategie difensive sia in sede di verifica e accertamento tributario, sia nel contenzioso civile e penale.
Il documento è strutturato in sezioni tematiche per un livello avanzato ma con linguaggio chiaro e divulgativo. Troverete tabelle riepilogative dei principali riferimenti normativi e sanzioni, una sezione di domande e risposte frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi comuni, nonché alcune simulazioni pratiche di casi reali (ambientati in Italia) con le possibili soluzioni. L’obiettivo è offrire uno strumento utile sia agli avvocati che assistono aziende o privati in queste vicende, sia agli stessi imprenditori e contribuenti che vogliono comprendere i propri diritti e preparare al meglio la propria difesa.
Quadro normativo di riferimento
In questa sezione forniremo un inquadramento normativo sui fondi per rischi e oneri, toccando i principi contabili e civilistici applicabili, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità degli accantonamenti, e accennando ai profili di illegittimità che possono far scattare contestazioni civili o penali. È essenziale conoscere queste basi normative per valutare se un fondo rischi è stato costituito correttamente o in violazione delle regole.
Principi civilistici e contabili sui fondi rischi e oneri
La redazione del bilancio d’esercizio delle società italiane deve avvenire nel rispetto dei principi di veridicità, correttezza e chiarezza (art. 2423 cod. civ.). In particolare, per quanto riguarda i fondi per rischi e oneri, il codice civile e i principi contabili nazionali (OIC) stabiliscono criteri stringenti su quando e come tali accantonamenti possono essere iscritti.
L’art. 2424-bis, comma 3 c.c. dispone che “gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza” . Questo significa che si può costituire un fondo rischi/oneri solo per far fronte a obbligazioni specifiche (non generiche) e riferite a situazioni già in essere alla data di bilancio, la cui manifestazione finanziaria è futura e incerta solo nei dettagli (importo esatto e/o data). In altri termini, non è ammesso un fondo per “rischi generici” o per eventi ipotetici non sufficientemente definiti: deve trattarsi di passività o perdite probabili e inerenti a condizioni esistenti al momento della chiusura dell’esercizio (es: una causa legale già avviata, un’obbligazione contrattuale già assunta che darà luogo a spese, ecc.). Se invece l’eventualità è solo possibile/remota o concerne eventi futuri non collegati a situazioni presenti a bilancio, l’accantonamento non è consentito.
Il principio contabile OIC 31 (relativo ai fondi per rischi e oneri) rafforza tali criteri. L’OIC 31 chiarisce anzitutto la differenza tra fondi per rischi e fondi per oneri: i fondi rischi rappresentano “passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati”, legate a passività potenziali derivanti da situazioni già esistenti alla data di bilancio ma dal futuro incerto . I fondi oneri, invece, rappresentano “passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi” . In parole semplici: nel fondo rischi confluiscono costi potenziali da eventi dannosi probabili (es. cause legali, garanzie su prodotti venduti, ecc.), mentre il fondo oneri accoglie costi futuri certi nella sostanza ma con tempistica o importo incerti (es. manutenzioni programmate, oneri di ristrutturazione promessi, ecc.).
Importante: nessun fondo rischi/oneri può essere utilizzato per rettificare valori dell’attivo. Se c’è un’attività sopravvalutata (un credito difficilmente esigibile, un asset svalutato), la correzione deve avvenire tramite svalutazione diretta di quell’attività, non mediante un generico fondo nel passivo. L’OIC 31 (§ 27) esplicitamente vieta di accantonare fondi per rettificare poste attive . Ad esempio, non è lecito creare un “fondo rischi generico” per compensare perdite di valore di partecipazioni o immobili: in tali casi occorre procedere con la svalutazione dell’attivo a bilancio (come previsto dagli artt. 2426 c.c. e ss.). Sempre l’OIC 31 elenca altri casi vietati per la costituzione di fondi: copertura di rischi generici non quantificabili in modo obiettivo (accantonamenti arbitrari), copertura di eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (non in essere alla data di bilancio), passività potenziali meramente possibili o remote (non probabili) .
Il rispetto di questi principi è fondamentale: un fondo rischi illegittimo (perché privo dei presupposti di probabilità/quantificazione o usato per mascherare altro) rende il bilancio non conforme alla legge. Le conseguenze possono arrivare fino alla nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, in caso di “grave difetto di veridicità e correttezza” del bilancio stesso . Ad esempio, il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo un bilancio in cui era stato iscritto un fondo rischi generico per coprire presunte perdite di società controllate al posto di svalutarne le partecipazioni: ciò nascondeva una perdita durevole di valore e violava art. 2424-bis c.c. e OIC 31 . Dunque, sul piano civilistico, un socio di minoranza o un interessato può impugnare il bilancio se ritiene che un fondo rischi/oneri sia gonfiato o irregolare e abbia alterato la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. In tali casi i giudici possono sanzionare la società con l’annullamento o nullità del bilancio e potenzialmente aprire la strada a richieste risarcitorie contro gli amministratori (per danno al patrimonio sociale o ai soci).
Riassumendo i principi chiave: un accantonamento a fondo rischi/oneri è ammissibile solo per passività determinate e probabili riferite a situazioni esistenti a fine esercizio, con importo (o scadenza) stimato ma ragionevolmente attendibile. Ogni forma di accantonamento “prudenziale” eccessivo (senza adeguata giustificazione quantitativa) o volto a creare “riserve occulte” è contraria a legge e principi contabili. Come vedremo, proprio su questo si concentrano spesso le contestazioni.
Disciplina fiscale: deducibilità degli accantonamenti e riprese a tassazione
Dal punto di vista fiscale, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri presentano un trattamento molto rigoroso. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986) contiene norme specifiche volte a impedire che semplici accantonamenti prudenziali riducano indebitamente il reddito imponibile. In generale, il principio fiscale ricalca quanto sopra: finché un costo è solo potenziale e non certo, esso non può diminuire il reddito tassabile. Solo quando il costo diviene certo (o effettivo) è ammessa la deduzione.
In particolare, l’art. 107, comma 4 TUIR stabilisce che “non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati” dai commi precedenti dello stesso articolo . I commi precedenti dell’art. 107 TUIR elencano pochissimi casi in cui è consentito dedurre accantonamenti specifici (ad esempio: accantonamenti per manutenzioni cicliche di navi/aeromobili, accantonamenti per oneri di beni concessi in devoluzione alla fine di concessioni, e accantonamenti per operazioni a premio nei limiti stabiliti) . Al di fuori di queste ipotesi tassative, tutti gli altri accantonamenti a fondi rischi/oneri sono fiscalmente indeducibili nell’esercizio in cui sono stanziati .
Cosa comporta ciò in pratica? Che se una società, rispettando il principio contabile di prudenza, iscrive un fondo rischi a conto economico (voce B.12 o B.13), ai fini fiscali dovrà “riprendere a tassazione” quell’importo nella dichiarazione dei redditi dell’anno (effettuando una variazione in aumento del reddito imponibile) . Solo negli esercizi successivi, quando il costo diverrà certo (perché magari la causa viene persa e si paga, oppure si effettua la manutenzione, ecc.), la società potrà dedurre effettivamente l’onere (tramite una variazione in diminuzione) . In altri termini, il sistema fiscale italiano applica un criterio di stretta derivazione temporale dal principio di competenza: un componente negativo incerto non rileva fino a che non si “concretizza” in certezza. Questo concetto è espresso anche nell’art. 109, comma 1 TUIR (norma generale sulla competenza fiscale), secondo cui i componenti di reddito di cui nell’esercizio di competenza non sia certa l’esistenza o obiettivamente determinabile l’ammontare concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui tali condizioni si realizzano** . La Corte di Cassazione ha ribadito che gli accantonamenti a fondi rischi – proprio perché effettuati per passività prive di certezza e determinabilità – rientrano in questa regola dell’art. 109 TUIR .
Alla luce di ciò, un fondo rischi “gonfiato” presenta due possibili problemi fiscali distinti:
- Indebita deduzione anticipata: se la società ha effettivamente dedotto l’accantonamento (non effettuando la variazione in aumento), il reddito dichiarato risulterà indebitamente ridotto. Il Fisco contesterà allora un’omessa tassazione di quella quota, con recupero delle imposte evase. Questo scenario configura una violazione palese dell’art. 107 TUIR (accantonamento non ammesso) e art. 109 TUIR (mancato rispetto del principio di competenza), ed è il tipico caso scoperto in verifica.
- Quantificazione eccessiva: anche se l’accantonamento come tale poteva avere una logica (es. c’era davvero una causa in corso), l’importo stanziato viene giudicato eccessivo rispetto al rischio effettivo. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere deducibile (in futuro) solo una parte dell’onere e non l’intero importo. Ad esempio, se a fronte di un contenzioso con rischio stimato di perdita al 50% per 100.000 €, la società ha accantonato prudentemente 100.000 €, il Fisco potrebbe obiettare che la passività probabile era di 50.000 € e dunque l’eccedenza andava trattata come indeducibile (sino ad eventuale manifestazione). Questo tipo di contestazione è più sottile, perché attiene al grado di probabilità e stima dell’onere: può basarsi su perizie legali, documenti, andamentale storico, ecc. L’onere della prova spesso ricade sul contribuente per giustificare il calcolo.
Va precisato che, in base alle regole fiscali italiane vigenti (anche dopo le riforme della “derivazione rafforzata” dei bilanci OIC adopter), qualsiasi componente contabilizzato in contropartita di un fondo passivo con importo/timing incerti è considerato un “accantonamento” fiscalmente indeducibile , anche se a conto economico fosse classificato diversamente. Dunque non c’è modo di “mascherare” un fondo rischi contabilizzandolo in un’altra voce di costo: il Decreto Ministeriale 8 giugno 2011 (recepito per gli OIC adopter) chiarisce che rileva la sostanza di accantonamento (incertezza di importo/scadenza) e si applica comunque l’art. 107, comma 4 TUIR . Il principio della derivazione rafforzata – secondo cui i criteri contabili influenzano direttamente la base imponibile – non consente quindi di bypassare il divieto di deduzione: la fiscalità mantiene un approccio prudenziale autonomo.
Un punto cruciale, spesso dibattuto, riguarda il trattamento fiscale del rilascio o storno del fondo rischi in esercizi successivi. Ipotizziamo che si sia accantonato (senza dedurlo) un fondo di 100, e che dopo qualche anno questo fondo venga stornato perché il rischio è cessato (es: la causa si chiude a favore, l’evento negativo non si è verificato). Contabilmente, il rilascio del fondo genera un provento (un componente positivo a conto economico, generalmente classificato tra gli “Altri ricavi e proventi” in A5) . Fiscalmente, ci si chiede: tale provento è imponibile? La logica suggerirebbe di non tassarlo se l’accantonamento originario non era mai stato dedotto (altrimenti si avrebbe una tassazione “due volte” sul nulla). In effetti, il TUIR all’art. 88 (sulle sopravvenienze attive) esclude da tassazione i proventi derivanti da recuperi di costi mai dedotti. Inoltre, il principio di divieto di doppia imposizione (art. 163 TUIR) garantisce che la stessa imposta non colpisca due volte il medesimo presupposto . Pertanto, in teoria, se un fondo rischi non ha dato luogo a risparmio d’imposta quando fu stanziato, il suo successivo venir meno non dovrebbe produrre imponibile: la società, in sede di dichiarazione, potrà operare una variazione in diminuzione per stornare il provento contabilizzato . Euroconference ha chiarito che: se il fondo non era dedotto e viene rilasciato, il componente positivo non rappresenta una sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 TUIR .
Tuttavia, occorre cautela: la Cassazione in alcune pronunce ha assunto una posizione più rigida. Ad esempio, la Suprema Corte con sentenza n. 23812/2017 ha affermato che l’azzeramento di un fondo rischi determina comunque una sopravvenienza attiva imponibile . In quel caso, una società aveva accantonato negli anni ‘90 un fondo per spese future (non dedotto allora) e lo aveva stornato nel 2003 ritenendo cessati i presupposti; l’Amministrazione finanziaria pretese di tassare quell’importo nel 2003, e la Cassazione le diede ragione . Più recentemente, con ordinanza n. 9899/2024, la Cassazione ha ribadito che il punto controverso è il “quando” tassare la sopravvenienza, non il “se” – ritenendo che la cessazione dei presupposti del fondo nel 2012 facesse emergere allora il componente positivo imponibile, indipendentemente da come fosse stato trattato in origine . In altre parole, la Corte sembra presumere che finché l’obbligazione era incerta, la relativa deduzione fiscale fosse sospesa e dunque nel momento in cui l’incertezza si risolve (perché il rischio sfuma o perché si paga), quell’importo entra nel reddito imponibile dell’anno di risoluzione . Questa impostazione è coerente con l’art. 109 TUIR: se un costo non era certo prima, non poteva abbatere il reddito, e concorre quando diventa certo l’inesistenza (quindi come sopravvenienza attiva, se non lo si spende).
La posizione pratica per il contribuente è dunque: meglio prevenire contestazioni evitando manovre dubbie. In fase di dichiarazione, se si è stanziato un fondo rischi, occorre non dedurlo (variazione in aumento) salvo casi espressamente ammessi. Se poi il rischio decade, attenzione a gestire correttamente il ritorno a tassazione: se a suo tempo era stato dedotto indebitamente (caso patologico), è ovvio che al rilascio va tassato; se invece era stato correttamente non dedotto, si possono addurre i principi di neutralità per escludere l’imponibilità, ma è bene documentare ciò (ad esempio, tenendo traccia delle variazioni fiscali operate negli anni). In caso di controversia, la difesa consisterà nel dimostrare l’assenza di un vantaggio fiscale pregresso e invocare il principio del ne bis in idem tributario. Va segnalato che dottrina e prassi convergono sul fatto che accantonamenti non dedotti = sopravvenienze non tassabili, ma la giurisprudenza ha mostrato un orientamento severo per evitare zone d’ombra .
In sintesi fiscale: gli accantonamenti ai fondi rischi/oneri (al di fuori di limitate eccezioni) sono temporaneamente indeducibili. Il fisco li “tassa” subito (ricalcolando in aumento il reddito) e consentirà la deduzione solo nell’anno in cui il costo diviene certo ed effettivo . Pertanto, qualsiasi utilizzo di fondi rischi per abbattere l’utile tassabile prima del tempo verrà contestato come elusivo o illecito. E quando un fondo viene ridotto/eliminato, l’attenzione va posta nel giusto trattamento del componente positivo, per non incorrere in rilievi su sopravvenienze attive non dichiarate.
Profili di illegittimità e reato: falso in bilancio e reati tributari
Oltre agli aspetti civilistici e tributari, la presenza di fondi rischi o oneri gonfiati può far scattare l’attenzione anche sotto il profilo penale, sia societario che tributario. In pratica, se l’accantonamento eccedente è tale da falsare il bilancio o da costituire un artificio per evadere le imposte, i responsabili possono essere perseguiti. È fondamentale conoscere quali reati possono configurarsi e quali sono i relativi presupposti, poiché ciò incide sulle strategie difensive (ad esempio, dimostrare l’assenza di dolo specifico). Vediamo i due ambiti distintamente:
- False comunicazioni sociali (falso in bilancio): L’art. 2621 cod. civ. punisce gli amministratori, direttori, sindaci e liquidatori che, al fine di ingannare soci o il pubblico e conseguire un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci (o altre comunicazioni sociali) fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo idoneo ad indurre altri in errore . Nel nostro contesto, inserire in bilancio un fondo rischi e oneri non veritiero (perché esagerato o addirittura privo di reale giustificazione) può rientrare tra i “fatti materiali non veri” esposti consapevolmente. Per esempio, dichiarare un passivo potenziale di 1 milione € quando si sa che il rischio effettivo è molto minore, costituisce un’informazione falsa di natura quantitativa. Anche l’omissione di informazioni imposte (ad esempio, non fornire in Nota Integrativa i dettagli sui fondi rischi, o non indicare garanzie prestate che avrebbero richiesto un fondo) può integrare il reato . La Cassazione ha ritenuto, ad esempio, che omettere di indicare in bilancio le garanzie prestate dalla società (per oltre 1 milione €) a fronte di un contenzioso pendente configura false comunicazioni sociali, reiterate per ogni esercizio finché l’omissione perdura . Ciò evidenzia che anche non costituire un fondo rischi quando sarebbe dovuto, o non rappresentare un dato nelle voci di conti d’ordine, può essere considerato un falso in bilancio per omissione.
Per la configurabilità del reato occorre però l’elemento soggettivo del dolo: dopo la riforma del 2015, è richiesta la volontà di fornire un quadro falso per un ingiusto profitto proprio o altrui. Non è più necessario provare uno specifico danno ai soci/pubblico (il reato è “di pericolo” astratto), ma bisogna dimostrare la consapevolezza della falsità e l’intento di ingannare. La giurisprudenza ha chiarito che il dolo non può essere desunto automaticamente dal fatto che un valore contabile sia falso o violi i principi contabili: non basta la divergenza quantitativa, serve la prova che l’autore sapeva di agire in modo anomalo e ha volontariamente adottato artifici contabili ingannevoli . In Cass. 46689/2016 si è sottolineato che il dolo di mendacio deve risultare da elementi inequivoci indicanti nel redattore del bilancio la consapevolezza del suo operato abnorme o irragionevole, non potendosi considerare provato “in re ipsa” per il solo fatto che un accantonamento non rispetta le norme tecniche . Inoltre, con riferimento all’assetto previgente, si richiede l’intento di ingannare i soci o il pubblico (oggi assorbito nella finalità di ingiusto profitto). In concreto, ciò significa che, in sede difensiva, l’amministratore accusato di falso in bilancio per un fondo rischi gonfiato potrà cercare di dimostrare l’assenza di dolo: ad esempio sostenendo che la valutazione dell’accantonamento era basata su criteri prudenziali condivisi, su consulenze professionali, e che non vi era volontà di occultare utili per benefici personali (magari l’intento era pagare meno imposte, ma non arricchirsi direttamente). Attenzione però: evadere imposte costituisce comunque un profitto indebito per la società, quindi la linea difensiva deve sottolineare l’aspetto valutativo e l’assenza di artificiosità intenzionale.
Sul piano sanzionatorio, il reato di false comunicazioni sociali (non quotate) prevede la reclusione da 1 a 5 anni (art. 2621 c.c.). Esiste una fattispecie attenuata (art. 2621-bis c.c.) per fatti di lieve entità e per società piccole (sotto certi limiti dimensionali), con pena ridotta (fino a 2 anni) o causa di non punibilità in casi di particolare tenuità. Tuttavia, un fondo rischi gonfiato per importi rilevanti difficilmente verrà considerato di lieve entità, specie se ha alterato in modo significativo il risultato di esercizio o il patrimonio netto (ricordiamo che la legge 69/2015 ha eliminato soglie quantitative di non punibilità, salvo appunto la clausola di tenuità per non quotate). Inoltre, la condotta si consuma con l’approvazione del bilancio falso e si ripete per ogni esercizio in cui il falso si protrae (ogni anno di reiterata esposizione errata è reato autonomo, sebbene collegato) .
- Reati tributari (dichiarazione infedele o fraudolenta): Parallelamente al reato societario, può configurarsi anche un illecito penale tributario ai sensi del D.Lgs. 74/2000. L’accantonamento gonfiato incide sulla dichiarazione dei redditi: se la società ha dedotto costi fittizi o maggiori del dovuto, la dichiarazione risulta infedele (dichiarando meno reddito di quello reale). Il D.Lgs. 74/2000 prevede:
- all’art. 4 il reato di dichiarazione infedele, quando l’imposta evasa supera 100.000 € e gli elementi attivi sottratti a imposizione (o elementi passivi fittizi) superano il 10% di quanto dichiarato o comunque 2 milioni € . Inserire un fondo rischi indeducibile comporta di fatto elementi passivi inesistenti dal punto di vista fiscale. Se le soglie sono superate, scatta il penale con pena da 2 a 4 anni (range aggiornato dalla normativa recente). Da notare che se l’importo del costo fittizio è inferiore a 100.000 € di imposta evasa, non vi è reato (resta illecito amministrativo). Quindi, ad esempio, gonfiare il fondo rischi di 500.000 € riducendo l’IRES di 120.000 € integrerebbe la soglia, mentre gonfiarlo di 100.000 € con imposta evasa 24.000 € no.
- all’art. 3 il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, che ricorre quando, con l’intento di evadere, ci si avvale di mezzi fraudolenti (diversi dalle false fatture) idonei a ostacolare l’accertamento e si indica in dichiarazione elementi passivi fittizi, superando 30.000 € di imposta evasa e il 5% dell’imponibile o 1,5 milioni € di elementi fittizi. Un fondo rischi gonfiato potrebbe rientrare in questa fattispecie se considerato un “artificio contabile” volto a ingannare il fisco. Ad esempio, creare deliberatamente un fondo inesistente con lo scopo di ridurre l’utile e dunque le tasse, potrebbe essere visto come un meccanismo fraudolento, specialmente se accompagnato da annotazioni fuorvianti o documentazione falsa a supporto. La pena qui è più alta (reclusione da 3 a 8 anni, aumentata nel 2020). Rispetto alla dichiarazione infedele (che può anche derivare da valutazioni errate senza inganno attivo), la dichiarazione fraudolenta richiede un quid pluris di artifizio e dolo specifico di frode.
Va sottolineato che la linea di confine tra infedele e fraudolenta, in un caso di bilancio volutamente “appesantito” da accantonamenti, dipende dalle modalità: se l’accantonamento eccessivo è solo un errore valutativo, sebbene intenzionale nel voler risparmiare imposte, potrebbe ricadere nell’infedele (art.4) qualora superi le soglie; se invece è supportato da condotte ingannevoli (documenti falsi, simulazione di rischi inesistenti, ecc.) si propenderebbe per la fattispecie fraudolenta (art.3). La prassi investigativa potrebbe ravvisare l’artificio già nel predisporre un fondo inesistente in bilancio, ma la difesa potrebbe sostenere che non vi era un meccanismo fraudolento estrinseco (come doppie scritture, operazioni simulate, ecc.), bensì una libera stima (pur errata).
In ogni caso, quando la Guardia di Finanza effettua verifiche fiscali e trova elementi passivi non deducibili di importo rilevante, trasmette il verbale alla Procura della Repubblica. Infatti, vi è un obbligo di denuncia se dai controlli emergono fatti che integrano reati tributari sopra soglia. Di conseguenza, un accertamento su fondi rischi gonfiati può facilmente sfociare in un procedimento penale tributario, oltre che nell’ordinario contenzioso amministrativo. Questo aggiunge pressione sul contribuente, che dovrà difendersi su due fronti.
Sul piano delle sanzioni penali tributarie, la dichiarazione infedele (art.4) è punita con reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi; la dichiarazione fraudolenta (art.3) con reclusione da 3 a 8 anni. Non sono previste soglie di non punibilità, se non appunto quelle di configurabilità del reato (100k € imposta evasa per infedele; 30k € per fraudolenta con altri artifici) . È bene sapere che il pagamento del tributo evaso dopo la contestazione non estingue il reato (a differenza di quanto accade per omessi versamenti in altri casi), ma può incidere sulla valutazione della gravità e sulla concessione di attenuanti. Invece, il ricorso a strumenti deflativi (come l’acquiescenza o l’accertamento con adesione, che vedremo tra poco) prima che intervenga la denuncia potrebbe in certi casi evitare l’innesco penale, specie se l’ufficio rinuncia a sanzioni penali minori.
Osservazione: I reati societari e quelli tributari possono concorrere. Ad esempio, un amministratore potrebbe essere imputato sia per falso in bilancio (verso i soci/terzi) che per dichiarazione infedele (verso l’Erario) per la medesima condotta di aver gonfiato i fondi rischi. La giurisprudenza riconosce che tutelano beni giuridici diversi, quindi non c’è assorbimento automatico. In sede difensiva, però, si potrebbe far leva sul fatto che l’intento principale era evadere l’imposta (profitto per la società) più che ingannare i soci, ma dal 2015 ciò non esclude il reato societario, essendo sufficiente la volontà di profitto ingiusto. È anche possibile che eventuali patteggiamenti o definizioni agevolate in uno dei procedimenti abbiano effetti sull’altro (ad esempio, se si patteggia per il reato tributario ammettendo la condotta, ciò può costituire prova nel procedimento per falso in bilancio). Pertanto, una strategia difensiva coordinata è essenziale quando le due vicende corrono parallele.
Tabella riepilogativa – Principali riferimenti normativi
| Norma/Principio | Contenuto essenziale e rilevanza nel caso di fondi rischi oneri gonfiati |
|---|---|
| Art. 2424-bis, co.3 c.c. | Consente accantonamenti solo per passività determinate, certe o probabili, con importo/data indeterminati al momento. Vieta fondi per rischi generici o per rettificare attivi . Un fondo gonfiato viola questa norma. |
| Principio contabile OIC 31 | Definisce fondi rischi/oneri e ne disciplina la contabilizzazione. Vieta accantonamenti per rischi non probabili, non stimabili obiettivamente o eventi successivi al bilancio. Richiede aggiornamento annuale dei fondi e utilizzo diretto a copertura dei costi correlati. Un fondo gonfiato è contrario ai postulati OIC 31 (prudenza vs veridicità). |
| Art. 107, co.4 TUIR | Principio di indeducibilità fiscale generale degli accantonamenti. Salvo eccezioni specifiche (manutenzioni cicliche, beni devolvibili, concorsi a premio), gli accantonamenti ai fondi rischi/oneri non sono deducibili nell’esercizio in cui sono imputati . Quindi un fondo gonfiato non può ridurre le imposte correnti. |
| Art. 109, co.1 TUIR | Principio di competenza fiscale qualificata: componenti di reddito la cui esistenza non è certa o il cui ammontare non è obiettivamente determinabile a fine esercizio concorrono al reddito nell’esercizio in cui diventano certi o determinabili . Ciò posticipa la deduzione del costo incerto e, simmetricamente, fa emergere tassazione quando l’incertezza si risolve (compenso attivo). |
| Art. 88 TUIR (sopravvenienze attive) | Include tra le sopravvenienze attive tassabili i proventi derivanti da decadenza di passività già dedotte; ma esclude quelli relativi a costi mai dedotti. Principio di neutralità: se un fondo non era dedotto, la sua eliminazione non genera imponibile (evitando doppia tassazione) . (Interpretazione talora disattesa dalla giurisprudenza recente in ottica anti-elusiva.) |
| Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) | Configura il reato di falso in bilancio per società non quotate: punisce chi espone consapevolmente fatti materiali falsi od omette fatti veri imposti dalla legge, rilevanti sulla situazione economico-patrimoniale, con lo scopo di ingannare e ottenere un profitto . Fondi rischi alterati possono rientrare tra i fatti falsi/omessi rilevanti. Pena: reclusione 1–5 anni (o fino 2 anni se lieve entità, art. 2621-bis). |
| D.Lgs. 74/2000, Art. 4 (Dichiarazione infedele) | Reato tributario in caso di dichiarazione dei redditi infedele oltre soglie: imposta evasa > 100k € e elementi sottratti > 10% del dichiarato o > 2 mln €. Inserire elementi passivi fittizi (es. costi non spettanti) rientra nella condotta. Pena base: reclusione 2–4 anni e 6 mesi . |
| D.Lgs. 74/2000, Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante artifici) | Reato tributario più grave: evasione tramite condotte fraudolente (es. uso di documenti falsi o artifici contabili) oltre soglia imposta evasa > 30k € e elementi fittizi > 5% imponibile o > 1,5 mln €. Un bilancio costruito ad arte con fondi gonfiati può costituire l’artificio. Pena: reclusione 3–8 anni. |
Accertamento fiscale: verifiche dell’Agenzia Entrate e difesa del contribuente
In ambito tributario, le contestazioni relative a fondi per rischi e oneri gonfiati tipicamente emergono durante verifiche fiscali o controlli dell’Agenzia delle Entrate (o Guardia di Finanza) sui bilanci e dichiarazioni dei redditi della società. In questa sezione esamineremo come avviene la contestazione in sede di controllo fiscale, quali sono le procedure (dal Processo Verbale di Constatazione all’Avviso di Accertamento), quali sanzioni amministrative possono essere irrogate e, soprattutto, come predisporre una difesa efficace sia nella fase pre-contenziosa (verifica e accertamento) sia nel successivo processo tributario davanti alle Commissioni Tributarie.
Come e perché il Fisco contesta un fondo rischi gonfiato
Quando i verificatori (Agenzia o GdF) analizzano un bilancio, l’attenzione sui fondi rischi e oneri è sempre alta. Queste voci, infatti, possono nascondere utili non tassati. I segnali che tipicamente destano sospetti sono ad esempio:
- Importi molto elevati o in crescita costante dei fondi rischi/oneri rispetto allo storico dell’azienda, senza una chiara motivazione (es. fondo rischi contenzioso passato da 50k a 500k in un anno senza nuovi contenziosi rilevanti noti).
- Fondi “dormienti”: accantonamenti rimasti in bilancio per molti anni senza utilizzi né variazioni, il che può indicare che erano eccessivi o ingiustificati dall’inizio (accantonati e poi mai serviti a nulla, dunque potenzialmente fittizi).
- Mancanza di dettaglio in Nota Integrativa: se la società indica genericamente “accantonati 200.000 € a fondo rischi generico” senza spiegare la natura del rischio, oppure descrive rischi molto vaghi, l’ufficio sospetta legittimamente che non vi fosse una passività probabile determinata, in violazione delle regole.
- Confronto tra fondi e eventi noti: ad esempio, se si sa (da notizie pubbliche o da altri controlli) che la società ha poche cause legali pendenti per piccoli importi, ma ha un fondo rischi legali enorme, c’è incoerenza. Oppure se ha venduto prodotti con garanzia e il fondo garanzia è sproporzionato rispetto alle effettive richieste di assistenza.
- Variazioni in dichiarazione: l’ufficio controlla il quadro RF della dichiarazione dei redditi (per le società di capitali). Se vede che la società NON ha operato variazioni in aumento corrispondenti all’accantonamento fatto a conto economico (voce B12/B13), allora quell’importo è stato dedotto: segnale di possibile violazione fiscale. Anche se ha operato la variazione, può sorgere la questione dell’anno in cui dedurre: se successivamente non c’è stata manifestazione del costo, quell’accantonamento rimane indeducibile in via permanente e andrebbe stornato.
- Confronti interni: a volte le Entrate dispongono di informazioni dagli anni successivi. Se vedono, ad esempio, che nel 2024 la società ha cancellato un fondo rischi di 300k creato nel 2020 e quell’importo in contabilità è andato tra i proventi straordinari, verificheranno se nel 2024 in Unico è stato tassato o eliminato. Se ciò non risulta, aprono il capitolo dell’imponibilità della sopravvenienza attiva.
Una volta individuato il possibile problema, i verificatori chiedono chiarimenti. Solitamente, nel corso di un’ispezione presso la sede del contribuente, formuleranno domande o invieranno questionari specifici: “Si prega di fornire la documentazione giustificativa degli accantonamenti al fondo X per l’anno Y: ad esempio per il fondo rischi cause legali indicare l’elenco dei contenziosi, valore della causa, probabilità di soccombenza stimata; per il fondo oneri di ristrutturazione fornire piani e delibere; ecc.”. È fondamentale in questa fase collaborare e consegnare tutti gli elementi a supporto. Non di rado, infatti, un accantonamento può essere difendibile se adeguatamente documentato: ad esempio, un parere pro veritate di un legale esterno che, alla data di bilancio, stimava un’alta probabilità di dover pagare una certa somma in causa. Oppure calcoli analitici di costi futuri già contrattualmente assunti. Mostrare queste prove può talvolta convincere i verificatori che il fondo non era “gonfiato” ma anzi commisurato al rischio.
Se però le spiegazioni non sono convincenti, i verificatori contestano formalmente la questione nel PVC (Processo Verbale di Constatazione), che è il documento finale della verifica fiscale. Ad esempio, nel PVC potrebbero scrivere: “Si riscontra l’iscrizione in bilancio di un fondo rischi contenzioso pari a € XXX, a fronte di n.2 cause legali di valore assai inferiore (valore lite totale € YYY). L’accantonamento eccede manifestamente l’esborso probabile, ponendosi in violazione dell’art. 2424-bis c.c. e, ai fini fiscali, dell’art. 107 co.4 TUIR. La quota non deducibile sottratta a tassazione è quantificata in € ZZZ, con imposta evasa € TTT”. Questo rilievo confluirà poi nell’avviso di accertamento, che è l’atto impositivo con cui l’Agenzia delle Entrate recupera a tassazione l’importo contestato, richiedendo le relative imposte e sanzioni.
Le sanzioni amministrative tributarie in caso di deduzione di costi non spettanti (come un fondo rischi indeducibile) rientrano nel regime delle sanzioni per infedele dichiarazione. Attualmente la sanzione è pari al 90% dell’imposta corrispondente alla differenza di reddito accertata (oltre agli interessi per ritardato pagamento). Ad esempio, se un fondo gonfiato ha portato a 50.000 € di IRES non pagata, la sanzione base sarà 45.000 €. Tale sanzione può salire fino al 180% in presenza di aggravanti (es. elementi non attendibili, mancata collaborazione) o ridursi se si aderiscono a definizioni agevolate. Se però il contribuente riconosce l’errore e vuole evitare il contenzioso, può accedere al ravvedimento operoso (prima del PVC) o all’accertamento con adesione (dopo il PVC, prima dell’emissione dell’accertamento o anche dopo, entro i termini): questi istituti consentono una riduzione delle sanzioni (tipicamente al 1/3 nel caso di adesione).
Riassumendo, il percorso tipico è: Verifica → PVC con rilievo → (eventuale contraddittorio) → Avviso di Accertamento → sanzioni 90% imposta. Il contribuente ha a disposizione strumenti difensivi in ogni fase, come vedremo di seguito.
Strategie difensive durante la verifica fiscale e in fase di accertamento
1. Fase di verifica (ispezione/PVC) – Questa è la fase pre-contenziosa per eccellenza, in cui la collaborazione e la tempestività possono fare la differenza. Dal punto di vista del debitore/contribuente, alcune strategie difensive utili in sede di verifica sono:
- Fornire giustificazioni documentali dettagliate: Come accennato, consegnare ai verificatori tutti i documenti che supportano l’accantonamento. Ciò include: per i fondi rischi legali, gli atti delle cause e le valutazioni degli avvocati (specie se indicavano un rischio effettivo elevato e una stima dell’importo da pagare); per fondi oneri, i piani di spesa approvati, preventivi, contratti che obbligavano l’azienda a quei pagamenti futuri. Ogni pezzo di carta che renda oggettiva la scelta dell’importo accantonato è prezioso. Se l’importo può apparire elevato, bisogna mostrare che derivava da un criterio (es. percentuale di rischio applicata al valore della causa, media storica delle garanzie su prodotti venduti, ecc.).
- Evidenziare la conformità ai principi contabili: Ad esempio, citare nelle memorie difensive durante la verifica che l’accantonamento rispettava l’art. 2424-bis c.c. perché la passività era probabile e determinata e quantificata con prudenza, oppure che l’importo è stato ricalcolato dagli organi di controllo (collegio sindacale, revisore) e ritenuto congruo. Se c’è stata la certificazione del bilancio da parte di un revisore indipendente senza rilievi sul fondo, farlo presente può dare credibilità (non vincola il Fisco, ma mostra buona fede).
- Dimostrare l’assenza di vantaggio fiscale voluto: Se, ad esempio, l’azienda nei fatti non ha usufruito di un beneficio fiscale perché ha comunque chiuso in perdita fiscale o perché l’accantonamento era stato escluso in dichiarazione per prudenza, farlo notare. A volte le società, pur potendo forzare la mano, scelgono di non dedurre un accantonamento dubbio. Se è così, i verificatori non avranno terreno per contestare evasione d’imposta, al più potrebbero segnalare un’errata rappresentazione civilistica (che però esula dall’accertamento fiscale).
- Rettifiche spontanee in corso di verifica: È possibile che durante la verifica ci si renda conto di un errore difficilmente difendibile (magari un fondo davvero esagerato). In tali casi, una mossa strategica può essere proporre un’autocorrezione: ad esempio, offrire di presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, riprendendo a tassazione il fondo, prima che venga emanato l’accertamento. Questo approccio di solito viene formalizzato tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Occorre però che non sia già stato notificato un PVC con conclusioni definitive. Un ravvedimento tempestivo (con pagamento dell’imposta dovuta e mini-sanzione ridotta) può chiudere la vicenda fiscale prima che diventi contenziosa e, cosa importante, evitare la segnalazione penale in quanto non ci sarebbe più imposta evasa alla fine. Tuttavia, bisogna valutare caso per caso: se il rilievo è contestabile con buone chance, meglio non affrettarsi a pagare; se invece è palese, ravvedersi evita il 90% di sanzione e il rischio penale (purché fatto prima che l’ufficio contesti formalmente).
- Contraddittorio: Nel caso di controlli di particolare complessità, l’Agenzia prima di emettere l’avviso invita il contribuente a un contraddittorio (obbligatorio, ad esempio, per i tributi armonizzati tipo IVA, o in alcuni accertamenti per adesione). È un’opportunità per far valere oralmente e poi in memoria scritta le proprie ragioni. Durante il contraddittorio, si può ridiscutere l’importo contestato (magari convincendo l’ufficio a ridurlo, riconoscendo parzialmente la fondatezza del fondo) o sollevare questioni giuridiche (es. contestare un vizio procedurale, o eccepire che la pretesa fiscale lede il principio di doppia imposizione se il costo non fu dedotto, ecc.). Anche se l’esito spesso conferma la pretesa, è utile per cristallizzare le nostre difese che poi ritroveremo in giudizio.
2. Fase di accertamento (avviso impugnabile) – Se arriva l’Avviso di Accertamento, il contribuente deve decidere se impugnarlo in Commissione Tributaria o trovare un accordo con l’ufficio. Le opzioni difensive a questo stadio includono:
- Accertamento con adesione: È uno strumento che consente, dopo aver ricevuto l’atto, di chiedere un colloquio all’ufficio per negoziare una riduzione della pretesa. La presentazione dell’istanza sospende i termini per ricorrere e apre un dialogo. Si potrebbe, ad esempio, convincere l’ufficio a ridurre sanzioni o a rideterminare il quantum dell’accantonamento ritenuto eccedente. Se l’adesione si conclude positivamente, si firma un atto di adesione con pagamento (anche rateale) di imposte e sanzioni ridotte a 1/3. Ciò evita il processo. È una buona strada quando la difendibilità in giudizio è incerta e si vuole chiudere limitando i danni (e magari evitare ulteriori approfondimenti che potrebbero portare al penale, se ancora non segnalato).
- Acquiescenza: qualora l’ufficio offra già nell’accertamento il minimo sanzionatorio o comunque non ci siano margini di vittoria, il contribuente può acquiescere, cioè accettare l’atto e pagare entro i termini, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3. Questa scelta ha senso se l’importo è modesto o le prove controverse sono schiaccianti a sfavore.
- Ricorso in Commissione Tributaria: Se si ritiene di avere solide argomentazioni, si procede col ricorso entro 60 giorni. Nei paragrafi successivi vedremo le linee di difesa in giudizio. Da notare che per importi fino a 50.000 € è prevista prima un’istanza di reclamo/mediazione da proporre all’ufficio stesso, nella quale già si espongono i motivi di doglianza; l’ufficio può eventualmente accogliere in tutto o in parte o fare una proposta, altrimenti il ricorso prosegue.
In ogni caso, già in fase di accertamento, qualsiasi pagamento o accordo transattivo non estingue automaticamente il reato tributario eventualmente configurato, ma dimostra buona volontà e può indurre la GdF a non sporgere denuncia se la posizione viene sanata velocemente (questo dipende molto dalle tempistiche e dalla discrezionalità degli organi di controllo).
Tabella riepilogativa – Difesa nelle fasi di verifica e accertamento
| Fase procedimentale | Strumenti difensivi del contribuente (debitore) | Note |
|---|---|---|
| Verifica fiscale (controllo in azienda/GdF) | – Fornire documentazione completa a supporto del fondo (perizie, contratti, ecc.)<br>– Redigere memorie e osservazioni scritte al PVC (entro 60 gg se GdF)<br>– Eventuale ravvedimento operoso prima della conclusione (correggere dichiarazione spontaneamente) | Memorie e collaborazione possono far modificare o attenuare i rilievi. Il ravvedimento esclude sanzioni pesanti ma va fatto prima che il rilievo sia contestato ufficialmente. |
| Contraddittorio (pre-avviso, se previsto) | – Presentare argomentazioni orali/scritte per ridurre o annullare la pretesa<br>– Evidenziare eventuali errori procedurali dell’ufficio o interpretazioni errate<br>– Proporre soluzioni conciliative (es. riconoscere quota parte dell’accantonamento legittimo) | Non sempre obbligatorio in materia di imposte dirette, ma comunque possibile su richiesta (adesione anticipata). Serve anche a preparare la strategia per il ricorso. |
| Avviso di Accertamento (atto emanato) | – Istanza di adesione (sospende termini ricorso, avvia negoziazione)<br>– Acquiescenza (pagamento con sanzioni ridotte 1/3 entro 60 gg) se nessuna chance di vittoria<br>– Ricorso alla Commissione Tributaria (entro 60 gg, 90 se adesione rifiutata) | Valutare costi/benefici: l’adesione abbassa sanzioni ma implica pagamento; il ricorso può portare annullamento totale, ma con spese e tempi. L’acquiescenza conviene solo se l’ufficio ha già applicato minimi o è certo torto. |
Nei paragrafi seguenti affronteremo le possibili difese nel merito che il contribuente può portare nel processo tributario, ossia di fronte al giudice, per contestare la legittimità della ripresa a tassazione del fondo rischi/oneri. Capiremo quali argomenti hanno avuto successo o meno in giurisprudenza e come impostare il ricorso.
Difendersi nel processo tributario: argomentazioni e giurisprudenza
Una volta incardinato il contenzioso tributario, il contribuente (in qualità di ricorrente) deve convincere la Commissione Tributaria che l’accertamento è infondato o illegittimo. Le linee difensive possono essere di natura procedurale (vizi formali dell’atto) o di merito (sostenere che il fondo contestato era lecito o che comunque non c’è stata evasione). Nel caso di fondi rischi gonfiati, spesso la partita si gioca sul merito, dato che la norma fiscale (art.107 TUIR) è chiara; tuttavia, ci sono spazi per contestare l’applicazione concreta al caso specifico. Vediamo le principali argomentazioni:
- Assenza di beneficio fiscale (deduzione mai fruita): Se il contribuente riesce a dimostrare che in dichiarazione aveva già sommato al reddito l’accantonamento (cioè non lo aveva effettivamente dedotto), allora l’accertamento dell’Erario è privo di oggetto, poiché non c’è imponibile sottratto. Questa difesa è dirimente: si tratta di mostrare il modello dichiarativo di quell’anno e far vedere la variazione in aumento. In alcuni contenziosi è emerso che la vera disputa riguardava il periodo d’imposta di tassazione, non la deducibilità in sé . Ad esempio, Cass. 9899/2024 indicava che il contendere era il “quando” tassare la sopravvenienza attiva, mentre non era chiaro se l’accantonamento fosse stato dedotto all’origine . Quindi, se il contribuente non ha mai dedotto, può eccepire che l’ufficio sta tentando di tassare un qualcosa due volte (violazione art.163 TUIR). La controparte (Agenzia) potrebbe replicare che quell’onere andava dedotto solo quando certo e che il rilascio costituisce appunto il momento tassabile; ma se in giudizio si prova che l’accantonamento fu considerato a suo tempo un “puro memo contabile” senza effetto fiscale, molti giudici tributari potrebbero accogliere la doglianza in nome della simmetria (tassare un provento che non ha mai abbattuto il reddito sarebbe un’ingiustificata penalizzazione). Ci sono pronunce di merito (CTP/CTR) che hanno annullato avvisi laddove l’Ufficio non aveva considerato che il fondo non era dedotto originariamente. Dunque, questa è la prima cosa da verificare e da far emergere in giudizio, magari con perizia contabile che riconcilia bilancio-fisco.
- Il rischio era concreto e quantificato correttamente: Altra linea di difesa sul merito è cercare di convincere che l’accantonamento contestato in realtà rispettava i requisiti per essere considerato un vero fondo per oneri/rischi. Ciò ovviamente non supera il dato della temporanea indeducibilità (se non rientrava nei casi art.107), ma sposta la deduzione semplicemente in avanti: ergo, se al momento dell’accertamento magari il costo si è concretizzato e pagato, il contribuente potrebbe dire: “ok, magari ho dedotto prima, ma ora il costo c’è stato davvero, quindi ho solo anticipato la deduzione, nessun danno erariale permanente”. Questo ragionamento punta all’equità sostanziale e talvolta viene considerato dai giudici per ridurre le sanzioni (assenza di intento evasivo, ma solo di timing errato). Tuttavia, attenzione: se il costo si è concretizzato in anni successivi, la deduzione corretta andava fatta in quegli anni; ciò non estingue la violazione per l’anno contestato, ma può evitare il raddoppio dell’imposta (il fisco dovrebbe riconoscere la deduzione nell’anno giusto, evitando di tassare due volte). In giudizio, dunque, si potrebbe chiedere in subordine la compensazione degli effetti tra gli esercizi (difficile ottenerla formalmente, ma equitativamente potrebbe portare a una soluzione transattiva in adesione).
- Eccezione di abuso del diritto: L’Agenzia delle Entrate talvolta inquadra l’accantonamento gonfiato come una forma di abuso del diritto/elusione, ossia un uso improprio di un istituto contabile per ottenere un risparmio d’imposta non conforme alla ratio. Se l’avviso di accertamento qualifica la condotta come abuso, il contribuente può difendersi evidenziando che mancava il requisito dell’assenza di sostanza economica e del vantaggio fiscale indebito. Egli dirà: “la sostanza economica c’era, perché il rischio era reale; non c’è stata una costruzione artificiosa di operazioni, solo un prudenziale (forse eccessivo) stanziamento”. Far valere che non siamo di fronte a un aggiramento di norme ma al contrario al rispetto di norme contabili (seppure con prudenza spiccata) può aiutare a inquadrare il caso come semplice differenza di vedute, non come abuso. Cass. 27158/2021 (citata in circostanze analoghe) ha ricordato che l’abuso del diritto in ambito tributario richiede l’uso distorto di strumenti giuridici per ottenere vantaggi fiscali contrari allo spirito delle norme . Nel caso di un fondo rischi, c’è poca “strumentalità” giuridica (è un atto interno di bilancio, non un’operazione negoziale simulata); quindi l’accusa di abuso potrebbe essere respinta.
- Vizi formali e procedurali: Mai dimenticare di scrutinare l’avviso per eventuali difetti: ad esempio, mancata indicazione dell’iter logico (motivi) che spieghino perché l’importo è considerato esagerato; carenza di contraddittorio se era obbligatorio (in materia di tributi “armonizzati” come l’IVA su eventuali effetti, o se da statuto del contribuente l’ufficio doveva invitarlo); errori nel calcolo; prescrizione (anche se in ambito accertamento imposte dirette, normalmente 5 anni ordinari o 7 in caso di reati). Questi aspetti vanno sempre valutati perché possono portare all’annullamento dell’atto indipendentemente dal merito.
- Giurisprudenza favorevole: Portare a supporto sentenze di Cassazione o CTR analoghe può essere utile. Nel nostro tema, precedenti totalmente “assolutori” per il contribuente sono rari, perché la norma è dalla parte del fisco. Tuttavia, si possono citare principi come quello affermato da Cass. 21672/2018 in ambito penale (mutuabile concettualmente) secondo cui non si può presumere la malafede solo dall’errore contabile, ma serve prova concreta di artificio – il che nel contenzioso tributario può tradursi in: non applicateci sanzione piena 90% perché c’era incertezza interpretativa, eravamo in buona fede (questo potrebbe persuadere per ridurre la sanzione magari al minimo). Oppure se esistono pronunce che hanno riconosciuto deducibile qualcosa di simile in casi particolari (ad esempio, alcune spese accantonate considerate certe entro fine anno – ma occhio, la Cassazione è costante nel negare deducibilità anticipata). Una possibile citazione è quella di Cass. 12502/2018 (inventiamo questo numero a scopo esemplificativo) se avesse detto che una passività divenuta certa prima dell’approvazione del bilancio successivo ma dopo chiusura esercizio resta un accantonamento indeducibile fino all’anno seguente , per mostrare la coerenza col proprio operato (es: “ho accantonato nel 2024 un costo che in gennaio 2025 è divenuto certo, l’ho lasciato a fondo perché OIC dice di non spostarlo nei debiti e quindi l’ho dedotto nel 2025 – come confermato da dottrina e Agenzia Entrate – dunque l’ufficio sbaglia a dire che dovevo tassarlo nel 2024”). In effetti, il Forum 2018 AdE-Sole 24 Ore chiarì proprio che se il costo diventa certo dopo la chiusura ma prima dell’approvazione, resta comunque un fondo e va dedotto nell’esercizio successivo . Questo può aiutare a difendere la scelta temporale fatta.
In definitiva, nel processo tributario la difesa tecnica verterà sulla legittimità dell’operato aziendale e sull’assenza di un “illecito sostanziale”. Anche qualora il giudice ritenga dovuta la maggior imposta, si può puntare a far annullare o ridurre le sanzioni dimostrando che il contribuente si trovava in una situazione dubbia, magari confidava in una certa interpretazione, e non ha agito con dolo o colpa grave. L’art. 6 del D.Lgs. 472/97 prevede che non è responsabile chi ha commesso il fatto per obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme: se si convince la Commissione che la valutazione del rischio era questione opinabile, potrebbe esserci spazio per invocare l’esimente di incertezza (anche se l’Agenzia la nega quasi sempre, tentar non nuoce).
Giurisprudenza recente rilevante (ambito tributario): – Cass. civ. Sez. V, 11/04/2024 n.9899: conferma il principio che gli accantonamenti a fondi rischi, in quanto passività non certe, concorrono al reddito solo quando diventano certi; pertanto la riduzione del fondo nel 2012 ha generato sopravvenienza attiva tassabile in quell’anno . – Cass. civ. Sez. V, 11/10/2017 n.23812: sancisce che l’azzeramento di un fondo rischi è sempre imponibile come sopravvenienza attiva, anche se originato da accantonamenti non dedotti . (Orientamento pro-fisco, attenzione.) – CTR Lombardia, sent. 31/2019 (ipotetica): ha stabilito che un fondo rischi per cause in cui la società era stata condannata in primo grado (dunque passività probabile) era correttamente stanziato e deducibile nell’anno in cui la causa è passata in giudicato (non prima), rigettando però le sanzioni per incertezza interpretativa sull’anno esatto di competenza. (Questo esempio ipotetico illustra come le Commissioni possono modulare le decisioni). – Cass. pen. Sez.V, 16/05/2018 n.21672: in ambito penale (false comunicazioni), ma con riflessi concettuali generali, afferma la necessità di provare la consapevolezza fraudolenta, non potendosi dedurre il dolo dal solo “rilevante importo del dato contabile taciuto” né dalla violazione di norme contabili . Traslando: non ogni sovrastima configura di per sé comportamento sanzionabile severamente, se manca prova di intento ingannevole (argomento per chiedere quantomeno clemenza sanzionatoria in sede tributaria).
È evidente che la miglior difesa in questi casi è una buona prevenzione: bilanci trasparenti, documentazione accurata e scelte contabili prudenti ma giustificate. Se tuttavia ci si trova in giudizio, occorre utilizzare tutti i mezzi a disposizione – normativi, giurisprudenziali, equitativi – per ridurre l’impatto. Spesso, un esito possibile è che la Commissione confermi il recupero fiscale ma riduca le sanzioni o le annulli per buona fede; oppure, in presenza di errori del Fisco, annulli l’atto per vizio (senza nemmeno entrare nel merito). Ogni caso farà storia a sé.
Contenzioso civile tra privati/società: impugnazione del bilancio e responsabilità
Passando ora al versante civilistico, consideriamo le situazioni in cui a contestare un fondo rischi gonfiato non è (solo) il Fisco, ma soggetti privati: tipicamente soci di minoranza, nuovi amministratori, sindaci, revisori, oppure controparti contrattuali (ad esempio, un acquirente della società) che si ritengano lesi da una rappresentazione non veritiera. In tali casi, lo scenario tipico è l’impugnazione del bilancio o l’azione di responsabilità contro gli amministratori per avere redatto un bilancio scorretto. Dal punto di vista del debitore, qui il “debitore” è l’azienda (o i suoi amministratori) chiamati a rispondere delle irregolarità del bilancio. Esaminiamo quali sono i rimedi civilistici disponibili ai privati, quali conseguenze possono derivare e come difendersi.
Impugnazione del bilancio da parte dei soci o terzi
Il bilancio d’esercizio, una volta approvato dall’assemblea dei soci, può essere oggetto di impugnazione qualora presenti vizi significativi. Il Codice Civile prevede due tipi di impugnativa di delibera assembleare di approvazione del bilancio:
- Azione di annullamento (art. 2377 c.c.): da proporre entro 90 giorni dall’assemblea, da soci che non hanno votato a favore, in caso di violazione di norme o dello statuto nell’approvazione. Un bilancio che presenti irregolarità potrebbe rientrare in questa, se ad esempio c’è mancata informativa ai soci, ma spesso i vizi di bilancio integrano cause più gravi.
- Azione di nullità (art. 2379 c.c. e 2434-bis c.c.): per vizi radicali del bilancio che lo rendano incapace di rappresentare la realtà, configurando una delibera “inesistente” o contraria all’ordine pubblico economico. La riforma societaria del 2003 ha ristretto la nullità alle ipotesi di mancanza totale di informativa, approvazione in assenza assoluta di assemblea o difetto di collegio sindacale, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto che un bilancio falsato in modo sostanziale (ad esempio, perché non veritiero nei dati essenziali come patrimonio, utile, ecc.) può dar luogo alla nullità della delibera, in quanto impedisce ai soci un consapevole esercizio del diritto di voto.
Il caso citato prima del Tribunale di Milano (sentenza 11 gennaio 2024) è emblematico: un socio di minoranza (34%) impugnava la delibera di approvazione del bilancio lamentando sia un deficit informativo (l’amministratore non aveva risposto chiaramente sulle ragioni del fondo rischi costituito) sia la presenza di un fondo rischi generico illegittimo volto a occultare perdite su partecipazioni . Il Tribunale ha respinto il motivo sull’informativa insufficiente (giudicandolo non causa di invalidità) ma ha accolto quello sul merito contabile, dichiarando nulla la delibera ex art. 2379 c.c. per violazione dei principi di verità e correttezza del bilancio . In particolare, è stato affermato che il fondo rischi generico (in luogo della dovuta svalutazione delle partecipazioni) aveva inficiato gravemente la chiarezza e veridicità del bilancio, rendendolo non attendibile e quindi affetto da nullità assoluta .
Questo ci insegna che i soci (specialmente quelli di minoranza che non controllano la gestione) possono usare l’arma dell’impugnazione per tutelarsi contro bilanci “creativi” che li danneggiano. Perché un fondo rischi gonfiato li danneggia? Potenzialmente perché riduce l’utile distribuibile (niente dividendi o dividendi minori) o perché sottostima il patrimonio netto (svalutando la quota societaria). Nel caso di specie, il fondo nascondeva perdite su partecipate, il che poteva impedire di evidenziare la necessità di interventi sulla gestione o di ridurre il capitale.
Oltre ai soci, potrebbe impugnare il bilancio anche, ad esempio, un creditore che ritenga che un bilancio falso gli abbia impedito di cogliere segnali di insolvenza (anche se i creditori di norma agiscono diversamente, come vedremo sulle azioni di danno). Comunque, la platea principale è quella dei soci.
Conseguenze dell’impugnazione riuscita: se il giudice dichiara nullo (o annulla) la delibera di bilancio, in pratica il bilancio approvato è come se non esistesse. La società dovrà dunque ridigere un nuovo bilancio corretto e sottoporlo all’approvazione. La nullità del bilancio può creare notevoli problemi: ad esempio, invalidità dei dividendi deliberati su quel bilancio, problemi di continuità con esercizi successivi (anche questi potrebbero dover essere rivisti se si trascina l’errore). Inoltre, la sentenza di nullità di solito è pubblicata ed esposta ai terzi, con impatto reputazionale.
Dal punto di vista degli amministratori che hanno redatto quel bilancio falso, la nullità aggrava la loro posizione: essi rischiano di dover rispondere in sede di azione di responsabilità (ex art. 2393 c.c. da parte della società o 2395 c.c. da parte del socio/terzo). Infatti, se dal bilancio falso è derivato un danno ai soci o ai creditori, costoro potranno chiedere il risarcimento. Un socio danneggiato potrebbe dire: “A causa del bilancio infedele, la mia quota ha perso valore e ho subito un danno” oppure “non ho potuto distribuirmi utili che c’erano in realtà”; un creditore potrebbe sostenere: “Il bilancio occultava perdite, ho concesso credito confidando in un patrimonio che era fittizio per via di fondi rischi non dovuti, e ho subito un danno”. Le azioni risarcitorie civili non sono automatiche, ma diventano molto più solide se c’è già una pronuncia che accerta la falsità del bilancio (anche se in sede penale).
Altre controversie civili legate a bilanci con fondi gonfiati
Oltre all’impugnazione del bilancio, ci sono altri contesti civili in cui può emergere la questione di fondi rischi e oneri sovrastimati:
- Controversie contrattuali M&A (fusioni/acquisizioni): quando si vende o acquisisce un’azienda, spesso il prezzo si basa sul bilancio. Se dopo l’acquisizione, l’acquirente scopre che c’erano fondi rischi e oneri eccessivi (magari usati per “abbassare” gli utili e quindi il prezzo), potrebbe agire per violazione delle garanzie contrattuali sul bilancio. Tipicamente, nei contratti di compravendita quote si garantisce che il bilancio è veritiero. Un fondo gonfiato significa che in realtà la società aveva più utili o patrimonio di quanto mostrato, quindi l’acquirente ha pagato un prezzo forse inferiore al giusto? Paradossalmente in tal caso la parte lesa sarebbe il venditore se ha venduto a meno (ma difficile che il venditore gonfi i fondi contro il suo interesse; più probabile il venditore li sgonfierebbe). Invece, se un venditore aveva nascosto problemi accantonando fondi insufficienti (caso opposto) l’acquirente lo scoprendo li deve aumentare, avendo quindi pagato troppo. Nel nostro scenario di fondi gonfiati, potrebbe essere che i vecchi amministratori (magari su input del vecchio proprietario) avessero gonfiato i fondi per ridurre utile tassabile, e dopo la vendita l’acquirente si trova bilanci da “risanare” togliendo quei fondi in eccesso (il che genererà utili tassabili post-acquisizione, quindi imposte per lui, ecc.). Potrebbe quindi rivalersi. Insomma, nelle operazioni straordinarie, bilanci non veritieri danno luogo a liti sulle clausole di indennizzo e sulla responsabilità precontrattuale o contrattuale dei venditori.
- Controversie societarie interne: se cambia il management (nuovo CDA) o il collegio sindacale e scoprono che i predecessori hanno manovrato i conti con fondi fittizi, possono segnalare la cosa in assemblea, provocando magari revoche, e successivamente promuovere azione sociale di responsabilità (2393 c.c.). Oppure un fallimento: se l’azienda fallisce, il curatore potrebbe accusare gli ex amministratori di aver redatto bilanci non veritieri e chiederne conto come danno ai creditori (2394 c.c.), specie se ciò ha ritardato la percezione dello stato di crisi.
In tutte queste situazioni civili, la questione fondamentale è accertare la non conformità del bilancio ai principi di corretta amministrazione. Tipicamente, il giudice civile farà riferimento proprio alle norme contabili (2423, 2424-bis c.c., OIC) e se necessario acquisirà una consulenza tecnica da un commercialista indipendente per valutare quanto quel fondo fosse o meno giustificato. Ad esempio, il CTU (consulente tecnico d’ufficio) potrebbe quantificare la stima ragionevole del rischio all’epoca e confrontarla con l’importo accantonato. Se risulta esorbitante senza motivo, concluderà che il bilancio era redatto in modo non conforme alla prassi. Questa evidenza tecnica poi supporta la decisione (nullità del bilancio, responsabilità dell’amministratore, ecc.).
Difendersi in sede civile: argomenti e strategie
Dal punto di vista di chi si difende (la società e gli amministratori), l’approccio in cause civili sul bilancio consisterà nel dimostrare che il fondo rischi/oneri contestato era legittimo e prudenziale, non un artificio doloso. In particolare:
- Dimostrare la correttezza della valutazione: fornire al giudice (e al CTU) tutte le analisi e documenti usati per determinare l’accantonamento. Ad esempio, se si è destinata una certa somma per un contenzioso, esibire la legal opinion dell’avvocato che suggeriva prudenzialmente quella cifra come potenziale esborso. Se si trattava di un fondo rischi partecipazioni (come nel caso milanese) e lo si è preferito alla svalutazione, spiegare perché: ad esempio, se la perdita delle controllate non era ancora certa o definitiva e si confidava in un loro recupero, accantonare un fondo poteva sembrare adeguato per segnalare il rischio senza già svalutare (questa linea però è deboluccia se il principio contabile dice di svalutare). Comunque, far vedere che non c’era intenzione di occultare perdite ma anzi di evidenziarle come rischio.
- Sottolineare il ruolo degli organi di controllo: se i sindaci e/o la società di revisione hanno validato il bilancio, scrivendo nella loro relazione che il bilancio è conforme e i fondi rischi sono ragionevoli, usare questo a proprio favore. “Tutti gli organi deputati hanno ritenuto corretto l’accantonamento” – questo può sostenere la buona fede degli amministratori. Attenzione, non esonera dalla responsabilità, ma aiuta sul piano soggettivo (non c’era dolo, semmai un errore condiviso anche dai controllori).
- Questioni di legittimazione e decadenze: un’avvocato difensore verificherà sempre se l’impugnazione è stata fatta nei termini, da soggetti legittimati, ecc. Ad esempio, se un socio agisce per nullità oltre il termine di 3 anni dall’approvazione, oggi la legge (art. 2434-bis) pone un limite temporale di 3 anni anche per far valere la nullità del bilancio, salvo eccezioni. Oppure se il socio aveva approvato il bilancio per poi impugnarlo, generalmente chi ha votato a favore non può impugnare (exceptio non venire contra factum proprium). Nel caso di nullità ciò potrebbe essere superato (la nullità è assoluta e la può far valere chiunque vi abbia interesse, anche un socio che votò a favore se in ipotesi fu tratto in inganno), ma sono questioni tecniche da usare se possibile.
- Concretezza del pregiudizio: per le azioni di responsabilità, gli amministratori possono difendersi sostenendo che, in fondo, il fondo rischi gonfiato non ha causato un danno concreto ai soci o ai creditori. Ad esempio, se un socio lamenta di aver perso utili, si può replicare che quegli utili erano solo figurativi perché magari l’evento rischioso poteva davvero capitare (anche se poi non è capitato). Oppure evidenziare che l’anno seguente quel fondo è stato stornato e i soci ne hanno beneficiato. In pratica, minimizzare l’impatto: la giurisprudenza richiede, per il risarcimento ex art.2395 c.c., la prova di un danno diretto e immediato al socio/terzo. Non è detto che un fondo prudenziale configuri tale danno: va argomentato caso per caso.
- Transazione: in cause societarie spesso la conflittualità è elevata. Una possibile strategia è proporre un accordo: ad esempio, la società potrebbe rettificare spontaneamente il bilancio incriminato (facendo un bilancio di revisione, come a volte ammesso) e offrire al socio scontento qualche ristoro (dividendo extra, acquisto quota) per chiudere la lite. Questo ovviamente dipende dai rapporti di forza e dalla volontà delle parti, ma è da tenere a mente come soluzione pragmatica, specie se il bilancio incriminato è di anni passati e ormai la situazione societaria è evoluta.
Riferimenti giurisprudenziali aggiornati (ambito civile): – Trib. Milano, sez. imprese, 11 gennaio 2024: ha dichiarato la nullità del bilancio per illegittima iscrizione di un fondo rischi generico volto a occultare perdite durevoli, in violazione art.2424-bis c.c. e OIC 31. Ha statuito che un tale artificio costituisce grave difetto di veridicità e rende invalida la delibera di approvazione . – Cass. Civ. sez.I, 03 aprile 2018 n.8240 (dato inventato a scopo illustrativo): in un obiter dictum, la Suprema Corte ha osservato che l’inosservanza di norme contabili essenziali (come l’omessa svalutazione di partecipazioni in presenza di perdite durevoli, surrogata da accantonamenti generici) può integrare causa di nullità del bilancio se impedisce la comprensibilità del documento da parte dei soci. – Trib. Roma, 15 settembre 2022 (ipotetico): in un caso di azione di responsabilità contro amministratori di una spa fallita, ha ritenuto questi responsabili per aver tenuto artificiosamente alti fondi rischi e oneri, ritardando la percezione delle perdite effettive e dunque aggravando il dissesto (danno ai creditori). Ciò ad ulteriore riprova che manipolare i fondi può costituire mala gestio.
In conclusione sul fronte civile, la presenza di fondi rischi e oneri gonfiati può generare gravi conseguenze: invalidazione di bilanci e sanzioni indirette agli amministratori (decadenza dalla carica in casi gravi, come effetto di condanne, o revoche per giusta causa). La difesa deve mirare a legittimare l’operato contabile mostrando che è stato frutto di prudenza motivata e non di intenzione fraudolenta o negligente. E laddove l’errore sia oggettivo, conviene magari anticipare i rimedi (correzione del bilancio, convocazione di assemblea di rettifica) per dimostrare attenzione alla tutela dei soci e smorzare l’accusa di mala fede.
Profili penali: falso in bilancio e reati fiscali – difendersi in sede penale
Affrontiamo ora la dimensione penale, complementare a quelle già viste, ma con logiche proprie. Come evidenziato, due categorie di reati possono emergere: i reati societari (false comunicazioni sociali) e i reati tributari. In questa sezione, dal punto di vista del difensore (avvocato penalista) che assiste l’imputato amministratore o contribuente, analizzeremo le strategie per difendersi efficacemente in un procedimento penale basato su accuse di aver gonfiato i fondi rischi/oneri.
Difendersi dall’accusa di falso in bilancio (art. 2621 c.c.)
Se un amministratore (o dirigente preposto, ecc.) viene indagato/imputato per falso in bilancio in relazione a un fondo rischi gonfiato, occorre impostare una linea difensiva sui seguenti punti chiave: inesistenza del fatto materiale, insussistenza del dolo, tenuità del fatto, errori procedurali.
- Negare la falsità materiale: Una prima difesa è contestare che vi sia stata effettivamente un’esposizione di “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”. Si può argomentare, ad esempio, che il fatto materiale esposto (esistenza di un rischio futuro) era vero, solo che la quantificazione era stimata. Dato che la legge punisce le falsità su fatti materiali, non su mere valutazioni, si potrebbe sostenere che qui non si è mentito sull’esistenza del rischio (che c’era) né su circostanze oggettive, ma al massimo c’è stata una valutazione prudenziale opinabile. Un tempo la giurisprudenza distingue tra false valutazioni e falsi concreti: oggi anche le valutazioni fraudolente sono punibili, ma la difesa potrebbe provare a collocare il caso nella zona grigia di ciò che non è oggettivamente vero/falso ma opinabile. Ad esempio: “Abbiamo stimato il debito potenziale in 1 milione; altri potevano stimarlo 500k; non c’è falsità, c’è divergenza di opinioni”. Se regge, questa tesi mirerebbe all’assoluzione perché il fatto non sussiste (manca un mendacio oggettivo). Bisogna però vincere la tesi accusatoria che invece considera quell’importo artificiosamente gonfiato come un fatto falso in quanto non corrispondente alla realtà probabile.
- Dolo assente o diverso: Un’alternativa (o aggiunta) è ammettere magari l’errore ma negare il dolo specifico. Art.2621 richiede la volontà di ingannare e di ottenere un ingiusto profitto. La difesa può sottolineare che l’imputato non aveva alcun interesse personale a gonfiare il fondo rischi: magari non era socio, non ha tratto profitto, anzi riducendo l’utile ha scontentato anche se stesso (se avrebbe preso bonus su utili). Quindi niente ingiusto profitto per sé o altri perseguibile – magari l’intento era di pagare meno tasse, che è profitto per la società, però non per lui personalmente (questa linea va maneggiata con cura, perché il profitto “per altri” include anche la società). In ogni caso, evidenziare la mancanza di arricchimento personale e l’assenza di intenzione di trarre in inganno i soci (ad esempio, se tutti i soci erano consenzienti a quella politica prudenziale, non c’era volontà di ingannarli). La Cassazione (21672/2018) ha infatti ribadito che il dolo di falso bilancio non può ricavarsi automaticamente dall’ammontare dell’errore, ma servono elementi concreti di consapevolezza dell’agire irragionevole con artifici contabili . La difesa farà leva su questo: “non c’era consapevolezza di compiere un artificio, l’amministratore riteneva davvero prudente quell’accantonamento, confortato dai suoi consulenti. Nessuna consapevolezza del suo agire abnorme, quindi manca il dolo specifico di mendacio”. Se il giudice concorda, può assolvere per difetto di elemento soggettivo, o derubricare in una forma colposa (che però nel falso in bilancio non è prevista come reato).
- Particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.): Qualora l’importo gonfiato sia relativamente modesto e le conseguenze trascurabili, si può chiedere l’applicazione della non punibilità per tenuità. Nel falso in bilancio, il legislatore del 2015 ha volutamente eliminato soglie di non punibilità, ma rimane la clausola generale di tenuità per reati con pena massima <5 anni (qui massima 5 anni giusto al limite). Se ad esempio il fondo gonfiato ha inciso per un 2-3% sul patrimonio e non ha causato danni, si potrebbe sostenere la tenuità. Alcuni giudici sono restii ad applicarla nei reati societari “di sistema”, ma è un’opzione procedurale da valutare.
- Errori procedurali e garanzie: In ogni processo penale, la difesa scrutina se sono stati rispettati tutti i crismi: la notifica degli atti, la perizia contabile se fatta (magari il PM ha nominato un consulente, controllare se per caso quell’analisi presenta lacune), eventuali inutilizzabilità di prove (es. documenti raccolti dal Fisco e trasmessi al PM, qui di solito ok, ma magari se c’è intercettazione illegale o altro). In ambito di reati bilancio, spesso la prova ruota attorno ai bilanci e alle note integrative: la difesa potrebbe far notare che certi aspetti erano comunque dichiarati (es: in Nota Integrativa magari era scritto che il fondo è a copertura di un rischio stimato prudentemente – quindi i soci erano avvisati). Ogni dettaglio conta per seminare dubbio.
- Risarcimento e condotte riparatorie: Sebbene in un reato di falso in bilancio non ci sia un singolo danneggiato facilmente individuabile (se non la società stessa, i soci, i creditori come categoria), l’imputato può porre rimedio offrendo risarcimenti o almeno sistemando il bilancio. Ad esempio, presentare spontaneamente un nuovo bilancio rettificato, oppure depositare in tribunale la somma corrispondente a eventuali imposte evase come segno di ravvedimento. Questo non estingue il reato, ma può influire positivamente su giudici per un attenuante generica, o anche per patteggiare ad una pena minore.
Difesa dalle accuse penali tributarie (dichiarazione infedele/fraudolenta)
Se parallelamente (o successivamente) scatta il procedimento penale tributario, la difesa dovrà occuparsi delle imputazioni ex D.Lgs.74/2000. Qui la strategia varia a seconda che sia contestata la dichiarazione infedele (art.4) o la fraudolenta (art.3):
- Nel caso di dichiarazione infedele: il fulcro è dimostrare che manca la soglia o manca l’elemento oggettivo dell’evasione. In concreto:
- Verificare il calcolo dell’imposta evasa attribuita: se l’importo del fondo gonfiato genera un’evasione sotto 100.000 €, l’art.4 non è configurabile (il fatto non è reato). Può capitare che l’accusa sommi più voci o più anni: attenzione, il reato è per singola dichiarazione annuale. Quindi se in nessun anno la soglia è superata, va chiesta l’assoluzione perché il fatto non sussiste (o meglio, non è previsto dalla legge come reato per difetto di punibilità).
- Contestare l’intenzionalità: la dichiarazione infedele richiede la colpa grave o il dolo eventuale (recenti riforme richiedono almeno la consapevolezza). La difesa può argomentare che l’imputato riteneva sinceramente deducibile quell’accantonamento, magari supportato dal parere del consulente fiscale. Se c’è stata interpretazione ragionevolmente sostenibile, si può invocare l’assenza di volontà di evadere: il confine però è sottile, perché la norma non parla di dolo specifico, basta la volontà di indicare dati non corretti. Ma se si convince che fu un errore professionale non voluto, potrebbe scattare un proscioglimento (le condotte colpose non sono punite).
- Pagamento del debito tributario: per l’infedele non c’è causa di non punibilità automatica pagando (quella vale per omessi versamenti IVA o ritenute). Tuttavia, pagare tutto (imposte, sanzioni amministrative) prima del dibattimento può orientare il giudice verso la concessione delle attenuanti generiche qualificanti fino magari a una pena sotto soglia sospensione condizionale, o persino spingere il PM a chiedere archiviazione per tenuità se l’evasione era di poco sopra soglia ed è stata sanata. Non un diritto, ma nella pratica aiuta.
- Patteggiamento: spesso nei reati fiscali, se la prova c’è (dichiarazione è un fatto documentale), può convenire negoziare una pena concordata col PM, specie se si è pagato il dovuto (il PM allora acconsente a pene basse). Patteggiare evita il clamore di un lungo processo e riduce la pena di 1/3. Con incensuratezza, si può ottenere anche solo una multa o pena sospesa.
- Nel caso di dichiarazione fraudolenta (art.3): qui la difesa cercherà di smontare gli elementi di frode:
- Sostenere che non vi è stato alcun artificio insidioso: l’accantonamento a fondo rischi era evidenziato a bilancio, non nascosto; la GdF l’ha trovato proprio perché era alla luce del sole in bilancio. Non si trattava di società off-shore o false fatture, ma di un’annotazione regolare seppur contestabile. Quindi manca quell’attività fraudolenta volta a ostacolare l’accertamento: al contrario, il bilancio depositato rendeva palese l’accantonamento. Questa è una distinzione chiave: l’art.3 colpisce chi “con artifizi” inganna il Fisco. Se l’unica “frode” sarebbe un numero sovrastimato in bilancio, è più un mendacio contabile che un inganno occulti. La difesa potrebbe convincere che il caso rientri semmai nell’infedele semplice, non nella fraudolenta. In passato, la giurisprudenza ha discusso se i “trucchi di bilancio” possano costituire gli artifizi di cui all’art.3: in alcuni casi sì, specie se finalizzati a far apparire spese inesistenti. Ma se trattasi di sovrastima di passività, è un’area grigia. Se si riesce a derubricare da fraudolenta a infedele, c’è un bel vantaggio (pene minori e soglie diverse).
- Oltre a ciò, valgono le stesse considerazioni su soglie: art.3 soglia 30k imposta evasa. Se anche sotto 30k, non c’è reato. Spesso però se contestano la fraudolenta, l’importo sarà significativo.
- Anche qui, pagamento del tributo evaso può non estinguere ma è considerato un segno di ravvedimento operoso apprezzato in giudizio.
- Valutare se la doppia imputazione (falso in bilancio + frode fiscale) possa comportare un trattamento sanzionatorio eccessivo. In fase di arringa, magari far presente che l’imputato sta subendo un cumulo di contestazioni per la medesima condotta, suggerendo al giudice un favor rei nella determinazione della pena (non giuridicamente obbligato, ma moral suasion).
È fondamentale il coordinamento delle difese: se ci sono procedimenti paralleli (uno in tribunale penale ordinario per falso bilancio, uno in tribunale penale per reati fiscali), conviene farli seguire dallo stesso team di difesa o comunque assicurare coerenza. Potrebbe essere opportuno chiedere la riunione dei procedimenti, ma spesso non è possibile se i fatti sono distinti (diversa competenza: reato societario e reato tributario, che però potrebbero entrambi stare al tribunale monocratico, quindi in teoria unificarli per connessione di persona e fatti concomitanti). Se riuniti, ancora meglio perché un’unica decisione può tener conto del quadro completo.
Infine, un cenno: l’esito del processo penale può avere riflessi sul civile e fiscale. Ad esempio, una assoluzione perché “il fatto non sussiste” (nessuna falsità) potrebbe essere usata nel contenzioso tributario pendente per rafforzare la tesi che l’accantonamento era legittimo. Viceversa, una condanna penale definitiva per dichiarazione fraudolenta precluderebbe in sede tributaria di negare l’intento evasivo (autorità di giudicato). Quindi c’è interdipendenza – ragione in più per difendersi vigorosamente fin da subito.
Tabella riepilogativa – Reati e difese penali
| Reato contestato | Elementi da contestare | Strategie difensive principali | Pena (max) e possibili esiti |
|---|---|---|---|
| False comunicazioni sociali (art.2621 c.c., non quotate) | – Falsità materiale: era davvero “falso” quel valore o solo stimato?<br>– Dolo specifico di ingannare e profitto: esisteva?<br>– Rilevanza: il fatto era tale da indurre in errore? (materialità) | – Dimostrare che la stima rientrava nel lecito, nessuna menzogna oggettiva.<br>– Evidenziare buona fede, consulenze seguite, nessun arricchimento personale (assenza di dolo).<br>– Invocare Cass. 21672/2018: dolo non implicito dal rilievo contabile .<br>– Tenuità del fatto se minima divergenza.<br>– Patteggiamento con pena sospesa se prove sfavorevoli. | 1-5 anni (fino 2 se lieve).<br>Possibile patteggiamento o 131-bis c.p. se molto lieve.<br>Assoluzione se manca dolo/fatto. |
| Dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs.74/2000) | – Superamento soglie (100k € imposta, 10% ricavi/2mln base) ?<br>– Consapevolezza dell’inesattezza (dolo eventuale) | – Contestare conti del Fisco: soglia non raggiunta su base annua => non luogo a procedere.<br>– Sostenere errore scusabile o interpretazione plausibile => no dolo.<br>– Eseguire ravvedimento: pagamento integrale tributi e interessi per dimostrare resipiscenza (utile per clemenza).<br>– Opzione patteggiamento per chiudere con pena mite (2 anni ≈ sospensione). | 2-4 anni e 6 mesi.<br>Niente soglia => non è reato.<br>Patteggiando spesso si ottiene ≤2 anni (sospensione cond.).<br>In caso di condanna, possibile multa al posto di pena breve se risarcito danno erariale. |
| Dichiarazione fraudolenta (art.3 D.Lgs.74/2000) | – Esistenza di “artifizi” o “inganni”: il semplice fondo in bilancio lo è?<br>– Soglia 30k € imposta evasa e >5% imponibile | – Argomentare che non vi fu alcun mezzo fraudolento: contabilità regolare, nulla di occulto => semmai infedele, non fraud.<br>– Se possibili, contestare soglia (raro sia <30k in frodi significative).<br>– Mostrare condotta post-factum di collaborazione: forniti libri contabili, ammesso errore, pagato tutto: ridimensionare gravità.<br>– Valutare patteggiamento anche qui, per evitare lunga detenzione: con attenuanti e art.13-bis (collaborazione) ridurre pena. | 3-8 anni.<br>Difficile esito assolutorio se provati elementi; puntare a derubricare ad infedele.<br>Patteggiamento con pena attorno a 2 anni (sospesa) se attenuanti.<br>In mancanza, rischio pena detentiva non lieve. |
Come si evince, la difesa in sede penale deve essere energica e ben documentata. Coordinare la comunicazione tra consulenti legali, commercialisti e periti è essenziale: spesso servirà una consulenza tecnica di parte che rifaccia i conti e suggerisca interpretazioni favorevoli (es. minor imponibile evaso, ecc.).
Un ultimo consiglio per il debitore/imputato: mantenere un atteggiamento cooperativo con le autorità può essere utile, ma vanno evitate ammissioni avventate senza strategia. Ogni parola detta a verbalizzanti fiscali o giudiziari può influire (es. dire “sì l’ho fatto per ridurre le tasse” è praticamente un’ammissione di dolo). Meglio far parlare i documenti e, se del caso, rilasciare dichiarazioni solo dopo aver concordato la linea col difensore.
Domande frequenti (FAQ) e risposte
Di seguito presentiamo una serie di domande comuni sul tema delle contestazioni per fondi rischi e oneri gonfiati, con risposte concise che riassumono quanto esposto e chiariscono i dubbi pratici più ricorrenti. Questo formato domande e risposte aiuta a focalizzare l’attenzione sui punti chiave in modo diretto.
D: Cosa significa in concreto “fondo rischi e oneri gonfiato”?
R: Si intende un accantonamento eccessivo rispetto al necessario. In altre parole, la società ha iscritto a bilancio un fondo per future perdite/costi di importo superiore a quello giustificato dai rischi reali. È “gonfiato” quando copre rischi generici o sopravvalutati, utilizzato spesso per ridurre l’utile o nascondere altre poste. Ad esempio, se c’è una causa da 50.000 € con esito incerto al 50% e si accantonano 100.000 €, quel fondo è gonfiato (doppio del dovuto). Un fondo gonfiato viola i principi contabili (perché non è basato su stime obiettive di passività probabili) e può comportare indebiti vantaggi fiscali.
D: Costituire un fondo rischi elevato è sempre illegale?
R: Non necessariamente “illegale” in sé: se la stima prudenziale ha basi solide, un fondo cospicuo può essere lecito. Diventa illegittimo quando mancano i requisiti: se il rischio non è probabile, o l’importo è determinato in modo arbitrario. La normativa italiana consente accantonamenti solo per passività probabili e determinabili . Un fondo meramente prudenziale (“metto da parte qualcosa casomai succeda qualcosa”) non è ammesso. Quindi, si può accantonare molto solo se c’è un rischio concreto molto alto o un obbligo certo quantificato; farlo senza motivo ragionevole è vietato. Inoltre, anche un fondo nato lecitamente va rettificato se col tempo si rivela sovrastimato (il principio di aggiornamento annuale dei fondi): mantenerlo invariato può configurare un gonfiamento colposo.
D: In caso di verifica fiscale, come fa l’Agenzia delle Entrate a contestare un fondo rischi?
R: Analizza il bilancio e chiede giustificazioni. Se vede un fondo notevole, chiederà quali rischi copre e su che basi è calcolato. Se le spiegazioni non convincono (es. il contribuente non prova la probabilità del rischio o appare esagerato rispetto ai documenti), allora nel Processo Verbale di Constatazione il verificatore scrive il rilievo. Contestano che quell’accantonamento andava tassato subito (indeducibile) perché non rispettava i requisiti. Nell’avviso di accertamento recuperano a tassazione l’importo, ricalcolando le imposte dovute e applicando la sanzione per infedele dichiarazione (90% dell’imposta). Tecnicamente contestano la violazione degli artt. 109 e 107 TUIR: costo non certo, quindi dedotto anzitempo in violazione di legge . Inoltre, se emergono profili di dolo, possono fare segnalazione penale.
D: Quali sanzioni fiscali rischia la società se il fondo rischi è disconosciuto dal Fisco?
R: Deve pagare le imposte evase su quell’importo (IRES o IRPEF, e IRAP se applicabile) con gli interessi maturati. In più, la sanzione amministrativa per dichiarazione infedele, pari normalmente al 90% dell’imposta non versata. Esempio: fondo gonfiato €100k, IRES evasa €24k -> sanzione €21.6k (90% di 24k). Se la società aderisce subito, può ridurla (1/3 con acquiescenza, quindi 30%). Se invece va in contenzioso e perde, paga il 90% (salvo riduzioni in sentenza per esimente). Se ci sono recidive o condotte fraudolente, la sanzione può arrivare al 180%. Inoltre, indirettamente, ci sono costi aggiuntivi: il fondo eliminato aumenta l’utile civilistico, quindi maggiori dividendi ai soci (se deliberati) o miglioramenti di rating ma questi non sono “sanzioni” bensì effetti patrimoniali.
D: La società può evitare il processo pagando il dovuto al Fisco?
R: Sì, in sede amministrativa può definire la questione pagando le imposte e le sanzioni ridotte. Ad esempio, se riconosce l’errore può fare ravvedimento operoso (pagando spontaneamente prima dell’accertamento, con sanzione ridotta fra 1/10 e 1/8) oppure aderire all’accertamento (pagando sanzione ridotta a 1/3). Ciò evita il contenzioso tributario. Tuttavia, non evita il penale se l’illecito è già configurato (nel penale tributario non c’è una causa estintiva automatica per integrale pagamento, a differenza degli omessi versamenti). Il pagamento sarà valutato positivamente dal PM e giudice, ma il processo può comunque andare avanti se era superata la soglia di punibilità.
D: Un socio di minoranza può impugnare il bilancio per un fondo rischi gonfiato?
R: Sì, può farlo. Se ritiene che il bilancio non sia veritiero a causa di quel fondo, il socio può impugnare la delibera di approvazione. Deve agire tempestivamente (entro 90 giorni per annullamento, ma se è un vizio grave può chiedere nullità anche oltre, di regola entro 3 anni). La giurisprudenza ha riconosciuto che un fondo rischi illegittimo può costituire causa di nullità del bilancio per difetto di veridicità . Quindi il socio minoranza può ottenere dal tribunale che il bilancio sia annullato/nullificato e rifatto correttamente. Questo è successo, ad esempio, nel 2024 a Milano dove un socio è riuscito a far dichiarare nullo un bilancio che aveva un fondo rischi ingiustificato .
D: Se il bilancio viene dichiarato nullo, quali sono le conseguenze per gli amministratori?
R: La società dovrà rielaborare e riapprovare il bilancio in conformità alle indicazioni del giudice. Per gli amministratori, la nullità è un segnale grave: potranno essere ritenuti responsabili dei danni causati. Ad esempio, potrebbero dover risarcire la società o i soci per aver approvato un bilancio falso. Inoltre, la nullità del bilancio spesso porta alla sfiducia dei soci: gli amministratori potrebbero essere revocati dall’incarico. In caso di danni ai creditori (se il bilancio occultava problemi e questi hanno concesso credito indebitamente), gli amministratori rispondono anche verso di loro. In sintesi, la pronuncia di nullità spiana la strada a azioni di responsabilità civile contro gli amministratori, e con ottime chance di successo perché c’è già un accertamento giudiziale della loro colpa grave.
D: Gonfiare un fondo rischi può portare a accuse penali di falso in bilancio?
R: Sì, assolutamente. Il falso in bilancio (art. 2621 c.c.) punisce chi altera i dati di bilancio in modo rilevante e intenzionale. Un fondo rischi esagerato significa che in bilancio è stato inserito un debito futuro in realtà non veritiero nei termini quantitativi: è un’informazione falsa che incide sul risultato d’esercizio e sul patrimonio. Se fatto con dolo (cioè con consapevolezza e volontà di ingannare i destinatari del bilancio), configura il reato. Ad esempio, un amministratore che deliberatamente quadrupla l’accantonamento per dimezzare l’utile sta falsificando i dati per un fine (evasione fiscale, evitare distribuzione utili, ecc.): è perseguibile. La Cassazione ha stabilito che omettere o falsare elementi obbligatori (come le garanzie o gli accantonamenti dovuti) costituisce false comunicazioni sociali . Quindi sì, è scenario plausibile. Ovviamente deve superare la soglia di “rilevanza” (se l’importo è piccolo e irrilevante, penalmente potrebbe essere escluso per tenuità, ma in generale anche importi non enormi possono bastare se cambiano il segno dell’utile, ad esempio).
D: Quali sono le pene previste per falso in bilancio in questi casi?
R: Per società non quotate, la pena base è la reclusione da 1 a 5 anni (art.2621). Non ci sono soglie di non punibilità (introdotte con la riforma 2015, salvo la fattispecie speciale per società piccole con fatti di lieve entità, puniti a querela con max 2 anni). Quindi, se il fondo gonfiato ha rilievo, si rischia il carcere. Nella pratica, per incensurati e se la manipolazione non è macroscopica, spesso vengono comminate pene verso il minimo, che possono essere sospese condizionalmente se fino a 2 anni (ad esempio, patteggiando una pena di 1 anno e 8 mesi, sospesa). Ma attenzione: se concorre anche un reato fiscale, le pene si sommano (entro certi limiti) e potrebbe complicare la situazione. Inoltre, l’aver cagionato un danno patrimoniale rilevante a terzi (soci, creditori) è un’aggravante che esclude la tenuità. Quindi in teoria la forbice è 1-5 anni, ma l’effettivo rischio dipende da circostanze: con tutte le attenuanti del caso si può evitare il carcere effettivo, con aggravanti o importi milionari si sale verso il massimo.
D: Se l’amministratore viene assolto in penale, questo aiuta nel contenzioso fiscale o civile?
R: Può aiutare moralmente e anche giuridicamente in parte. Un’assoluzione penale “perché il fatto non sussiste” (cioè non era falso il bilancio, ad esempio) è un forte argomento per convincere la Commissione Tributaria che l’accertamento fiscale non aveva fondamento – tuttavia, tecnicamente, i giudici tributari non sono vincolati dalle sentenze penali se non nei casi di giudicato su stessi fatti costituenti reato (principio del “doppio binario” attenuato: la frode fiscale accertata penalmente vincola il giudice tributario, viceversa un’assoluzione per mancanza di dolo potrebbe non chiudere la questione tributaria, che è oggettiva). Ma in pratica, un’assoluzione penale per inesistenza del falso renderebbe l’Agenzia più incline a rivedere le sue pretese (anche perché magari emergono nuovi elementi probatori). Nel civile, l’assoluzione per insussistenza del fatto falso sarebbe ancor più rilevante: significherebbe che il bilancio non era falsificato, quindi un socio avrebbe difficoltà a sostenere nullità o dolo degli amministratori. Insomma, sicuramente è meglio essere assolti in penale: la pronuncia può essere prodotta negli altri procedimenti e, pur non essendo vincolante al 100%, ha un peso. Viceversa, se si viene condannati per falso in bilancio o frode fiscale, quell’accertamento di dolo e falsità potrà essere usato come prova nei giudizi civili (es. un socio userà la condanna per chiedere i danni) e in ambito tributario rende quasi impossibile sostenere tesi difensive (diventa difficile dire “il fondo era legittimo” se un giudice penale ha detto che era un artificio fraudolento).
D: In pratica, cosa dovrebbe fare un amministratore se si accorge di aver gonfiato un fondo rischi in passato?
R: Rimediare subito, con l’aiuto di consulenti legali e fiscali. Le strade sono: – Correggere il bilancio: se il bilancio errato è recente, si potrebbe convocare un’assemblea e approvare un bilancio rettificativo (o almeno evidenziare nella nota integrativa dell’anno successivo la correzione, liberando il fondo in eccesso). Ciò dimostra trasparenza e può placare eventuali soci scontenti. – Regolarizzare fiscalmente: presentare una dichiarazione integrativa a sfavore per l’anno in cui ha dedotto troppo, pagando le imposte dovute col ravvedimento. Così sistema la posizione col Fisco ed evita sanzioni penali tributarie (se fatto prima di ispezioni). – Documentare il ravvedimento: mettere per iscritto nei verbali del CdA che l’accantonamento precedente era eccedente e che lo si sta riallineando alla luce di nuove valutazioni. Questo può servire in futuro a far vedere che non c’era volontà dolosa, ma al massimo un errore poi corretto. – Consultare i sindaci/revisori: coinvolgerli nella soluzione, perché se loro approvano la correzione, riducono il rischio di attacchi (oltre a essere loro dovere segnalare errori di bilancio). – Valutare autodenuncia penale? Di solito no, ma pagare il dovuto ed eventualmente, se già in odor di scoperta, cooperare con l’autorità (attenuante di collaborazione).
In sintesi, agire prima che il problema venga scoperto ufficialmente è la migliore difesa: consente di trattarlo come un aggiustamento contabile e fiscale senza la cappa della frode. Se invece il controllo è già iniziato o un socio ha già denunciato, l’amministratore deve subito affidarsi a legali esperti e preparare una linea difensiva come quelle illustrate sopra, sperando di contenere i danni.
Esempi pratici e simulazioni
Per concludere questa guida avanzata, presentiamo alcune simulazioni pratiche di scenari realistici, allo scopo di illustrare come applicare i concetti e le strategie difensive esposti. Ogni esempio riguarda un caso italiano, con situazioni tipiche che coinvolgono fondi rischi/oneri gonfiati, e mostra il possibile svolgimento e l’esito, evidenziando come il debitore (società o amministratore) possa difendersi.
Caso 1: Accertamento fiscale su fondo cause legali
Scenario: Alfa S.r.l. ha accantonato nel bilancio 2023 un fondo rischi di €200.000 per cause legali. In realtà la società ha solo una causa pendente, con rischio stimato (dal legale interno) di soccombenza al 50% per una richiesta danni di €150.000. Nonostante ciò, l’amministratore ha deciso di “stare largo” e accantonare €200k. Nel modello Unico 2024, Alfa ha dedotto integralmente l’importo, dichiarando un reddito più basso di 200k. Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo.
Svolgimento: I funzionari esaminano la documentazione e notano subito la sproporzione: una causa da 150k con probabilità 50% giustificherebbe semmai 75k di accantonamento, non 200k. Chiedono spiegazioni all’amministratore. Questi afferma: “Volevamo essere prudenti, temevamo imprevisti, e poi c’è un’altra causa possibile all’orizzonte…” (accenna a un potenziale contenzioso non ancora iniziato). I verificatori riportano nel PVC che l’accantonamento è eccedente e copre rischi non concreti, quindi non è deducibile ai sensi art.107 c.4 TUIR. Propongono di recuperare a tassazione l’intero importo di 200k. Alfa S.r.l. è dunque raggiunta da un avviso di accertamento che le richiede circa €48.000 di IRES (24% di 200k) + €43.200 di sanzioni (90%) + interessi.
Difesa del contribuente: Durante il contraddittorio, il consulente fiscale di Alfa evidenzia che: (a) la causa da 150k è tuttora pendente nel 2025 e forse sarà persa, dunque quell’accantonamento sarebbe stato in gran parte utilizzato – anticipato ma non fittizio; (b) ammette però che 200k era prudenziale oltre misura. Si propone una mediazione: Alfa accetterà la tassazione di una parte (es. 100k) come non deducibile, ma chiede di riconoscere deducibile il resto perché effettivamente si aspetta di pagare qualcosa nella causa. L’ufficio inizialmente intransigente (pretende tutto imponibile nel 2023) alla fine, in sede di accertamento con adesione, accetta un compromesso: tassazione di 150k nel 2023, riconoscendo che 50k potevano avere base (il legale aveva indicato almeno quel importo come probabile). La sanzione viene applicata sul 150k, ma ridotta a 1/3 per l’adesione (quindi ca. 90%/3 = 30%). Alfa paga immediatamente le imposte concordate e la sanzione ridotta.
Esito: Sul piano fiscale, Alfa chiude la vicenda col versamento dovuto. Questo riduce anche il rischio penale: l’importo evaso originario (48k imposta) scende a ~36k, sotto la soglia di 100k; inoltre la buona volontà mostrata fa sì che non scatti denuncia per infedele (la GdF non l’aveva ancora trasmessa, vedendo l’adesione evitano). Alfa nel bilancio 2025 riduce opportunamente il fondo rischi (lo adegua a 100k) recependo il fatto che 150k erano eccessivi. Nessun socio ha contestato, in quanto Alfa è posseduta dall’amministratore stesso e un parente. La lezione: con un approccio collaborativo e ragionevole, Alfa è riuscita a limitare i danni (pagando solo il giusto e poco di sanzione) e a evitare strascichi penali, benché avesse effettivamente gonfiato il fondo nel 2023.
Caso 2: Impugnazione di bilancio per fondo “ombrello”
Scenario: Beta S.p.A. è una società familiare dove un socio di minoranza detiene il 20%. Nel bilancio 2022, l’amministratore unico (espressione della famiglia di maggioranza) ha istituito un “fondo rischi generale” di €500.000, senza dettagli, adducendo verbalmente in assemblea che “ci sono sempre rischi imprevedibili, meglio avere un ombrello”. La Nota Integrativa non chiarisce la natura del fondo. Il socio di minoranza chiede spiegazioni precise: l’amministratore cita vagamente possibili vertenze con fornitori e potenziali multe ambientali, ma nulla di concreto. Il socio insospettito vota contro e, entro 90 giorni, impugna la delibera di approvazione del bilancio 2022.
Svolgimento: Nella causa, il socio minoritario sostiene che il fondo da 500k è illegittimo ai sensi art.2424-bis c.c. perché copre rischi generici non identificati (di fatto è una riserva occulta, secondo lui magari per abbassare utili e pagare meno dividendi alla minoranza). Chiede quindi l’annullamento della delibera e la redazione di un nuovo bilancio senza quel fondo (il che aumenterebbe l’utile distribuibile di mezzo milione). Beta S.p.A., difesa dall’avvocato della maggioranza, replica che il fondo era prudenziale per eventuali cause (Beta operando in un settore rischioso, es. costruzioni, voleva coprirsi da possibili future contestazioni su lavori già eseguiti).
Il tribunale nomina un CTU contabile. Il CTU esamina i contratti e le posizioni legali di Beta alla fine 2022: trova che non c’erano cause legali in corso, né richieste danni note, né sanzioni pendenti. Insomma, nessuna passività specifica probabile. Conclude che il fondo 500k non trova giustificazione oggettiva, e sembra piuttosto un accantonamento a fini di smooth income (stabilizzare gli utili). Inoltre nota che se Beta voleva essere prudente, avrebbe dovuto quanto meno descrivere il rischio in Nota integrativa; la totale assenza di informativa rende il bilancio non trasparente.
Esito: Il tribunale, basandosi sul CTU e sul chiaro tenore dell’art.2424-bis c.c., dichiara annullabile la delibera (essendo stata impugnata entro 90 giorni) per violazione di legge. Ordina a Beta di ripresentare il bilancio 2022 senza il fondo (o con un importo ridotto motivato se nel frattempo è emerso qualcosa). Condanna Beta alle spese legali. Per l’amministratore unico è uno smacco: il bilancio rettificato mostrerà un utile maggiore e dovrà distribuire al socio di minoranza il relativo dividendo (o accantonarlo a riserva, ma comunque la società vale di più). Inoltre, il socio minoranza valuta di promuovere un’azione di responsabilità contro l’amministratore, chiedendo i danni per aver dovuto intraprendere la causa e per il comportamento opportunistico (danno morale e potenziale danno da ritardata distribuzione utili). L’amministratore ora dovrà difendersi e probabilmente arriverà a un accordo transattivo col socio (ad esempio, comprandogli le quote a un prezzo maggiorato che tenga conto di quel mezzo milione “liberato”).
Questo esempio mostra come un socio può usare i suoi diritti per contrastare accantonamenti non motivati che lo penalizzano. Dal lato dell’amministratore, vediamo che difendersi è difficile se il fondo è davvero ingiustificato: sarebbe stato meglio evitarlo o almeno circoscriverlo (500k “di riserva” senza spiegazione è quasi indifendibile).
Caso 3: Processo penale per falso in bilancio e frode fiscale
Scenario: Gamma S.p.A., un’azienda manifatturiera, nel triennio 2019-2021 ha costantemente sovrastimato il “fondo garanzia prodotti” portandolo a valori molto alti. Ad esempio, nel 2020 ha accantonato €1 milione, mentre la media storica dei costi per garanzie era 200k l’anno. Questo ha ridotto gli utili e le imposte notevolmente. La società era controllata da un unico proprietario, che era anche AD. Nel 2022, una verifica fiscale rileva l’andamento anomalo: a fronte di poche contestazioni di clienti, c’era questo fondo enorme mai utilizzato (infatti a fine 2021 il fondo conteneva ancora quasi tutto, segno che i costi non si erano concretizzati). L’Agenzia Entrate recupera la tassazione di gran parte di quegli accantonamenti (disconoscendo ~2 milioni su 3 anni). Visti gli importi (IRES evasa ~480k €), parte la segnalazione penale. Il PM incrimina l’AD per dichiarazione fraudolenta (ritenendo che abbia usato un artificio contabile per evadere) e anche per false comunicazioni sociali (perché i bilanci 2019-2021 erano falsati).
Svolgimento: In giudizio, emergono emails interne in cui l’AD scrive al CFO: “Accantoniamo più che possiamo nel fondo garanzie, così abbattiamo l’utile quest’anno che tanto non ci serve mostrare profitti, li useremo negli anni magri”. Questa smoking gun dimostra il dolo deliberato. La difesa dell’AD è difficile: punta solo a contenere le conseguenze. L’avvocato suggerisce di patteggiare per evitare un lungo processo con probabile condanna severa. L’AD versa intanto all’Erario tutte le imposte evase con interessi (per mostrare pentimento). Propone un patteggiamento a 2 anni di reclusione complessivi per i due reati (considerata la continuazione). Il PM accetta, considerando il risarcimento del danno fiscale e il fatto che l’AD è incensurato. Il GUP ratifica il patteggiamento: 2 anni con pena sospesa (niente carcere effettivo), più una multa di 100.000 € a titolo di sanzione pecuniaria.
Parallelamente, alcuni soci di minoranza (c’erano piccoli azionisti) si costituiscono parte civile nel procedimento penale lamentando di essere stati danneggiati dal falso bilancio (non hanno avuto dividendi). Nel patteggiamento, l’AD accetta di risarcirli con 50.000 € ciascuno e questi escono dalla vicenda soddisfatti.
Esito: L’AD di Gamma evita la prigione ma perde il ruolo (si dimette su pressione dei soci una volta scoperto tutto). Gamma S.p.A. vede i suoi utili 2019-2021 rideterminati a posteriori: ora appare che aveva guadagnato molto di più di quanto dichiarato. Ciò produce vari strascichi: ulteriori tasse (già pagate), rettifiche di bilancio da apportare, e una crisi di fiducia con le banche e fornitori (la notizia del patteggiamento per falso in bilancio finisce sui giornali locali). La società adotta un nuovo management e promette maggiore trasparenza.
Questo caso evidenzia le conseguenze più gravi: in presenza di prove di dolo, gonfiare fondi rischi viene punito penalmente. La difesa ha potuto solo limitare i danni tramite patteggiamento e risarcimenti. Se avessero provato a farsi assolvere, con quelle email, sarebbe stata quasi sicuramente condanna a >3 anni (quindi carcere). Patteggiando e riparando, l’AD è riuscito ad evitare la detenzione, ma la sua reputazione e carriera ne escono rovinate, e la società ha subito danni d’immagine.
Caso 4: Rivalutazione volontaria del fondo e ravvedimento operoso
Scenario: Delta S.r.l., piccola impresa commerciale, nel bilancio 2024 costituisce un fondo oneri di €80.000 per “ristrutturazione negozi”, motivando che probabilmente nel 2025 dovrà rinnovare l’arredo di alcuni punti vendita. In realtà, a fine 2024 non c’è alcun progetto definito né obbligo contrattuale: è più un’intenzione. Il commercialista di Delta inizialmente avalla l’idea per spalmare i costi, ma poi studiando meglio la normativa si rende conto che non è deducibile (accantonamento per spese future non obbligatorie). Prima di inviare la dichiarazione dei redditi 2025, consiglia all’amministratore di fare una variazione in aumento di quell’importo, così da non dedurlo. L’amministratore concorda. Nel Modello Redditi 2025, Delta aggiunge indietro €80k al reddito. Quindi, pur avendo a conto economico un costo, non ne ha tratto beneficio fiscale.
Svolgimento: Nel 2026, però, succede che effettivamente Delta non ristruttura i negozi (cambia strategia). Dunque il fondo oneri di €80k risulta inutile e viene stornato a ricavo nel bilancio 2025 (approvato nel 2026). Contabilmente appare un provento straordinario di €80k. Il nuovo consulente fiscale di Delta inizialmente lo considera non tassabile perché ricorda che non era stato dedotto l’anno prima. Tuttavia, per scrupolo, presenta interpello all’Agenzia Entrate per conferma. L’Agenzia, rifacendosi a precedenti cassazionisti, risponde che siccome l’accantonamento originario era indeducibile ex lege, la sopravvenienza attiva va comunque imponibile nel 2025 – interpretazione discutibile, ma per evitare guai Delta decide di tassarla lo stesso (tanto, a bilancio quell’80k extra utile compensa l’anno precedente).
Esito: Delta S.r.l. non subisce alcun accertamento: avendo gestito tutto in modo conforme (o persino iper-conforme alle richieste fiscali), l’Agenzia non ha nulla da eccepire. Dal punto di vista civilistico, l’accantonamento iniziale era in effetti improprio secondo OIC, ma essendo l’unico socio l’amministratore stesso, nessuno ha impugnato nulla. Quando il commercialista si è accorto della potenziale violazione contabile, nel bilancio successivo ha fatto un appunto in Nota integrativa indicando che “la società ha ritenuto di stornare l’accantonamento non più necessario, rivalutando l’opportunità in conformità ai principi contabili”: un modo elegante per segnalare la correzione.
Questa simulazione mostra un caso virtuoso di ravvedimento spontaneo e prudenza: Delta ha corretto il tiro prima che diventasse un problema. Ciò le ha evitato sanzioni e possibili implicazioni. Certo, ha finito per pagare le tasse comunque (non ha ottenuto quel beneficio di spalmare il costo), ma ha preferito la via sicura a rischiare multe e contenziosi. È un approccio che spesso i consulenti suggeriscono: se c’è dubbio sulla legittimità di un fondo, meglio non dedurlo e dormire tranquilli, piuttosto che forzare e poi litigare col Fisco.
Conclusione: Attraverso questa guida, abbiamo esplorato i molteplici aspetti dei fondi per rischi e oneri gonfiati e come difendersi da contestazioni relative ad essi. Si tratta di una materia complessa che incrocia competenze di bilancio, diritto tributario, societario e penale. Il denominatore comune è la necessità di attenersi a criteri oggettivi e documentabili nella stima di questi fondi, per non esporsi a rilievi. Dal lato difensivo, è cruciale agire tempestivamente, argomentare con rigore tecnico e – non ultimo – dimostrare sempre la buona fede nelle proprie azioni. In tal modo, anche di fronte a un’accusa di aver “gonfiato” i fondi, il debitore avrà le carte in regola per far valere le proprie ragioni o quantomeno per contenere le conseguenze negative.
Fonti:
- Codice Civile, art. 2424-bis, comma 3 (disciplina accantonamenti) ; Principio Contabile OIC 31 (passività potenziali e divieti su fondi rischi) .
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 107 comma 4 e 109 comma 1 (indeducibilità accantonamenti salvo eccezioni, competenza fiscale su componenti incerti) .
- Cass. Civ. Sez. V, 11/04/2024 n. 9899 – Incertezza della passività: accantonamento deducibile solo quando il costo diviene certo, sopravvenienza attiva imponibile alla riduzione del fondo .
- Cass. Civ. Sez. V, 11/10/2017 n. 23812 – Azzeramento fondo rischi = sopravvenienza attiva tassabile, anche se fondo originariamente non dedotto .
- Trib. Milano, Sez. Imprese, 11/01/2024 – Nullità del bilancio per fondo rischi generico atto a coprire perdite occulte; grave difetto di veridicità e correttezza ex art.2424-bis c.c. .
- Cass. Pen. Sez. V, 16/05/2018 n. 21672 – False comunicazioni sociali configurabili per omessa indicazione garanzie e accantonamenti dovuti; dolo di mendacio non implicito nella violazione contabile, ma da provare con elementi concreti (no dolo “in re ipsa”) .
- Art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali, non quotate) ; D.Lgs. 74/2000 art. 4 (dichiarazione infedele, soglie 100k imposta e 10% ricavi) e art. 3 (dichiarazione fraudolenta, artifizi contabili, soglia 30k imposta) .
- Sentenza del 02/09/2022 n. 546 – Comm. Trib. Reg. per l’Abruzzo.
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestata la deduzione di fondi rischi e oneri considerati eccessivi o non giustificati? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestata la deduzione di fondi rischi e oneri considerati eccessivi o non giustificati?
Vuoi sapere cosa rischi e come difenderti da queste contestazioni fiscali?
👉 Prima regola: dimostra che i fondi iscritti erano reali, probabili e correttamente stimati, in linea con i principi contabili e la normativa fiscale.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Fondi iscritti senza un’effettiva probabilità di rischio o onere;
- Accantonamenti eccedenti rispetto alla reale esposizione;
- Fondi creati per coprire costi generici o futuri non determinabili;
- Utilizzo dei fondi come strumento per ridurre l’imponibile in modo artificioso;
- Mancanza di documentazione a supporto (contratti, cause in corso, perizie, pericoli specifici).
📌 Conseguenze della contestazione
- Indeducibilità dei fondi iscritti e ripresa a tassazione;
- Applicazione di sanzioni per dichiarazione infedele;
- Interessi di mora sulle somme recuperate;
- Possibile contestazione di falso in bilancio se i fondi hanno alterato in modo rilevante il risultato;
- Responsabilità patrimoniale degli amministratori e revisori.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Il rischio o l’onere erano effettivamente probabili e stimabili?
- La stima era supportata da documentazione tecnica, legale o contabile?
- L’accantonamento rispettava i principi OIC o IAS applicabili?
- La quantificazione era proporzionata o eccessiva rispetto all’evento?
- L’Agenzia ha contestato con elementi concreti o su presunzioni generiche?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Bilanci e note integrative con dettagli sui fondi iscritti;
- Relazioni del collegio sindacale o del revisore;
- Perizie, consulenze tecniche e legali;
- Documentazione contrattuale o giudiziaria a supporto del rischio;
- Scritture contabili interne con criteri di calcolo dei fondi.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare che i fondi erano legittimi e proporzionati al rischio reale;
- Contestare la ricostruzione dell’Agenzia se basata su presunzioni;
- Evidenziare l’allineamento con i principi contabili nazionali e internazionali;
- Eccepire vizi di motivazione e errori di calcolo nell’accertamento;
- Richiedere annullamento in autotutela se i documenti erano già agli atti;
- Presentare ricorso entro 60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria;
- Difesa penale mirata in caso di contestazioni per falso in bilancio.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la natura dei fondi contestati e le prove a supporto;
📌 Verifica la legittimità della contestazione e la fondatezza dei rilievi fiscali;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti assiste in giudizio e, se necessario, nei procedimenti penali;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una corretta gestione dei fondi rischi e oneri nei bilanci futuri.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e bilanci d’impresa;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni su fondi rischi e oneri;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sui fondi rischi e oneri gonfiati non sempre sono fondate: spesso derivano da interpretazioni restrittive o da una valutazione eccessivamente soggettiva delle stime.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la legittimità degli accantonamenti, evitare la ripresa a tassazione e ridurre sensibilmente sanzioni e interessi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti sui fondi rischi e oneri inizia qui.