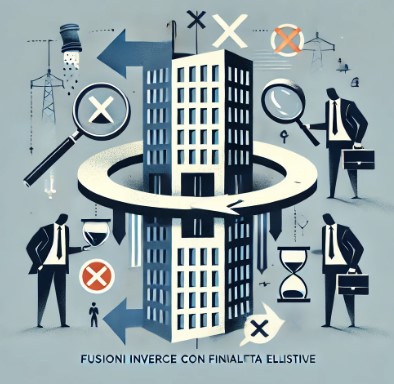Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché una fusione inversa realizzata dalla tua società è stata ritenuta elusiva? In questi casi, l’Ufficio presume che l’operazione non sia stata effettuata per reali ragioni economiche o organizzative, ma soltanto per ottenere indebiti vantaggi fiscali. La conseguenza è la riqualificazione dell’operazione come elusiva o abusiva, con recupero delle imposte, applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: vi sono difese per dimostrare la validità economica della fusione inversa.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta una fusione inversa
– Se l’operazione è priva di reali motivazioni economiche, industriali o organizzative
– Se i benefici fiscali risultano sproporzionati rispetto agli effetti aziendali
– Se la fusione appare strumentale al riporto di perdite fiscali non altrimenti utilizzabili
– Se vengono trasferiti beni o partecipazioni con valori ritenuti incongrui
– Se l’Ufficio presume che l’operazione sia stata ideata solo per ridurre il carico fiscale complessivo
Conseguenze della contestazione
– Disconoscimento dei vantaggi fiscali derivanti dalla fusione
– Recupero delle imposte dirette e indirette non versate
– Applicazione di sanzioni per abuso del diritto o elusione fiscale
– Interessi di mora sulle somme accertate
– Maggior rischio di controlli futuri su altre operazioni straordinarie del gruppo
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare le reali ragioni economiche e gestionali che hanno portato alla fusione inversa
– Produrre piani industriali, business plan, delibere societarie e consulenze a supporto
– Contestare la riqualificazione come elusiva se l’operazione ha prodotto benefici organizzativi concreti
– Evidenziare vizi di motivazione, difetti di istruttoria o errori di calcolo nell’accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare l’operazione di fusione e la documentazione contabile e societaria
– Verificare la legittimità della contestazione secondo le norme fiscali e societarie
– Redigere un ricorso fondato su prove concrete e vizi procedurali dell’accertamento
– Difendere la società davanti ai giudici tributari contro richieste indebite
– Tutelare il gruppo da conseguenze fiscali sproporzionate e da contestazioni future
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione o eliminazione delle sanzioni e degli interessi non dovuti
– Il riconoscimento della legittimità della fusione inversa
– La sospensione delle richieste di pagamento già avviate
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: le fusioni inverse sono operazioni complesse e spesso sotto la lente del Fisco. È essenziale predisporre una documentazione completa delle motivazioni economiche per difendersi da accuse di elusione.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e operazioni straordinarie – spiega come difendersi in caso di contestazioni su fusioni inverse con finalità elusive e come tutelare i tuoi diritti.
👉 La tua società ha ricevuto una contestazione per una fusione inversa ritenuta elusiva? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo gli atti, confronteremo i dati contestati e costruiremo la strategia difensiva più efficace per proteggere la tua impresa.
Che cos’è una fusione inversa?
In ambito societario, la fusione inversa (detta anche “fusione rovesciata”) è una particolare operazione di fusione in cui avviene il contrario di quanto accade di norma: è la società controllata ad incorporare la società controllante . In altre parole, invece che fondere la società figlia nella capogruppo, si fonde la holding nella propria controllata. Si pensi ad esempio a una holding ALFA S.r.l. che possiede il 100% di BETA S.p.A. (società operativa): in una fusione inversa sarà BETA S.p.A. (controllata) ad incorporare ALFA S.r.l. (controllante), con conseguente estinzione di ALFA e mantenimento in vita di BETA. I soci originari della controllante riceveranno in cambio azioni o quote della controllata, mantenendo così indirettamente la medesima partecipazione nell’entità risultante .
Questa forma di fusione è perfettamente lecita e prevista dalla legge, rientrando nella disciplina generale delle fusioni societarie del codice civile (artt. 2501 e segg. c.c.). Anzi, nella prassi è frequente ricorrere alla fusione inversa quando si vuole evitare di creare problemi di continuità nei contratti o nelle autorizzazioni intestate alla società operativa . Infatti, facendo incorporare la holding dalla controllata (che tipicamente è l’impresa operativa sul mercato, titolare di beni, contratti, licenze e autorizzazioni), si assicura che quest’ultima continui ad esistere senza soluzione di continuità, evitando ad esempio:
- Decadenze o necessità di volture contrattuali: la società operativa rimane la stessa parte contrattuale, quindi non occorre trasferire contratti o autorizzazioni a un’altra entità, evitando complicazioni burocratiche o il rischio che alcune controparti oppongano clausole di change of control.
- Mantenimento di licenze e rapporti giuridici: la controllata già detiene le necessarie abilitazioni per l’attività; con la fusione inversa questi rapporti rimangono in capo ad essa senza dover richiedere nuovi permessi .
- Continuità di mercato e d’immagine: il nome e la presenza sul mercato della società operativa restano invariati, evitando potenziali confusioni presso clienti e fornitori.
Esempio: La società Beta S.p.A. produce beni e ha numerosi contratti con clienti e fornitori, oltre a licenze amministrative. È interamente partecipata dalla holding Alfa S.r.l.. Per riorganizzare il gruppo, si opta per la fusione inversa: Beta S.p.A. incorpora Alfa S.r.l.. Così Beta S.p.A. prosegue la sua attività produttiva senza dover modificare i contratti (rimane la stessa persona giuridica), e i soci di Alfa diventano soci direttamente di Beta nelle stesse proporzioni originarie . La struttura del gruppo si semplifica (sparisce la holding) ma l’operatività aziendale di Beta non subisce intoppi.
In sintesi, la fusione inversa è uno strumento legittimo di riorganizzazione societaria, usato spesso per ragioni organizzative (semplificare la catena partecipativa, incorporare la holding) e commerciali (tutelare la continuità dei rapporti della società operativa). Tuttavia, come vedremo, proprio questa natura “atipica” può talora destare sospetti in chi controlla la legittimità dell’operazione.
Perché le fusioni inverse possono essere contestate?
Nonostante la liceità intrinseca della fusione inversa, le autorità fiscali e i creditori potrebbero contestarla quando ritengano che sia stata realizzata con finalità elusive o fraudolente. In particolare, due profili sono spesso oggetto di contestazione:
- Profilo tributario (elusione fiscale): il Fisco può sospettare che la fusione sia volta principalmente a ottenere un vantaggio fiscale indebito, sfruttando la neutralità fiscale delle fusioni per aggirare imposte che sarebbero altrimenti dovute. Si parla in tal caso di abuso del diritto o elusione fiscale, che in base all’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) ricorre quando il contribuente pone in essere operazioni formalmente legittime ma prive di sostanza economica, mirate essenzialmente a ottenere benefici fiscali indebiti . Ad esempio, una fusione inversa potrebbe essere contestata se realizzata allo scopo di:
- Evitare la tassazione di plusvalenze: fondendo una società si cerca di evitare che emergano imponibili (es. plusvalenze latenti che sarebbero tassate in caso di cessione o liquidazione) .
- Dedurre indebitamente costi: ad esempio, generare interessi passivi deducibili trasferendo un debito sulla società operativa (c.d. debt push-down) senza una reale controparte economica, tipicamente in operazioni di Merger Leveraged Buy-Out (MLBO) sospette .
- Trasferire perdite fiscali o altri “tax assets”: attraverso la fusione si punta a utilizzare perdite pregresse o altri benefici fiscali di una società che altrimenti sarebbero limitati o persi, eludendo le norme che ne restringono il riporto (in questi casi esistono regole anti-elusive specifiche, si pensi all’art. 172 co.7-9 TUIR sulle perdite in caso di fusione, come vedremo).
- Aggirare imposte indirette: ad esempio, il consolidamento di beni immobili tramite fusione per pagare solo imposta fissa di registro (€200) invece dell’imposta proporzionale dovuta in caso di compravendita degli immobili. Un caso classico: invece di vendere un immobile (scontando imposta di registro al 9% e imposte ipocatastali) si fonde la società immobiliare proprietaria con la società acquirente, così la proprietà dell’immobile passa senza tassazione proporzionale. Le autorità potrebbero considerarla un’operazione elusiva volta a “risparmio d’imposta fraudolento” ex art. 10 L. 408/1990 (norma antielusiva previgente), come affermato ad esempio dalla Cassazione in riferimento ad analoghe manovre su immobili .
- Profilo civilistico/concordatario (tutela dei creditori): i creditori sociali possono temere che la fusione – specie se coinvolge una società indebitata – sia effettuata per sottrarre garanzie patrimoniali o complicare la loro possibilità di recupero del credito. In termini semplici, potrebbero accusare la fusione di essere un atto in frode ai creditori o addirittura una simulazione finalizzata a far “sparire” il debitore. Ad esempio:
- Se una società gravata da debiti viene fusa (magari inversamente, con una controllata sana che la incorpora), i creditori potrebbero vedervi un tentativo di confondere patrimoni e rendere più difficile l’escussione, specie se la società debitrice viene assorbita e si estingue.
- In ambito fallimentare, un’operazione di fusione potrebbe essere sospettata come distrattiva, potenzialmente rilevante anche come bancarotta fraudolenta se volta a ledere la par condicio creditorum. Ad esempio, fondere una società in dissesto con un’altra per sottrarre attivi alla procedura concorsuale può portare a indagini penali.
- Più in generale, i creditori potrebbero reagire con azioni come l’opposizione alla fusione (strumento preventivo previsto dal codice civile), l’azione revocatoria post-fusione o l’azione di simulazione, per fare in modo che l’operazione non pregiudichi il loro diritto di recuperare i crediti (analizzeremo dettagliatamente tali rimedi).
In definitiva, la fusione inversa in sé non è vietata, ma diventa problematica quando appare come un mero espediente: se priva di sostanza economica e motivazioni autentiche, l’operazione rischia di essere disconosciuta dal Fisco (sul piano tributario) o attaccata dai creditori (sul piano civilistico). Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono le norme chiave da conoscere, come si accerta un abuso del diritto, quali tutele hanno i creditori e soprattutto come predisporre una strategia difensiva efficace in caso di contestazione, dal pre-contenzioso fino all’eventuale giudizio, compresa la possibilità di soluzioni transattive.
Prima di addentrarci nei dettagli, presentiamo una tabella riepilogativa dei principali profili di contestazione in una fusione e dei relativi strumenti di difesa in sintesi:
<table> <thead> <tr><th>Possibile contestazione</th><th>Descrizione</th><th>Strumenti di difesa del debitore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td><small>Abuso del diritto (elusione fiscale)</small></td><td>Operazione formalmente lecita ma priva di sostanza economica, mirata a ottenere un risparmio d’imposta indebito (es. fusione per evitare tassazione di plusvalenze o dedurre costi fittizi) .</td><td>Dimostrare valide ragioni economiche non marginali dell’operazione (business purpose) e la presenza di effetti reali diversi dal risparmio fiscale . Fornire documentazione (perizie, piani industriali, verbali) che provi la sostanza economica. Eventualmente, aver ottenuto un interpello anti-abuso favorevole prima dell’operazione.</td></tr> <tr><td><small>Frode ai creditori</small></td><td>Fusione realizzata per pregiudicare i creditori (es. far “sparire” la società debitrice incorporandola in un’altra, confondendo i patrimoni e rendendo più difficile l’azione di recupero).</td><td>In fase preventiva, la mancata opposizione dei creditori nei termini consente di perfezionare la fusione (v. art. 2503 c.c.). Se contestata ex post (es. con azione revocatoria), difendersi provando che l’operazione non ha causato un danno ai creditori (assenza di eventus damni) o che vi erano motivazioni lecite (es. riorganizzazione industriale) senza intento di frode. Mostrare che il patrimonio post-fusione resta capiente per i debiti, o che sono state offerte garanzie ai creditori.</td></tr> <tr><td><small>Simulazione</small></td><td>Accordo fraudolento tra soci per creare una fusione solo apparente, celando un diverso disegno (es. fusione dichiarata ma con accordo occulto di gestire separatamente i patrimoni, o di retrocedere beni ai vecchi soci) .</td><td>La simulazione è di difficile prova; la difesa consisterà nel sottolineare la reale esecuzione degli effetti della fusione (effettiva integrazione di patrimoni e organizzazioni) e l’assenza di accordi occulti. Far valere che, per un terzo creditore, la prova è stringente e basata su presunzioni gravi, precise e concordanti: se non emergono elementi concreti di simulazione (controdichiarazioni, comportamenti incoerenti), l’operazione deve ritenersi genuina.</td></tr> <tr><td><small>Violazioni procedurali nella fusione</small></td><td>Inosservanza delle formalità previste dal codice civile (es. mancata redazione di documenti obbligatori, violazione di termini o quorum deliberativi) che potrebbe aver pregiudicato soci o terzi.</td><td>Far valere l’irretrattabilità della fusione una volta iscritta (art. 2504-quater c.c., niente nullità) . Eventuali irregolarità formali possono al più dar luogo a responsabilità per danni degli amministratori verso soci/terzi, non all’invalidazione della fusione. Se del caso, sanatoria delle irregolarità in assemblea o mediante atti integrativi.</td></tr> <tr><td><small>Ipotesi di reato tributario o fallimentare</small></td><td>Accusa che l’operazione costituisca reato, ad esempio dichiarazione fiscale fraudolenta/infedele (D.Lgs. 74/2000) se il risparmio d’imposta supera soglie penali, oppure bancarotta fraudolenta se la fusione è fatta per distrarre attivi a danno dei creditori in previsione di fallimento.</td><td>Enfatizzare che dal 2015 l’abuso del diritto fiscale non è penalmente rilevante (non integra reato se non c’è violazione di specifica norma tributaria). Distinguere chiaramente l’operazione (lecita, dichiarata al fisco) da eventuali condotte fraudolente (es. occultamento di beni o uso di false fatture). Nel caso di accuse di bancarotta, provare che la fusione non ha sottratto attivi ai creditori e rientrava in scelte gestionali lecite, senza dolo di frode.</td></tr> </tbody> </table>
Nota: La tabella sopra fornisce una panoramica semplificata. Ciascun tema sarà approfondito nelle sezioni seguenti, con riferimenti normativi (es. art. 10-bis L.212/2000 per l’abuso del diritto) e giurisprudenza recente (sentenze di Cassazione rilevanti su fusioni elusive e tutele creditorie). Passiamo ora a delineare il quadro normativo di base su fusioni e abuso del diritto, per poi esaminare come difendersi nel merito delle contestazioni.
Quadro normativo: fusioni societarie e abuso del diritto
Per comprendere come difendersi, occorre innanzitutto avere chiari i riferimenti normativi che regolano le fusioni e contrastano le operazioni elusive. In questa sezione esamineremo: (1) la normativa civilistica sulle fusioni (incluse le particolarità delle fusioni inverse); (2) il regime fiscale ordinario delle fusioni (neutralità e limiti, come il trattamento delle perdite); (3) la clausola generale antiabuso introdotta nel 2015 e la relativa procedura di contestazione; (4) la distinzione tra elusione ed evasione, soprattutto riguardo alle conseguenze sanzionatorie, anche penali.
Norme civilistiche sulle fusioni (cenni, con focus sulla fusione inversa)
Le fusioni societarie sono disciplinate dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile. Senza entrare nei dettagli tecnici di tutte le fasi (progetto di fusione, delibere, atti di fusione), evidenziamo alcuni punti chiave utili nel contesto delle contestazioni elusive:
- Legittimità della fusione inversa: Il Codice Civile non distingue espressamente tra fusione “diretta” e “inversa”; entrambe sono permesse. La differenza è solo nella struttura del gruppo pre-fusione (controllante vs controllata che sopravvive). La prassi notarile conferma che anche nelle fusioni inverse si possono applicare le procedure semplificate previste per le fusioni di società interamente partecipate (art. 2505 c.c.) . In particolare, se la controllata/incorporante è posseduta al 100% dalla controllante/incorporanda, non essendoci terzi da tutelare nel concambio, si può omettere la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio e, con il consenso unanime, anche la relazione degli amministratori . Questo per dire che la fusione inversa è normale quanto la fusione diretta dal punto di vista civilistico.
- Effetti giuridici della fusione: Ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., la fusione comporta la universale successione della società risultante (o incorporante) in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società fuse. La società incorporata si estingue, ma non si ha una vera “discontinuità”: la giurisprudenza la definisce un’operazione con effetti evolutivi e non traslativi in senso stretto. Significa che tutti i beni, diritti e obblighi passano automaticamente all’incorporante, che ne risponde anche dei debiti. Ciò è cruciale per i creditori: la fusione non estingue i debiti, ma li trasferisce alla società risultante. Ad esempio, se Alfa S.r.l. (controllante) aveva un debito verso un creditore, dopo la fusione inversa tale debito sarà in capo a Beta S.p.A. (incorporante) e il creditore potrà rivalersi su Beta. Come vedremo, il creditore ha strumenti per evitare che la fusione pregiudichi le sue ragioni (opposizione, ecc.), ma se questi non vengono azionati la fusione non lo priva del diritto di credito – ne può complicare l’esazione in pratica, ma giuridicamente Beta S.p.A. ne risponde come successore universale.
- Tutela dei soci e dei terzi: La legge predispone vari strumenti di tutela procedurale:
- Informativa e documentazione pre-fusione: progetto depositato, situazione patrimoniale, relazione amministratori ed esperti (queste ultime escluse in alcuni casi di fusione semplificata). L’omissione dolosa di informazioni o il mancato rispetto di questi obblighi può dare luogo a responsabilità di amministratori e esperti.
- Opposizione dei creditori (art. 2503 c.c.): è il principale strumento a protezione dei creditori sociali, come dettagliato più avanti. I creditori anteriori alla fusione possono opporsi entro 60 giorni dall’ultima iscrizione della delibera, ottenendo una sospensione dell’operazione . Se non si oppongono nei termini, la fusione può divenire efficace, ma restano possibili rimedi successivi (revocatoria, risarcimento).
- Invalidità della fusione: l’art. 2504-quater c.c. stabilisce che, iscritta la fusione nel Registro Imprese, non può essere dichiarata nulla né annullata. Ciò per tutelare la certezza dei traffici giuridici: non è ammesso far “saltare” la fusione a posteriori per vizi procedurali . L’unico rimedio per soci o terzi lesi da eventuali irregolarità resta la richiesta di risarcimento danni (es. azione di responsabilità contro amministratori). Questo principio di irretrattabilità è da tenere a mente: anche se emerga un problema (fiscale o civile), la fusione in sé non può essere annullata – gli effetti verso terzi rimangono, si potranno al più disconoscere ai fini fiscali o renderla inopponibile a un creditore specifico (via revocatoria).
- Fusione e creditori particolari: Nel caso di società in crisi, la fusione può intersecarsi con procedure concorsuali (es. fusione durante un concordato preventivo o incorporazione di società in liquidazione). Il Codice della Crisi d’Impresa oggi regolamenta alcuni aspetti (artt. 2501 c.c. e segg. come novellati). Non entriamo in questi dettagli, ma notiamo che qualsiasi fusione deve rispettare l’art. 2740 c.c. (principio di responsabilità patrimoniale: rispondere dei debiti con tutto il patrimonio presente e futuro). Se una fusione pregiudica tale garanzia, e i creditori non sono stati adeguatamente considerati, scattano i rimedi di legge (opposizione, revocatoria, ecc.).
In sintesi, dal punto di vista civilistico la fusione inversa segue le stesse regole generali: è un’operazione lecito-strumentale di riorganizzazione, con effetti successori e tutele procedurali. Ciò che cambia nella fusione inversa è solo la dinamica dei soggetti coinvolti (la controllata incorpora la controllante). Questo particolare assetto può essere sfruttato con intenti elusivi, soprattutto fiscali, ma la legge civile non ne fa un caso sospetto di per sé. Tutto dipende dalle motivazioni concrete e dagli effetti dell’operazione.
Regime fiscale ordinario delle fusioni: neutralità ed eccezioni
In campo tributario, le fusioni societarie beneficiano di regimi di neutralità fiscale: l’ordinamento in generale non vuole penalizzare le riorganizzazioni aziendali con carichi fiscali immediati, a patto che non siano un veicolo di evasione. Ecco i punti principali del regime fiscale delle fusioni in Italia:
- Neutralità ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF): L’art. 172 del TUIR (DPR 917/86) prevede la neutralità fiscale della fusione. In sostanza, il passaggio di beni e valori dalla società incorporata all’incorporante non costituisce realizzo di plusvalenze imponibili. I valori fiscalmente riconosciuti dei beni rimangono quelli originari (continuità dei valori fiscali). Allo stesso modo, la fusione non genera di per sé componenti positivi o negativi rilevanti (eccetto eventuali conguagli in denaro sopra il 10%, considerati distribuzione di utili). Questo principio evita che ogni fusione comporti tassazione come se fosse una vendita. Esempio: se la società incorporata ha immobili iscritti a bilancio a 1 milione ma con valore di mercato 5 milioni, fondendola normalmente non si tassa la differenza di 4 milioni (non emergono plusvalenze tassabili, i beni transitano con il loro valore netto contabile). Ciò spiega perché talvolta si usano fusioni per evitare di “cristallizzare” plusvalori latenti.
- Imposta di registro e altre imposte indirette: La fusione non è considerata un atto traslativo ai fini dell’imposta di registro. Ai sensi dell’art. 4, lettera b) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, gli atti di fusione sono soggetti a registro in misura fissa (€200). Anche le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa in caso di trasferimento di immobili per effetto di fusione. Questo regime di favore (rispetto ad un trasferimento oneroso che pagherebbe imposta proporzionale) è giustificato dalla natura meramente organizzativa della fusione. Tuttavia, se l’operazione fosse considerata elusiva (cioè una finta fusione per mascherare una vendita di immobili), l’Amministrazione potrebbe contestare l’abuso e chiedere l’imposta proporzionale evasa . Su questo punto c’è stata in passato disputa interpretativa sull’art. 20 del DPR 131/86 (criterio di interpretazione degli atti ai fini registro), ma una riforma del 2018 ha chiarito che non si possono riqualificare più atti come uno solo ai fini dell’imposta di registro. Resta però applicabile la clausola generale antiabuso per colpire costruzioni artificiose.
- Riporto delle perdite fiscali e altri “tax attributes”: Una fusione può comportare il trasferimento all’incorporante di elementi come perdite fiscali pregresse, interessi passivi non dedotti, ecc. Il legislatore ha previsto limiti per evitare abusi: l’art. 172 co. 7-8 TUIR stabilisce che le perdite fiscali dell’incorporata sono utilizzabili dall’incorporante solo se supera due test al momento della fusione: test di vitalità (l’incorporata deve aver svolto attività che ha generato ricavi nei 2 anni precedenti) e test di capienza patrimoniale (il patrimonio netto della incorporata non deve essere superiore al suo attivo al netto delle perdite, ecc.). In mancanza di tali requisiti, le perdite si perdono a meno che non si presenti un interpello per disapplicare la norma dimostrando che la fusione non è effettuata a solo scopo elusivo di utilizzare quelle perdite . Questo interpello è detto “disapplicativo” (art. 11, co.2, L. 212/2000) e ne parleremo nelle strategie difensive. Ad ogni modo, il riporto delle perdite è un tema caldo: se una fusione inversa avviene tra una società in utile e una con grosse perdite, il Fisco potrebbe guardarla con sospetto (chiedendosi: si è fusa la perdente solo per poter abbattere gli utili dell’altra con quelle perdite?). Caso analogo per altri benefici come interessi indeducibili pregressi, ACE, ecc.: esistono norme specifiche antiabuso che ne condizionano il trasferimento (spesso prevedendo anch’esse la possibilità di interpello per dimostrare l’assenza di intenti elusivi) .
- Rivalutazioni e disavanzi da fusione: In una fusione può emergere un disavanzo da fusione (se il prezzo pagato per l’incorporata eccede il suo patrimonio netto contabile) che può essere allocato su beni o avviamento. La deducibilità di eventuali quote di ammortamento su questo disavanzo è stata oggetto di attenzione: l’Amministrazione teme che si creino artatamente “avviamenti autoprodotti” per generare costi deducibili. Ad esempio, se Tizio possiede un’azienda individuale e la conferisce in Alfa Srl per X euro, poi Alfa Srl si fonde in Beta Spa, quest’ultima potrebbe iscrivere un avviamento pari a X (se eccede i netti contabili) e dedurre ammortamenti nei 18 anni successivi. Se queste operazioni sono tra parti correlate, il Fisco potrebbe contestare l’abuso, specie se l’avviamento è “auto-generato” senza un effettivo nuovo valore (e magari con meccanismi di retrocessione delle partecipazioni). La Cassazione ha affermato il principio che i costi derivanti da operazioni elusive sono indeducibili , quindi se la fusione è ritenuta abusiva gli ammortamenti connessi all’avviamento iscritto possono essere recuperati a tassazione. Occorre pertanto prestare molta attenzione a non basare la fusione solo sulla creazione di voci ammortizzabili senza sostanza.
Riassumendo, la legge fiscale favorisce le fusioni (neutralità, imposte fisse, continuità nei valori) per non ostacolare le riorganizzazioni aziendali. Ma proprio queste previsioni di favore possono indurre abusi: neutralità e continuità significano che tramite fusione si possono spostare beni e tax attributes senza pagare subito imposte. Se la ragione predominante è questa (spostare basi imponibili altrove o evitare tasse), l’operazione è a rischio contestazione. È qui che entra in gioco la disciplina sull’abuso del diritto.
La clausola generale anti-elusione: art. 10-bis Statuto del Contribuente
Dal 1° ottobre 2015 in Italia è in vigore una clausola generale antiabuso codificata, che ha unificato i concetti di abuso del diritto ed elusione fiscale. Si tratta dell’art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal D.Lgs. 128/2015 sulla certezza del diritto nei rapporti fisco-contribuente . Questa norma è il faro per valutare operazioni come le fusioni inverse sotto il profilo fiscale. Vediamone i punti essenziali:
- Definizione di abuso/elusione (comma 1): costituiscono abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti . In altre parole, se metto in piedi un’operazione che a prima vista è lecita (non viola letteralmente alcuna legge tributaria), ma non ha una vera ragion d’essere se non il risparmio d’imposta, il Fisco può qualificarla come abuso e disconoscerne i benefici fiscali. Il concetto chiave è duplice: mancanza di sostanza economica + vantaggio fiscale indebito. La norma precisa che un’operazione è “priva di sostanza economica” se i fatti, atti e contratti sono inidonei a produrre effetti economici significativi diversi dai vantaggi fiscali ottenuti . Esempi di indici di mancanza di sostanza: l’operazione è incoerente con la normale logica di mercato o con la struttura giuridica tipica (cioè si usano strumenti giuridici anomali rispetto allo scopo dichiarato) . Il vantaggio fiscale è “indebito” se contrasta con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario .
- Conseguenze (comma 2): le operazioni abusive non sono opponibili al fisco. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate le disconosce, ricalcolando i tributi come se l’operazione non fosse mai avvenuta o fosse avvenuta in forma non elusiva . Nel nostro contesto, se una fusione inversa è considerata abusiva, il Fisco può ignorarla e tassare ciò che avrebbe tassato in assenza di essa (es: tassare plusvalenze, negare deduzioni di interessi, ecc.), tenendo conto naturalmente di quanto il contribuente ha eventualmente già versato in esecuzione dell’operazione .
- Operazioni non abusive (comma 3): cruciale è la “via di uscita” che la norma offre. Stabilisce che non si considerano mai abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, volte al miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa . Questo significa che se il contribuente ha un serio motivo di business (ristrutturazione, razionalizzazione, necessità finanziarie, ragioni commerciali, ecc.) e il vantaggio fiscale è una conseguenza secondaria, l’operazione è lecita anche se comporta risparmio d’imposta. È praticamente il recepimento del principio del business purpose: ciò che conta è che vi sia una sostanza economica apprezzabile e un obiettivo imprenditoriale genuino alla base. Nel caso delle fusioni: una fusione societaria accompagnata da reali e sostanziali ragioni economico-organizzative (es. integrazione di attività, sinergie operative, riduzione di costi di struttura) non potrà essere considerata elusiva solo perché comporta un risparmio d’imposta, in quanto quel risparmio è connaturato alla scelta consentita dal legislatore . Questo concetto è stato espresso chiaramente anche dalla giurisprudenza: ad esempio la Cassazione ha affermato che se l’ordinamento consente un certo regime (come la neutralità delle fusioni), il contribuente che ne usufruisce non è di per sé abusivo – a meno che non “forzi la mano” cioè utilizzi quella norma in modo distorto e contrario alla ratio .
- Libertà di scelta tra regimi (comma 4): correlato a quanto sopra, l’art. 10-bis specifica che resta ferma la libertà del contribuente di scegliere tra diverse operazioni o regimi fiscali offerti dalla legge quella fiscalmente meno onerosa . Quindi se ho due modi equivalenti di compiere un’operazione, posso lecitamente preferire quello che mi fa pagare meno tasse. Questo principio tutela la pianificazione fiscale legittima. L’abuso si ha solo se la scelta, pur di minor carico fiscale, è priva di sostanza economica ulteriore. Ad esempio: se posso riorganizzare un gruppo sia con una fusione sia con una cessione di asset, e scelgo la fusione perché fiscalmente neutrale, ciò è lecito a patto che la fusione abbia senso dal punto di vista organizzativo. Non è che il contribuente debba scegliere la via più costosa in assoluto; semplicemente non deve costruire vie artificiose solo per il fisco .
- Procedura di contestazione (commi 5-8): l’accertamento di abuso del diritto segue garanzie procedimentali precise:
- Richiesta di chiarimenti obbligatoria: prima di emettere un avviso di accertamento basato su abuso, l’ufficio deve notificare al contribuente una richiesta di spiegazioni, dettagliando i motivi per cui ritiene applicabile la norma antiabuso. Il contribuente ha 60 giorni per rispondere . Questo contraddittorio preventivo è previsto a pena di nullità dell’atto: se il Fisco emette l’accertamento senza aver richiesto chiarimenti, l’atto è nullo . Durante questi 60 giorni (che possono essere prorogati su istanza motivata), il contribuente potrà produrre documenti e memorie difensive.
- Termini per l’accertamento: tra la data in cui l’Amministrazione riceve le risposte del contribuente (o scadono i 60 giorni) e la scadenza del termine di decadenza per notificare l’accertamento, devono intercorrere almeno 60 giorni . Se mancano, il termine di decadenza si considera prorogato di quel tanto che serve a coprire i 60 giorni. Ciò per garantire che il contribuente abbia davvero la possibilità di essere ascoltato e che l’ufficio valuti prima di colpire.
- Motivazione rafforzata: l’eventuale avviso di accertamento dovrà essere motivat(o) in maniera specifica sia sulla condotta abusiva, sia sulle norme/principi elusi, sia sui vantaggi fiscali indebitamente conseguiti, sia infine sulle giustificazioni fornite dal contribuente (e perché sono state ritenute non valide) . La mancanza di una motivazione puntuale su questi elementi rende nullo l’atto.
- Onere della prova: l’art. 10-bis assegna all’Amministrazione l’onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’abuso (quindi deve provare che l’operazione è priva di sostanza economica e che il vantaggio ottenuto è indebito) . Dal canto suo, il contribuente può sempre cercare di provare la presenza di ragioni extrafiscali non marginali che giustifichino le operazioni . In giudizio, ciò si traduce in un approccio caso per caso: il giudice valuterà se l’ufficio ha dato evidenza degli elementi di artificiosità e se il contribuente ha fornito una spiegazione alternativa credibile e documentata.
- Conseguenze sanzionatorie (comma 9): la legge sancisce che l’abuso del diritto non è di per sé punibile penalmente . Inoltre, viene stabilito che, in caso di recupero a tassazione per abuso, i relativi maggiori tributi vengono iscritti a ruolo (ossia diventano esigibili) solo dopo la sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) . Ciò tutela il contribuente da esborsi immediati prima che un giudice si sia espresso. Quanto alle sanzioni amministrative tributarie, la legge afferma che restano applicabili “ove ne ricorrano i presupposti” . Su questo punto interpretativo: generalmente, se l’operazione era formalmente conforme alla legge, alcune sanzioni potrebbero non applicarsi (per esempio, se il contribuente ha seguito prassi o interpelli, può invocare buona fede). Tuttavia, in assenza di cause esimenti, l’ufficio tende ad applicare le sanzioni per infedele dichiarazione (anche se con attenuanti) quando disconosce un vantaggio abusivo. La giurisprudenza sta evolvendo: alcune sentenze hanno escluso sanzioni in caso di abusi particolarmente controversi (per incertezza normativa), ma in principio l’art. 10-bis non crea un’esenzione automatica dalle sanzioni amministrative. In altre parole, l’abuso non è reato ma può comunque comportare sanzioni tributarie (generalmente pari al 90% della maggior imposta, riducibili se c’è conciliazione o adesione).
In conclusione, l’art. 10-bis L.212/2000 è l’arma principe del Fisco contro operazioni come le fusioni inverse elusive. Al contempo, è anche la base legale della difesa del contribuente onesto: se hai valide ragioni economiche, l’operazione non è abuso. Tutta la strategia difensiva ruoterà attorno a questo: dimostrare la sostanza economica e le finalità extra-fiscali dell’operazione, contro la tesi dell’ufficio che la dipingerà come artificiosa e finalizzata solo al risparmio d’imposta.
Prima di passare alle strategie difensive, facciamo il punto su come la giurisprudenza ha applicato questi principi in casi di fusioni (inverse e non) con presunta finalità elusiva, nonché sulle azioni civili attivate dai creditori in vicende analoghe. La conoscenza delle pronunce più recenti ci aiuterà a individuare i trend e gli argomenti vincenti.
Giurisprudenza: casi recenti di fusioni elusive e rimedi dei creditori
In questo capitolo esamineremo alcune sentenze rilevanti degli ultimi anni riguardanti: – Operazioni di Merger LBO e fusioni inverse contestate come elusive (Giurisprudenza tributaria – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria). – Fusioni societarie contestate dai creditori come atti in frode (Giurisprudenza civile – Cassazione civile, sez. I o II e Corti di merito). – Cenni sui profili penal-tributari (Cassazione penale) relativi all’abuso del diritto.
L’obiettivo è evidenziare i principi chiave emersi che possano essere utilizzati nella difesa. Per comodità espositiva, suddivideremo i casi principalmente in due filoni: giurisprudenza tributaria sull’abuso/elusione e giurisprudenza civilistica sui rimedi dei creditori.
Giurisprudenza tributaria su fusioni e abuso del diritto
La Corte di Cassazione tributaria ha prodotto diverse pronunce in tema di fusioni (incluse le inverse) sospettate di elusione fiscale. Ecco alcuni casi emblematici e il loro insegnamento:
- Cassazione n. 13914/2023 (Sez. Trib., depositata 19 maggio 2023) – Operazione di MLBO con fusione inversa: Questo caso riguardava un classico Merger Leveraged Buy-Out dove una newco indebitata acquisisce una società target e poi viene incorporata dalla target stessa (fusione inversa). Nel dettaglio, alcuni soci di una società avevano creato una newco finanziata a debito per comprare quella stessa società (i soci vendono a se stessi tramite la newco, incassando il prezzo finanziato dalla banca), poi hanno fuso la newco nella “vecchia” società . Il risultato finale: l’impresa continua come prima (stessi asset, stessi soci in parte) ma ora gravata da un grosso debito i cui interessi sono deducibili fiscalmente – di fatto uno schema di leveraged cash-out in cui i soci escono con liquidità generata dal debito e l’azienda si ritrova indebitata (interessi deducibili) senza reale nuovo investimento . L’Agenzia delle Entrate contestava l’abuso, notando in particolare che alcuni dei vecchi soci erano rimasti soci (seppur di minoranza) anche dopo l’operazione finale , il che suggeriva un mancato effettivo cambio di controllo. I giudici di legittimità, pur ribadendo i principi generali (un’operazione di fusione LBO è lecita se sorretta da valide ragioni extrafiscali, come acquisizioni reali, ingresso di nuovi investitori, razionalizzazione, etc.), hanno dato torto al Fisco in questo caso, ritenendo infondato il motivo di ricorso . Dalla motivazione, per come nota dottrina, emergono alcuni passaggi fondamentali:
- La Cassazione richiama esplicitamente i chiarimenti della Circolare AE n. 6/E del 2016 in tema di LBO . Tale circolare (dell’Agenzia Entrate) afferma che, se nell’operazione di LBO concorrono gli stessi soggetti che controllavano la target, l’operazione potrebbe essere sospetta di abuso. Ciononostante, la Cassazione ha ritenuto che la sola permanenza parziale dei vecchi soci non basta a configurare l’abuso, se comunque vi sono elementi sostanziali che giustificano l’operazione . Nel caso concreto, pare che la società contribuente avesse addotto come ragione una riorganizzazione societaria e l’ingresso di un socio investitore; il Fisco invece sosteneva che la newco veicolo fosse inattiva e creata solo per motivi fiscali (far transitare il debito) e che il controllo non fosse realmente cambiato. La Corte ha ritenuto valide le ragioni del contribuente e non provato l’intento abusivo, rigettando il ricorso dell’Agenzia .
- Importante, la Corte sottolinea che spetta al contribuente, una volta contestato l’abuso, provare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali . Ciò è in linea col disposto dell’art. 10-bis: l’onere della prova iniziale sull’abuso è dell’ufficio, ma il contribuente deve comunque presentare elementi a sostegno della bontà economica dell’operazione. Nella vicenda, la società ha fornito giustificazioni (riorganizzazione, probabile utilità industriale) che hanno convinto i giudici.
In sintesi: la Cass. 13914/2023 conferma che operazioni di LBO con fusione inversa non sono abusive di per sé, purché servano a un’effettiva acquisizione/ingresso di nuovi soci e riorganizzazione e non siano un “auto-finanziamento” dei vecchi soci travestito. La presenza residua di alcuni vecchi soci non è sufficiente a bollare l’operazione come elusiva, se globalmente c’è stata una trasformazione sostanziale (ad esempio, un nuovo socio di maggioranza entrato, un cambio di governance, ecc.) .
- Cassazione n. 18577/2025 (Sez. Trib., ord. 8 luglio 2025) – Abuso in LBO “circolare”: Questa recentissima ordinanza (di metà 2025) aggiunge un tassello importante e bilancia il precedente. Da quanto risulta (il testo integrale non è interamente pubblico al momento in cui scriviamo), la Corte in questo caso ha riconosciuto la natura abusiva di un’operazione di LBO con fusione, caratterizzata dalla deduzione di interessi passivi a seguito dell’operazione . Si trattava probabilmente di uno schema in cui non vi era un reale cambio di controllo (ossia i soci preesistenti hanno re-ingegnerizzato la struttura societaria attraverso un veicolo finanziato a debito ma mantenendo la sostanza della proprietà), e l’unico effetto tangibile era il risparmio d’imposta derivante dalla deduzione degli interessi sul debito contratto per “acquisire” sé stessi. La Cassazione ha quindi applicato l’art. 37-bis del DPR 600/1973 (la norma anti-elusione allora vigente per i periodi d’imposta antecedenti al 2015) e ha confermato che un siffatto schema configurava condotta abusiva . In particolare viene citato dalla motivazione un passaggio: “configura condotta abusiva… l’operazione di leveraged buy-out caratterizzata dalla deduzione di interessi passivi…” . È verosimile che in quel caso la Cassazione abbia ravvisato un difetto di sostanza economica: stessa compagine a monte e a valle, veicolo artificioso, nessuna nuova risorsa o funzionalità ma solo vantaggio fiscale.
Nota: Il riferimento all’art. 37-bis DPR 600/73 indica che si trattava di annualità precedenti al 2015 (quando quell’articolo era in vigore). Ciò non toglie che i principi siano pienamente applicabili oggi sotto l’art. 10-bis, data la sostanziale continuità concettuale. Anzi, la Cassazione con questa ordinanza 18577/2025 ribadisce in sostanza: non tutti gli LBO passano indenni; se i fatti evidenziano chiaramente un disegno elusivo, la Cassazione lo censura . Quindi: LBO con newco “fantasma” e stessi vecchi soci = abuso, mentre LBO con reale acquisizione e motivi industriali = lecito. È una sottile linea di demarcazione, ben nota anche all’Agenzia Entrate, tant’è vero che la circ. 6/E-2016 e varie risposte a interpello distinguono proprio in base a questo discriminante (nuovo investitore/cambio di controllo sostanziale sì o no) .
- Cassazione n. 35398/2021 (ord. sez. Trib.) – Fusione semplificativa della catena societaria: In questa ordinanza, depositata il 20 novembre 2021, la Suprema Corte ha giudicato non elusiva una fusione in cui una S.p.A. incorporò un’altra S.p.A. e due società di persone (una snc e una sas) appartenenti allo stesso gruppo familiare . L’Agenzia delle Entrate sosteneva che tale operazione fosse priva di valide ragioni economiche ed esclusivamente finalizzata a evitare l’imposizione sulle plusvalenze latenti che sarebbero emerse in caso di liquidazione delle due società di persone . In pratica, invece di liquidare le società di persone (ciò avrebbe comportato assegnazione beni ai soci e tassazione delle plusvalenze su detti beni), si è optato per fondere tutto nella S.p.A. La Cassazione ha dato ragione al contribuente, sottolineando che si trattava di un’operazione di semplificazione del gruppo, rispondente a finalità di miglioramento strutturale o funzionale delle imprese e quindi non sanzionabile come abuso . La fusione accorpava entità riconducibili alla stessa famiglia, riducendo i costi di gestione duplicati, unificando il patrimonio in un solo soggetto più forte patrimonialmente. Questo è proprio l’esempio di “valide ragioni extrafiscali” che salvano l’operazione: il miglioramento organizzativo del gruppo è evidente, e la scelta di evitare la tassazione di plusvalenze latenti mediante fusione rientra nelle opzioni legittime offerte dal legislatore (che prevede la neutralità delle fusioni) . Cassazione in tal modo afferma che ridurre la catena societaria e razionalizzare l’organizzazione è una finalità lecita, e se l’operazione è coerente con tale finalità, il risparmio d’imposta ottenuto non è indebito ma fisiologico. Una massima tratta dal caso: “non è abusiva la fusione ex art. 172 TUIR che persegue il miglioramento strutturale dell’impresa, come la semplificazione della catena societaria, anche se tra gli effetti c’è l’assenza di tassazione di plusvalenze latenti diversamente dovuta” .
- Cassazione n. 868/2019 (sez. Trib.) – Legittimo risparmio d’imposta scegliendo l’opzione di legge: Questa sentenza, spesso citata in dottrina, ha stabilito un principio generale di grande importanza: se una certa operazione è espressamente prevista dalla legge e il contribuente la adotta ottenendo un risparmio d’imposta, ciò non è di per sé abuso . Il caso riguardava un’operazione societaria dove il contribuente aveva seguito un certo percorso consentito da norme tributarie, invece di un altro più oneroso, e il Fisco aveva tentato di contestare l’abuso. La Cassazione ha detto in sostanza: non si può sanzionare un contribuente solo perché, tra due strade lecite, ha scelto quella fiscalmente meno gravosa . Occorre provare che quella scelta fosse volta a ottenere un vantaggio indebito contrario alle finalità della norma. Questo principio riflette proprio il comma 4 dell’art. 10-bis, ed è un utile richiamo difensivo. Applicato alle fusioni: se la legge consente la fusione neutrale, non posso accusare di abuso un contribuente che preferisce fondere due società piuttosto che vendere asset con tassazione, a meno che emergano elementi di artificiosità (es. le società fuse non avevano alcuna logica economica autonoma se non quell’operazione). Quindi il difensore può argomentare, come suggerisce la dottrina: “Sto solo applicando la legge sulle fusioni, il vantaggio fiscale (neutralità, uso limitato delle perdite) è voluto dal legislatore, non c’è nulla di indebito” . Naturalmente ciò va sostenuto con cautela: se l’unico scopo era davvero sfruttare un “loophole”, il giudice potrebbe replicare che lo scopo fiscale era prevalente. Ma come linea generale, rivendicare la liceità formale e sostanziale dell’operato è un primo argine.
- Cassazione n. 653/2014 (sez. Trib.) – Operazione immobiliare elusiva ex art. 10 L. 408/90: Caso antecedente la codificazione dell’abuso, ma indicativo sul fronte immobili. La sentenza n. 653/2014 ha ritenuto integrasse un’operazione elusiva (ai sensi dell’art. 10 L. 408/90, vecchia norma anti-elusione) la seguente manovra: l’acquisto di terreni edificabili da parte di una società neocostituita, seguita da fusione della stessa con altra società, il tutto finalizzato ad aggirare obblighi tributari . In pratica, i terreni furono fatti comprare a una società-veicolo per poi fonderla, cercando di evitare imposte che sarebbero sorte in una vendita diretta. La Cassazione censurò la manovra come priva di valide ragioni economiche. Questo per dire che operazioni immobiliari che usino fusioni o scissioni per fruire di imposta fissa invece che proporzionale, se il contesto suggerisce un fine esclusivamente fiscale, sono a rischio. (È pur vero che dal 2018 l’art. 20 DPR 131 è stato modificato per evitare reinterpretazioni economiche degli atti di registro, ma rimane possibile l’applicazione dell’art. 10-bis in caso di costruzioni artificiose multiple).
- Cassazione n. 7708 e 7709/2017 (SS.UU. trib.) – Caso “ABCD” e il principio di certezza sull’art. 20 registro: queste Sezioni Unite (2017) riguardano principalmente l’imposta di registro, ma meritano menzione per completezza. Era uno schema di scissione e successiva cessione quote usato per minimizzare la tassazione di un trasferimento immobiliare. Le SS.UU., in quell’occasione, con un revirement dissero che l’art. 20 Registro doveva guardare all’atto e non all’operazione complessiva, sconfessando un indirizzo che avrebbe riqualificato l’insieme come cessione d’azienda tassabile. Successivamente il legislatore ha chiarito la portata di art. 20. Ciò segna che, almeno per le imposte indirette, c’è un limite legale all’approccio “economico” anti-elusivo. Rimane però salva la clausola generale per le imposte dirette, come già detto. Dunque su registro e ipocatastali oggi si tende ad applicare strettamente le norme agevolative se ne ricorrono i presupposti, senza troppo spazio a contestazioni retrospettive – a meno di evidenti frodi (es. simulazione).
In sintesi, dal panorama giurisprudenziale tributario possiamo trarre alcune linee guida utili in difesa:
- Business purpose cruciale: Se l’operazione di fusione (inversa) può essere motivata con un credibile progetto industriale/organizzativo (espansione, ingresso socio strategico, razionalizzazione di gruppo, salvaguardia di poste attive, richiesta di banche, ecc.), la difesa ha buone chance. Cass. 35398/2021 e 13914/2023 ne sono esempi: in presenza di ragioni sostanziali, la Cassazione ha respinto l’accusa di abuso .
- Change of control: per le operazioni LBO, un effettivo mutamento della compagine proprietaria (ingresso indipendente di un terzo o passaggio da controllo individuale a condiviso) è l’elemento fattuale che più di ogni altro distingue un LBO lecito da uno abusivo . In difesa, enfatizzare ogni cambiamento reale di governance o di business intervenuto grazie all’operazione.
- Interessi passivi e leva: se la contestazione verte sugli interessi dedotti per il debito trasferito, mostrare che il debito aveva una funzione economica (es. finanziare l’acquisizione effettiva, garantire investimenti) e che gli interessi sono proporzionati e “inerenti” all’attività produttiva . La Risposta AE 251/2024 ha confermato la deducibilità degli interessi in un LBO non abusivo, evidenziando che erano connessi all’investimento e utili ai flussi di cassa dell’impresa, quindi inerenti .
- Circolari e prassi: la circ. 6/E-2016 e varie risposte a interpello (2020, 2022, 2024) ribadiscono che le operazioni di LBO/fusione non sono elusive se c’è logica imprenditoriale (anche i finanziatori spesso richiedono la fusione inversa per tutelare il rimborso con i flussi della target, il che è una ragione economica valida) . Questi documenti possono essere citati a supporto (non hanno forza di legge ma mostrano la posizione ufficiale del Fisco, utile se positiva).
- Onere della prova: sottolineare se il Fisco non ha portato concreti elementi di artificiosità, limitandosi a congetturare intenti. Ad esempio, Cass.13914/2023 sembra aver considerato non sufficiente il solo dato della partecipazione residua dei vecchi soci per provare l’abuso . Quindi in giudizio si può contestare la carenza probatoria dell’Ufficio, specialmente se il contribuente ha fornito spiegazioni alternative plausibili.
Passando ora al fronte creditori e profili civilistici, analizziamo come la giurisprudenza ha trattato i casi di contestazioni su fusioni “fraudolente” o simulate ai danni di creditori.
Giurisprudenza civilistica: creditori, revocatoria e simulazione nelle fusioni
Quando una fusione (inversa o meno) viene sospettata di ledere i creditori, entrano in gioco strumenti di diritto civile. Negli ultimi anni, la Cassazione ha chiarito l’ammissibilità di tali strumenti e i limiti di tutela. Ecco i punti salienti con riferimenti giurisprudenziali:
- Opposizione dei creditori (art. 2503 c.c.): La Cassazione ha costantemente ricordato la funzione fondamentale di questo istituto. Il creditore che teme pregiudizio deve attivarsi entro 60 giorni dall’iscrizione del progetto di fusione per bloccare l’operazione . Una volta decorso tale termine senza opposizioni (o se le opposizioni sono rigettate o i creditori soddisfatti/garantiti), la fusione può essere attuata e il creditore non può più impedirla direttamente . Tuttavia – chiarisce la giurisprudenza – ciò non priva il creditore di ogni tutela successiva. Infatti:
- Cass. 31654/2019: ha confermato che l’art. 2504-quater c.c. (preclusione di nullità) non impedisce l’azione revocatoria della fusione . L’opposizione ex art. 2503 è preventiva e serve a evitare la fusione; la revocatoria, invece, è successiva e ne dichiara l’inefficacia relativa verso il creditore attore, senza intaccare la validità dell’atto per gli altri . In Cass. 31654/2019 la Suprema Corte spiega proprio che la fusione, pur non essendo un contratto tipico, può essere soggetta a revocatoria in quanto atto a titolo gratuito o a titolo oneroso potenzialmente lesivo della garanzia patrimoniale, e che ciò non contrasta con 2504-quater poiché la revocatoria non “smonta” la fusione ma la rende inopponibile al solo creditore istante . Dunque, il creditore che non ha fatto opposizione in tempo può comunque agire ex post per tutelarsi, purché ne ricorrano i presupposti (eventus damni e scientia fraudis).
- Conseguenza: dal lato del debitore (fusosi), il fatto di non aver ricevuto opposizioni nei termini è un punto a favore ma non una garanzia totale. In difesa, se poi arriva una revocatoria, potrà essere evidenziato che i creditori erano stati informati e non si opposero (quindi implicito riconoscimento che non vedevano pregiudizio), ma la mancanza di opposizione non impedisce al giudice di valutare successivamente il pregiudizio concreto.
- Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): Oggi pacificamente ritenuta ammissibile sulle fusioni. La giurisprudenza – come detto – è giunta ad ammettere la revocatoria di atti di fusione e scissione perché l’azione mira a dichiarare l’inefficacia relativa, lasciando intatta l’operazione verso gli altri soggetti . Ciò è compatibile con la natura della fusione. La Cassazione ha più volte applicato la revocatoria a fusioni/scissioni se queste hanno arrecato danno ai creditori e gli amministratori/soci erano consapevoli (consilium fraudis). Ad esempio, Cass. 13878/2019 (sempre in tema di fusione) e Cass. 21932/2021 (su scissione) confermano questa linea. Sul fronte transfrontaliero, citiamo Cass. 2153/2021: in un caso di fusione Italia-estero, dopo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (causa C-394/18, IGI vs Cicenia, 2020) è stato affermato che anche una fusione transfrontaliera può essere oggetto di revocatoria ordinaria in Italia . La CGUE ha detto che le direttive UE sulle fusioni non impediscono ai creditori di esercitare tutele come la revocatoria previste dal diritto nazionale, purché ciò non ostacoli sproporzionatamente la libertà di stabilimento . Il risultato è un equilibrio: la fusione transfrontaliera non deve diventare un mezzo per eludere i creditori; se c’è frode o abuso, i creditori possono colpire quell’atto in giudizio (e il giudice nazionale valuterà caso per caso).
Difendere una fusione da una revocatoria significa provare l’assenza di eventus damni (cioè che la fusione non ha reso più difficile per il creditore soddisfarsi) e/o l’assenza di consapevolezza dolosa. Ad esempio, se dopo la fusione la società risultante aveva comunque patrimonio sufficiente a pagare il debito, non c’è eventus damni. Oppure che l’operazione era nota e fatta in buona fede, magari volta a salvare l’azienda e non a danneggiare i creditori (qui però la scientia damni è spesso desunta dal fatto stesso che gli amministratori sapevano dei debiti e hanno comunque fatto la fusione, quindi è dura contestare la conoscenza – più pratico puntare sul negare il danno).
- Azione di simulazione: In teoria un creditore potrebbe sostenere che la fusione è simulata, cioè le parti in realtà non volevano unire le società ma perseguivano un diverso accordo occulto. Ad esempio, potrebbero aver simulato la fusione solo per far apparire estinta la società debitrice, con intesa segreta di gestire separatamente gli asset o retrocederli ai vecchi soci successivamente . La simulazione assoluta (fusione “finta”) è però molto difficile da provare, specie considerando che la fusione coinvolge delibere assembleari pubbliche e un complesso di atti formali. Tuttavia, Cass. 230/2025 (Sez. II Civ.) ha ribadito un principio interessante sul piano probatorio: il creditore, essendo terzo, può provare la simulazione anche con presunzioni e testimoni, non essendo vincolato ai limiti probatori che avrebbero le parti contrattuali . Ciò significa che il creditore può mettere insieme indizi (es. movimenti di beni post-fusione, strani accordi collaterali, mancanza di effettiva integrazione aziendale dopo la fusione, ecc.) e se riesce a convincere il giudice della presenza di un accordo simulato, può ottenere una dichiarazione di simulazione relativa (inefficacia verso di lui). In pratica avrebbe un effetto simile alla revocatoria: la fusione non gli è opposta. Ad ogni modo, la Cass. 230/2025 ammette la facoltà di prova ampia per il creditore, ma conferma che dimostrare una fusione simulata è arduo: serve evidenziare un pactum sceleris preciso, e spesso mancano controdichiarazioni o “smoking gun”. Più frequente infatti è che i creditori scelgano la strada della revocatoria o del risarcimento del danno, senza spingersi ad allegare una simulazione in senso tecnico (che richiede di provare l’accordo simulatorio tra le società). Dal lato difesa, si ribadirà la genuinità dell’operazione e l’assenza di accordi occulti; spesso basta l’oggettiva mancanza di prove contrarie.
- Responsabilità per danni verso i creditori: Va ricordato che, se una fusione causa pregiudizio ingiusto ai creditori, oltre agli strumenti sui singoli atti, questi potrebbero anche citare gli amministratori (e i soci eventualmente) per risarcimento del danno. Ciò in virtù dell’art. 2504-quater c.c. ultima parte: restano salvi i diritti dei terzi di ottenere il risarcimento di eventuali danni causati dalla fusione. Ad esempio, se la fusione è avvenuta in violazione della procedura (magari malafede nell’omissione di informazioni) e il creditore non è riuscito a opporsi per tempo, potrebbe chiedere i danni agli amministratori che hanno gestito l’operazione in frode. La giurisprudenza su questo è meno frequente (di solito i creditori preferiscono la revocatoria per aggredire direttamente i beni). Tuttavia, sapere che esiste questa spada di Damocle può servire da deterrente: se l’operazione è borderline, gli amministratori rischiano in proprio. In difesa, ovviamente, si negherà la sussistenza di un danno risarcibile o di comportamenti illegittimi.
In conclusione, la giurisprudenza civile ci dà queste indicazioni: – La fusione non è intoccabile: i creditori hanno vie per reagire anche post, e le Corti le riconoscono (revocatoria soprattutto). Quindi non si deve sottovalutare la loro posizione. – Difesa ex post possibile: se il debitore mostra che la fusione non ha aggravato il rischio per i creditori (es. fornendo garanzie, o dimostrando che i beni restano aggredibili nella incorporante), allora la revocatoria potrebbe essere respinta per mancanza di pregiudizio. Ad esempio, la Cassazione ha negato la revocatoria di una scissione dove era emersa l’assenza di eventus damni perché le due società post-scissione avevano patrimonio sufficiente pro-quota. – Esterovestizione via fusione: l’abbiamo accennata con Cass. 2153/2021. Se uno volesse usare la fusione transfrontaliera per “portare via” la società all’estero e sfuggire ai creditori italiani, sappia che ciò può essere contrastato con revocatoria e con misure fiscali anti-esterovestizione (il Fisco potrebbe continuare a considerare residente in Italia la società se la direzione effettiva resta qui, a dispetto della fusione all’estero) . Anche in sede UE, la libertà di stabilimento non protegge operazioni abusive o puramente fittizie.
Alla luce di questo panorama giurisprudenziale, nel prossimo capitolo ci concentreremo sulle strategie difensive concrete. Ovvero: cosa può fare un debitore (inteso sia come contribuente verso il fisco, sia come società verso creditori) per prevenire o contrastare efficacemente le contestazioni su una fusione inversa sospettata di elusione/frode.
Strategie difensive: come prepararsi e come reagire
In questa sezione operativa, assumiamo la prospettiva del debitore/società che ha realizzato (o intende realizzare) una fusione inversa potenzialmente critica e vuole difendersi da possibili contestazioni. Divideremo le strategie in due momenti: 1. Prevenzione e preparazione (prima e durante l’operazione) – per mettere in sicurezza la fusione, ridurre il rischio di contestazione e raccogliere elementi probatori a proprio favore. 2. Gestione del contenzioso (dopo l’eventuale contestazione) – come impostare la difesa in sede di confronto con l’Agenzia delle Entrate (fase pre-accertamento e accertamento con adesione) e poi davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, nonché come difendersi da eventuali azioni dei creditori sul piano civile.
Prima della fusione: pianificazione e interpelli preventivi
La miglior difesa è la prevenzione. Se si sta pianificando una fusione inversa e si intravedono possibili profili elusivi, è opportuno agire proattivamente:
- Valutare l’operazione in ottica anti-abuso: analizzare onestamente se la fusione ha sostanza economica. Ci si chieda: Faremmo questa fusione anche se non ci fosse alcun vantaggio fiscale? Quali benefici aziendali concreti porta? Se la risposta è nebulosa, è un segnale di allerta. In tal caso, considerare l’opportunità di modificare la struttura dell’operazione per darle maggiore sostanza (es: coinvolgere un partner reale, combinare la fusione con una ristrutturazione operativa genuina, evitare schemi troppo complessi).
- Documentare le ragioni extrafiscali: sin dalle deliberazioni iniziali, occorre mettere nero su bianco i motivi economico-organizzativi. Ad esempio, far predisporre una relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies c.c. estremamente dettagliata (anche se in fusione semplificata non è obbligatoria, è utile farla ugualmente a fini interni), in cui si evidenziano:
- Le sinergie attese dall’operazione (risparmio di costi duplicati, migliore efficienza gestionale, miglior utilizzo di capitali, ecc.).
- La situazione di mercato e perché la fusione aiuta ad affrontarla (es: dimensione aziendale, accesso a credito, ecc.).
- Eventuali esigenze dettate da terzi: es. una banca finanziatrice ha richiesto espressamente la fusione inversa per vincolare i flussi di cassa al rimborso del debito ; oppure un investitore ha posto come condizione per entrare nel capitale la razionalizzazione del gruppo.
- Ogni elemento sostanziale: ad esempio, se l’operazione rientra in un passaggio generazionale, spiegare il perché (il padre socio unico fa entrare il figlio con quote, poi fondono per continuità generazionale). Oppure: se ci sono problemi contrattuali che la fusione inversa evita (lo si scriva chiaramente: “la fusione viene effettuata in forma inversa per non violare clausole di cambio controllo esistenti nei contratti X, Y”).
Questi documenti interni (verbali assembleari, relazioni amministratori, eventuali pareri pro veritate di consulenti) saranno preziosi in sede contenziosa per dimostrare ex post le valide ragioni extrafiscali . Costituiscono la prova che già in origine l’operazione aveva scopi leciti dichiarati, non inventati a posteriori sotto accertamento.
- Interpello anti-abuso (art. 11, co.1, lett. c, L.212/2000): Uno strumento chiave di prevenzione è presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere se l’operazione sarà considerata abusiva . L’interpello va inviato prima di effettuare l’operazione (comunque prima che scadano i termini dichiarativi relativi alla stessa) e deve descrivere dettagliatamente il caso, le operazioni, e chiedere un parere circa l’applicabilità o meno dell’art. 10-bis .
- Se l’Agenzia risponde che non c’è abuso, si ottiene una sorta di “benestare” vincolante per l’Amministrazione su quella fattispecie (salvo che la situazione di fatto non differisca da quanto dichiarato). Questo ovviamente mette al riparo da futuri accertamenti su quell’aspetto.
- Se l’Agenzia risponde che c’è abuso, il contribuente ha il vantaggio di conoscere ex ante la posizione fiscale e può decidere di rimodulare l’operazione per evitare l’abuso (magari cambiando struttura, attendendo tempi diversi, ecc.), oppure può comunque procedere conscio del rischio e preparandosi alla battaglia legale futura. L’interpello negativo non vincola il contribuente (può anche ignorarlo e fare lo stesso l’operazione), ma ovviamente se non segue le indicazioni andrà incontro quasi certamente a un accertamento.
- Se l’Agenzia non risponde nei 90 giorni (silenzio-assenso), l’assenza di risposta equivale a condivisione dell’interpretazione proposta dal contribuente. Bisogna tuttavia essere cauti: il silenzio-assenso vale solo se l’istanza era completa e riferita proprio all’art. 10-bis; conviene, se si ottiene, conservarne traccia a futura memoria in caso di contestazioni.
Negli ultimi anni l’Agenzia ha pubblicato diverse risposte a interpello su fusioni e LBO: ad esempio la Risposta n. 251/2024 citata prima , la Risposta n. 128/2022 (che riguardava un’aggregazione aziendale dichiarata non abusiva) , la Risposta n. 416/2020 (in tema di disapplicazione limiti di perdite in fusione) , ecc. Un interpello ben argomentato, facendo leva su queste posizioni già espresse, può spesso convincere l’AE. Ad esempio, se nel nostro caso c’è un vero cambio di controllo con nuovo investitore, citeremo la risposta 251/2024 dove l’AE ha detto che in presenza di tale elemento l’operazione “non configura un’operazione elusiva” .
- Interpello disapplicativo (art. 11, co.2, L.212/2000): Se l’operazione non è di per sé abusiva ma ricade in qualche norma antielusiva specifica (tipicamente sul riporto di perdite, interessi o ACE), si può presentare un interpello per chiedere la disapplicazione di quella norma antiabuso speciale, dimostrando che nel caso concreto non c’è scopo elusivo . Ad esempio, se la fusione fa perdere le perdite fiscali dell’incorporata perché non supera i test di legge, ma ci sono motivazioni industriali serie per la fusione e le perdite non sono il motivo dell’operazione, si può tentare un interpello per mantenere le perdite (mostrando piani di sviluppo, ecc.). L’Agenzia in questi interpelli è spesso rigorosa, ma se il quadro è convincente potrebbe accogliere (in alcuni casi ha accolto, specie se la società incorporata era “viva” e la fusione aveva logica diversa dal solo utilizzo delle perdite).
In definitiva, interpello sì o no? – Molti professionisti concordano che, se c’è anche solo un 30% di rischio che l’operazione venga considerata elusiva, conviene interpellare. Perché: – Se l’AE dice “tutto ok”, si dormono sonni tranquilli. – Se dice “non ok”, almeno lo si sa prima e si può cambiare rotta o prepararsi. – Se non si interpella e poi arriva un accertamento, il confronto inizia in salita.
Va detto che l’interpello antiabuso è gratuito, e dalla risposta (o silenzio) si ha un responso che vincola il Fisco. Quindi è uno strumento prezioso per chi vuole muoversi entro le regole con certezza.
Durante e subito dopo la fusione: accortezze per limitare i rischi
Oltre alla pianificazione, vi sono alcune accortezze da osservare in fase attuativa e immediatamente successiva:
- Trasparenza e coerenza: compiere l’operazione in modo trasparente, senza side agreements nascosti. Ad esempio, se i soci stipulano patti parasociali, assicurarsi che non contraddicano gli obiettivi dichiarati (es: sarebbe contraddittorio proclamare un cambio di controllo e poi firmare un patto che di fatto mantiene il potere al vecchio socio; ciò darebbe al Fisco un appiglio per dire che il cambio era fittizio). Nel caso citato di interpello 251/2024, ad esempio, fu rilevante che non vi fossero patti parasociali occulti che alterassero la pariteticità tra i nuovi soci .
- Business continuity: dopo la fusione, comportarsi in modo coerente con le ragioni addotte. Se si è detto che l’operazione serve per migliorare l’efficienza, poi non si deve chiudere la società o vendere subito gli asset (a meno che non fosse previsto come parte di un piano industriale genuino). Qualsiasi atto successivo che sembri smentire la narrazione iniziale potrebbe essere usato contro (es.: se l’AE vede che un mese dopo la fusione vendi l’unico immobile a un prezzo basso al socio, penserà che tutta l’operazione era preordinata a quello).
- Garanzie ai creditori: lato creditori sociali, se c’erano debiti significativi, considerare di offrire garanzie volontarie ai creditori prima o contestualmente alla fusione. Ad esempio, far rilasciare una fideiussione a favore del creditore, o accantonare somme in escrow. Questo può scoraggiare opposizioni e soprattutto, se poi qualcuno agisce in revocatoria, si potrà dire: abbiamo addirittura offerto garanzie, segno che non volevamo frodare nessuno. L’art. 2503 stesso prevede che il tribunale può autorizzare la fusione nonostante opposizione se i debiti vengono soddisfatti o garantiti. Quindi predisporre garanzie ex ante è una mossa difensiva astuta quando la situazione con i creditori è delicata.
- Comunicazione con i creditori: talvolta, se opportuno, informare attivamente i principali creditori del progetto di fusione e rassicurarli (magari fornendo piani su come saranno pagati). Questo può evitare che si sentano spiazzati e facciano causa. Certo, legalmente non è obbligatorio (basta l’iscrizione nel registro imprese), ma per creditori di grosso rilievo potrebbe convenire negoziare prima (anche perché se uno di essi fa opposizione, la fusione si blocca finché non lo si sistema).
- Timing: evitare concatenazioni troppo rapide e sospette. Ad esempio, se proprio c’è necessità di fare conferimento + fusione, meglio aspettare un certo tempo tra le due operazioni, dimostrando che la seconda non era già decisa prima (a meno che non si sia fatto interpello su tutto). Più gli eventi sono contestuali e ravvicinati, più è facile per il Fisco dire che c’era un disegno unitario (anche se ormai l’abuso non richiede più il “disegno” come il vecchio 37-bis, di fatto il ragionamento lo fanno).
- Conservare tutta la documentazione: sembra banale, ma avere poi in sede di verifica tutte le carte (verbali, piani finanziari, perizie, corrispondenza con banche/investitori) faciliterà il lavoro del difensore. Spesso i contenziosi si vincono o perdono sulla qualità della documentazione prodotta a supporto delle argomentazioni.
In caso di contestazione fiscale: difesa in sede di accertamento e contenzioso
Se, nonostante tutto, arriva dall’Agenzia delle Entrate una contestazione (notifica di “Comunicazione di elementi di accertamento ex art. 10-bis” o direttamente un Processo Verbale di Constatazione da parte della Guardia di Finanza in ambito verifica fiscale), occorre reagire tempestivamente e in modo strutturato:
- Fase del contraddittorio (richiesta chiarimenti art. 10-bis): Come detto, l’ufficio deve inviare una richiesta di chiarimenti prima di emettere l’avviso. Questa è una fase cruciale. Il contribuente ha 60 giorni per inviare una memoria difensiva. Qui vanno spese tutte le cartucce:
- Rispondere per iscritto in modo articolato, punto per punto alle argomentazioni del Fisco. Spiegare di nuovo le ragioni economiche, allegare tutta la documentazione che supporta la buona fede e la sostanza dell’operazione (verbali, contratti di finanziamento, piani, ecc.) .
- Se nella richiesta dell’AE ci sono errori di fatto, correggerli subito (es: “l’ufficio afferma che i soci dopo l’operazione erano gli stessi di prima, ma in realtà è entrato il fondo X col 40% come da verbale allegato…”).
- Citare precedenti a favore: se esistono risposte a interpello o circolari o sentenze calzanti, riportarle. Ad es., si potrebbe allegare copia della Risposta 251/2024 se simile, o menzionare Cass. 35398/2021 se il caso è di semplificazione del gruppo, ecc. Questo per “educare” l’ufficio a considerare l’operazione nella giusta luce e far capire che in giudizio abbiamo frecce al nostro arco.
- Tono costruttivo ma fermo: mostrarsi collaborativi (“siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento anche in via orale”), ma anche fermi nel sostenere la legittimità: usare la carta “non c’è indebito vantaggio, c’è valida ragione, l’ordinamento consente questa operazione come da art. 10-bis comma 3” .
Questa risposta scritta può in alcuni casi convincere l’ufficio a desistere o a ridimensionare la pretesa. Anche se spesso, realisticamente, l’Agenzia prosegue, una buona risposta è già un mattone della difesa futura: ciò che scriviamo qui sarà la base del ricorso in Commissione se si arriverà lì.
- Accertamento con adesione: Una volta notificato l’eventuale Avviso di Accertamento per abuso (o comunque l’atto impositivo), il contribuente ha la possibilità di avviare la procedura di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/97). Cos’è? È un tavolo di conciliazione pre-contenziosa con l’ufficio, dove si può cercare un accordo transattivo. Ci sono 90 giorni di sospensione dei termini per fare ricorso se si presenta istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Nel caso di contestazioni antiabuso, l’adesione può essere delicata: spesso verte su questioni di principio più che su cifre facilmente trattabili. Tuttavia, può valere la pena tentare se: – L’ufficio appare aperto a discutere (magari perché la posizione non è granitica, o perché c’è incertezza su alcuni aspetti). – Il contribuente vuole cercare un compromesso per evitare il contenzioso (ad esempio, riconoscere una parte del carico fiscale in cambio del ritiro di sanzioni o riduzione delle stesse).
Nell’adesione, potrebbe emergere ad esempio una soluzione di mediazione: il Fisco riconosce che c’era una parte di valide ragioni, ma insiste su un punto (es: non riconoscere deducibilità di una quota di interessi). Si potrebbe chiudere pagando quella quota, con sanzioni ridotte a 1/3 e cessando la materia del contendere. Bisogna fare attenzione: l’adesione comporta rinuncia al ricorso, quindi va accettata solo se si è convinti che il compromesso sia favorevole rispetto ai rischi del giudizio.
Un vantaggio di provare l’adesione è che durante la discussione si può comprendere meglio le argomentazioni dell’ufficio e magari convincerli su alcuni punti. Inoltre, le sanzioni in sede di adesione sono ridotte al 1/3 e non si applicano interessi di mora ulteriori. Ricordiamo che nelle contestazioni di abuso, l’ammontare delle imposte recuperate può essere consistente (plusvalenze latenti, deduzioni negati ecc.), quindi anche le sanzioni al 90% su quelle imposte sono consistenti – ridurle a 30% con adesione può far gola se la causa appare incerta.
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria): Se non c’è accordo, si passa al ricorso giudiziale. Qui la difesa deve essere costruita meticolosamente, riprendendo quanto già argomentato e arricchendo con eventuali nuovi elementi. Punti importanti:
- Impostare il ricorso evidenziando subito eventuali vizi formali dell’atto impositivo (es: mancanza della richiesta di chiarimenti o motivazione inadeguata rispetto alle controdeduzioni: se così fosse, chiedere l’annullamento per violazione art. 10-bis commi 7 e 8) .
- Nel merito, suddividere bene i capitoli: dimostrare punto per punto la sussistenza di sostanza economica (portare numeri se possibile: incremento Ebitda atteso, sinergie quantificate, costi risparmiati, ecc.), l’assenza di vantaggi indebiti (mostrare che il carico fiscale complessivo magari non è nemmeno diminuito o è diminuito in linea con misure agevolative previste dalla legge, quindi “voluto dal legislatore”), e la coerenza dell’operazione con la ratio delle norme (ad esempio: “la fusione gode di neutralità per favorire concentrazioni – la nostra era proprio una concentrazione industriale; non stiamo eludendo la norma, stiamo usandola secondo la sua finalità”).
- Chiamare eventualmente testimoni (nel processo tributario non è ammessa testimonianza orale, ma si possono produrre dichiarazioni giurate di terzi). Ad esempio, far fare una dichiarazione al funzionario di banca che attesti: “abbiamo richiesto noi come banca finanziatrice la fusione inversa per avere garanzia sui flussi”. Oppure la dichiarazione di un partner commerciale: “la fusione tra X e Y ha migliorato la posizione sul mercato e ridotto costi, confermo che era da tempo auspicata”. Non sempre i giudici tributari le considerano, ma è lecito tentarne l’inserimento come elementi di prova scritta.
- Se rilevante, eccepire che l’atto impositivo non ha considerato fatti decisivi o ha applicato male la norma: ad esempio, se l’ufficio ha ignorato l’esimente delle valide ragioni extrafiscali non marginali, sottolineare che ciò rende la motivazione incompleta. Oppure se ha ritenuto indebito un vantaggio ma quel vantaggio è espressamente previsto (es: ha considerato indebito il risparmio d’imposta derivante dall’assenza di tassazione di plusvalori, ma quella è la regola legale delle fusioni: si può argomentare che non è un “vantaggio indebito” ma la conseguenza di una scelta che l’ordinamento offre legittimamente ).
- Citare giurisprudenza e interpretazioni favorevoli come quelle discusse. I giudici apprezzano i riferimenti, specie a Cassazione o Corte UE. Ad esempio, menzionare Cass. 35398/21 per analogia, oppure riportare stralci di Cass. 13914/23 dove dice che il solo concorso dei vecchi soci non basta a provare abuso .
- Burden of proof: rimarcare se l’AE non ha assolto al suo onere di provare la mancanza di sostanza. Ad esempio, dire: “L’ufficio si limita ad affermare che la società veicolo era ‘dormiente’, ma non fornisce elementi oggettivi; al contrario la società ha dimostrato che…”. Se le prove dell’AE sono carenti, farlo notare con forza (in dubio pro contribuente, verrebbe da dire, anche se in realtà il giudice tributario poi valuta nel complesso).
Infine, cosa aspettarsi: nei gradi di merito, le Corti di Giustizia Tributaria provinciali e regionali potrebbero non essere sempre allineate. Alcune Commissioni hanno approcci più formalistici (se c’è risparmio consistente, tendono a dar ragione al Fisco), altre più pro-contribuente. Non scoraggiarsi se in primo grado va male: la partita spesso si gioca in Cassazione, dove i principi di diritto vengono applicati con maggior uniformità. L’importante è creare un solido dossier agli atti già nei primi gradi, così che in Cassazione la nostra posizione sia chiara e ben documentata.
Difendersi dalle azioni dei creditori
Parallelamente al fronte fiscale, se ci sono creditori scontenti: – Se viene proposta un’opposizione ex art. 2503: bisogna costituirsi dinanzi al Tribunale e dimostrare che la fusione non lede le ragioni del creditore opponente. Tipicamente si cercherà di mostrare che post-fusione il patrimonio è invariato o comunque sufficiente a soddisfarlo, o che il credito è contestato/inesistente, o offrire subito garanzie (cauzione, fideiussione) per ottenere l’autorizzazione a procedere lo stesso . Dal lato pratico, se il creditore ha ragione (la fusione lo pregiudica davvero), conviene eventualmente trovare un accordo transattivo (pagarlo o garantirlo) per fargli ritirare l’opposizione. Se invece l’opposizione è solo ostruzionistica, contrastarla evidenziando l’assenza di pericolo concreto. – Se arriva una citazione per revocatoria: predisporre la difesa come sopra accennato: provare mancanza di eventus damni (es. confrontare indici di solvibilità pre e post fusione, per mostrare che la fusione non ha reso il debitore meno solvibile – anzi magari ha unito patrimoni e rafforzato la garanzia generale). Se l’eventus damni è palese (tipo la società debitrice aveva immobili, fondendosi quelli si confondono e magari sono stati subito venduti altrove), puntare su questioni procedurali o consilium fraudis (negare che vi fosse l’intento di nuocere; magari la fusione era decisa prima che il credito nascesse? se il credito è posteriore e la fusione originaria, manca un presupposto). – Far valere se possibile che il creditore era a conoscenza e non si è opposto, come elemento di sua acquiescenza. – In certi casi, eccepire la decadenza dell’azione se fuori dai tempi (5 anni dal compimento dell’atto per la revocatoria ordinaria). – Simulazione o altre azioni: come detto, raramente i creditori scelgono la via della simulazione pura. Se succede, la difesa è molto simile: negare con forza l’esistenza di accordi occulti e sottolineare la reale attuazione della fusione (i patrimoni si sono consolidati, la società risultante opera normalmente, ecc., quindi nulla di simulato). – Bancarotta e profili penali: qualora – scenario peggiore – la fusione preceda di poco un fallimento e il curatore ipotizzi la bancarotta distrattiva (argomentando che la fusione ha distratto patrimonio), la difesa penale dovrà provare che l’operazione era di risanamento e non di sabotaggio, che non c’è stato depauperamento ma anzi un tentativo (anche se poi fallito) di salvare l’impresa. Se la fusione è avvenuta quando l’insolvenza era già conclamata, è difficile sfuggire a contestazioni; se era parte di un piano di ristrutturazione genuino, portare evidenze di ciò (delibere, pareri, ok dei creditori principali, ecc.). Comunque, ricordiamo che sul piano tributario, grazie all’art. 10-bis, l’elusione fiscale non è più penalmente punibile , quindi almeno non si rischia una denuncia per evasione fiscale se l’operazione, pur contestata, è stata trasparente nelle dichiarazioni (diverso sarebbe se per attuare l’abuso si sono anche fatte false comunicazioni, ma allora si sconfina nella frode).
Abbiamo così delineato le principali strategie. Per una visione più sintetica, proponiamo una tabella riepilogativa degli strumenti difensivi a disposizione del contribuente/società nelle varie fasi:
<table> <thead> <tr><th>Fase</th><th>Strumento difensivo</th><th>Descrizione e finalità</th><th>Vantaggi</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Prima dell’operazione<br>(pianificazione)</td><td>Analisi interna anti-abuso</td><td>Valutare la sostanza economica della fusione e identificare eventuali elementi critici (solo risparmi fiscali, possibili creditori lesi).</td><td>Permette di modificare ex ante l’operazione per renderla più solida (es. coinvolgere nuovi soci, evitare strutture artificiose) ed evitare errori.</td></tr> <tr><td>Prima dell’operazione</td><td>Documentazione ragioni economiche</td><td>Redigere relazioni, verbali e business plan dettagliati che evidenzino i motivi extrafiscali (sinergie, riorganizzazione, richieste di banche/investitori, ecc.).</td><td>Crea prova scritta delle motivazioni genuine, utile in caso di future contestazioni per dimostrare la buona fede e l’esistenza di finalità non elusive .</td></tr> <tr><td>Prima dell’operazione</td><td>Interpello anti-abuso</td><td>Istanza all’Agenzia Entrate per avere parere vincolante circa la natura non abusiva (o abusiva) dell’operazione progettata .</td><td>Se positivo, blindatura dell’operazione (nessun accertamento su quel profilo); se negativo, chance di rivedere i piani. Rimuove incertezza e documenta la volontà di agire correttamente.</td></tr> <tr><td>Prima/durante</td><td>Garanzie ai creditori</td><td>Offerta di garanzie (fideiussioni, ipoteche, pegni) o pagamento parziale ai creditori potenzialmente lesi, prima della fusione o come condizione per attuarla.</td><td>Evita o attenua opposizioni ex art. 2503 c.c.; in caso di successiva revocatoria, dimostra la mancanza di intento di frode (avendo tutelato i creditori fin dall’inizio).</td></tr> <tr><td>Durante</td><td>Trasparenza e coerenza</td><td>Condotta operativa conseguente alle motivazioni dichiarate: eseguire realmente l’integrazione societaria, non porre in essere atti contraddittori (patti occulti, vendite sospette post-fusione, etc.).</td><td>Riduce gli indizi a carico in possibili contenziosi. Un comportamento coerente rende più credibile la tesi difensiva che l’operazione era genuina e non simulata.</td></tr> <tr><td>Dopo (fase accertamento)</td><td>Memoria difensiva nel contraddittorio</td><td>Risposta scritta all’Agenzia a seguito della richiesta di chiarimenti art. 10-bis, con allegazione di prove e controdeduzioni puntuali .</td><td>Possibilità di convincere l’ufficio a soprassedere o ridurre la pretesa. Inoltre costruisce già il dossier difensivo per l’eventuale giudizio, mostrando collaborazione e preparando la linea argomentativa.</td></tr> <tr><td>Dopo (fase pre-contenziosa)</td><td>Accertamento con adesione</td><td>Procedura di confronto con l’ufficio post-notifica dell’atto impositivo, per raggiungere un accordo su imposte/sanzioni dovute (se del caso).</td><td>Può chiudere la vicenda evitando i costi e i tempi del contenzioso, con sanzioni ridotte (1/3). Utile se si prospetta una soluzione transattiva accettabile (ad es. riconoscere una parte delle imposte evitando però il grosso delle sanzioni).</td></tr> <tr><td>Dopo (contenzioso)</td><td>Ricorso tributario</td><td>Difesa tecnica in giudizio: eccezioni di nullità dell’atto se presenti; prova documentale delle ragioni extrafiscali; eventuali testimonianze scritte; richiami a giurisprudenza e circolari pro contribuente.</td><td>Un ricorso ben costruito può portare all’annullamento dell’accertamento. Anche se serve arrivare in Cassazione, consente di far valere i propri diritti davanti a giudici terzi e, spesso, di ottenere riduzioni o annullamenti significativi della pretesa fiscale.</td></tr> <tr><td>Dopo (azioni creditori)</td><td>Opposizione/ difesa in revocatoria</td><td>Resistere a iniziative dei creditori dimostrando assenza di pregiudizio (no eventus damni) o di malafede; sottolineare che la fusione mirava a obiettivi legittimi e ha rispettato la legge (ad esempio, credito posteriore, oppure patrimonio rimasto sufficiente).</td><td>Può evitare che l’atto di fusione venga dichiarato inefficace verso il creditore o che si debbano risarcire danni. In particolare, vincere un’opposizione significa poter procedere con la fusione; vincere una revocatoria significa mantenere gli effetti dell’operazione per tutti.</td></tr> </tbody> </table>
Questa tabella ricapitola il toolkit difensivo del debitore. Da notare che molte di queste mosse sono da effettuarsi in anticipo (soprattutto sul fronte fiscale): una volta che l’operazione è fatta male, rimediare è difficile. Ad esempio, se non si è documentato nulla e dopo due anni arriva un accertamento, si dovrà faticare il doppio per recuperare pezze d’appoggio. Dunque il messaggio chiave è: giocare d’anticipo.
Nel prossimo capitolo, per calare queste indicazioni nella realtà, esamineremo alcune simulazioni pratiche di possibili scenari in settori specifici – immobiliare, consulenziale, tecnologia – e come le strategie difensive si applicano in concreto.
Casi pratici e settori di applicazione
Di seguito proponiamo tre esempi pratici, ispirati a situazioni tipiche nei settori indicati (immobiliare, consulenziale, tecnologico), per capire come possano sorgere le contestazioni di fusione inversa abusiva e come il debitore possa difendersi in ciascun contesto:
Esempio 1: Settore immobiliare
Scenario: Immobiliare Alfa S.r.l. è una società di famiglia che possiede diversi immobili. La famiglia Alfa vuole trasferire gli immobili in una nuova società di investimento immobiliare (Beta S.p.A.) partecipata anche da un fondo, senza pagare imposte di trasferimento elevatissime. Decidono quindi di fondere inversamente Immobiliare Alfa in Beta S.p.A. (dove Alfa ha prima conferito gli immobili). Così Beta rimane proprietaria degli immobili, e i soci di Alfa ottengono azioni di Beta.*
Possibile contestazione: L’Agenzia Entrate vede in questa operazione il tentativo di aggirare l’imposta di registro (e ipocatastali) che sarebbe stata dovuta su una compravendita di immobili. Formalmente la fusione paga €200 di registro fisso, anziché il 9% del valore degli immobili. Se Beta S.p.A. era di nuova costituzione e praticamente non operativa, il Fisco potrebbe sostenere che la fusione è stata usata come “veicolo elusivo” per trasferire immobili tra proprietari sostanzialmente diversi senza tassazione. In passato, casi simili (anche con scissioni e conferimenti) sono stati ritenuti elusivi , a meno di dimostrare valide ragioni. Inoltre, i creditori (ad esempio banche che avevano ipoteche sugli immobili di Alfa) potrebbero temere un pregiudizio se Beta è patrimonialmente meno solida.
Difesa: – Sul piano fiscale, bisogna enfatizzare le ragioni economiche: ad esempio, Beta S.p.A. è partecipata da un fondo di investimento immobiliare, quindi l’operazione ha portato nuovi capitali nella gestione (non è solo la famiglia Alfa – c’è un partner esterno che investe, segno di operazione di riorganizzazione e finanziamento, non mero passaggio interno). Inoltre, la fusione potrebbe essere motivata con la volontà di creare un grande player immobiliare unendo patrimoni per meglio accedere al mercato (ragione imprenditoriale). Se questo è documentato (piano industriale, accordo col fondo), il risparmio di imposta di registro può apparire come effetto collaterale, non come unico scopo. – Un punto tecnico da sfruttare: la legge prevede espressamente registro fisso sulle fusioni; quindi di per sé non c’è violazione di una norma, e il vantaggio fiscale è “voluto dal legislatore”. Citare Cass. 868/2019 come analogia: scegliere una strada lecita fiscalmente più conveniente (fusione vs vendita) non è di per sé abuso . Occorre tuttavia convincere che esisteva un business purpose. Ad esempio, sottolineare che con la fusione il gruppo famiglia-fondo ha accorpato le attività immobiliari in un unico veicolo societario efficiente, mentre diversamente sarebbero restate spezzettate – questo migliora la gestione (riduzione costi, patrimonio consolidato per garanzie su finanziamenti, ecc.). Magari evidenziare che dopo la fusione Beta S.p.A. ha intrapreso nuovi investimenti (segno di vitalità economica). – Sul fronte creditori: Spiegare, se vero, che Beta S.p.A. dopo fusione ha un patrimonio netto robusto (includendo gli immobili ex Alfa e il capitale apportato dal fondo) quindi i creditori di Alfa non sono pregiudicati; anzi, ora hanno come debitore una S.p.A. con soci più solidi. Offrire comunque continuità di garanzie: ad esempio, se c’erano ipoteche su immobili, restano in essere sugli stessi immobili ora di proprietà Beta (la fusione non le rimuove) – dunque il creditore ipotecario mantiene il suo diritto sul bene. Se qualche creditore chirografario di Alfa lamenta rischio, si potrebbe evidenziare che Beta ha assunto tutti i debiti ed è solvente, eventualmente proponendo una garanzia aggiuntiva (p.es. il fondo o la famiglia rilasciano fideiussione). – Se l’Agenzia contestasse, un interpello preventivo qui sarebbe stato utile. In mancanza, in contraddittorio si può citare eventuali prassi su casi simili. Ad esempio la Risposta AE n. 39/2022 riguardava proprio una fusione con società immobiliare e ha chiarito (se era quella) che l’operazione non aveva intento elusivo laddove rispettava i requisiti di legge e non vi era un risparmio “indebito” oltre la normale applicazione dell’imposta fissa . In generale, ricordare come il legislatore stesso ha previsto regimi per agevolare riorganizzazioni immobiliari (basti pensare alla PEX per le cessioni di partecipazioni in società immobiliari, ecc.): se la famiglia Alfa avesse venduto le quote di Alfa S.r.l. al fondo, quelle sì esenti (PEX). Invece hanno optato per fusione – non un artificio, ma un’opzione disponibile. – Se fosse rilevante la questione perdite fiscali (spesso le immobiliari hanno plusvalenze latenti più che perdite), comunque evidenziare che Alfa S.r.l. non aveva perdite da portare in dote, quindi la fusione non è servita a “usar perdite”. Se invece le aveva, e Beta era inattiva, qui l’abuso sarebbe palese: in quel caso, se difendibile, andava fatto interpello disapplicativo per tenere le perdite.
Esito atteso: Se la difesa riesce a dimostrare che Beta post fusione è un soggetto più forte e funzionale (nuovi soci, progetti di sviluppo) e che non c’è stato alcun intento di frode verso creditori (nessun bene occultato, tutti i creditori conosciuti soddisfatti/garantiti, ecc.), è plausibile ottenere un esito favorevole. Cass. 35398/2021 offre un precedente: in un caso di fusione “di comodo” per evitare plusvalenze su liquidazione di società immobiliari, la Cassazione l’ha giudicata lecita in quanto finalizzata a miglioramento strutturale . Il nostro caso è analogo se ben motivato.
Esempio 2: Settore consulenziale
Scenario: Studio Gamma S.n.c. è una società tra professionisti (consulenti aziendali) con 3 soci, e Gamma Holding S.r.l. è la controllante posseduta dagli stessi soci dove nel tempo hanno accumulato utili. Si decide di fare una fusione inversa: Studio Gamma S.n.c. (controllata operativa) incorpora Holding S.r.l. (controllante). Motivo dichiarato: semplificare la struttura e far confluire tutto in un’unica società di capitali per meglio attrarre investitori o partner industriali in futuro.
Possibile contestazione fiscale: L’Agenzia potrebbe sospettare che l’operazione miri a trasformare redditi personali in redditi societari con tassazione più bassa, oppure a generare un avviamento deducibile. Infatti, poniamo che Holding S.r.l. aveva acquistato tempo prima (dai soci stessi) una parte di clientela o marchio creando un avviamento iscritto a bilancio. Con la fusione, quell’avviamento permane in Studio Gamma S.n.c. (divenuta S.r.l. post fusione) e viene ammortizzato riducendo il reddito tassabile. L’AE potrebbe dire: avete autoprodotto un avviamento vendendo a voi stessi l’attività e poi avete fuso per dedurvelo – tipico schema abusivo se privo di sostanza. Inoltre, i soci col passaggio a S.r.l. potrebbero evitare l’IRAP (anche se in verità le STP pagano IRAP di base comunque). Il sospetto aumenterebbe se Holding non aveva altre attività se non possedere lo studio.
Difesa: – Mostrare che la fusione era parte di un progetto di crescita dimensionale: ad es. l’intento è trasformare lo Studio in una società di capitali più strutturata, magari in vista di aggregazioni con altri consulenti o di ingresso nel capitale di un socio finanziatore. Se ci sono evidenze (contatti con potenziali partner che preferiscono interloquire con una Spa, necessità di rating bancario migliore ottenibile come spa, etc.), evidenziarle. – Se c’è l’elemento generazionale: uno dei soci anziani vuole ritirarsi, i giovani vogliono continuare come S.r.l. – anche questo è un valido motivo extrafiscale (passaggio da forma personalistica a capitale per continuità dell’impresa professionale). – Riguardo all’avviamento deducibile: bisogna dimostrare che non è stato creato ad arte. Se la holding aveva realmente pagato per rilevare la clientela/branch dello studio anni fa, e quell’avviamento esiste contabilmente, la fusione in sé non crea nuovo avviamento, semplicemente porta a dedurre quello residuo. Argomentare che ciò è legittimo in base alle norme (le quali consentono l’ammortamento dell’avviamento acquisito). Per negare l’abuso, sottolineare che l’operazione di cessione iniziale allo holding aveva sue ragioni (ad esempio proteggere il patrimonio personale dei soci trasferendo l’attività in una società di capitale, etc.), non era finalizzata solo alla deduzione. E la fusione ora serve ad integrare definitivamente le due entità perché mantenere separata la holding è inefficiente. – Un elemento di difesa può essere: prima della fusione, Studio Gamma come SNC pagava IRPEF sui redditi dei soci e IRAP; dopo come SRL pagherà IRES 24% e i soci pagheranno dividendi eventualmente con tassazione del 26%. Non c’è un risparmio netto enorme, anzi talvolta la tassazione complessiva può risultare maggiore (dipende dalle scelte di distribuzione). Quindi non è neppure certo il “vantaggio fiscale” – anzi, la fusione trasforma un reddito da lavoro (pro-quota soci) in reddito di capitale tassato separatamente. – Se l’AE punta sull’abuso per avviamento autoprodotto, si può citare giurisprudenza sul punto che dice che se l’operazione è reale (c’è stata una cessione con un prezzo effettivo) la deduzione è consentita e l’abuso non sussiste, salvo provare che era un passaggio meramente cartolare. Forse qualche Cassazione come la 2853/2013 trattava casi simili. In mancanza, usare art. 10-bis: l’avviamento dedotto è frutto di un’operazione (la cessione iniziale al holding) che aveva valide ragioni? Se sì, non indebito. – Creditori: di solito gli studi consulenza non hanno grandi debiti; se però, ad es., Studio Gamma aveva un debito con l’Erario o la Cassa previdenza, questi sono creditori pubblici. Dovendo incorporare la holding, Studio Gamma non si estingue (è la incorporante), dunque i creditori non perdono il debitore originario. In questo caso la fusione inversa è anche pensata per non far estinguere la società operativa che aveva eventuali rapporti pendenti. Quindi si può dire ai creditori: il vostro debitore Studio Gamma rimane attivo, anzi ora ha anche il patrimonio che stava in Holding. Nessun pregiudizio, semmai il contrario (garanzia unificata).
Esito atteso: Settore consulenziale, a differenza dell’immobiliare, di solito ha meno attenzione fiscale sulle imposte indirette, e più su quelle dirette (deduzioni costi, ecc.). Se la fusione è stata attuata per consolidare attività e facilitare progetti futuri (documentati), l’abuso non sussiste perché c’è sostanza economica (passaggio generazionale, cambio forma giuridica per esigenze di mercato, ecc.). Un accorgimento: forse sarebbe stato utile far valutare lo studio e far emergere plusvalore in modo trasparente, ma in fusione non si tassa. Finché i soci non incassano nulla (e la fusione inversa in sé non dà conguagli in denaro), non c’è utilità estratta. Quindi l’AE dovrebbe sforzarsi molto per provare un vantaggio indebito. Probabilmente, se ben difesa, la contestazione potrebbe essere evitata o comunque risolta magari rifiutando qualche deduzione minore ma mantenendo il grosso dei benefici.
Esempio 3: Settore tecnologico (e fusione transfrontaliera)
Scenario: Tech Startup Delta S.r.l. è una PMI innovativa italiana con proprietà intellettuale (software) di valore. Un investitore estero propone di fondersi con la sua società Epsilon Ltd (sede in Irlanda) per creare una realtà multinazionale. Si progetta una fusione transfrontaliera inversa: Delta S.r.l. (controllata) incorpora Epsilon Ltd (che diventa quindi una branch in Irlanda di Delta oppure Delta sposta sede). Dalla fusione, la società risultante sarà di diritto italiano (Delta) ma con socio estero. Oppure si potrebbe fare viceversa: se volessimo spostare la sede all’estero, far incorporare Delta dalla società irlandese (fusione diretta transfrontaliera).
Poniamo che lo scopo in realtà sia (nel sospetto del Fisco) portare sede fiscale all’estero dove la tassazione è più favorevole, mantenendo in Italia le attività di fatto (caso di esterovestizione), oppure trasferire gli IP assets all’estero riducendo le imposte su royalty future.
Possibile contestazione fiscale: l’Agenzia vede un rischio di esterovestizione: ovvero che formalmente la società risultante dica di essere estera (se fusione diretta) mentre mantiene base operativa in Italia. Se invece la società resta italiana ma con socio estero, potrebbe temere comunque uno schema per spostare utili (es. pagando royalty al socio estero, se ha la proprietà IP post-fusione). Inoltre, potrebbe applicarsi la disciplina di exit tax: trasferendo la residenza o asset all’estero tramite fusione, la legge prevede che i componenti latenti siano tassati salvo regime di sospensione UE . Quindi il Fisco starà attento che Delta abbia assolto eventuali exit tax su IP portata fuori.
Creditori: in operazioni cross-border c’è il timore per i creditori italiani di dover inseguire la società all’estero per soddisfarsi. Specie se la società italiana si estingue in una fusione diretta in Epsilon, i creditori italiani di Delta potrebbero doversi attaccare alla nuova società di diritto irlandese, il che è scomodo.
Difesa: – Sul piano tributario internazionale: fondamentale qui dimostrare la sostanza economica transnazionale dell’operazione. Per es., che c’è un genuino progetto di espansione sui mercati esteri tramite l’unione con Epsilon Ltd che opera già in quel settore in altri Paesi. Se c’è una due diligence e un piano di integrazione, mostrarlo. Far vedere che non è per pagare meno tasse, ma per creare un gruppo più competitivo (ad esempio, Epsilon porta capitali e accesso al mercato UK/USA, Delta porta tecnologia). – Se viene trasferita la sede all’estero: assicurarsi di pagare l’exit tax dovuta o di attivare i regimi di sospensione comunitari (in ambito UE, si può chiedere di sospendere la tassazione finché i beni restano nell’UE, ex art. 166 TUIR). Non dare l’impressione di voler scappare senza pagare. Anzi, comunicare al Fisco con anticipo il trasferimento e la determinazione delle plusvalenze su IP e l’opzione per il regime di sospensione (o pagarle ratealmente). – Riguardo all’esterovestizione: se la società nominalmente va all’estero ma le persone chiave restano in Italia, altissimo rischio di contestazione (l’AE potrebbe dire che la sede direzionale effettiva è ancora in Italia quindi la società è fiscalmente residente in Italia comunque, rendendo vano il tentativo ). Quindi la difesa migliore è non fare esterovestizione: se si sposta sede, spostare davvero cervelli e governance. Se non è fattibile, allora mantenere residenza in Italia e fare piuttosto una fusione con la società estera come incorporata (così Delta rimane italiana e i profili di residenza sono risolti). – Indipendentemente dalla struttura, evidenziare che la fusione cross-border è sostenuta da normative UE precise, che le finalità non sono elusive ma di libertà di stabilimento: presentare la cosa come sfruttare opportunità di mercato e finanziamenti internazionali, non come tentare arbitraggio fiscale (anche se un po’ lo è). – Creditori: se Delta S.r.l. si fonde in Epsilon Ltd (società estera), i creditori italiani possono opporsi (secondo la direttiva, l’opposizione segue le regole della società che si estingue, quindi legge italiana, 60 giorni) . Offrire garanzie a questi creditori è doppiamente importante, perché dopo la fusione recuperare crediti su una società estera è complicato. Quindi una mossa difensiva è: prima della fusione transfrontaliera, pagare/garantire tutti i debiti noti di Delta, così nessuno ha motivo di opporsi. E se anche successivamente qualcuno prova la revocatoria, potremo dire che i creditori non sono stati danneggiati (erano stati pagati o garantiti). Cass. 2153/2021 conferma che i creditori possono fare revocatoria anche su transfrontaliera , quindi tenere presente che se l’operazione fosse per frodarli, non la passeranno liscia. Dunque meglio prevenirli. – Case study difensivo: Si può citare la causa CGUE C-394/18 (IGI vs Cicenia): lì la Corte UE ha detto ok alle revocatorie nazionali purché non impediscano ingiustificatamente la fusione transfrontaliera . In quell’occasione il debitore cercava di usare la libertà di stabilimento per sottrarsi ai creditori ed è stato stoppato. Va fatto capire che nel nostro caso non c’è intento fraudolento: fusione cross-border ≠ fuga dai creditori. Ad esempio, la direzione rimane in Italia (se la società resta italiana) e comunque gli asset restano tracciabili. – In difesa dell’operazione, se contestata come abuso, invocare magari la Raccomandazione UE 2012/772 sulla pianificazione fiscale aggressiva citata nei lavori preparatori , ma qui andiamo sul difficile. Meglio restare sul concreto: “non stiamo spostando utili senza tasse: l’eventuale plusvalore sul software lo tassiamo (o congeliamo secondo le regole), l’attività continua in UE con sostanza, il partner straniero era necessario per crescere, quindi non c’è vantaggio indebito ma solo l’applicazione del diritto UE che consente riorganizzazioni transfrontaliere”.
Esito atteso: se genuina, l’operazione tech cross-border può passare il vaglio: molte startup italiane si fondono con entità estere per scalare globalmente, ed è considerato normale. L’importante è non fare mosse ingenue tipo pensare di evitare tasse di realizzo su IP: quelle vanno gestite con le regole esistenti (exit tax). E convincere che non c’è fittizietà. In presenza di un investitore estero vero, che apporta denaro e richiede quella struttura, la motivazione extrafiscale è forte (accesso a capitali esteri, mercati esteri). Un credito difensivo è proprio dire: ce lo hanno chiesto gli investitori e/o le banche – esattamente come in molti LBO, anche qui: “le banche internazionali ci finanziano solo se la holding sta in Irlanda”, ad esempio. Non sarà patriottico, ma come ragione economica è concreta (ambiente normativo più stabile ecc.).
Abbiamo visto come applicare i principi a casi concreti. A conclusione, presentiamo una sezione Domande frequenti che riassume i dubbi tipici e le risposte basate su quanto esposto.
Domande frequenti (FAQ)
D: In parole semplici, cos’è una fusione inversa?
R: È una fusione in cui la controllata incorpora la controllante. Immagina due società, A (holding) che possiede B (operativa). Invece di far confluire B in A, si fa il contrario: B incorpora A. Alla fine, A sparisce e B rimane, ma i soci di A diventano soci di B. Serve spesso a mantenere viva la società operativa (B) che ha contratti, licenze e business in corso, evitando di trasferire tutto alla holding .
D: La fusione inversa è illegale?
R: No, di per sé è pienamente legale. Il Codice Civile la consente e la prassi societaria la usa comunemente. Non esiste una norma che vieti “fusione inversa”. Diventa un problema solo se viene fatta con un intento abusivo (es. frodare il Fisco o i creditori). Ma se ci sono ragioni aziendali valide (riorganizzare il gruppo, evitare complicazioni contrattuali, integrare attività) è del tutto lecita.
D: Perché il Fisco guarda con sospetto le fusioni inverse?
R: Non tanto perché sono inverse, ma perché spesso in certi schemi le fusioni (inverse o no) vengono usate per ottenere benefici fiscali indebiti. Con la fusione puoi: – Spostare beni e partecipazioni senza tassazione immediata (neutralità fiscale). – Usare perdite fiscali che magari altrimenti sarebbero andate perse. – Dedurre costi come interessi passivi di un debito creato ad hoc (leveraged buy-out).
Il Fisco quindi verifica se l’operazione aveva sostanza economica o era fatta solo per quel risparmio d’imposta . La fusione “inversa” entra in gioco spesso negli LBO, quindi è associata a possibili abusi, ma non è l’inversione in sé: è l’uso distorto di qualsiasi fusione che preoccupa il Fisco.
D: Cosa rischio se l’Agenzia delle Entrate contesta la fusione come abuso del diritto?
R: In caso di contestazione confermata (cioè se perdi in giudizio o accetti l’accertamento), gli effetti sono: – Disconoscimento dei vantaggi fiscali: il Fisco ricalcola le imposte come se la fusione non fosse avvenuta o fosse avvenuta senza gli artifici. Ad esempio, ti tassa quelle plusvalenze che la fusione aveva evitato, oppure ti nega la deduzione di quegli interessi passivi sul debito dell’LBO . – Imposte aggiuntive e interessi: dovrai pagare le imposte non versate a suo tempo, con interessi maturati. – Sanzioni amministrative: di regola l’abuso porta sanzioni per dichiarazione infedele (percentuale dell’imposta). Non c’è esenzione automatica. Tuttavia potresti evitare sanzioni se dimostri che c’era incertezza normativa o se avevi un interpello (ad esempio, se avevi chiesto un parere e magari non ti hanno risposto). – Nessun reato penale: importante, l’abuso fiscale non costituisce reato , quindi non rischi sanzioni penali (a meno che tu non abbia anche commesso reati come frodi, falso in bilancio, ecc. – ma parliamo di altro in quel caso). – Effetti a catena: se quell’imposta era già oggetto di definizioni (tipo condono, ecc.), potrebbe riaprirsi la questione. Ad esempio, Cass. 21614/2021 ha detto che se condoni, ma emerge un abuso su quell’anno, l’abuso resta accertabile nonostante il condono. Quindi occhio.
D: La società incorporata (holding) aveva debiti. Con la fusione inversa che fine fanno?
R: Diventano debiti della società incorporante (la controllata). Per legge, la società risultante dalla fusione risponde di tutti i debiti delle società fuse. Quindi i creditori della holding possono rivalersi sulla controllata post fusione. Attenzione però: se prima c’erano due patrimoni separati (holding e controllata), ora c’è un unico patrimonio fuso. Se la holding era indebitata e la controllata no, ora la controllata “erede” deve pagare i debiti della holding, magari intaccando asset che prima erano fuori dalla portata di quei creditori. Per questo i creditori possono opporsi se vedono che la fusione li danneggia (esempio: la controllata aveva altri debiti e col cumulo rischia il collasso, etc.) .
D: Cosa può fare un creditore per opporsi alla fusione?
R: Ha un’arma immediata: l’opposizione ex art. 2503 c.c. da proporre entro 60 giorni dalla pubblicazione del progetto di fusione . Se il creditore la presenta in tribunale e dimostra che la fusione può pregiudicarlo, il giudice può sospendere la fusione fino a che non venga fornita una garanzia o pagato il debito. Quindi la fusione potrebbe essere bloccata. Se il creditore non fa in tempo o non lo sapeva, a fusione conclusa non può più annullarla, ma può agire con l’azione revocatoria per renderla inefficace verso di lui (in pratica, potrà continuare a far valere il suo credito come se la fusione non fosse avvenuta, aggredendo beni confluiti altrove). Inoltre potrebbe chiedere danni agli amministratori se la fusione gli ha causato un danno ingiusto.
D: Quindi, una volta passati 60 giorni e fatta la fusione, sono al sicuro dai creditori?
R: Non totalmente. Come detto, potrebbero fare revocatoria entro il termine di legge (5 anni dall’atto). Certo, la revocatoria richiede di dimostrare che la fusione ha danneggiato le loro ragioni (ad esempio, che ha reso più difficile il recupero del credito) e che c’era consapevolezza di ciò da parte del debitore . Se tu debitore hai agito in buona fede e la fusione non ha impoverito il patrimonio destinato ai creditori, la revocatoria potrebbe non avere successo. Ma se invece hai fatto sparire proprio la società debitrice dentro a un’altra, confondendo i patrimoni, c’è un concreto rischio che il giudice dichiari l’inefficacia della fusione verso il creditore (il che complica tutto). Insomma, meglio prevenire: se sai che la tua holding aveva debiti e vuoi fonderla, può convenire raggiungere un accordo coi creditori prima (pagandoli o garantendoli) per evitare grane successive.
D: Ho sentito parlare di fusioni usate per fare leveraged buy-out. Come funziona e perché contestato?
R: Il Merger LBO è uno schema: Tizio vuole acquisire l’azienda X senza soldi propri. Crea una società veicolo (Newco), la Newco ottiene un finanziamento dalla banca, con quei soldi compra X (i vecchi proprietari di X incassano). Poi Tizio fonde la Newco indebitata con X (spesso la fusione è inversa: X incorpora Newco). Risultato: X continua a operare ma ora ha addosso il debito contratto per il proprio acquisto e può dedurre gli interessi passivi di quel debito. Inoltre i vecchi soci magari sono anche rimasti in parte nell’operazione, monetizzando però una quota. Questo schema consente un effetto fiscale chiamato debt push-down: spostare il debito a livello della società operativa che genera reddito, così gli interessi si scaricano dalle tasse . È contestato se non c’è un reale cambio di controllo o una logica industriale, perché appare un giro artificiale per finanziare con debito (deducibile) l’uscita di soci (che incassano il prestito) . Se invece c’è un nuovo investitore, un cambio vero (es. un private equity entra e rileva l’azienda, caricando parte del debito in azienda), di solito lo considerano lecito purché il fine sia acquisire e far crescere l’azienda . La Cassazione ha avuto casi di LBO: uno del 2023 (Cass. 13914) in cui ha detto ok perché c’erano ragioni valide , e uno del 2025 (Cass. 18577) in cui ha detto abuso perché era uno schema meramente fiscale (stessi soci, debito fittizio) .
D: Se faccio una fusione e il Fisco la ritiene abusiva, rischio anche sanzioni penali per evasione?
R: No, per fortuna dal 2015 la legge chiarisce che l’elusione fiscale (abuso del diritto) non costituisce reato penale . In passato c’era stato dibattito: alcune sentenze (Cass. 7739/2012) avevano detto che si poteva configurare il reato di dichiarazione infedele se l’elusione superava le soglie penali . Ma la situazione è cambiata: il D.Lgs. 128/2015 ha messo nero su bianco la non punibilità penale. Quindi, se ad esempio hai dedotto interessi grazie a uno schema elusivo, al massimo dovrai pagare le imposte e le sanzioni amministrative, ma non ti faranno un processo penale per questo. Diverso è se nella fusione c’è stata frode fiscale (ad es. gonfiare fatture, creare documenti falsi): quello è reato a prescindere. Ma il semplice abuso, no.
D: Cosa posso fare per ridurre le possibilità di una contestazione fiscale su una fusione che sto pianificando?
R: Riassumendo i consigli chiave: – Chiedere un interpello anti-abuso all’Agenzia prima di procedere, spiegando quello che vuoi fare e perché. Così saprai in anticipo la loro posizione e in caso di ok sei protetto . – Mettere tutto per iscritto: prepara una robusta relazione sulle ragioni economiche dell’operazione (sinergie, riorganizzazione, ecc.). Meglio abbondare in dettagli di business (numeri, piani, ecc.). – Non nascondere il vantaggio fiscale, se c’è: paradossalmente, a volte ammettere che c’è un risparmio d’imposta ma sostenere che è secondario può dare un’aria di trasparenza. Se fai interpello, ti conviene dichiarare quale vantaggio fiscale otterrai – l’Agenzia lo sa comunque, meglio parlarne apertamente per poi dire che non è indebito. – Avere sostanza: se puoi, struttura l’operazione in modo che qualcosa di vero cambi: un nuovo socio, un aumento di capitale, un miglioramento effettivo nell’organizzazione. Evita operazioni circolari (quelle in cui alla fine i soggetti sono gli stessi e solo le forme giuridiche diverse). Se proprio devi farle, preparati a controbattere mostrando perché comunque servivano. – Considera alternative: a volte scegliere una via leggermente più costosa ma più lineare può evitarti guai. Esempio: se il vero obiettivo era prelevare utili, forse meglio distribuirli come dividendi tassandoli, piuttosto che costruire un LBO autogestito rischioso. Valuta pro e contro con consulenti.
D: E se la contestazione arriva comunque?
R: Allora gioca di rimessa ma con lucidità: – Rispondi per le rime all’invito a controdedurre (non lasciare scadere i 60 giorni senza dire nulla!). Spiega e allega documenti . – Valuta se aderire parzialmente: a volte cedere su un punto (tipo rinunci a dedurre una parte di costi) può chiudere la vicenda con danno limitato. – Se vai in causa, metti i migliori argomenti nero su bianco, cita la giurisprudenza (anche europea se serve), e magari procurati qualche parere pro-veritate di un tributarista di chiara fama da allegare (può influenzare positivamente). – Non scoraggiarti in primo grado: spesso in queste materie complesse, il giudizio tributario di merito è un terno al lotto. In Cassazione invece i principi di diritto (come l’onere della prova, il concetto di valide ragioni extrafiscali) trovano terreno più solido. Preparati eventualmente ad arrivare fin lì.
D: Quali sono le fonti più autorevoli da citare in mia difesa?
R: Sicuramente: – L’art. 10-bis L.212/2000 stesso (disciplina abuso) . – Sentenze di Cassazione rilevanti: Cass. Sezioni Unite 2008 n.30055 (che consacra l’abuso prima della legge), Cass. 7739/2012 (rilevanza penale negata poi superata) , Cass. 8487/2013 (valide ragioni extrafiscali concetto), Cass. 3769/2018 (libertà scelte economiche), Cass. 868/2019 (non punire scelte consentite) , Cass. 13914/2023 e 18577/2025 (LBO) , Cass. 35398/2021 (fusione non elusiva per semplificazione) , Cass. 31654/2019 (revocatoria fusione ok) , Cass. 2153/2021 (revocatoria transfrontaliera ok) , Cass. 230/2025 (prova simulazione da creditori). Queste sono solo alcune, ma mostrano l’orientamento. – Documenti dell’Amministrazione finanziaria: la Circolare 6/E del 2016 in particolare, che ha riconosciuto le condizioni per non considerare elusivo un LBO (cambio controllo sostanziale, logica imprenditoriale) . Inoltre eventuali Risposte a interpello pertinenti (es. interpello 251/2024 citato prima, o altri del 2022). – Direttive UE e Cass. UE: ad esempio la direttiva fusioni 2009/133/CE (neutralità fiscale solo su redditi, non copre quelle su IVA e registro), la giurisprudenza della Corte di Giustizia come Halifax (abuso IVA) e Cadbury Schweppes (sull’abuso nella libertà di stabilimento – se fai società fittizie all’estero è abuso). Nel nostro contesto Cadbury può essere menzionata per dire: la libertà di stabilimento tutela le scelte genuine, ma non quelle puramente artificiali miranti a eludere il fisco di origine. – Norme italiane specifiche: art. 2503 e 2504-quater c.c. per dire no nullità fusione e rimedi creditori ; art. 172 TUIR per la neutralità e test perdite; art. 11 DLgs 74/2000 per rimarcare che reati come infedele dichiarazione richiedono violazioni di legge, non scelte elusive.
Citare fonti autorevoli dimostra al giudice (o all’AE in adesione) che la questione è stata studiata e che hai basi solide, il che può aumentarne la convinzione.
Conclusione: Difendersi da contestazioni su fusioni inverse con finalità elusive è impegnativo, ma non impossibile. Preparazione, trasparenza e conoscenza delle regole del gioco (norme antiabuso e tutela dei creditori) sono le armi principali. Ogni caso è a sé, ma questa guida avanzata offre gli strumenti per affrontare la battaglia su un terreno quantomeno livellato. In definitiva, se la fusione ha sostanza e logica economica, esistono buone chance di far valere le proprie ragioni e uscire vittoriosi dal confronto, mantenendo intatti sia i benefici legittimi dell’operazione sia la propria serenità legale.
Fonti utili e riferimenti normativi/giurisprudenziali citati:
– Art. 2501 e segg. c.c. (disciplina delle fusioni).
– Art. 2503 c.c. (opposizione dei creditori alla fusione) .
– Art. 2504-quater c.c. (irreversibilità della fusione una volta attuata) .
– DPR 917/1986, art. 172 (neutralità fiscale delle fusioni e limiti al riporto perdite).
– DPR 131/1986, Tariffa I, art.4 (registro fisso per fusioni) .
– Legge 212/2000, art. 10-bis (abuso del diritto/elusione fiscale) .
– Cass. civ. Sez. Trib. ord. n. 35398/2021 (fusione semplificazione catena societaria non abusiva) .
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 13914/2023 (LBO fusione inversa, principi anti-abuso) .
– Cass. civ. Sez. Trib. ord. n. 18577/2025 (riconosciuto abuso in schema LBO “circolare”) .
– Cass. civ. Sez. I n. 31654/2019 (azione revocatoria ammissibile su fusione) .
– Cass. civ. Sez. II ord. n. 230/2025 (prova della simulazione da parte del creditore) .
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 868/2019 (legittimità risparmio d’imposta se conforme a opzione di legge) .
– Cass. civ. Sez. Trib. n. 653/2014 (operazione elusiva su terreni con artifizi societari) .
– Cass. civ. Sez. Trib. SS.UU. n. 30055/2008 (riconoscimento giurisprudenziale dell’abuso del diritto).
– Cass. pen. Sez. III n. 7739/2012 (rilevanza penale elusione, poi superata legislativamente) .
– D.Lgs. 128/2015 (certezza diritto): introd. art. 10-bis e irrilevanza penale abuso .
– Circolare AE 6/E del 2016 (operazioni di LBO e abuso) .
– Raccomandazione UE 2012/772/UE (pianificazione fiscale aggressiva) .
– Corte Giust. UE, causa C-394/18 IGI vs Cicenia (fusioni transfrontaliere e revocatoria).
– Sentenza del 15/01/2014 n. 653 – Corte di Cassazione – DEF Finanze
– Risposta n. 128/2022 – Agenzia Entrate
– Risposta n. 39/2022 – Agenzia Entrate
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestata una fusione inversa ritenuta elusiva? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestata una fusione inversa ritenuta elusiva?
Vuoi sapere cosa rischi e come puoi difenderti da queste contestazioni?
La fusione inversa è un’operazione straordinaria in cui la società controllata incorpora la società controllante. È uno strumento legittimo di riorganizzazione societaria, ma se l’Agenzia delle Entrate ritiene che sia stata effettuata con il solo scopo di ottenere vantaggi fiscali indebiti (es. utilizzo di perdite fiscali, aggiramento di vincoli impositivi), può contestarla come abuso del diritto.
👉 Prima regola: dimostra che la fusione aveva ragioni economiche valide e non esclusivamente fiscali.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Compensazione di perdite fiscali considerate non utilizzabili;
- Trasferimento di benefici fiscali da una società all’altra;
- Riassetti societari senza reali finalità industriali o organizzative;
- Operazioni complesse senza vantaggi economici concreti, ma solo fiscali;
- Mancanza di documentazione sulle motivazioni extrafiscali.
📌 Conseguenze della contestazione
- Disconoscimento degli effetti fiscali della fusione;
- Recupero delle imposte con interessi;
- Sanzioni dal 90% al 180% delle imposte accertate;
- Indeducibilità delle perdite fiscali utilizzate;
- Rischio di contestazioni penali in caso di frode societaria.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Piani industriali e strategici che hanno motivato la fusione;
- Ragioni organizzative, gestionali o finanziarie documentate;
- Documentazione societaria (verbali, perizie, delibere assembleari);
- Applicabilità dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (abuso del diritto);
- Motivazione dell’accertamento: l’Agenzia si è basata su fatti concreti o su mere presunzioni?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Atto di fusione e relazione degli amministratori;
- Perizie di stima indipendenti;
- Bilanci delle società coinvolte;
- Verbali del consiglio di amministrazione e dell’assemblea;
- Documentazione su sinergie, razionalizzazione dei costi, esigenze operative.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche oltre al vantaggio fiscale;
- Contestare la qualificazione come operazione elusiva se non supportata da prove;
- Richiamare la giurisprudenza favorevole sulle operazioni straordinarie;
- Eccepire vizi dell’accertamento: notifica irregolare, motivazione insufficiente, decadenza;
- Richiedere autotutela se le motivazioni extrafiscali erano già agli atti;
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni contro l’accertamento.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la fusione contestata e la documentazione societaria;
📌 Verifica la correttezza della contestazione dell’Agenzia delle Entrate;
✍️ Redige memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, anche in sede penale;
🔁 Suggerisce strategie preventive per strutturare le fusioni in modo conforme e inattaccabile.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in operazioni straordinarie e diritto tributario;
✔️ Specializzato in difesa di società contro contestazioni di abuso del diritto;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle fusioni inverse con finalità elusive non sempre sono fondate: spesso si basano su presunzioni e su una visione riduttiva delle ragioni dell’operazione.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la legittimità economica e gestionale della fusione, evitare la riqualificazione come abuso e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti sulle fusioni inverse inizia qui.