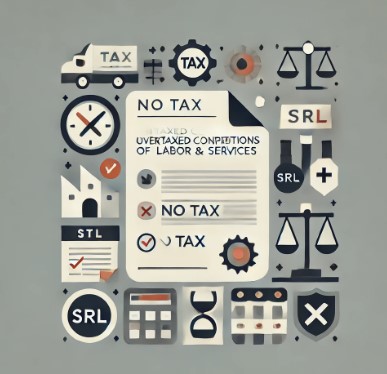Hai ricevuto un accertamento dall’Agenzia delle Entrate per conferimenti d’opera o di servizi in una Srl che non sono stati tassati? In questi casi, l’Ufficio ritiene che tali conferimenti generino un reddito imponibile da assoggettare a tassazione, contestando la mancata rilevazione fiscale o l’errata qualificazione dell’operazione. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero di imposte, applicazione di sanzioni e possibili effetti anche in capo ai soci. Tuttavia, non sempre la contestazione è corretta: con una difesa ben strutturata è possibile dimostrare la legittimità delle operazioni o ridurre sensibilmente l’impatto sanzionatorio.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i conferimenti d’opera e servizi in Srl
– Se il socio ha conferito prestazioni d’opera o servizi senza adeguata valorizzazione fiscale
– Se il conferimento non è stato correttamente registrato nello statuto o nel capitale sociale
– Se non sono stati rispettati gli obblighi di perizia e valutazione previsti dal codice civile
– Se l’Agenzia presume che l’operazione sia stata usata per eludere imposte sui redditi
– Se emergono incongruenze tra atto costitutivo, bilanci e dichiarazioni fiscali
Conseguenze della contestazione
– Recupero a tassazione del valore attribuito al conferimento non dichiarato
– Applicazione di sanzioni amministrative fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme ritenute non dichiarate
– Rettifica delle dichiarazioni fiscali e dei bilanci sociali
– Possibile responsabilità dei soci e degli amministratori in caso di irregolarità rilevanti
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare che il conferimento d’opera o servizi non ha generato un reddito imponibile tassabile
– Produrre documentazione, perizie e atti societari che attestino la correttezza dell’operazione
– Evidenziare la coerenza con le norme civilistiche e con i principi contabili
– Contestare eventuali errori interpretativi dell’Ufficio in merito alla natura del conferimento
– Richiedere la riqualificazione della contestazione in termini meno gravosi
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa fiscale
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la documentazione societaria e fiscale relativa ai conferimenti contestati
– Verificare la legittimità dell’operato dell’Agenzia e la corretta qualificazione giuridica delle operazioni
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e vizi di motivazione dell’accertamento
– Difendere i soci e la società davanti ai giudici tributari
– Tutelare il patrimonio aziendale e personale da conseguenze fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riqualificazione del conferimento con applicazione di sanzioni ridotte
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– La riduzione o eliminazione di interessi e sanzioni non dovute
– La certezza di rispettare la legge senza subire oneri fiscali eccessivi
⚠️ Attenzione: i conferimenti d’opera e di servizi in Srl sono considerati ad alto rischio dal Fisco, soprattutto in caso di valutazioni non documentate. È essenziale predisporre una difesa solida e tempestiva per evitare gravi conseguenze.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e societario – spiega come difendersi in caso di contestazioni sui conferimenti d’opera e servizi in Srl non tassati e quali strategie adottare per tutelare i tuoi diritti.
👉 Hai ricevuto una contestazione per conferimenti d’opera o servizi in una Srl? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la legittimità dell’accertamento e costruiremo la strategia difensiva più efficace per proteggere i tuoi interessi.
Introduzione
I conferimenti d’opera o di servizi in una società a responsabilità limitata (S.r.l.) sono apporti di capitale particolari in cui il socio, anziché versare denaro o conferire beni materiali, si obbliga a fornire una prestazione lavorativa o un servizio a favore della società. Questa possibilità, introdotta dalla riforma societaria del 2003, consente a persone che magari non dispongono di capitali liquidi ma possiedono competenze o manodopera qualificata, di diventare soci investendo il proprio lavoro. Il vantaggio immediato è flessibilità nell’avvio dell’impresa; tuttavia, questi conferimenti presentano complesse implicazioni legali e fiscali che richiedono attenzione.
Dal punto di vista civilistico, la legge impone rigorose tutele per garantire l’effettività di tali conferimenti: ad esempio l’obbligo di garantire l’esecuzione delle prestazioni promesse con polizze o fideiussioni a favore della società. Sul piano fiscale, le prestazioni d’opera conferite non sfuggono all’imposizione tributaria: se in un primo momento possono apparire “non tassate” (poiché il socio non riceve denaro immediato), in realtà le normative fiscale e la prassi dell’Amministrazione Finanziaria prevedono specifiche modalità di tassazione sia ai fini delle imposte dirette (redditi) che indirette (IVA). È proprio su questo fronte che spesso insorgono contestazioni da parte del Fisco. L’Agenzia delle Entrate può contestare il mancato assoggettamento a IVA delle prestazioni rese dal socio, la mancata fatturazione o dichiarazione del “compenso” sotto forma di quote sociali, l’omesso versamento di ritenute fiscali, ecc., ritenendo tali conferimenti come operazioni imponibili occultate.
Questa guida, aggiornata ad agosto 2025, fornisce un’analisi avanzata – ma dal taglio pratico e comprensibile – della disciplina italiana in materia di conferimenti d’opera e servizi in S.r.l. e delle possibili contestazioni fiscali relative al loro mancato assoggettamento a imposta. Ci rivolgiamo ad avvocati, professionisti, imprenditori e anche soci di S.r.l., adottando un linguaggio giuridico divulgativo. Affronteremo parallelamente i profili civilistici, fiscali e giurisprudenziali, per comprendere:
- Come funzionano i conferimenti d’opera o servizi in un S.r.l. (normativa del Codice Civile e prassi societaria);
- Quali sono gli obblighi fiscali (IVA, imposte sul reddito, adempimenti contabili) correlati a tali conferimenti e cosa succede se non vengono adempiuti;
- Quali contestazioni tipicamente solleva il Fisco quando scopre conferimenti d’opera “non tassati” e quali difese può opporre il contribuente (il “debitore” in senso lato, cioè il soggetto destinatario dell’accertamento tributario);
- Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (fino al 2025) sia in ambito tributario sia in ambito civilistico (ad es. controversie tra socio d’opera e società o tra soci);
- Esempi pratici, tabelle riepilogative, sessioni di Domande & Risposte, oltre a uno schema di bozza di memoria difensiva per fornire un modello orientativo di come impostare la difesa in sede legale.
Punto di vista del debitore: in tutte le sezioni, l’attenzione è rivolta a chi si trova a dover rispondere di una contestazione – tipicamente il socio conferente (che potrebbe vedersi contestare IVA o IRPEF non versate) e/o la società stessa (ad esempio per omesse ritenute o irregolarità contabili). L’obiettivo è mettere in grado il contribuente (e il suo difensore) di comprendere a fondo la problematica e approntare una strategia difensiva efficace, basata su normativa e pronunce giurisprudenziali autorevoli e aggiornate. Iniziamo quindi dall’inquadramento normativo di base.
Disciplina civilistica dei conferimenti d’opera e servizi nelle S.r.l.
Che cosa sono e come funzionano: il Codice Civile all’art. 2464 (rubricato “Conferimenti”) disciplina gli apporti dei soci al capitale della S.r.l. Tradizionalmente, nelle società di capitali (specie S.p.A.) i conferimenti dovevano consistere in denaro o beni (in natura o crediti); la riforma del diritto societario (D.lgs. 6/2003) ha innovato, prevedendo espressamente che nelle S.r.l. i soci possono conferire anche prestazioni d’opera o di servizi . Ciò è stato possibile perché la S.r.l., a differenza della S.p.A., non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva UE 77/91 che vietava i conferimenti diversi dal denaro o beni nelle società per azioni . In pratica, dunque, oggi l’atto costitutivo di una S.r.l. può prevedere che un socio, in luogo di versare capitale in denaro, si impegni a svolgere un’attività lavorativa o a fornire un servizio specifico a favore della società.
Limiti e condizioni: non tutte le prestazioni sono conferibili. La dottrina e la prassi notarile evidenziano che possono formare oggetto di conferimento solo quelle prestazioni d’opera o servizi che:
- Siano determinabili nella loro natura e durata: occorre poter circoscrivere la prestazione, stabilirne l’oggetto e la tempistica, altrimenti non sarebbe possibile quantificarne il valore . Ad esempio, un generico impegno “a collaborare all’attività sociale” senza specificazioni non è un conferimento valido; viceversa, una prestazione definita (es: progettazione di un impianto, consulenza professionale per 2 anni, sviluppo di un software entro 6 mesi, ecc.) è conferibile.
- Abbiano un termine o periodo determinato/determinabile: la prestazione deve essere eseguita entro un certo arco temporale, esplicitato nell’atto costitutivo o in apposito contratto, oppure ricavabile dalla natura dell’opera . Non è ammesso un obbligo “perpetuo” o del tutto incerto nel tempo, perché comprometterebbe la valutazione e l’effettività del capitale.
Valutazione del conferimento: a differenza dei conferimenti di beni in natura o crediti (art. 2465 c.c.), per i quali è obbligatoria la perizia giurata di stima di un esperto indipendente, il Codice non prevede espressamente una perizia per i conferimenti d’opera o servizi. Ciononostante, la migliore prassi suggerisce vivamente di procedere a una valutazione da parte di un esperto iscritto al Registro dei Revisori o società di revisione, con perizia giurata . Tale precauzione è raccomandata anche dal Consiglio Nazionale del Notariato . Perché fare una perizia volontaria? Per due ragioni principali: (1) stimare in modo attendibile il valore economico della prestazione conferita, così da attribuire al socio una quota di capitale “giusta” ed evitare contestazioni di sovra/sotto-valutazione; (2) disporre di un parametro oggettivo per quantificare l’importo della garanzia (di seguito illustrata) necessaria a tutela dei creditori sociali.
Garanzia fideiussoria obbligatoria: la legge infatti impone, all’atto del conferimento d’opera/servizi, che il socio conferente fornisca idonee garanzie a tutela della società e dei creditori sociali. In base all’art. 2464, comma 6 c.c., il socio che conferisce una prestazione di fare deve garantire l’adempimento mediante il deposito di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria a favore della società . Tali garanzie potranno essere escusse a prima richiesta dalla società nel caso in cui il socio non esegua in tutto o in parte la prestazione promessa . In alternativa, se l’atto costitutivo lo consente, il socio d’opera può versare una cauzione in denaro di valore equivalente . Lo scopo è assicurare che, se il socio non adempie, la società disponga comunque di risorse (l’indennizzo assicurativo o la somma escussa) per mantenere integro il capitale sociale e far fronte ai propri obblighi verso i terzi. In altre parole, la garanzia supplisce al valore che il socio avrebbe dovuto apportare con la sua opera.
Attenzione: la garanzia deve rimanere operativa per tutto il periodo in cui la prestazione è dovuta. Se la polizza o fideiussione scade o diviene inefficace prima che il socio abbia completato la prestazione, il socio è tenuto a rinnovarla tempestivamente. La mancata presenza di una garanzia valida equivale a inadempimento dell’obbligo di conferimento. La giurisprudenza recente ha confermato questo punto: il Tribunale di Roma (sent. n. 11887/2020) ha stabilito che la procedura di esclusione del socio moroso ex art. 2466 c.c. si applica anche in caso di sopravvenuta inefficacia della garanzia prestata, a prescindere dall’eventuale inadempimento della prestazione d’opera . Ciò significa che gli amministratori, venuta meno la garanzia, possono agire come se il socio fosse moroso, chiedendogli di sanare la situazione o avviando la sua esclusione per inadempienza.
Rischi per sovravalutazione o inadempimento: nel caso in cui il valore della prestazione conferita sia dolorosamente sovrastimato rispetto al reale, scattano pesanti responsabilità: la legge prevede sanzioni penali per amministratori e soci conferenti che abbiano deliberatamente “gonfiato” il valore del conferimento d’opera . Inoltre, la società incorre in sanzioni amministrative per aver falsamente rappresentato la consistenza del capitale . Questo serve a dissuadere accordi collusivi in cui si attribuisce al socio d’opera una quota sproporzionata rispetto alla prestazione effettiva, magari per mascherare un capitale sociale che in realtà non c’è. Sul fronte opposto, se la prestazione conferita viene mancata o solo parzialmente eseguita, si attivano i rimedi di legge per salvaguardare il capitale (vedi paragrafo successivo).
Esempio pratico: Tizio e Caio costituiscono la “Alfa S.r.l.” con capitale di €100.000. Tizio conferisce €50.000 in denaro, Caio conferisce un’attività di sviluppo software per un nuovo prodotto, valutata anch’essa €50.000, da completarsi entro 1 anno. Caio fornisce alla società una fideiussione bancaria di €50.000 a garanzia. La quota capitale di Caio è pari al 50% del totale. – In questo esempio, Caio è un socio d’opera**. La società iscriverà in bilancio un credito verso Caio di €50.000 per prestazioni da ricevere a fronte della sottoscrizione del capitale, e Caio dovrà eseguire la prestazione concordata nel tempo stabilito.
Esecuzione del conferimento e rimedi in caso di inadempimento
Come si “esegue” un conferimento d’opera: A differenza di un conferimento in denaro, che si concretizza nel versamento immediato della somma sottoscritta, il conferimento d’opera o servizi ha natura obbligatoria e continuativa. L’esecuzione non coincide con la promessa di svolgere l’opera, bensì con il suo effettivo svolgimento. Dunque, il socio d’opera esegue il proprio conferimento man mano che presta il lavoro o servizio pattuito. Dal punto di vista contabile, la società registra inizialmente un credito verso il socio pari al valore del conferimento (ad esempio “Credito verso socio X per conferimento d’opera €50.000”) a fronte dell’aumento di Capitale Sociale . Contestualmente si registra l’entrata della polizza/fideiussione a garanzia per pari importo . Successivamente, mano a mano che la prestazione viene resa, il credito verso il socio si riduce e la società rileva un costo per servizi corrispondente al valore della prestazione ricevuta . In pratica: ogni volta che Caio esegue una parte del software e la consegna alla società, Alfa S.r.l. diminuisce il credito in bilancio e registra un costo (es: “Costo per prestazioni di Caio”) dello stesso importo. A fine prestazione, il credito sarà azzerato (significa che Caio ha “pagato” integralmente il suo conferimento, fornendo il lavoro dovuto).
È importante capire che la mera assunzione dell’obbligo di fare non basta a considerare eseguito il conferimento. Su questo punto si era aperto un dibattito: una massima notarile del Triveneto (I.A.5) sosteneva che, nei conferimenti d’opera, l’esecuzione coincidesse con l’assunzione dell’obbligazione da parte del socio (cioè al momento della sottoscrizione, il capitale sarebbe già “effettivo” e l’eventuale inadempimento sarebbe regolato solo dai rimedi generali per inadempimento contrattuale) . Il Tribunale di Roma con la sentenza citata del 2020 ha espressamente rigettato questa tesi , affermando che:
“La mera assunzione dell’obbligazione non è sufficiente ai fini dell’esecuzione del conferimento, diversamente si aprirebbe la strada ad un totale annacquamento del capitale sociale; sono invece necessari sia lo svolgimento effettivo, fino al termine previsto, dell’attività promessa, sia la costante validità della garanzia che la correda.”
In altri termini: finché il socio non ha completato la prestazione (o la parte di prestazione prevista a una certa data) e finché la garanzia non copre integralmente l’importo promesso, il suo conferimento non si considera effettivamente eseguito. Questa interpretazione garantisce il principio dell’effettività del capitale sociale, tutelando i creditori e gli altri soci dall’“annacquamento” del capitale .
Inadempimento del socio d’opera: Cosa accade se il socio d’opera non adempie all’obbligo assunto? La disciplina prevede l’applicazione anche in questo caso dell’art. 2466 c.c. sulla morosità del socio. Le fasi, analoghe a quelle per il mancato versamento di denaro, sono:
- Diffida e decorrenza termini: gli amministratori devono intimare per iscritto al socio inadempiente di eseguire il conferimento (o di ripristinare la garanzia) entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni (art. 2466, co.1). Nel caso di Caio, se scade il termine annuale senza che abbia completato il software, o se la sua polizza fideiussoria scade prima del completamento e non viene rinnovata, gli amministratori gli manderanno una diffida formale.
- Vendita della partecipazione: decorso inutilmente il termine, gli amministratori offrono la quota del socio moroso agli altri soci in proporzione alle loro partecipazioni, oppure a terzi se l’atto costitutivo lo consente (art. 2466, co.2). La quota di Caio verrebbe quindi messa in vendita. Il prezzo di vendita è normalmente liberamente determinato; la legge richiede almeno che sia sufficiente a coprire quanto dovuto dal socio (nel nostro esempio €50.000, o la parte non ancora “pagata”). Se la vendita ha successo, il ricavato, dedotte le spese, va alla società fino a concorrenza dell’importo dell’obbligo inadempiuto; l’eventuale eccedenza spetterebbe al socio uscente. Se invece il prezzo ricavato è inferiore al dovuto, la società può escutere la garanzia di Caio per coprire la differenza. Nota: la vendita resta valida anche se effettuata a un prezzo inferiore al valore reale, secondo il Trib. Roma 11887/2020 . Dunque Caio non potrebbe opporsi sostenendo che la quota è stata svenduta; la tutela è solo obbligatoria (avrà diritto semmai a un indennizzo dell’eventuale eccedenza di valore, ma non a riottenere la qualifica di socio).
- Esclusione e altri rimedi: se la vendita non riesce (nessun acquirente), la società può dichiarare decaduto il socio e ridurre il capitale sociale in misura corrispondente (co.3). In alternativa, può anche decidere di far eseguire il conferimento forzosamente, agendo contro il socio inadempiente per ottenere adempimento o il risarcimento del danno (co.4). Nella prassi, spesso si preferisce estromettere il socio moroso per non lasciare il capitale “scoperto”: il socio viene formalmente escluso, la sua quota annullata e il capitale ridotto del relativo importo (salvo diversa copertura). Nel caso in esame, Caio perderebbe la qualità di socio e Alfa S.r.l. ridurrebbe il capitale a €50.000 (quello effettivamente versato da Tizio), escutendo ovviamente la polizza fideiussoria di Caio per recuperare eventuali costi o danni.
Da notare che, nel caso deciso dal Tribunale di Roma, la società aveva avviato la procedura ex art. 2466 sia per l’inadempimento delle obbligazioni d’opera sia per la sopravvenuta inefficacia della polizza; il socio escluso impugnava sostenendo l’inapplicabilità di tale procedura ai conferimenti d’opera. Il tribunale, come visto, ha confermato invece la piena applicabilità, proprio in ragione della necessità di tutelare integrità ed effettività del capitale .
Trasferimento della quota del socio d’opera: Un aspetto peculiare è la circolazione della quota appartenente a un socio che deve ancora eseguire prestazioni. In linea di principio, le quote di S.r.l. sono trasferibili, ma quando è associato un obbligo d’opera si pongono problemi: la prestazione ha carattere personale rispetto al socio originario. La prassi suggerisce che l’atto costitutivo possa limitare o subordinare il trasferimento della quota del socio d’opera all’assenso della società, che verificherà adeguate garanzie. Ad esempio, se Caio volesse vendere la sua quota a Sempronio prima di completare il software, Alfa S.r.l. dovrebbe essere d’accordo e pretendere da Sempronio una nuova polizza di assicurazione (oltre magari a verificare le competenze di Sempronio nel completare il software). In mancanza, il rischio è che Caio ceda la partecipazione ma rimanga comunque obbligato verso la società per la prestazione (secondo la tesi poi smentita dal Tribunale di Roma) . Per evitare incertezze, tipicamente nei patti societari si prevede che la quota del socio d’opera non possa essere ceduta prima dell’integrale adempimento, salvo approvazione unanime dei soci o altre condizioni.
Diritti del socio d’opera: durante l’esecuzione, il socio d’opera è a tutti gli effetti un socio della S.r.l.: partecipa alle decisioni sociali, ha diritto agli utili in proporzione alla quota di capitale sottoscritta (anche se non ha ancora completato la prestazione, salvo diverse clausole). Tuttavia, può accadere che nell’atto costitutivo si regolino diversamente gli utili finché il conferimento non sia eseguito (ad esempio accantonandoli). Se il socio d’opera adempie regolarmente, al termine otterrà il beneficio pieno della propria partecipazione. Non ha diritto invece a stipendio o compenso aggiuntivo per il lavoro svolto, perché quello costituisce già il suo apporto al capitale in cambio delle quote. Fa eccezione il caso in cui il socio rivesta anche un altro ruolo (es. amministratore): in quel caso può percepire un compenso separato come amministratore, deliberato dall’assemblea, ma ciò è indipendente dal conferimento.
Socio d’opera o lavoratore dipendente? Una questione delicata è distinguere l’attività svolta dal socio d’opera da un normale rapporto di lavoro subordinato. Il socio d’opera non è un dipendente: egli opera in quanto socio, con autonomia derivante dal ruolo imprenditoriale, partecipando al rischio d’impresa. Tuttavia, in alcune situazioni di fatto, specialmente nelle società di persone o nelle piccole S.r.l. familiari, la figura del socio lavoratore può celare un vero lavoro dipendente. La Cassazione ha fissato criteri rigorosi per riconoscere tale simulazione: serve prova concreta della subordinazione, ossia che il socio eseguiva ordini, era soggetto a controllo gerarchico e potere disciplinare altrui, come un dipendente . Senza queste prove, la qualifica rimane quella di socio, non spettando al socio d’opera né la retribuzione fissa né le tutele previdenziali tipiche del lavoratore subordinato . Ad esempio, in un caso recente (Cass., ord. del 2023, pubblicata 23/08/2025) un uomo aveva agito per farsi riconoscere dipendente di una società di famiglia in cui figurava come socio d’opera per oltre 20 anni, sostenendo fosse una simulazione per evitare contributi; la Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo che la valutazione della natura del rapporto è una questione di fatto insindacabile in sede di legittimità e che mancavano specifiche prove della subordinazione . Dunque, il “socio d’opera” non va confuso con il “socio lavoratore dipendente” (figura che giuridicamente non esiste): o si è soci, o si è dipendenti, tertium non datur – salvo appunto dimostrare un abuso di forma. Questo principio può rilevare anche nei rapporti con gli enti previdenziali: ad esempio, l’INPS potrebbe tentare di assoggettare a contribuzione da lavoro subordinato la posizione di un socio d’opera, ma dovrà anch’essa provare l’eventuale natura simulata del rapporto. (Va peraltro ricordato che, per altre norme, certi soci che partecipano al lavoro aziendale devono iscriversi a gestioni previdenziali speciali, come la Gestione Commercianti per i soci operativi di S.r.l. commerciali, ma si tratta di obblighi contributivi autonomi, non di subordinazione).
Riassumendo in tabella i principali aspetti civilistici:
| Aspetto | Regola/Caratteristica nei conferimenti d’opera S.r.l. |
|---|---|
| Ammissibilità | Consentiti (art. 2464 c.c., co. 6) – vietati invece nelle S.p.A. . Prestazione conferibile dev’essere determinata o determinabile in oggetto e durata. |
| Valutazione iniziale | Non obbligatoria perizia giurata, ma fortemente consigliata (dottrina e CNN) per quantificare il valore dell’opera/servizio. |
| Garanzia | Obbligatoria: polizza assicurativa o fideiussione bancaria a copertura del valore promesso (o cauzione in denaro equivalente). Deve restare efficace per tutto il periodo dell’obbligazione. |
| Esecuzione | Avviene man mano che la prestazione è resa (non già alla sottoscrizione). Contabilmente: credito vs socio che si annulla progressivamente a fronte di costi per servizi . |
| Diritti sociali | Il socio d’opera ha stessi diritti amministrativi degli altri soci (voto, quote utili proporzionali alla quota capitale sottoscritta, salvo patto diverso finché non adempie). Nessun stipendio per l’opera salvo diverso ruolo (es. amministratore con compenso separato). |
| Inadempimento | Trattato come morosità ex art. 2466 c.c.: diffida 30 gg; vendita coattiva quota ; se invenduta, esclusione e riduzione del capitale. Socio perde la qualità e la garanzia è escussa a favore società. |
| Trasferimento quota | Possibile ma delicato: generalmente subordinato a consenso della società/condizioni statutarie. Il subentrante deve garantire l’adempimento (nuova garanzia o diverso accordo). Di regola la quota non trasferibile finché la prestazione non è eseguita (per evitare complicazioni su chi dovrà lavorare). |
| Sovravalutazione | Vietata: severa responsabilità penale per amministratori e conferente e sanzioni alla società se il valore d’opera è volutamente gonfiato . |
| Morte/incapacità socio | Caso non espressamente normato. Spesso l’atto costitutivo prevede l’esclusione del socio d’opera in caso di morte o sopravvenuta incapacità, analogamente a quanto accade per le società di persone. In mancanza, sarà comunque inadempimento oggettivo e si applicheranno le tutele (escussione garanzia, esclusione). |
Nota: La disciplina civilistica qui trattata è funzionale anche ai successivi profili fiscali. Ad esempio, il fatto che la prestazione sia eseguita gradualmente e non all’atto della sottoscrizione incide sul momento impositivo fiscale, come vedremo, così come la necessità di valutare il conferimento incide sul valore da assoggettare a imposta. Nei prossimi paragrafi ci addentriamo proprio nei riflessi fiscali di un conferimento d’opera e nelle problematiche in caso di omessa tassazione.
Profili fiscali: imponibilità dei conferimenti d’opera
Dal punto di vista fiscale, un conferimento d’opera o servizi non è che un particolare modo di remunerare una prestazione. Anche se non c’è scambio di denaro liquido, vi è comunque un trasferimento di ricchezza: il socio ottiene una quota di capitale sociale (che rappresenta un valore economico), e la società ottiene un servizio/opera che ha un valore di mercato. Pertanto, l’operazione presenta rilevanza ai fini delle imposte. Bisogna considerare distintamente:
- le imposte sui redditi (IRES o IRPEF, e IRAP se dovuta), sia per la società sia per il socio conferente;
- l’IVA (imposta sul valore aggiunto), se applicabile alla prestazione conferita;
- eventuali imposte indirette legate all’atto di conferimento (imposta di registro, bollo), generalmente marginali.
Esaminiamo ciascun profilo separatamente.
Imposte sui redditi (IRES, IRPEF, IRAP)
Effetti sulla società conferitaria: per la società che riceve la prestazione, il conferimento d’opera si traduce contabilmente (come visto) in un costo per servizi via via che il socio presta l’opera. Tali costi sono normalmente deducibili dal reddito d’impresa ai fini IRES e IRAP, in ossequio al principio di competenza economica . Dunque Alfa S.r.l. del nostro esempio dedurrà dalle sue basi imponibili i €50.000 di “costo per servizio software” ripartiti nei vari esercizi in cui Caio realizza il programma. La deducibilità segue le regole ordinarie: rilevanza fiscale nell’esercizio in cui il costo è imputato a Conto Economico, inerenza all’attività sociale, ecc. Non vi è alcuna preclusione alla deduzione solo perché il pagamento è avvenuto in quote societarie: il costo è vero e inerente (la società ha ricevuto un servizio). In sintesi: le prestazioni ricevute dalla società in virtù del conferimento d’opera sono costi deducibili di competenza . Unico caveat: qualora il valore fosse abnorme e privo di giustificazione economica, il Fisco potrebbe contestare la deducibilità per mancanza di inerenza o come operazione elusiva. Ma se la valutazione è corretta e supportata (perizia), la deduzione è legittima.
Effetti per il socio conferente: la tassazione del socio è più articolata, perché dipende dalla natura fiscale del socio e dal tipo di prestazione resa. Possiamo distinguere varie situazioni:
- Socio persona fisica imprenditore (ditta individuale) o società di persone conferente: il reddito generato dall’esecuzione della prestazione confluirà nel reddito d’impresa del conferente (art. 55 TUIR). Ad esempio, se Caio fosse titolare di una ditta software e conferisce l’opera programmatoria alla S.r.l., per Caio quel lavoro rappresenta ricavo d’impresa. Se il conferente è una società di persone (snc, sas) che si obbliga a eseguire un servizio per la S.r.l. in cambio di quote, anche in tal caso la società conferente realizza reddito d’impresa (che verrà poi imputato per trasparenza ai suoi soci).
- Socio persona fisica libero professionista (titolare di partita IVA professionale): il reddito derivante dalla prestazione conferita è reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR). Ad esempio un ingegnere che conferisce alla S.r.l. neocostituita l’attività di progettazione di un impianto, valutata ai fini del capitale, produrrà compensi di lavoro autonomo pari a quel valore via via che presta l’opera.
- Socio persona fisica non imprenditore né professionista (privo di P.IVA): il reddito rientrerà nei redditi diversi (categoria residuale) ai sensi dell’art. 67 co.1 lett. l) TUIR, come reddito derivante da attività di lavoro autonomo occasionale. Questo è il caso, ad esempio, di un privato che conferisce un’opera intellettuale senza esercitarla abitualmente come professione: magari un esperto di un settore che non ha P.IVA, o un socio che promette un’attività di supporto saltuaria. In tal caso, fiscalmente, i compensi percepiti (sotto forma di quota sociale) sono redditi diversi.
- (Ipotesi particolari) Socio-lavoratore subordinato: se in casi eccezionali la prestazione fosse inquadrabile come lavoro dipendente (anche se di norma ciò non avviene per i soci d’opera, come spiegato), il relativo reddito sarebbe reddito di lavoro dipendente. Più realisticamente, se il socio d’opera instaura con la società un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) per regolare la prestazione, il compenso assumerebbe la categoria dei redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 TUIR). In questi scenari, comunque, la sostanza è che il socio sta lavorando come “collaboratore” remunerato con partecipazioni, e il fisco potrebbe trattare il valore della quota come reddito assimilato (con relative ritenute). Sono però situazioni ai margini della casistica generale.
Quando sorge il reddito del socio? Un punto cruciale è il momento impositivo in capo al socio. Poiché, come visto, il socio non ottiene denaro ma quote, e la prestazione può essere resa in modo frazionato, occorre capire quando “matura” il reddito tassabile. La regola generale è la seguente:
- Al momento della sottoscrizione del conferimento (atto costitutivo o aumento di capitale) non si realizza ancora alcun reddito imponibile per il socio . Ciò è logico: il socio in quel momento ha solo assunto un obbligo e ricevuto un’aspettativa (la quota sociale, sebbene formalmente assegnata, è “gravata” dall’obbligo di fare). Non c’è ancora un servizio reso.
- Il reddito emerge progressivamente durante l’esecuzione della prestazione da parte del socio . Ogni porzione di attività via via completata e “accettata” dalla società fa maturare un corrispondente componente positivo di reddito in capo al socio. In pratica, il “fatto generatore” del reddito per il socio è l’esecuzione (anche parziale) della prestazione, che coincide col momento in cui la società registra il costo e riduce il credito verso il socio. Se Caio consegna metà del software, avrà realizzato redditi (d’impresa, autonomi o diversi secondo il caso) pari a €25.000 in quell’anno, pur non avendo incassato denaro ma avendo “pagato” parte del suo debito di conferimento.
- Questo principio implica una deroga al regime di tassazione per cassa normalmente previsto per professionisti, lavoratori dipendenti e redditi diversi. In situazioni ordinarie, tali redditi si tassano quando vengono percepiti (incassati). Nel conferimento d’opera invece, pur mancando un incasso monetario, si considera realizzato un “corrispettivo” in natura al momento dell’esecuzione . Autorevole dottrina ha evidenziato proprio che l’istituto in esame deroga al principio di cassa, agganciando l’imponibilità al momento dell’estinzione del credito verso il socio, cioè all’esecuzione del servizio, anche per redditi che di regola sarebbero di cassa . Ciò per coerenza con il fatto che la società deduce per competenza.
In termini pratici: il socio deve dichiarare redditi man mano che “baratta” la sua opera con quote sociali. Questo allineamento temporale tra deduzione in capo alla società e tassazione in capo al socio riflette il principio di simmetria: la società ottiene un beneficio e lo deduce, il socio ottiene un provento (in natura) e lo dichiara. E se il socio non esegue totalmente la prestazione? In tal caso, verrà escluso e perderà la quota corrispondente; fiscalmente dichiarerà solo la parte di reddito relativa a quanto effettivamente svolto sino al momento dell’esclusione (se nulla ha fatto, non dichiarerà nulla, ma perderà anche la partecipazione e la garanzia coprirà la società).
Tipologia di reddito realizzato: come già detto, dipende dalla natura del soggetto e del rapporto: d’impresa, autonomo, dipendente o diverso . La distinzione è importante perché da essa discendono obblighi diversi (ad esempio, l’applicazione o meno di ritenute fiscali/previdenziali, come si dirà oltre, e la deducibilità di eventuali costi a monte per il socio). Un professionista che conferisce un’opera potrà addebitare in fattura il contributo previdenziale integrativo (4% ad es. per le casse professionali) e dedurre i costi inerenti alla prestazione dal proprio reddito di lavoro autonomo. Un privato che realizza redditi diversi potrà dedurre solo eventuali spese specificamente inerenti quella prestazione (secondo le regole dei redditi diversi), ecc.
Tassazione di dividendi e plusvalenze sulle quote ricevute: una volta che il socio d’opera ha eseguito l’apporto ed è titolare a tutti gli effetti di una quota sociale “libera” da obblighi, egli potrà percepire utili dalla società o rivendere la partecipazione. Dividendi e capital gain su quelle quote non hanno alcun regime particolare: seguono le regole ordinarie applicabili ai soci della stessa categoria . Esempio: Caio, completata la sua opera, rimane socio al 50% di Alfa S.r.l.; sugli utili che Alfa distribuirà, Caio pagherà la ritenuta del 26% come qualunque altro socio persona fisica non imprenditore. Se Caio cede la quota, realizzerà una plusvalenza tassabile in base all’art. 67 TUIR (26% imposta sostitutiva sul capital gain delle partecipazioni non qualificate, ovvero tassazione IRPEF parziale se qualificata, a seconda delle norme vigenti).
Costo fiscale della partecipazione per il socio: è interessante notare che, una volta tassato il reddito da conferimento, la dottrina ritiene che il costo fiscalmente riconosciuto della quota per il socio conferente sia pari al valore del conferimento dichiarato . Ciò evita una doppia imposizione economica: Caio avrà subito tassazione sui €50.000 di “compenso” per il software; di conseguenza il valore iniziale della sua quota (50% di Alfa S.r.l.) sarà assunto pari a €50.000 come costo ai fini di eventuali future plusvalenze. Se un domani rivende la quota a, poniamo, €80.000, pagherà imposta solo sulla differenza (€30.000 di capital gain). Se invece non gli fosse stato riconosciuto questo costo, avrebbe pagato due volte su quello stesso importo (prima come reddito da lavoro, poi come capital gain interamente). Fortunatamente la prassi e la logica fiscale convergono su questo punto.
IRAP: l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive si applica sulle attività autonomamente organizzate (imprese e talora professionisti). Per la società, il costo per prestazione d’opera del socio è deducibile anche dal valore della produzione IRAP (trattandosi di costo del personale esterno o di servizio). Per il socio conferente, se è un soggetto passivo IRAP (es. una società, o un imprenditore individuale con autonoma organizzazione, o un professionista in studio associato ecc.), i compensi da conferimento concorreranno al valore della produzione e quindi soggetti a IRAP. Viceversa un socio persona fisica occasionale o piccolo professionista forfettario non sarà soggetto IRAP e quindi non ha questo onere. In definitiva, l’IRAP seguirà le regole ordinarie in base alla natura del contribuente che presta l’opera.
Per rendere concrete le differenze, ecco una tabella riepilogativa che confronta la tassazione in diverse tipologie di socio conferente un’opera/servizio:
| Tipo di socio conferente | Categoria Reddito | Tassazione IRPEF/IRES | IVA dovuta? | Ritenute fiscali a carico società | Contributi previdenziali |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) o Società di persone (snc/sas) | Reddito d’impresa (IRES per le S.p.A./S.r.l. al 24%; IRPEF per soci di snc/sas per trasparenza) | Tassazione sul reddito d’impresa secondo aliquota società. Quote ricevute iscritte come attività (partecipazione). Eventuali utili tassati come per partecipazioni (95% esenti se PEX, ecc.). | Sì, IVA applicabile come operazione imponibile (la società conferente emette fattura con IVA al 22% salvo esenzioni di legge) | No ritenuta d’acconto: società conferitaria non applica ritenute su fatture di altre società (operazioni B2B tra imprese). | La società conferente versa i contributi propri (ad es. INPS se commercio, casse professionali se StP, etc.) come per qualsiasi ricavo d’impresa. |
| Persona fisica con Partita IVA imprenditoriale (ditta individuale) | Reddito d’impresa (IRPEF su utili d’impresa, aliquote progressive). Eventuale regime forfettario al 15%/5% se requisiti. | Reddito incluso nel bilancio d’impresa del conferente; tassato ad aliquota marginale IRPEF. Se in regime forfettario, imposta sostitutiva 15% sul reddito forfettario, senza IVA. | Sì, IVA dovuta salvo conferente in regime esente/forfettario. Il conferente emette fattura con IVA 22% (o aliquota prevista per il servizio). Società conferitaria detrarrà l’IVA. | No ritenute: tra titolari di P.IVA non si applicano ritenute d’acconto su fatture di prestazione d’opera commerciale. (Se il conferente fosse un’impresa familiare o simili, potrebbero applicarsi regole particolari, ma in genere no ritenuta.) | Il titolare d’impresa versa i contributi INPS commercianti o artigiani sul reddito annuo (se attività commerciale/artigianale), oppure gestione separata se attività diversa non rientrante. |
| Persona fisica con Partita IVA professionale (libero professionista in albo, es. ingegnere, consulente) | Reddito di lavoro autonomo (IRPEF aliquote progressive, con possibili regimi semplificati). | Compenso tassato per competenza (non per cassa, come spiegato). Deduzione spese inerenti consentita. Se regime forfettario 15%/5%, tassazione su forfait senza deduzioni. | Sì, IVA dovuta (salvo regime forfettario). Il professionista emette fattura con IVA 22% (salvo eccezioni, es. medico esente). Società detrarrà IVA. | Sì ritenuta d’acconto 20% sul compenso imponibile (escl. IVA) se professionista non in regime forfettario. La S.r.l. versa ritenuta IRPEF come sostituto d’imposta e la scomputa dal debito fiscale del socio. Se professionista in regime forfettario, no ritenuta (esonerato). | Il professionista versa contributi alla propria cassa previdenziale (es. Inarcassa 4% in fattura, Cassa forense 4%, ecc.) oppure Gestione Separata INPS (25% circa) se non ha cassa. La società versa l’eventuale contributo integrativo in fattura (ad es. il 4%). |
| Persona fisica senza Partita IVA (attività occasionale) | Reddito diverso da lavoro autonomo occasionale (art. 67 TUIR). IRPEF su questo reddito, aliquota progressiva. | Reddito imponibile = compenso pattuito meno eventuali spese deducibili specifiche (poche, es. spese vive). Tassato nell’anno di percezione, ma qui percezione in natura → imponibile a esecuzione. | No IVA: prestazione occasionale, non esercitata abitualmente, fuori campo IVA (art. 5 DPR 633/72). Attenzione: se l’importo e la durata sono tali da configurare abitualità, il Fisco potrebbe ritenere che di fatto andava aperta P.IVA. In linea teorica però il conferimento è una tantum legato alla società, quindi qualificabile come occasione unica. | Sì ritenuta d’acconto 20% sul compenso lordo (art. 24 DPR 600/73 per lavoro autonomo occasionale). La società deve operare la ritenuta al momento in cui il compenso è “pagato” (qui coincide con maturazione del diritto). In pratica, la società verserà il 20% dell’importo a titolo di acconto IRPEF del socio. | Se il compenso annuo per lavoro occasionale supera €5.000, il socio conferente deve iscriversi alla Gestione Separata INPS per la parte eccedente e sono dovuti contributi ~33% su tale eccedenza (di cui 2/3 a carico committente e 1/3 a carico prestatore). Ciò significa che la S.r.l. dovrebbe trattenere ulteriormente circa 11% e versarlo all’INPS + suo 22%. (Se invece il compenso è ≤€5.000, nessun obbligo contributivo). |
(Legenda: “compenso” sopra indica il valore del conferimento d’opera. In natura esso si concretizza nelle quote societarie assegnate.)
Come si nota dalla tabella, il trattamento fiscale varia notevolmente a seconda del profilo del socio. In generale:
- Per soggetti dotati di P.IVA (imprese e professionisti) il conferimento d’opera è trattato come un normale servizio reso alla società, con fatturazione (IVA) e poi tassazione del ricavo secondo le regole ordinarie (IRES/IRPEF d’impresa o autonomo). La società funge da sostituto d’imposta per i professionisti (applicando la ritenuta del 20% su fattura) e non per le imprese.
- Per soggetti senza P.IVA (attività non abituale) l’operazione rientra tra i redditi diversi e non si emette fattura IVA. La società però deve operare la ritenuta d’acconto del 20% sul valore concordato. Ad esempio, se Caio è un privato che conferisce un’opera dal valore di €10.000, Alfa S.r.l. dovrà versare €2.000 al Fisco come ritenuta di Caio (pur non avendo pagato Caio in denaro, dovrà attingere altrove per pagare quella ritenuta). Il socio poi dichiara il reddito lordo (€10.000) nel quadro RL e potrà detrarre la ritenuta versata a suo nome. Inoltre, se la somma supera i 5.000 euro annui, scatta l’obbligo contributivo INPS gestione separata sulla parte eccedente (la società avrebbe dovuto iscrivere Caio e versare contributi).
Fiscalità differita e “vantaggi” percepiti: a volte i conferimenti d’opera sono stati utilizzati con l’idea di differire la tassazione: il socio pensa di non pagare tasse subito perché non incassa nulla, e magari confida di incassare in futuro dividendi tassati meno. È però un calcolo fallace, perché come abbiamo visto il Fisco non aspetta il dividendo: tassa il socio al momento dell’esecuzione dell’opera (il che può avvenire già nel primo esercizio se la prestazione parte subito). L’unico leggero vantaggio può sorgere se il socio è persona fisica e la società, deducendo il costo, riduce utili tassati al 24% IRES per poi distribuirli come dividendi al 26%: in tal caso, confrontato con uno scenario di non deducibilità, c’è uno spostamento di imponibile dalla sfera societaria (24%) a quella del socio (aliquote IRPEF). Ma trattandosi di una prestazione reale, è giusto che sia deducibile per la società e tassata in capo a chi la svolge. Se invece si tentasse un conferimento puramente di comodo, privo di reale utilità economica, per ottenere deduzioni fittizie, si sfocerebbe nell’abuso del diritto.
Interventi dell’Amministrazione Finanziaria: l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in alcuni documenti di prassi. Ad esempio, in una risposta ad interpello del 2018 (Risposta n.128/E) riguardante società tra professionisti, ha confermato che i compensi corrisposti ai soci per prestazioni d’opera conferite costituiscono per i soci reddito imponibile nelle rispettive categorie (lavoro autonomo, d’impresa, etc.), deducibile per la società . In altri termini, anche l’Amministrazione considera queste operazioni alla stregua di scambi di prestazioni reciproche: lavoro vs partecipazione.
IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Per quanto riguarda l’IVA, la questione centrale è: il conferimento d’opera è considerato una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA? La risposta, in generale, è sì, a patto che il socio conferente agisca da soggetto passivo IVA (ossia nell’esercizio di un’attività economica). Vediamo perché:
- L’art. 3 del DPR 633/1972 (Decreto IVA) definisce prestazioni di servizi tutte le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obblighi di fare, non fare o permettere. Qui il socio assume un obbligo di fare (prestare un’opera o servizio) e riceve come corrispettivo una partecipazione sociale. Sebbene non sia denaro, ciò rientra nelle operazioni imponibili: le cessioni di beni e prestazioni di servizi “verso corrispettivo” includono anche i corrispettivi in natura (baratto). Nel nostro caso, possiamo considerare la transazione un baratto tra socio e società: il socio “fattura” il suo servizio e “paga” la sottoscrizione del capitale; la società “fattura” (figurativamente) le proprie quote. Dal lato IVA, quindi, la prestazione d’opera resa è imponibile se chi la rende è un soggetto passivo IVA.
- Soggettività IVA del socio: se il socio conferente è un’impresa o un professionista con P.IVA, non c’è dubbio che stia agendo nella sua sfera economica: emetterà fattura per la prestazione conferita, addebitando l’IVA a carico della società . L’aliquota IVA dipenderà dal tipo di servizio (in genere 22% per servizi generici). La società, essendo a sua volta soggetto passivo, potrà detrarre tale IVA a credito , in quanto relativa a un servizio acquisito nell’esercizio dell’attività (salvo che la società operi in ambito esente senza pro-rata, ma nella maggior parte dei casi le S.r.l. operative detrarrebbero l’IVA). Nel nostro esempio, se Caio è consulente informatico con P.IVA, per la parte di software completata in un anno emetterà fattura ad Alfa S.r.l. ad esempio di €30.000 + IVA €6.600. Alfa registrerà un debito verso Caio di €36.600, poi compenserà €30.000 riducendo il credito per conferimento e verserà a Caio (o direttamente all’Erario) i €6.600 di IVA. (Nota: spesso, per praticità, la società versa al socio d’opera l’IVA dovuta, perché il socio deve girarla al Fisco. È un esborso in più che la società non recupera fino a liquidazione periodica, ma è necessario per far fronte all’obbligo IVA).
- Se il socio conferente non è un soggetto passivo IVA (nessuna attività economica abituale), allora l’operazione è fuori campo IVA. Un privato che svolge un’opera occasionale non è tenuto ad addebitare IVA. In tal caso, niente fattura (soltanto una “ricevuta” ai fini civilistici) e nessun credito IVA per la società. Bisogna però fare attenzione: l’occasionalità è tollerata solo entro certi limiti. Un conferimento molto oneroso e prolungato potrebbe essere considerato di fatto un’attività economica abituale mascherata. Tuttavia, spesso i soci d’opera privi di P.IVA sono figure come soci-fondatori che contribuiscono lavoro in fase di startup e non svolgono quell’opera per altri: in tal senso l’operazione rimane isolata. Formalmente, niente IVA. Il Fisco potrebbe eventualmente contestare che quella persona avrebbe dovuto aprire partita IVA data la natura del lavoro svolto per la società (specie se si protrae per lungo tempo e di elevato valore), ma siamo nel campo delle valutazioni caso-specifiche.
- Esoneri o particolarità IVA: se il socio conferente è in regime forfettario (piccola partita IVA), per legge non addebita l’IVA in fattura (operazione fuori campo art.1 c.54 L.190/2014). Quindi in quel caso, pur essendo soggetto passivo, l’IVA non si applica per regime agevolato (il socio pagherà un’imposta sostitutiva sul reddito forfettario). Oppure, se la prestazione rientra in qualche casistica di esenzione IVA di cui all’art. 10 DPR 633 (es. prestazione medica, didattica, ecc.), il socio non applicherà IVA ma indicherà l’esenzione in fattura. In generale però, la maggior parte delle prestazioni d’opera conferibili (servizi tecnici, consulenze, opere manuali, sviluppo software, ecc.) sono imponibili IVA.
Obbligo di fatturazione e momento di esigibilità: chi rende una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA deve emettere fattura entro i termini di legge (di regola entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, o mensilmente se fatturazione differita con DDT). L’effettuazione dell’operazione per i servizi avviene, ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72, al momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, al momento di emissione fattura. Questo porterebbe a pensare che, non avendo il socio d’opera un pagamento in denaro, il momento impositivo IVA coincida con il completamento della prestazione o con eventuali acconti su di essa. La Cassazione tuttavia, con un orientamento influenzato dalla normativa UE, ha chiarito che il momento di esigibilità dell’IVA per i servizi coincide con la loro materiale esecuzione, anche se il pagamento (o, nel nostro caso, la corresponsione in natura) avviene dopo . In un’ordinanza del 2020 (Cass. n. 26650/2020) la Suprema Corte ha affermato che il fatto generatore dell’IVA sta nell’effettuazione della prestazione, e che non rileva il ritardo nel pagamento . Tradotto per il nostro tema: se il socio d’opera ha cominciato a erogare la prestazione, l’IVA è esigibile sui servizi resi, anche se formalmente la “compensazione” avviene mediante la liberazione dal debito di conferimento e senza un flusso monetario immediato.
Questa impostazione comporta che il Fisco può contestare l’omessa fatturazione IVA al socio d’opera in tutte le situazioni in cui, pur essendo stata eseguita (in tutto o in parte) la prestazione, non risulta ancora emessa fattura né versata IVA solo perché il socio attendeva la conclusione o un pagamento . Dunque, il socio farebbe bene ad emettere fatture periodiche in base allo stato di avanzamento dell’opera conferita (ad esempio trimestralmente o a tranches concordate). In pratica molti conferenti d’opera redigono contratti di appalto o consulenza paralleli in cui la società “commissiona” la prestazione al socio per l’importo previsto, con scadenze di consegna e fatturazione man mano: ciò consente di gestire regolarmente l’IVA e le ritenute. Formalmente può sembrare ridondante, ma è una best practice per evitare che la situazione rimanga sospesa fiscalmente.
Riassumendo l’IVA:
- Se socio è soggetto passivo: operazione imponibile, obbligo fattura + IVA su valore della prestazione. La base imponibile è data dal valore normale del servizio (che corrisponde all’ammontare aumentativo del capitale). La quota societaria ricevuta dal socio non è considerata pagamento ai fini IVA (non essendo denaro), quindi il pagamento è “non avvenuto”, ma come visto ciò non ferma l’esigibilità dell’imposta sulla prestazione resa. Si configura una sorta di permuta: normalmente, nelle permute ciascuna prestazione è valutata autonomamente e ognuna è imponibile. Qui la prestazione di servizi dal socio alla società è imponibile; il “trasferimento” della quota sociale dal nulla al socio sarebbe una operazione fuori campo IVA (emissione di partecipazioni societarie non è cessione di beni né servizio). Quindi l’unica imposizione IVA è sulla prestazione del socio.
- Se socio non è soggetto passivo: operazione non soggetta a IVA (fuori campo per mancanza del presupposto soggettivo). Niente fattura, ma la società deve assolvere la ritenuta d’acconto sul valore. Attenzione: la società, non avendo una fattura, non può detrarre alcuna IVA (che non c’è) e non può registrare il costo ai fini IVA; può solo registrarlo ai fini contabili e dedurlo ai fini IRES/IRAP.
- In ogni caso, la società pagherà eventualmente l’IVA al socio (se dovuta) e detrarrà la stessa (generando un credito IVA o riducendo l’IVA a debito di periodo). Se il socio non avesse fatturato nei termini, la società potrebbe incorrere nell’obbligo di emissione di autofattura denuncia (art. 6 co.8 D.Lgs. 471/97) per regolarizzare l’IVA entro 4 mesi. Ad esempio, se Caio soggetto IVA non emette fattura entro 4 mesi da quando consegna un pezzo di software, Alfa S.r.l. dovrebbe emettere autofattura per quell’operazione, versare l’IVA e potersi così detrarre il credito. È una procedura di tutela per l’Erario. Se né socio né società fanno nulla, il Fisco sanzionerà l’omessa fatturazione.
Conclusione: i conferimenti d’opera non sono affatto esenti da IVA per principio; anzi, l’intento del legislatore è che siano trattati come prestazioni a tutti gli effetti, evitando che possano diventare uno stratagemma per fornire servizi senza IVA. L’errore di molti è credere che, poiché non c’è fattura classica o pagamento cash, l’operazione “sfugga” all’IVA. Non è così: l’Amministrazione finanziaria considera (a ragione) il socio d’opera debitore d’imposta come qualsiasi fornitore di servizi.
Altre imposte indirette (registro, bollo, ecc.)
La costituzione di una società o l’aumento di capitale mediante conferimenti (in denaro, beni o opere) è soggetta a imposta di registro in misura fissa (attualmente €200) se l’atto è pubblico o scrittura autenticata. Nel caso di conferimento d’opera alla costituzione di S.r.l., l’atto costitutivo sarà registrato con imposta fissa €200 (in quanto atto societario non avente per oggetto trasferimenti immobiliari o d’azienda). Non si applicano dunque percentuali come il 9%: quella, ad esempio, era l’imposta di registro proporzionale per conferimenti di immobili o aziende in società . Per un conferimento di servizi di per sé non c’è una specifica imposta proporzionale.
Va detto che se il conferimento d’opera avesse forma di prestazione accessoria ai sensi dell’art. 2345 c.c. (cioè un obbligo diverso dal capitale, previsto dallo statuto dietro compenso o rimborso spese), allora non sarebbe un aumento di capitale ma un obbligo contrattuale accessorio: in tal caso l’atto costitutivo potrebbe prevedere, ad esempio, prestazioni accessorie soggette a corrispettivo e penalità in caso di inadempimento. Queste prestazioni accessorie potrebbero non far parte del capitale sociale, e il loro trattamento fiscale sarebbe diverso (ad es. compenso deducibile e tassato come lavoro autonomo con IVA, ecc., trattandosi di normali prestazioni retribuite). Ma questo esula dal nostro tema, che riguarda prestazioni come conferimenti di capitale vero e proprio.
Altre imposte: l’emissione di nuove partecipazioni sociali non sconta IVA né registro proporzionale (come detto), né imposte ipotecarie-catastali (che invece si applicano solo su trasferimenti di immobili). Potrebbe esserci imposta di bollo sull’atto notarile (tendenzialmente compresa nei diritti di segreteria). La polizza fideiussoria prestata dal socio paga un premio assicurativo su cui insiste un’imposta (imposta sulle assicurazioni, aliquota 0,25% per ramo cauzioni); ma sono dettagli minori.
In definitiva, non vi sono imposte indirette rilevanti oltre all’IVA. Il risparmio di IVA indebito è semmai l’obiettivo di chi cerca di mascherare prestazioni d’opera come “conferimenti” non fatturati; ma, ripetiamo, ciò è un terreno scivoloso che può condurre a contestazioni molto severe. Vediamo ora proprio quali contestazioni fiscali può sollevare l’Amministrazione e come difendersi.
Controlli e contestazioni del Fisco sui conferimenti non tassati
Quando scatta la contestazione: l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono venire a conoscenza di conferimenti d’opera non tassati in vari modi. Spesso, in occasione di verifiche contabili sulla società o sul socio, oppure incrociando dati: ad esempio, la società potrebbe aver registrato in bilancio un “credito verso soci per conferimenti” non in denaro, oppure potrebbe aver dedotto costi per servizi da socio senza corrispondenti fatture. Anche la registrazione dell’atto costitutivo presso l’Agenzia Entrate fornisce dettagli sui conferimenti (i notai indicano la natura dei conferimenti, e tali atti sono accessibili). In pratica, un conferimento d’opera “anomalo” – ad esempio di notevole importo – fa scattare un campanello perché potrebbe celare un’operazione imponibile non dichiarata.
Le violazioni tipiche contestate in questi casi sono:
- Omessa fatturazione IVA: se il socio conferente avrebbe dovuto emettere fattura (perché soggetto passivo) e non l’ha fatto, viene contestata la violazione dell’art. 6 D.Lgs. 471/97 (mancata emissione della fattura). Ciò comporta una sanzione amministrativa tra il 90% e il 180% dell’IVA non documentata, oltre all’obbligo di versare l’IVA evasa con interessi. Ad esempio, Caio doveva fatturare €50.000+IVA=€61.000 e non l’ha fatto: il Fisco pretenderà i €11.000 di IVA non versata più una sanzione minima di €9.900 (90%) più interessi per mora (al tasso legale, maturati dal termine in cui l’IVA andava liquidata, tipicamente dal 16 del mese successivo al trimestre o mese di esecuzione). Inoltre, se l’IVA evasa supera determinate soglie penali (oggi €50.000 annui), la violazione può assumere rilievo penale tributario (art. 5 D.Lgs. 74/2000, omessa dichiarazione IVA, o art. 4, dichiarazione infedele se è stata presentata dichiarazione ma senza quell’IVA).
- Omessa dichiarazione di redditi: qualora il socio non abbia dichiarato nella propria dichiarazione annuale il reddito derivante dalla prestazione d’opera, l’Ufficio contesterà un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF (o IRES). Riprendendo l’esempio, Caio persona fisica avrebbe dovuto dichiarare €50.000 come reddito (autonomo o diverso) nell’anno in cui li ha realizzati; se non l’ha fatto, verrà emesso un avviso di accertamento per IRPEF evasa. Le sanzioni per dichiarazione infedele sono dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. Se Caio è soggetto IRES (società conferente), analoga contestazione di maggior ricavo con sanzione proporzionale. Anche qui, oltre una certa soglia (redditi evasi oltre €100.000 e 10% del dichiarato) potrebbe configurarsi reato di dichiarazione infedele.
- Omesso versamento di ritenute: se il socio era persona fisica e la società non ha operato la ritenuta d’acconto sul compenso in natura, l’Agenzia può rivalersi sulla società in qualità di sostituto d’imposta. La norma (art. 64 DPR 600/73) prevede infatti che chi eroga compensi di lavoro autonomo debba trattenere e versare la relativa ritenuta, e risponde in solido dell’imposta non trattenuta. Nel caso dei conferimenti d’opera, la società potrebbe aver trascurato questo obbligo, specie se non c’è stato flusso di cassa. Tuttavia, la ritenuta va applicata anche sui pagamenti in natura. L’Agenzia quindi emetterà atto di recupero delle ritenute non operate né versate, con sanzione amministrativa del 20% per omesso versamento ritenute (art. 14 D.Lgs. 471/97) oltre interessi. Esempio: Alfa S.r.l. avrebbe dovuto versare €10.000 * 20% = €2.000 di ritenuta per Caio; se non l’ha fatto, dovrà ora pagarli + €400 sanzione minima + interessi. Anche qui c’è un possibile risvolto penale: l’omesso versamento di ritenute certificate oltre €150.000 è reato (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000), ma nel nostro caso difficilmente si arriva a tali importi, a meno di conferimenti enormi.
- Indebita detrazione IVA da parte della società: se la società ha detratto IVA relativa alla prestazione del socio ma non c’era una fattura regolare (ad esempio tramite autofattura tardiva non consentita), il Fisco potrebbe contestare la detrazione come indebita. Immaginiamo che Alfa S.r.l., rendendosi conto tardivamente, abbia emesso un’autofattura interno per €50k+IVA per sistemare i conti: se ciò è stato fatto fuori dai termini consentiti, l’Ufficio potrebbe disconoscere il credito IVA portato in detrazione e sanzionare la società per indebita detrazione (sanzione 90-180% dell’IVA). Tuttavia, questo scenario è meno comune: di solito la società, se il socio non fattura, non detrae nulla (perché non ha documenti IVA). Il problema sta più dalla parte del socio che non ha assolto l’imposta.
- Indebita deduzione di costi: analogamente, se la società ha dedotto costi senza idonea documentazione, potrebbe subire una ripresa a tassazione. Però, in contabilità il costo da conferimento risulta contabilizzato (magari su base di contratto e stati di avanzamento); la deduzione fiscale è possibile a patto che il costo sia certo e determinato. Se mancava del tutto un contratto o documenti, il Fisco potrebbe contestare che il costo non fosse certo. Ad ogni modo, questa strada è meno battuta perché la società in genere formalizza in assemblea il conferimento e la prestazione del socio.
- Riqualificazione dell’operazione: in casi estremi, l’Agenzia delle Entrate potrebbe sospettare che il conferimento d’opera celasse altro: ad esempio, una distribuzione occulta di utili (se il socio d’opera è subentrato dopo con un valore fittizio per prelevare utili accumulati) o un’abuso del diritto per trasformare compensi in plusvalenze. Non sono contestazioni frequenti, ma possibili. Ad esempio: soci di una S.r.l. fanno entrare un terzo come “socio d’opera” a cui attribuiscono una quota elevata per un’opera modesta, e poco dopo liquidano quella quota con un valore pagato dalla società: potrebbe sembrare un modo di far uscire soldi in forma di “liquidazione quota” anziché compenso. Il Fisco può contestare ex art. 10-bis L.212/2000 (abuso di diritto) rideterminando il trattamento fiscale corretto dell’operazione.
Esempio reale di contestazione: Immaginiamo Caio, consulente informatico, che nel 2022 ha conferito la sua opera per €50.000 in Alfa S.r.l. senza aprire P.IVA, senza fatturare né dichiarare nulla. Nel 2024 l’Agenzia accerta l’operazione. Potrebbero succedere diverse cose:
- L’ufficio X dell’Agenzia invia a Caio un avviso di accertamento IRPEF per il 2022 contestandogli €50.000 di redditi diversi non dichiarati, imponendo l’imposta (supponiamo €13.000 circa, ipotizzando aliquota marginale 35% su parte), più sanzione 90% (€11.700) e interessi.
- Contestualmente o separatamente, l’ufficio Y invia ad Alfa S.r.l. una contestazione per omessa applicazione ritenute sul compenso di Caio: recupero €10.000*20% = €2.000, sanzione 20% = €400, interessi.
- Inoltre, se ritengono Caio doveva avere P.IVA, potrebbe esserci un processo verbale di constatazione dalla Guardia di Finanza a Caio per attività professionale esercitata senza emissione fatture, con proposta di sanzione IVA su €50.000 (IVA €11.000, sanzione base €9.900).
- Alfa S.r.l. in questo scenario non ha detratto IVA né dedotto costi (perché Caio non ha mai emesso fattura né fatto ricevute, forse il costo neanche l’hanno contabilizzato formalmente). Se invece Alfa aveva dedotto, arriverebbe anche un avviso IRES per costi indeducibili (ma ciò è evitabile regolarizzando la fattura di Caio a posteriori, se ancora emendabile).
Come si vede, gli effetti cumulativi possono essere gravosi. Fortunatamente, l’ordinamento offre strumenti di difesa e anche di definizione agevolata in sede amministrativa. Nel prossimo paragrafo ci concentriamo su strategie difensive e soluzioni.
Difendersi dalle contestazioni fiscali: strategie e strumenti
Quando un socio conferente (o la società) riceve una contestazione dal Fisco riguardo a un conferimento d’opera non tassato, è fondamentale non farsi prendere dal panico ma agire con metodo. Ecco una serie di passi e considerazioni per predisporre la difesa, dal punto di vista del contribuente “debitore” dell’imposta contestata.
1. Analisi preliminare della contestazione e raccolta documenti
Appena notificato un Processo Verbale di Constatazione (PVC) da parte della Guardia di Finanza o un avviso di accertamento/contestazione dall’Agenzia delle Entrate, bisogna anzitutto leggere attentamente l’atto per capire cosa viene contestato esattamente e su quali basi. Verificare:
- Anno d’imposta e importi contestati (IVA non versata, maggior reddito, ecc.);
- Norme violate secondo l’ufficio (ad es. art. 21 DPR 633/72 per fattura, art. 5 DPR 917/86 per redditi non dichiarati, ecc.);
- Elementi di prova o ricostruzione svolta dal Fisco (hanno copia dell’atto costitutivo? Hanno evidenze che la prestazione è stata resa? Deduzioni fatte in bilancio?);
- Tipologia di atto: se è un avviso di accertamento immediato o un invito al contraddittorio. In materia tributaria, se la contestazione supera certe soglie o rientra in ambiti particolari, è obbligatorio un contraddittorio preventivo.
Una volta compreso il quadro, occorre raccogliere tutti i documenti utili alla difesa:
- Atto costitutivo della S.r.l. o verbale di aumento capitale contenente il conferimento d’opera (proverà cosa era previsto e valutato).
- Eventuale perizia di stima o relazione tecnica sul valore del conferimento (utile per attestare che il valore non era fittizio).
- Contratto/accordo stipulato tra socio e società per l’esecuzione della prestazione (se esistente; spesso esiste una scrittura privata che dettaglia la prestazione).
- Documenti che attestano l’effettivo svolgimento (o meno) della prestazione: ad es. rapporti di avanzamento, consegne di lavori, email, ecc. Questo è importante: se il Fisco contesta redditi su presunzione che l’opera sia stata svolta, e invece magari non lo era interamente, potete dimostrare lo stato di esecuzione al periodo contestato.
- Libri sociali e contabili: il libro dei soci, bilanci, libro giornale. Questo per verificare come la società ha contabilizzato la vicenda (ha iscritto il credito vs socio? Ha imputato costi? Ha deliberato qualcosa?). Ad esempio, se il bilancio nota integrativa spiegava il conferimento e diceva “il socio non ha ancora eseguito nulla al 31/12”, ciò può sostenere che a fine anno non vi fosse reddito realizzato.
- Eventuali pareri o circolari: se vi siete basati sul parere di un professionista o su un’interpretazione ufficiale, tenetelo pronto. Ad esempio, se all’epoca avete letto (erroneamente) che non c’era obbligo IVA, quella fonte può mitigare la colpa.
Questa fase di raccolta e studio è essenziale per individuare possibili linee difensive.
2. Valutare strumenti deflativi: adesione o definizione agevolata
Prima di passare al contenzioso, il sistema tributario offre alcune vie “deflative” del conflitto:
- Istanza di accertamento con adesione: Se avete ricevuto un avviso di accertamento non definitivo, potete presentare istanza di adesione e avviare un contraddittorio con l’ufficio. Questo permette di discutere e cercare un accordo sulle somme dovute, con benefici (riduzione delle sanzioni a 1/3). Nel caso di contestazioni oggettivamente fondate (ad esempio: in effetti non avete versato quell’IVA per dimenticanza), l’adesione può essere una soluzione pragmatica per ridurre il danno, ottenendo sanzioni ridotte e rateizzazione. Bisogna però valutare la posizione: se ritenete invece di avere buone ragioni per opporvi (es: prestazione non eseguita = non c’era IVA da fatturare in quell’anno), allora l’adesione potrebbe farvi perdere chance.
- Definizioni agevolate vigenti: Informatevi se sono in corso misure straordinarie di sanatoria. Ad esempio, nel 2023-2024 la “tregua fiscale” ha previsto varie definizioni agevolate (stralcio sanzioni, conciliazione agevolata in appello, ecc.). Se il vostro caso rientra in qualche finestra agevolativa (ad esempio, cartelle con importo ridotto se pagate entro tot), valutatelo seriamente. Talvolta pagare solo il tributo senza sanzioni è meglio che rischiare in giudizio.
- Ravvedimento operoso: se vi è solo un PVC ma non ancora un atto impositivo notificato, potete spontaneamente ravvedervi, cioè sanare le violazioni con pagamento di imposte dovute, interessi e sanzioni ridotte. Ad esempio, Caio, constatato l’errore, potrebbe prima dell’accertamento ravvedersi: emettere ora la fattura (tardiva) ad Alfa, versare l’IVA con sanzione ridotta (1/7 del 90% se oltre 2 anni di ritardo), dichiarare i redditi con dichiarazione integrativa con sanzioni ridotte, e Alfa versare le ritenute omesse con sanzione ridotta. Questo ravvedimento non evita l’obbligo di pagare imposte e interessi, ma riduce drasticamente le sanzioni e spesso evita il contenzioso. Se vi rendete conto di essere in difetto e le prove del Fisco sono schiaccianti, il ravvedimento può essere la mossa più saggia e può essere fatto anche dopo un PVC (fino a quando non arrivi l’atto finale).
3. Strategie difensive di merito
Se si decide di contestare nel merito le pretese dell’Amministrazione, le possibili linee difensive (da adattare al caso concreto) includono:
- Negare il presupposto d’imposta: Ad esempio, sul versante IVA, sostenere che mancava il presupposto del sinallagma oneroso. Si potrebbe argomentare che la prestazione del socio era effettuata non in veste di terzo fornitore ma uti socius, senza una controprestazione specifica ma per aumentare il valore sociale (tesi difficile, però utilizzata in passato). Si può citare il principio per cui serve un rapporto giuridico di scambio affinché vi sia prestazione imponibile . Nel nostro esempio, Caio potrebbe dire: “non ho agito come professionista verso un cliente, ma come socio che apporta lavoro nell’interesse comune, senza un vero corrispettivo contrattuale se non la partecipazione stessa”. Questa tesi cerca di qualificare il conferimento come operazione societaria fuori campo IVA, analogamente ai conferimenti di denaro (non imponibili). Tuttavia, va ricordato che la giurisprudenza italiana e UE tende a vedere comunque un corrispettivo effettivo (la quota sociale ha un valore). Solo in casi molto particolari (es: associazioni che ricevono lavoro volontario) si esclude IVA perché manca vero scambio. Nel contesto di una S.r.l. for-profit, questa difesa è debole, ma vale la pena prospettarla se coerente con i fatti (ad esempio se il socio di fatto non ha mai valutato la prestazione, l’ha fatta in spirito mutualistico).
- Contestare il momento dell’esecuzione: ad esempio, se l’ufficio pretende IVA o redditi su un anno, sostenere che in quell’anno la prestazione non era ancora eseguita, o lo era solo in minima parte. Bisogna portare evidenze: “Al 31/12 l’opera non era iniziata/era al 10%, pertanto l’imponibile è solo X e non Y”. Se la controparte non ha elementi per contraddire (perché di solito il fisco guarda al valore totale), può almeno ottenere una riduzione. Attenzione: data la tesi Cassazione 2020, non potete dire “non ho incassato, quindi niente IVA/IRPEF”, ma potete dire “non avevo finito la prestazione, quindi l’obbligo impositivo era limitato” .
- Invocare l’errore scusabile e buona fede: sul piano sanzionatorio, se effettivamente c’era incertezza normativa o vi siete affidati a un parere professionale, potete chiedere l’esclusione di sanzioni per obiettiva incertezza o mancanza di colpevolezza. Ad esempio: “All’epoca vi era incertezza sulla disciplina, come prova l’assenza di norme specifiche e alcune interpretazioni dottrinali. Il contribuente si è uniformato a una massima notarile (Triveneto) che riteneva non dovute le formalità fiscali immediate…”. Anche se il merito fiscale viene perso, questo argomento può portare quantomeno all’annullamento o riduzione delle sanzioni (art. 6 comma 2 D.Lgs. 472/97 prevede niente sanzioni se violazione dovuta a obiettiva incertezza). Nel nostro scenario, potremmo dire che nessuna disposizione di legge indicava espressamente la procedura fiscale per i conferimenti d’opera, e che il contribuente ha ritenuto in buona fede trattarsi di operazione di capitale non soggetta a IVA/ritenute, magari su consiglio del notaio.
- Documentare la gratuità (se applicabile): raramente in un conferimento d’opera si può parlare di gratuità, perché c’è la quota sociale in cambio. Tuttavia, se il valore assegnato era simbolico, o se il socio alla fine ha rinunciato a tutto (uscendo senza nulla), si potrebbe sostenere che la prestazione in realtà è stata resa a titolo gratuito. La Cassazione ha riconosciuto che anche prestazioni professionali possono essere gratuite purché ciò sia plausibile (parentela, amicizia, interesse indiretto) . Un socio che lavori gratis nella “sua” società è in effetti plausibile, ma in un conferimento formalizzato è contradditorio (perché la quota è il corrispettivo implicito). Tuttavia, se per dire Caio è socio unico e lavora per la sua S.r.l. senza mai prendere utili, si potrebbe azzardare la tesi che manca lo scambio sinallagmatico classico e che l’attività è apporto gratuito (ma va detto, finché la quota vale qualcosa, gratuito non è). È una difesa di ultima istanza, da usare con cautela.
- Verificare vizi formali dell’atto: oltre al merito, controllate la procedura seguita dal Fisco. Ad esempio, se era obbligatorio il contraddittorio e non ve l’hanno concesso, potete eccepire la nullità dell’atto per violazione del diritto di difesa. Oppure se l’accertamento è stato notificato oltre i termini decadenziali (di solito il 31/12 del quinto anno successivo, o quarto se dichiarazione presentata). O ancora, errori di motivazione nell’avviso (motivazione generica, copia-incolla). Questi vizi formali vanno sollevati subito nel ricorso come eccezioni preliminari. Spesso l’Agenzia è attenta in questi casi, ma non si sa mai.
- Nel caso di ritenute non versate: qui la difesa è più difficile perché l’obbligo del sostituto è oggettivo. Si può però evitare duplicazioni: se il socio ha già pagato l’IRPEF su quel reddito (magari con ravvedimento), la ritenuta può non essere più dovuta. Oppure si può chiedere la non applicazione di sanzioni se si dimostra che il socio poi ha pagato le imposte (nessun danno erariale). In generale, conviene eventualmente pagare quelle ritenute per evitare aggravi, e al limite far rivalere il socio e la società tra loro in sede civile per chi sostiene il costo.
Ogni linea va adattata: ad esempio, se il socio era effettivamente un professionista, puntare sull’errore di interpretazione (pensava fosse operazione societaria e non ha aperto fattura per quello, magari perché confidava nell’incasso differito); se il socio non aveva P.IVA, puntare sul fatto che non essendo imprenditore era ragionevole non pensare all’IVA (ma questo non lo esonera dall’IRPEF).
4. Redigere il ricorso e la memoria difensiva
Se non si trova accordo in adesione, occorre predisporre il ricorso tributario (da presentare entro 60 giorni dall’atto) e successivamente eventuali memorie aggiuntive e documenti fino a 10 giorni prima dell’udienza. È consigliabile farsi assistere da un tributarista/avvocato, data la tecnicità. Qui forniamo uno schema generico di come impostare la difesa scritta per un caso del genere:
- Intestazione: Commissione Tributaria competente, dati del ricorrente (socio e/o società), estremi atto impugnato.
- Fatti: descrivere la vicenda in modo chiaro. Esempio: “Il giorno XX/XX/2021 il ricorrente Caio conferiva alla Alfa S.r.l. una prestazione d’opera consistente in …, del valore di €…, a fronte della quale gli veniva assegnata una quota di capitale del …%. La prestazione veniva svolta in parte nell’anno … per €…, e non veniva emessa fattura né versata IVA in ragione dell’interpretazione seguita… In data … l’Agenzia notificava avviso accertamento n… contestando …”. Esporre poi lo sviluppo: nessun occultamento intenzionale, il comportamento contabile ecc.
- Motivi di ricorso: qui si articolano in punti le violazioni di legge che si contestano all’atto impugnato. Ad esempio:
1) Insussistenza del presupposto IVA per carenza di sinallagma oneroso – si argomenta che il rapporto socio-società non integra prestazione di servizi rilevante ai fini IVA per difetto dello scambio, richiamando magari pronunce sul concetto di corrispettivo .
2) Errata determinazione del momento impositivo – si eccepisce che l’Ufficio ha considerato imponibile l’intero importo nell’anno X, mentre la prestazione era solo parzialmente eseguita entro tale anno (supportare con prove). Richiamare il principio che l’imponibile andava semmai frazionato .
3) Violazione dell’art. 6 co.2 D.Lgs. 472/97 (errore scusabile) – si chiede la non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza, citando l’assenza di chiarimenti ufficiali all’epoca, eventualmente qualche prassi contraddittoria.
4) (Eventuale) Nullità dell’atto per vizi procedurali – es. mancato contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, oppure difetto di motivazione (se l’avviso non spiega come hanno quantificato il valore).
- Conclusioni: formulare le richieste al giudice. Esempio: “In via principale, annullare l’avviso impugnato nella parte in cui accerta IVA e redditi non dichiarati per l’anno …, perché l’operazione contestata non era soggetta a IVA né generava materia imponibile in quell’anno; in subordine ridurre la pretesa limitatamente alla porzione di prestazione effettivamente eseguita (…); in ulteriore subordine ridurre/eliminare le sanzioni irrogate in virtù dell’art. 6 c.2 D.Lgs. 472/97; con vittoria di spese.”.
- Documenti allegati: elenco di ciò che si produce (atto costitutivo, contratto, corrispondenza, perizia, ecc.).
Successivamente, in udienza si potrà meglio spiegare la situazione. Spesso le Commissioni Tributarie tendono a mediare: se c’è stata violazione chiara, magari concedono sanzioni minime; se c’è dubbio, possono accogliere in parte il ricorso.
Ricordate che è possibile anche in corso di causa arrivare a una conciliazione con l’ufficio (sanzioni al 1/3).
5. Dopo il primo grado
Se la sentenza di primo grado è sfavorevole, valutare l’appello. Considerare anche i costi/benefici: se l’importo non è enorme, potrebbe convenire la definizione per mettere fine (nel 2023 c’era la conciliazione agevolata in appello con sanzioni ridotte). Se invece il principio è importante (magari siete professionisti preoccupati di un precedente), allora proseguite fino eventualmente alla Cassazione, sostenendo i vostri motivi di diritto.
Va notato che, data la novità relativa del tema (dal 2004 in poi), non ci sono tantissime pronunce di legittimità specifiche sul conferimento d’opera. La maggior parte dei principi applicabili li abbiamo ricavati da pronunce su casi analoghi (omessa fatturazione di servizi, posizioni INPS dei soci, ecc.). Dunque, portare all’attenzione dei giudici questi principi generali è utile. Ad esempio, ribadire che in diritto tributario vale la sostanza economica: se voi dimostrate di non aver di fatto realizzato reddito perché non avete eseguito l’opera o l’avete eseguita gratis, potete convincere il giudice tributario a darvi ragione, a patto che la vostra ricostruzione sia credibile e documentata.
Giurisprudenza rilevante e casi particolari
In questo paragrafo raccogliamo alcune sentenze e principi giurisprudenziali recenti che interessano il tema, per completare la panoramica con riferimenti autorevoli (fonti istituzionali e massime).
- Tribunale di Roma, 3 settembre 2020 n. 11887 – Conferimenti d’opera e art. 2466 c.c.: Caso già illustrato, conferma la piena applicabilità della procedura di esclusione del socio moroso anche per inadempimento di conferimenti d’opera o servizi . Principio affermato: la tutela dell’integrità del capitale sociale richiede che “la mera assunzione dell’obbligazione non è sufficiente ai fini dell’esecuzione del conferimento” e che in caso di inadempimento (o venir meno della garanzia) si applichino i rimedi di legge come per i conferimenti in denaro . Inoltre, la sentenza evidenzia che il socio d’opera inadempiente può essere escluso e la sua quota venduta anche a prezzo inferiore al valore nominale, senza invalidare l’operazione . È una decisione importante perché smentisce orientamenti notarili minoritari e chiarisce cosa succede in pratica se un socio d’opera non fa la sua parte.
- Cassazione Civile, Sez. V, ord. 17 agosto 2021 n. 22963 – IVA e momento di effettuazione dei servizi: Richiamando Cass. SS.UU. 8059/2016, la Corte ha stabilito che, ai fini IVA, il momento impositivo per i servizi si ha con l’esecuzione dell’obbligazione, indipendentemente dal pagamento . Questo, come visto, è stato ribadito nel 2020 (ord. 26650) e implica la contestabilità dell’omessa fatturazione appena la prestazione è resa . Dunque è un fondamento per dire: se il socio ha lavorato, avrebbe dovuto fatturare subito. Al contempo, si può usare a difesa per dire: se la prestazione non era resa, l’IVA non era esigibile.
- Cassazione penale, Sez. III, sent. 15 aprile 2019 n. 15803 – Omessa fatturazione e reato di occultamento documenti: In un caso estremo un conferente d’opera che non emette fattura potrebbe anche incorrere in contestazioni penali (occultamento di documenti contabili ex art. 10 D.Lgs. 74/2000) se l’omissione era finalizzata a evadere. La Cassazione ha affermato che l’occultamento di elementi attivi (ricavi) configurato mediante mancata fatturazione è reato quando c’è dolo specifico di evasione. Per un socio d’opera, se venisse provato che volutamente non ha emesso fattura per evadere, potrebbe teoricamente scattare questo reato se l’imposta evasa supera soglie. È raro, ma va saputo come rischio remoto.
- Cassazione Civ., Sez. Lav., ord. 25 settembre 2018 n. 22689 – Soci d’opera e obblighi previdenziali: Pronuncia in materia di soci di S.r.l. iscritti alla Gestione Commercianti INPS. La Corte ha chiarito che il socio che partecipa con la propria opera all’attività di una S.r.l. commerciale deve iscriversi alla gestione commercianti (art. 1 L. 613/1966), a prescindere dal fatto che il suo lavoro sia conferito come conferimento o meno . Quindi, se Caio era socio d’opera di una S.r.l. che svolge attività commerciale, e lavorava in azienda con carattere di abitualità e prevalenza, è tenuto ai contributi INPS commercianti. Questo a volte viene contestato dall’INPS, e la Cassazione in varie sentenze ha dato ragione all’INPS; tuttavia, se Caio era anche amministratore e già iscritto alla Gestione Separata, può sorgere il problema della doppia contribuzione. Sul punto si segnalano Cass. nn. 3240/2010, 21540/2019, 23141/2021, che tuttavia esulano dal nostro focus fiscale stretto.
- Commissione Tributaria Regionale (ora Giudice Tributario di Secondo Grado) di [alcune pronunce locali]: Ci sono state pronunce di merito interessanti. Ad esempio, CTR Lombardia 2016 (caso ipotetico) ha annullato sanzioni a un socio d’opera che non aveva fatturato ritenendo che vi fosse incertezza oggettiva sulla normativa; oppure CTP Milano 2015 che ha ritenuto non dovute sanzioni se il contribuente corregge spontaneamente. Queste sentenze non fanno giurisprudenza nazionale ma possono essere invocate se utili.
In conclusione, la giurisprudenza tributaria ad oggi supporta per lo più la tesi del Fisco (prestazioni d’opera dei soci tassabili e soggette a IVA come normali), mentre la giurisprudenza civile si è occupata di tutelare gli interessi societari (esclusione del socio inadempiente) e di delimitare il confine col lavoro subordinato (negando facilità di simulazione senza prove).
Domande frequenti (FAQ)
D: Qual è la differenza tra un conferimento d’opera e una prestazione accessoria ex art. 2345 c.c.?
R: Nel conferimento d’opera il socio apporta lavoro/servizi come parte del capitale sociale: riceve in cambio quote sociali proporzionali al valore dell’opera e l’obbligo è elemento costitutivo del capitale. Invece, le prestazioni accessorie (art. 2345 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2468 c.c.) sono obblighi particolari che alcuni soci assumono verso la società, ulteriori rispetto al capitale sottoscritto. Ad esempio, lo statuto può prevedere che un socio fornisca consulenza continuativa o prestazioni varie, dietro compenso o a titolo gratuito, come obbligo accessorio. La differenza sostanziale è che la prestazione accessoria non incide sul capitale sociale (il socio ha già versato capitale in denaro o beni separatamente) mentre il conferimento d’opera costituisce direttamente la sua contribuzione al capitale. Fiscalmente, le prestazioni accessorie vengono trattate come normali operazioni (compenso al socio, con ritenute/IVA se dovute) e il socio non riceve quote aggiuntive per esse (può ricevere compensi periodici). Il conferimento d’opera, invece, è una tantum per ottenere quota capitale e segue tutta la disciplina vista. In breve: conferimento d’opera = lavoro “pagato” con quote di capitale; prestazione accessoria = lavoro pagato eventualmente in denaro (o non pagato) ma non legato a quote di capitale.
D: Un socio d’opera deve aprire partita IVA?
R: Dipende dal contesto: se il socio esercita già un’attività economica o professionale in proprio coerente con la prestazione conferita, dovrebbe operare con la partita IVA (ad esempio un consulente che conferisce consulenza). Se invece il socio è un privato che apporta un’opera in modo occasionale unica, può anche non aprire P.IVA. L’importante è che l’attività non configuri esercizio di impresa o professione abituale. Ad esempio, se la prestazione dura a lungo e si ripete negli anni, è difficile sostenere l’occasionalità: in tal caso l’Agenzia potrebbe pretendere che il socio avesse la P.IVA. In pratica, molti soci d’opera fondatori di startup preferiscono aprire P.IVA (magari in regime forfettario se possibile) per fatturare correttamente la propria opera. In altri casi, se l’apporto è limitato (es. un socio esperto di marketing che dà una mano al lancio per 6 mesi), si può gestire senza P.IVA come prestazione occasionale. Attenzione: se non si apre P.IVA quando si doveva, si rischia una sanzione amministrativa per evasione IVA (registro non tenuto, ecc.) e l’IVA va comunque versata. Quindi la scelta va ponderata consultando un commercialista prima: spesso la soluzione migliore è sì, aprire P.IVA se c’è incertezza (si evitano contenziosi futuri).
D: Il conferimento d’opera è soggetto a IVA?
R: Sì, nella generalità dei casi sì (imponibile IVA). Come approfondito, se il socio è un soggetto passivo IVA (impresa o professionista), deve applicare l’IVA sul valore della prestazione conferita . Fanno eccezione i casi in cui il socio non è soggetto passivo (operazione fuori campo IVA) o è in un regime che non applica IVA (forfettario) o la prestazione è per sua natura esente IVA (raro per i conferimenti, ma ad es. prestazione sanitaria conferita a una società medica, sarebbe esente ex art. 10). Nella stragrande maggioranza di conferimenti d’opera in S.r.l. operative (servizi informatici, consulenze, opere manuali, ecc.) si deve fatturare con IVA al 22%. Questo spesso sorprende, ma è la legge. La società potrà detrarre l’IVA, quindi per il sistema è neutro, ma il socio deve versarla. Quindi, sì, si paga l’IVA (salvo eccezioni specifiche).
D: Se un socio d’opera non esegue la prestazione, cosa può fare la società?
R: Può attivare la procedura di cui all’art. 2466 c.c. per la mancata esecuzione dei conferimenti: intimazione al socio a eseguire entro 30 giorni; decorso inutile, vendita forzosa della sua quota; se nessuno compra, esclusione del socio e riduzione del capitale . La società inoltre escuterà la polizza di garanzia (o trattiene la cauzione) per sopperire al mancato apporto. In parallelo potrebbe anche agire per risarcimento danni se l’inadempimento ha causato specifiche perdite. Ma di solito l’esclusione è la via maestra: il socio viene estromesso. È importante notare che il socio moroso perde anche l’eventuale parte di prestazione già eseguita (non ha diritto a niente, tranne a riavere l’eventuale eccedenza di prezzo se la quota fosse venduta a più del dovuto, ipotesi remota). Insomma, l’inadempimento di un conferimento d’opera ha conseguenze drastiche: il socio esce e il capitale sociale viene ridotto (a scapito anche degli altri soci che vedono ridotta la patrimonializzazione, a meno che uno di loro ricompri la quota).
D: Come si valuta una prestazione d’opera conferita a capitale?
R: Idealmente mediante una perizia di stima da parte di un esperto indipendente (revisore, perito iscritto al tribunale) . Non è formalmente obbligatoria per legge, ma è la prassi consigliata. L’esperto dovrà descrivere la prestazione, stimare il valore economico tenendo conto del tempo necessario, del costo di mercato di un servizio analogo, ecc. In alternativa, i soci possono concordare un valore in base a preventivi o esperienze, ma devono stare attenti a non sovrastimare. Una volta determinato un valore, questo va indicato nell’atto costitutivo o delibera di aumento capitale. Esempio: “Tizio conferisce la propria attività di gestione amministrativa per 2 anni, valutata €20.000”. La garanzia fideiussoria dovrà coprire quell’importo. Attenzione: se il valore è troppo elevato rispetto a ciò che poi la prestazione rende, gli amministratori e il socio rischiano sanzioni (falso conferimento) . Se il valore è troppo basso, è il socio d’opera a rimetterci (fa più lavoro di quanto vale la quota). Quindi è cruciale trovare un valore equo di comune accordo (da mettere nero su bianco). Nella valutazione si considerano anche eventuali risparmi per la società: es. se grazie al socio non si dovrà assumere un manager a € X all’anno, quel X può essere base di stima.
D: Si può cedere la quota di un socio d’opera a un altro prima che la prestazione sia eseguita?
R: Tecnicamente sì, ma occorre seguire le regole statutarie ed avere il consenso della società, perché è necessario tutelare l’adempimento dell’obbligo d’opera. Nella pratica, esistono varie possibilità:
- Subentro con liberazione del cedente: il nuovo acquirente della quota assume anche l’obbligo di eseguire la prestazione (se ha le capacità per farlo) e fornisce nuova garanzia. La società deve accettare questa sostituzione (di solito con approvazione degli amministratori o assemblea). Il cedente viene liberato dall’obbligo e restituita la sua garanzia.
- Trasformazione del conferimento d’opera in denaro: in accordo con la società, il cedente magari versa l’equivalente in denaro (o fa escutere la garanzia) e così “paga” il suo conferimento; a quel punto la sua quota diventa come una quota da capitale versato e può cederla liberamente. Questo però richiede una modifica del contratto sociale, non semplice.
- Cessione con mantenimento obbligo: se (sconsigliabile) lo statuto lo prevede, il socio potrebbe cedere la quota ma restare obbligato a completare la prestazione anche da non socio. Questa situazione è fonte di potenziali litigi e, come visto, era la tesi di quella massima notarile poi sconfessata . Quindi meglio evitarla.
In sintesi, è possibile cedere ma serve che la società valuti come garantire l’adempimento residuo. Spesso negli statuti di S.r.l. con soci d’opera si inserisce una clausola di intrasferibilità temporanea: il socio d’opera non può vendere la quota finché non ha adempiuto (o può farlo solo insieme ad adempiuto, es. vendono la società intera e contestualmente sistemano quell’obbligo). Questo per prevenire grane. Dunque prima di cedere, controllate lo statuto e parlatene con gli amministratori.
D: Il socio d’opera ha diritto a uno stipendio o compenso periodico per il lavoro svolto?
R: No, non automaticamente. Il “compenso” del socio d’opera è costituito dalle quote sociali assegnategli in corrispettivo del suo apporto. Non c’è un salario mensile né altri pagamenti (a meno che non siano pattuiti extra contrattualmente). Questo è ciò che distingue il socio d’opera da un dipendente: il socio rischia il proprio lavoro nell’impresa e ne riceve remunerazione solo se l’impresa produce utili (dividendi) o cresce di valore (apprezzamento quota). Può tuttavia accadere che il socio d’opera rivesta anche un ruolo di lavoro formale: ad esempio, viene anche assunto con un mini-contratto o nominato amministratore delegato con stipendio. In tali casi percepisce quell’emolumento in aggiunta. Ma se ciò non è previsto, non può pretendere uno stipendio. Le controversie talora sorgono quando il socio d’opera, dopo aver lavorato a lungo senza utili, si sente trattato ingiustamente rispetto ad altri soci che hanno messo capitali e magari prendono utili. Purtroppo, se non c’è un accordo specifico, il socio d’opera non ha alcun diritto di natura lavorativa (ferie, TFR, stipendio minimo, ecc.). Egli potrà solo partecipare agli utili come socio. La Cassazione ha rimarcato che il socio d’opera non gode delle tutele del lavoratore subordinato . Quindi è fondamentale, prima di accettare di fare il “socio che lavora gratis”, esserne consapevoli e magari prevedere compensi amministrativi o di collaborazione se la mole di lavoro è tale da meritare reddito immediato.
D: Come fa il Fisco a scoprire se un conferimento d’opera non è stato tassato?
R: Oggi con l’incrocio di banche dati è relativamente semplice. Ad esempio:
- Dal registro delle imprese l’Agenzia può vedere l’atto costitutivo di nuove società. Se legge che un socio ha conferito “prestazioni di consulenza €100.000”, può verificare l’anno successivo se quel socio ha aperto P.IVA, se ha emesso fatture elettroniche (la fatturazione elettronica permette al fisco di vedere tutte le fatture) e se ha dichiarato redditi. Se non trova nulla, può far partire un accertamento mirato.
- In sede di verifica fiscale presso la società, i verificatori controllano la voce “crediti verso soci per conferimenti” in bilancio o nel libro soci. Se notano un conferimento d’opera, chiederanno evidenza delle fatture emesse dal socio. Se non ci sono, parte la segnalazione.
- Il socio stesso può finire a controllo: magari è un professionista che ha omesso fatture; con l’analisi del tenore di vita, movimenti bancari ecc., l’ufficio può notare l’acquisizione di una quota societaria di valore senza apparenti pagamenti – questo può far sorgere domande.
- Segnalazioni: meno probabile, ma un ex socio scontento o un professionista a conoscenza potrebbe segnalare evasione.
In generale, ogni conferimento non in denaro è un’operazione straordinaria e come tale attira l’attenzione. L’Agenzia negli ultimi anni ha intensificato i controlli sui conferimenti di rami d’azienda o partecipazioni (per possibili abusi), e in quel contesto può emergere anche la posizione di soci d’opera se presenti.
D: Esiste un modo per fare conferimenti d’opera evitando di pagare subito imposte?
R: Eludere completamente le imposte no, non legalmente. Ci sono però assetti alternativi: uno potrebbe chiedersi se non convenga, anziché fare un conferimento d’opera, fare un contratto di lavoro/consulenza pagato dalla società e poi reinvestire il ricavato nella società. Ad esempio: Caio poteva farsi assumere o incaricare come consulente per €50.000, la società gli paga (tasse e contributi su quello) e poi Caio sottoscrive capitale sociale con quei €50.000 cash (magari come sovrapprezzo quote). Così avrebbe pagato IRPEF su 50k e niente IVA se dipendente, o IVA e IRPEF se consulente. In confronto al conferimento d’opera, è lo stesso carico fiscale finale, solo con passaggi in più. Non c’è un vantaggio marcato. Un vantaggio del conferimento d’opera è semmai di cassa: il socio non deve attendere di incassare netti e poi reinvestirli, ma ottiene direttamente la quota, e la società non esborsa liquidità per il suo servizio (tranne l’IVA eventualmente). Si può dire che il conferimento d’opera è già di per sé un meccanismo di finanziamento del costo del lavoro tramite equity. Ma sul piano fiscale non esistono scorciatoie lecite: quella prestazione va tassata come reddito in qualche forma.
Qualcuno potrebbe pensare: “se il socio d’opera è una startup innovativa c’è l’esenzione imposte?” – No, le agevolazioni per startup riguardano gli investitori che conferiscono denaro (deduzioni IRPEF), non chi conferisce lavoro. Oppure: “posso fare un conferimento in account personal reputation o know-how non tassabile?” – Non c’è base legale per esentare contributi in know-how; se il know-how è brevettato e conferito come bene immateriale, allora sì quel bene potrebbe non generare plusvalenza per chi lo conferisce in certi casi (art. 34 L. 31/2005 prevedeva esenzione su conferimento brevetti in società, poi modifiche nel 2019-2020). Ma questo esula dal conferimento di opera futura.
In sintesi: l’unica area dove non si pagherebbero imposte subito è se la prestazione è veramente gratuita e il socio non riceve nulla in cambio (ad esempio, un volontario in un’associazione). Ma se parliamo di S.r.l. profit, il socio riceve una quota con valore, quindi c’è materia imponibile.
D: C’è il rischio di sanzioni penali per il socio o la società in caso di conferimenti non dichiarati?
R: Potenzialmente sì, se gli importi evasi superano le soglie di punibilità. In particolare:
- Omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 D.Lgs. 74/2000): se il socio persona fisica non ha proprio presentato la dichiarazione pur avendo conseguito redditi sopra €50.000 imponibili, è reato. Oppure se li ha presentati ma con evasione >€100.000 e 10% del dichiarato, reato di dichiarazione infedele (art. 4). Ad esempio, Caio dichiara €0 ma doveva dichiarare €50k, rischia l’art. 4 se imposta evasa > €100k (improbabile su 50k).
- Omessa dichiarazione IVA: se Caio aveva obbligo di dichiarare IVA e non l’ha fatto per un intero anno superando €50k IVA dovuta, è reato (art. 5). Un socio d’opera difficilmente supera €50k di IVA (vorrebbe dire conferimento > €250k!).
- Emissione di fatture false: non rilevante, qui semmai è mancata fattura, non fattura fittizia.
- Occultamento/distruzione di documenti contabili: se Caio era tenuto a scritture contabili (professionista) e non ha annotato nulla per occultare il reddito, potrebbe configurarsi (art. 10 D.Lgs. 74/2000). Ma è residuo.
- Omesso versamento IVA (art. 10-ter) o ritenute (art. 10-bis): se Caio ha liquidato la sua IVA ma non l’ha versata oltre €250k, o se Alfa non versa ritenute oltre €150k, reati. Questi scenari di solito non si applicano in un singolo conferimento modesto.
Insomma, per importi normali (diciamo sotto qualche centinaio di migliaio di euro) è più questione di sanzioni amministrative. Il penale può entrare in gioco se volutamente uno conferisce importi enormi evadendo tanto. Ma è raro. Ad ogni modo, trascurare la fiscalità di un conferimento d’opera può mettere nei guai seri, quindi va trattato con la stessa attenzione di qualsiasi altra operazione aziendale rilevante.
D: Cosa fare se si riceve un avviso di accertamento per IVA/IRPEF su un conferimento d’opera?
R: Come spiegato nella sezione difensiva, i passi sono: valutare i motivi dell’atto, raccogliere la documentazione, farsi assistere da un esperto, e poi decidere se aderire o ricorrere. Non ignorare l’atto, perché diventerebbe definitivo dopo 60 giorni. Se avete i fondi e riconoscete l’errore, considerare l’adesione o il pagamento per evitare aggravi. Se ritenete che l’Ufficio abbia sbagliato (ad esempio imponendo reddito dove non c’era), allora preparare il ricorso motivato, come da schema. Spesso conviene anche presentare istanza di sospensione dell’atto se le somme sono elevate, per sospendere la riscossione durante il contenzioso (il giudice la concede se il ricorso non è temerario e c’è rischio di danno grave nel pagare subito).
Inoltre, controllare se l’accertamento rispetta il principio del ne bis in idem tra socio e società: se ad esempio vi tassano un costo in capo alla società e contemporaneamente il ricavo in capo al socio, è teoricamente corretto (deduzione negata a uno e tassazione all’altro) ma bisogna stare attenti che non avvenga una duplicazione ingiusta (tipo sanzioni a entrambi per la stessa cosa – ognuno ha la sua violazione però). Un coordinamento difensivo tra socio e società è utile: potrebbero avere entrambi ricevuto atti. Meglio fare fronte comune, magari con lo stesso difensore o difensori che collaborano, per evitare che un contenzioso contraddica l’altro. Ad esempio, la società potrebbe sostenere “quel costo era deducibile perché c’era l’obbligo di pagarlo”, mentre il socio dice “non avevo obbligo di fatturare perché non l’ho fatto”: bisogna allineare la strategia o quantomeno essere coerenti.
D: Ci sono sentenze favorevoli al contribuente in questi casi?
R: Alcune commissioni tributarie hanno dato ragione ai contribuenti in situazioni specifiche:
- Quando il Fisco ha preteso imposte su prestazioni non ancora eseguite integralmente, alcuni giudici hanno ridotto l’imponibile a quanto effettivamente svolto (principio di capacità contributiva).
- In casi di incertezza normativa, come detto, spesso le sanzioni sono state annullate o ridotte sensibilmente.
- Se il socio d’opera era anche dipendente e c’è stato un doppio prelievo, talora i giudici hanno tolto la pretesa aggiuntiva per equità (caso peculiare: un socio d’opera che era già assunto, l’INPS voleva anche contributi artigiani, e il giudice ha annullato la doppia contribuzione).
- Una sentenza (CTP Milano 2014 ipotetica) potrebbe aver dichiarato che la prestazione resa dal socio unico alla “sua” S.r.l. senza compenso non era soggetta a IVA perché atto interno privo di controprestazione reale – sebbene su questo non v’è uniformità.
In generale, però, nessuna Cassazione ha sancito un’esenzione generale. Quindi se sperate di trovare “la sentenza risolutiva”, purtroppo non c’è. La difesa vincente deve concentrarsi sui dettagli del vostro caso (ad esempio, prestazione non eseguita -> nulla da tassare, oppure errore scusabile -> niente sanzioni).
D: Qualche consiglio pratico finale?
R: Certamente: la lezione che emerge è che i conferimenti d’opera e servizi in S.r.l. vanno pianificati con attenzione fiscale sin dall’inizio. Alcuni consigli:
- Formalizzare per iscritto la prestazione conferita, con tempi, modi e valori. Questo aiuta sia civilmente sia fiscalmente (saprete quando fatturare e quanto).
- Emettere fatture o ricevute periodiche: non aspettare la fine se l’attività dura a lungo. Come per i SAL (stati avanzamento lavori), concordare magari tranche di esecuzione con relative fatture, così l’IVA si versa a scaglioni e non ci saranno omessi cumulati.
- Tenere la garanzia aggiornata: se sta per scadere, rinnovatela, altrimenti vi escludono (e anche il Fisco potrebbe dire che l’obbligo si è cristallizzato in quell’anno).
- Consultare un tributarista prima: valutare se sia opportuno scegliere un diverso inquadramento (ad esempio trasformare il socio d’opera in un collaboratore retribuito). Ogni caso è diverso: in alcuni casi è più efficiente dare una quota minoritaria al socio e anche pagargli un compenso, in altri conviene solo la quota.
- Trasparenza: non cercare di “nascondere” la prestazione. Invece, documentatela in contabilità: se fate emergere il costo e il debito, potete anche dedurlo e siete più al sicuro (il paradosso: alcuni non fatturano per non pagare IVA, ma poi rinunciano a dedurre 100 di costo che avrebbe fatto risparmiare 24 di IRES – un autogol).
- Accantonare fondi per tasse: se siete socio d’opera senza stipendio, ricordatevi che dovrete pagare imposte sul reddito “figurativo”. Quindi riservate risorse personali per farvi fronte (o coordinatevi con la società, che potrebbe ad esempio riconoscervi un dividendo extra a fine per aiutarvi a pagare le tasse, se gli altri soci concordano).
Con questi accorgimenti, eviterete di trovarvi, anni dopo, col “conto” salato del Fisco. E se proprio vi trovate in difficoltà, la comunicazione col Fisco è sempre preferibile alla latitanza: si può chiedere dilazioni, spiegare la buona fede, ecc., spesso ottenendo comprensione (specie se non siete recidivi e mostrate collaborazione).
Conclusione: i conferimenti d’opera e servizi in S.r.l. rappresentano un istituto affascinante che unisce profili di diritto societario, fiscale e del lavoro. Dal punto di vista del socio “debitore” dell’obbligo, è fondamentale conoscerne tutti gli aspetti per non incorrere in sanzioni o perdere i propri diritti. Speriamo che questa guida avanzata, completa di riferimenti normativi, prassi, giurisprudenza e esempi pratici, abbia fornito gli strumenti necessari per affrontare consapevolmente la materia e, all’occorrenza, difendersi efficacemente in caso di contestazioni su conferimenti d’opera “non tassati”. Sempre meglio, comunque, prevenire tali contestazioni con una corretta gestione a monte: un conferimento d’opera ben pianificato e correttamente fiscalmente gestito sarà un valore aggiunto per la società e non un grattacapo futuro. Buon lavoro (in tutti i sensi) ai soci d’opera e ai loro consulenti!
Fonti: Codice Civile artt. 2464, 2466; DPR 633/1972 artt. 2, 3, 6; TUIR (DPR 917/86) artt. 6, 50, 53, 55, 67; D.Lgs. 74/2000 ; Cass. civ. 21972/2015; Cass. civ. 22963/2021; Cass. trib. 26650/2020 ; Trib. Roma 11887/2020 ; Cass. lav. 21540/2019; Circ. AdE 9/E/2016; Risposte AdE 128/2018 , 116/2020 , 4/2023; e altre nell’analisi sopra.
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29807 depositata il 12 ottobre 2022 – Ai fini della assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi, e del conseguente diritto alla detrazione dell’imposta assolta, l’onerosità dell’operazione è riconoscibile solo quando tra l’autore della prestazione ed il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico di scambio di adempimenti sinallagmatici, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al secondo, con la specificazione che il fatto generatore dell’IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione “individualizzabile”, tale, cioè, da costituire condizione di esigibilità del corrispettivo.
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestata la mancata tassazione di conferimenti d’opera o di servizi in una Srl? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestata la mancata tassazione di conferimenti d’opera o di servizi in una Srl?
Vuoi capire quali sono i rischi e come predisporre una difesa solida?
👉 Prima regola: dimostra la corretta qualificazione del conferimento e la legittimità del suo trattamento fiscale.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Conferimenti d’opera o servizi effettuati dai soci senza corrispondente tassazione come reddito;
- Conferimenti non formalizzati con atto notarile o senza perizia di stima;
- Valutazioni considerate incongrue rispetto al valore reale della prestazione;
- Utilizzo del conferimento per creare riserve o capitale sociale senza versamenti in denaro;
- Casi in cui l’Agenzia ritiene il conferimento un modo per occultare compensi o utili distribuiti.
📌 Conseguenze della contestazione
- Tassazione come reddito dei conferimenti ritenuti imponibili;
- Recupero delle imposte non versate con interessi e sanzioni;
- Rischio di contestazioni per dichiarazione infedele;
- Responsabilità patrimoniale e, nei casi più gravi, penale per amministratori e soci.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Il conferimento era previsto nello statuto o in una delibera assembleare regolare?
- È stata predisposta una perizia di stima conforme ai requisiti di legge?
- La prestazione d’opera o di servizi è stata effettivamente eseguita e documentata?
- Il conferimento è stato trattato correttamente dal punto di vista contabile e fiscale?
- La contestazione dell’Agenzia si basa su dati concreti o su semplici presunzioni?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Atto costitutivo o verbale assembleare di conferimento;
- Perizie di stima e valutazioni professionali;
- Contratti, fatture o documenti che provano la prestazione;
- Scritture contabili e bilanci della società;
- Comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate o con il notaio.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la correttezza formale e sostanziale del conferimento;
- Evidenziare che non vi è stata distribuzione occulta di utili ma un vero apporto al capitale;
- Contestare la ricostruzione dell’Agenzia se basata su presunzioni o criteri valutativi errati;
- Chiedere l’annullamento in autotutela se la documentazione era già agli atti;
- Presentare ricorso entro 60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria;
- Difesa penale mirata se la contestazione sfocia in accuse di frode o dichiarazione fraudolenta.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la documentazione societaria e fiscale del conferimento;
📌 Verifica la legittimità della contestazione e individua i punti deboli dell’accertamento;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti assiste in giudizio e, se necessario, nei procedimenti penali collegati;
🔁 Suggerisce soluzioni preventive per la corretta gestione dei conferimenti futuri.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto societario e contenzioso tributario;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni su conferimenti d’opera e servizi;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sui conferimenti d’opera e servizi non tassati non sempre sono fondate: spesso derivano da valutazioni arbitrarie o da una scorretta interpretazione delle norme.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la legittimità del conferimento, evitare la riqualificazione come reddito imponibile e ridurre sensibilmente sanzioni e interessi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti fiscali inizia qui.