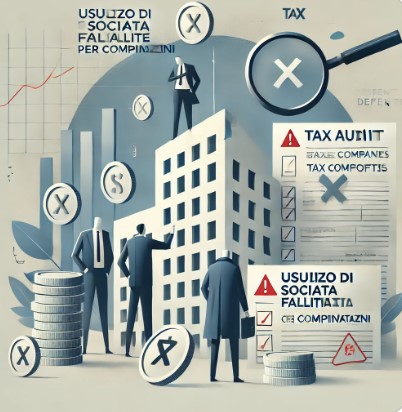Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché sono state utilizzate società fallite per compensazioni fiscali? In questi casi, l’Ufficio presume che i crediti vantati da tali società non siano reali o non più esigibili, e che siano stati strumentalmente usati per ridurre indebitamente il carico fiscale di altre imprese. La conseguenza è il recupero delle imposte, con sanzioni molto pesanti e, nei casi più gravi, possibili contestazioni penali. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la validità delle compensazioni o ridurre l’impatto delle sanzioni.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’utilizzo di società fallite per compensazioni
– Se i crediti fiscali usati in compensazione provengono da società dichiarate fallite o cessate
– Se i crediti non risultano effettivamente certificati o iscritti nei bilanci delle società originarie
– Se le compensazioni appaiono sproporzionate rispetto all’attività effettiva della società fallita
– Se vi sono incongruenze tra le comunicazioni fiscali e le compensazioni effettuate tramite F24
– Se l’Ufficio presume un uso fraudolento di crediti inesistenti per abbattere il debito fiscale
Conseguenze della contestazione
– Recupero immediato delle imposte indebitamente compensate
– Applicazione di sanzioni fino al 200% dell’importo contestato
– Interessi di mora calcolati dalla data della compensazione
– Blocco delle compensazioni future e inserimento in liste di controllo
– Possibile denuncia penale per indebita compensazione o frode fiscale
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare la reale esistenza e spettanza dei crediti usati in compensazione
– Produrre certificazioni, bilanci e comunicazioni ufficiali che attestino la validità dei crediti
– Contestare la qualificazione di “inesistenti” se i crediti erano “non spettanti”, per ridurre le sanzioni applicabili
– Evidenziare errori di calcolo, vizi di motivazione o difetti di istruttoria dell’accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare i crediti fiscali contestati e la documentazione societaria delle aziende coinvolte
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta qualificazione dei crediti
– Redigere un ricorso fondato su prove concrete e vizi formali dell’accertamento
– Difendere gli amministratori e le società davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e aziendale da conseguenze fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riqualificazione dei crediti da “inesistenti” a “non spettanti” con sanzioni ridotte
– La sospensione delle richieste di pagamento già avviate
– La riduzione o eliminazione di sanzioni e interessi non dovuti
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: l’uso di società fallite per compensazioni è considerato ad alto rischio dal Fisco. È essenziale predisporre prove solide per evitare contestazioni fiscali e penali.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e societario – spiega come difendersi in caso di contestazioni per utilizzo di società fallite nelle compensazioni e come tutelare i tuoi diritti.
👉 Hai ricevuto una contestazione per compensazioni basate su crediti di società fallite? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la natura dei crediti contestati e costruiremo la strategia difensiva più efficace per proteggere i tuoi interessi.
Introduzione
L’utilizzo di società fallite in schemi di compensazione di crediti d’imposta è una pratica elusiva che ha attirato l’attenzione crescente dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza negli ultimi anni. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate contesta a contribuenti (imprese o persone fisiche) di aver usato in compensazione crediti tributari tramite società ormai fallite, spesso allo scopo di abbattere indebitamente i propri debiti fiscali. Si tratta di uno scenario complesso che coinvolge profili di diritto tributario, diritto penale tributario e anche diritto civile/fallimentare, con responsabilità potenziali per amministratori, soci, professionisti e altri soggetti coinvolti.
Dal punto di vista del debitore (cioè del contribuente cui viene contestato l’uso indebito dei crediti), trovarsi al centro di un’accusa del genere può essere allarmante. Le conseguenze infatti possono includere il recupero immediato delle imposte non versate, sanzioni fiscali molto elevate, e nei casi più gravi persino imputazioni penali per il reato di indebita compensazione. Inoltre, quando nello schema sono coinvolte società terze (ad esempio società “cartiere” poi fallite che hanno originato i crediti, o società che hanno assunto il debito altrui – il cosiddetto accollo fiscale), possono sorgere questioni di responsabilità civile degli amministratori, dei soci e dei cessionari di tali crediti.
Scopo di questa guida è fornire un’analisi approfondita e aggiornata ad agosto 2025 su questo tema, con taglio professionale ma anche divulgativo. Ci rivolgiamo sia a professionisti legali e fiscali (avvocati, commercialisti) sia a imprenditori e privati contribuenti che vogliono capire come prevenire e difendersi da contestazioni dell’Agenzia delle Entrate relative a compensazioni indebite legate a società fallite.
Esamineremo dapprima il quadro normativo italiano sulle compensazioni dei crediti d’imposta, evidenziando cosa è lecito e cosa no. Spiegheremo la distinzione fondamentale tra crediti “non spettanti” e crediti “inesistenti”, cruciale in questi casi, alla luce delle novità normative del 2024 e delle più recenti sentenze (in particolare le Sezioni Unite della Cassazione a fine 2023). Approfondiremo poi come operano questi schemi fraudolenti, in particolare il ruolo delle società fallite nel generare crediti fittizi o nel fungere da accollanti, e i relativi profili civilistici (responsabilità di amministratori, soci, cessionari e altri).
Successivamente analizzeremo le sanzioni tributarie e i possibili rilievi penali, includendo le soglie di punibilità e le difese in ambito penale (ad es. pagamento del dovuto per evitare la punibilità). Descriveremo poi l’iter con cui l’Agenzia delle Entrate individua e accerta queste violazioni – dai controlli automatizzati sugli F24 fino all’avviso di accertamento o atto di recupero – e come il contribuente può intervenire in ogni fase.
Dal punto di vista difensivo, forniremo strategie e consigli pratici: come impostare la difesa in modo da far ricadere il caso nella fattispecie meno grave possibile, come utilizzare gli strumenti deflativi (adesione, autotutela, ecc.), come coordinare la difesa tributaria con quella penale se necessario. Illustreremo anche esempi concreti di casi (tratti da esperienza pratica e giurisprudenza) con le relative difese possibili: ad esempio il caso di un credito IVA inesistente generato con fatture false tramite una società “cartiera” fallita, il caso di un credito realmente esistente ma utilizzato oltre i limiti (non spettante), il caso di un accollo fiscale tra società collegate, ecc.
Infine, proporremo una sezione di Domande e Risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più frequenti, e tabelle riepilogative che schematizzano i punti chiave: differenze tra credito non spettante e inesistente, termini di accertamento, sanzioni e responsabilità dei vari soggetti coinvolti. L’obiettivo è offrire una guida completa, aggiornata al 2025, che consenta al lettore di orientarsi con sicurezza su questa materia e di sapere come difendersi efficacemente da una contestazione dell’Erario relativa a utilizzo di società fallite per compensazioni.
Compensazione dei crediti d’imposta: quadro generale
Prima di addentrarci nelle peculiarità dei crediti fittizi legati a società fallite, è utile richiamare brevemente cos’è la compensazione dei crediti d’imposta e come funziona nel nostro ordinamento. La compensazione è uno strumento contabile-fiscale che permette al contribuente di utilizzare crediti tributari vantati verso l’Erario per pagare debiti tributari o contributivi, invece di eseguire pagamenti monetari . In pratica, tramite il modello F24, si “scala” l’importo di un credito d’imposta dal debito da versare. Ciò semplifica la gestione finanziaria e può evitare doppi esborsi: ad esempio, un credito IVA annuale può essere usato per compensare il versamento di ritenute o contributi dovuti, evitando di pagare liquidità per questi ultimi mentre si attende il rimborso del credito IVA.
Riferimenti normativi: La disciplina generale della compensazione tributaria è contenuta nell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, che consente la compensazione “orizzontale” (tra tributi diversi, o tributi e contributi) entro certi limiti. Esistono poi norme specifiche per particolari crediti o situazioni. Ad esempio, la Legge n. 244/2007, art. 1 c. 53 (Finanziaria 2008) aveva posto un limite annuale all’ammontare dei crediti compensabili, limite più volte aumentato: oggi (2025) il tetto generale è pari a 2 milioni di euro annui, come modificato dalla recente riforma e trasfuso nell’art. 3 del D.Lgs. 33/2025 . Inoltre, per taluni utilizzi di crediti in compensazione, sono previste specifiche procedure di controllo preventivo: ad esempio è obbligatorio il visto di conformità di un professionista abilitato sul modello dichiarativo per poter compensare crediti annuali IVA superiori a 5.000 €, o crediti da bonus fiscali sopra determinate soglie (obbligo introdotto dal D.L. 124/2019) . Queste misure sono state introdotte proprio per prevenire abusi nelle compensazioni.
Tipologie di crediti compensabili: rientrano nella compensazione sia crediti emergenti da dichiarazione (ad esempio un credito IRPEF o IRES risultante dal saldo di dichiarazione dei redditi, oppure un credito IVA trimestrale/annuale dovuto a versamenti eccedenti) sia crediti d’imposta “agevolativi” istituiti da norme speciali (crediti per investimenti in beni strumentali, ricerca e sviluppo, bonus edilizi ceduti, crediti per assunzioni, ecc.) . Ogni credito ha le proprie condizioni di spettanza fissate dalla legge che lo ha creato. Ad esempio, un credito IVA è “spettante” se deriva effettivamente da operazioni attive/passive dichiarate e da versamenti effettuati in eccesso rispetto al dovuto; un credito R&S (ricerca e sviluppo) è spettante se le spese effettuate rientrano tra quelle ammesse secondo la normativa e – per gli anni più recenti – sono adeguatamente certificate secondo i criteri previsti (ad es. il Manuale di Frascati per definire l’attività di ricerca agevolabile) .
Meccanismo legittimo vs. indebito: Finché la compensazione avviene nel rispetto delle norme – ossia usando crediti realmente maturati e spettanti al contribuente, nei limiti e con le formalità previste – si tratta di un legittimo strumento di cash management fiscale. Si parla invece di compensazione indebita quando il contribuente utilizza in compensazione un credito che in realtà non gli spetta, in tutto o in parte . Le cause possono andare dal banale errore (es. un errato riporto contabile di credito) fino a forme fraudolente in cui il credito è stato artificiosamente creato o “acquistato” senza che vi fosse una reale operazione economica a monte . In ogni caso, l’utilizzo di un credito non dovuto equivale di fatto a un mancato versamento di imposte: l’Erario andrà quindi a recuperare la somma non versata, maggiorata di sanzioni e interessi.
I controlli dell’Amministrazione: La legge predispone vari livelli di controllo per intercettare compensazioni anomale. Alcune verifiche sono automatiche e avvengono al momento dell’elaborazione delle dichiarazioni e degli F24: ad esempio i controlli ex art. 36-bis DPR 600/1973 (per imposte dirette) e art. 54-bis DPR 633/1972 (per IVA) confrontano i dati e possono segnalare discrepanze, come l’utilizzo di un credito che non risulta dalle dichiarazioni presentate . In tal caso l’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) chiedendo chiarimenti o il versamento della differenza. Vi sono poi controlli formali (art. 36-ter DPR 600/1973) in cui l’ufficio richiede al contribuente documentazione a supporto di alcune voci, tra cui eventuali crediti dichiarati . Infine, se il caso appare serio (importo rilevante o sospetto di frode), l’Ufficio può avviare verifiche approfondite fino ad emettere un atto di recupero o avviso di accertamento ad hoc per riprendere il credito indebito . Più avanti descriveremo nel dettaglio queste fasi e gli atti.
In sintesi, il sistema consente e regola la compensazione di crediti, ma al tempo stesso predispone meccanismi per scovare e reprimere gli abusi. Il contribuente che utilizza crediti in compensazione deve essere ben consapevole delle regole e pronto a dimostrare la legittimità dei propri crediti in caso di controllo .
Nota sull’accollo tributario e uso di crediti altrui: È fondamentale chiarire che la compensazione presuppone, in via ordinaria, che credito e debito appartengano allo stesso soggetto fiscale. Negli schemi di frode che stiamo analizzando, spesso un soggetto cerca di pagare i propri debiti tributari usando crediti di altri soggetti (come società terze). Questo meccanismo – noto come accollo del debito d’imposta altrui con compensazione – è oggi vietato espressamente per legge (dal D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019) . Anche prima del divieto normativo esplicito, la Cassazione ha chiarito che non è mai stata ammessa la possibilità di estinguere il debito di un contribuente tramite crediti d’imposta vantati da un altro soggetto: in pratica l’accollo “esterno” non produce effetti liberatori verso l’Erario se il pagamento avviene mediante compensazione anziché con denaro . L’accollante (il terzo che si offre di pagare) può sì subentrare nel debito, ma non può utilizzare i propri crediti tributari per compensare il debito altrui – in caso contrario, i crediti di un soggetto verrebbero usati da un altro, in violazione del principio della personalità del credito tributario. Le Sezioni Unite della Cassazione già nel 2008 avevano affermato che l’accollo nel settore tributario “non trasforma l’accollante nel contribuente” e non incide sul rapporto d’imposta col Fisco . Più recentemente, è stata ribadita l’illegittimità dell’accollo con compensazione anche per periodi antecedenti al 2019, stante la mancanza di base normativa per un simile meccanismo . Pertanto, se un contribuente ha aderito a questo schema (magari istigato da consulenti esterni che millantavano crediti fiscali acquistabili), sappia che il debito d’imposta originario rimane a suo carico, poiché il pagamento via compensazione non è riconosciuto e verrà ripristinato l’obbligo di versamento originario, con sanzioni a carico dei responsabili.
Crediti “non spettanti” vs “crediti inesistenti”: definizioni normative aggiornate
Un passaggio fondamentale per impostare la difesa è capire la differenza tra un credito d’imposta “non spettante” e un credito “inesistente”. La distinzione può sembrare tecnica, ma comporta effetti enormi sui termini di accertamento concessi al Fisco e sulle sanzioni applicabili . Proprio perché la giurisprudenza tributaria aveva dato luogo a interpretazioni difformi su tale distinzione, il legislatore è intervenuto di recente a fornire definizioni normative esplicite. Vediamo dunque quali sono, alla luce del D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 87 (attuativo della Delega Fiscale 2023) e della giurisprudenza consolidata (culminata nelle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 34419/2023).
Definizioni normative vigenti (dopo il 2024): Il D.Lgs. 87/2024 – in vigore dal 1° settembre 2024 – ha inserito nel D.Lgs. 74/2000 (norme penali tributarie) e nel D.Lgs. 471/1997 (sanzioni amministrative) definizioni chiare di credito non spettante e credito inesistente. In particolare :
- Credito inesistente*: sono considerati inesistenti i crediti per i quali *mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente previsti dalla norma che li istituisce oppure i crediti i cui requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente (attuate con documenti falsi, simulazioni o altri artifici) . Questa definizione sostituisce la previgente formulazione dell’art. 13, c.5 D.Lgs. 471/1997 (risalente alla riforma del 2015), che qualificava inesistente il credito privo del presupposto costitutivo e non riscontrabile mediante controlli automatizzati o formali . La ratio del nuovo testo è duplice: da un lato, oggettivare la nozione di inesistenza (focalizzandosi sull’assenza dei requisiti sostanziali del credito, senza più la complicazione dei controlli automatizzati); dall’altro, reprimere più severamente i crediti frutto di frode documentale, prevedendo per essi un trattamento sanzionatorio aggravato (come vedremo).
- Credito non spettante*: per esclusione, sono non spettanti i crediti d’imposta che *sarebbero esistiti come fattispecie, ma di cui il contribuente ha fruito in violazione delle norme che ne regolano l’utilizzo . La legge parla di crediti “fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero in misura eccedente il limite previsto” (art. 1, lett. g-quinquies, D.Lgs. 74/2000) . In altre parole, un credito non spettante è un credito vero quanto a presupposti di base, ma che il contribuente non poteva utilizzare (o non poteva utilizzare integralmente) secondo le regole: ad esempio un credito spettante ma utilizzato anticipatamente rispetto a quando consentito, oppure oltre il tetto annuale, oppure senza aver osservato un adempimento formale richiesto a pena di decadenza.
Giurisprudenza di riferimento: Prima dell’intervento legislativo del 2024, la distinzione era stata delineata dalla Corte di Cassazione, seppur con alcune oscillazioni poi risolte dalle Sezioni Unite a fine 2023. In particolare, le Sezioni Unite civili n. 34419 e 34420 dell’11 dicembre 2023 hanno affermato in modo chiaro che “le due categorie appaiono strutturalmente distinte e, sul piano logico, alternative: il credito è inesistente oppure esiste ma è non spettante” . Hanno quindi ricondotto l’indirizzo giurisprudenziale all’interpretazione già fatta propria da alcune pronunce del 2021, valorizzando la distinzione anche ai fini dei termini di accertamento. Le SU 2023 hanno inoltre fornito criteri concreti per distinguere le due ipotesi:
- Credito inesistente in senso proprio – ricorre quando manca del tutto il presupposto sostanziale che genera il credito. Può trattarsi di una operazione fittizia mai avvenuta (es: un credito d’imposta per spese di R&S in realtà mai effettuate) . Oppure può trattarsi di un credito privo di un elemento essenziale richiesto dalla norma. Le SU fanno l’esempio di un credito R&S maturato senza svolgere effettivamente alcuna attività di ricerca . Importante, la Cassazione chiarisce che in questa categoria rientrano anche i casi in cui il credito, pur essendo formalmente sorto, in realtà appartiene a un soggetto diverso o è già stato utilizzato altrove . Dunque, se il contribuente utilizza un credito altrui (cioè di un altro soggetto), quel credito è considerato “inesistente” nei suoi confronti, benché magari fosse “esistente” in capo all’altro soggetto . Questo punto è cruciale nel contesto delle società fallite: i crediti originariamente appartenenti alla società X, se usati dal contribuente Y, per Y sono crediti inesistenti (manca il requisito soggettivo, cioè l’appartenenza del credito). Similmente, se un credito era reale ma si è estinto perché già compensato in passato, tentare di riutilizzarlo genera un credito inesistente.
- Credito non spettante – ricorre quando il credito esiste come fatto generatore, ma è venuto meno un elemento di legittimazione al suo utilizzo, spesso per ragioni formali o quantitative. Le Sezioni Unite spiegano che “l’inosservanza di meri adempimenti procedurali o la previsione di soglie/limiti di valore” non inficiano l’esistenza del credito, ma ne limitano l’utilizzabilità . Ad esempio, se un credito esiste ma il contribuente non ha presentato una comunicazione richiesta, oppure ha sforato un tetto annuale compensando un importo maggiore del consentito, il credito in sé non si annulla: semplicemente, l’eccedenza utilizzata o l’utilizzo anticipato sono considerati indebiti. In tali casi il credito viene trattato come non spettante (uso non conforme alle regole) anziché inesistente . La differenza è sottile ma importantissima: nel credito non spettante il fisco riconosce che, almeno in parte, quel credito poteva esistere, mentre nel credito inesistente nega proprio la realtà economico-giuridica del credito stesso, bollandolo come fittizio.
Un criterio ulteriore di distinzione evidenziato dalla normativa (previgente) e ripreso dalla giurisprudenza riguardava la rilevabilità tramite controlli automatici. Nella vecchia definizione (2015-2024) era detto che il credito è “inesistente” solo se la sua inesistenza non è riscontrabile dai controlli automatizzati delle dichiarazioni . In pratica, se l’irregolarità era tale da poter essere subito colta dai sistemi (ad es. utilizzo di un credito senza aver presentato affatto la dichiarazione da cui doveva emergere), allora il credito era trattato come non spettante (violazione palese), mentre se la frode era più sofisticata e non rilevabile automaticamente, si qualificava come credito inesistente con conseguenze più gravi . Dal 2024 questa distinzione formale è stata eliminata: ora conta solo la presenza dei requisiti sostanziali e l’eventuale fraudolenza, non più la difficoltà di scoperta. Tuttavia, va notato che le Sezioni Unite 2023 avevano già affermato che, ai fini della disciplina precedente, dovevano concorrere entrambe le condizioni (mancanza del presupposto e non rilevabilità automatica) per parlare di credito inesistente; diversamente, se mancava uno dei due elementi, il credito andava considerato non spettante . In altre parole, già la Cassazione aveva ridotto l’importanza del criterio “controlli automatici”, affermando che se un credito è privo di base ma la sua inesistenza era facilmente scopribile dai controlli, va trattato come non spettante, soggetto quindi al regime meno afflittivo . Questo ragionamento, ora superato dalla nuova normativa, è però stato importante per dirimere molte liti pregresse.
Ricapitolando in termini semplici: un credito non spettante è un credito vero sulla carta ma usato indebitamente (pensa a “credito vero, uso sbagliato”), mentre un credito inesistente è un credito falso o inesistente nella realtà (pensa a “credito finto, creato ad arte”). Ad esempio, se una società fallita A aveva un credito IVA di 100 (vero, risultante dalle sue dichiarazioni), e la società B cerca di usarlo, per B quello è credito inesistente (perché quel credito apparteneva a A, non a B). Se invece B aveva un proprio credito ricerca & sviluppo di 100 ma lo utilizza senza aver ottenuto la certificazione richiesta o oltre i limiti annuali, quel credito era esistente ma l’uso è irregolare: si tratterà di credito non spettante. La distinzione impatta su sanzioni e termini: come vedremo a breve, ai crediti inesistenti si applicano sanzioni più alte (70% che può salire al 140%/210% se vi è frode) e un termine di accertamento più lungo (tradizionalmente 8 anni), mentre ai crediti non spettanti si applicano sanzioni ridotte (25%) e i termini ordinari di accertamento (5 anni) .
Termini di accertamento e atti di recupero per crediti indebitamente compensati
Un aspetto cruciale per chi si difende in queste controversie è capire entro quando l’Agenzia delle Entrate può contestare l’utilizzo indebito di crediti e con quali atti. La normativa prevede infatti termini diversi a seconda che il credito sia qualificato come non spettante oppure inesistente, e strumenti specifici per il recupero.
Termini di decadenza per l’accertamento: In generale, per le imposte dirette e l’IVA, il Fisco ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (o del settimo se la dichiarazione è omessa) per notificare un avviso di accertamento. Questa regola vale anche per contestare l’indebito utilizzo di crediti non spettanti, assimilato a una violazione dichiarativa “ordinaria”. Viceversa, per i crediti inesistenti la legge ha tradizionalmente concesso un periodo più ampio. Già con l’art. 27, comma 16, D.L. 185/2008 (conv. L. 2/2009) era stato stabilito che il recupero di crediti d’imposta inesistenti potesse avvenire entro otto anni dal loro utilizzo , in deroga ai termini brevi, data la complessità delle verifiche necessarie su queste frodi. Le Sezioni Unite 2023 hanno confermato che questa estensione ad 8 anni si applica solo ai crediti effettivamente “inesistenti” e non anche a quelli meramente “non spettanti” . Quindi, un primo motivo di difesa del contribuente è spesso quello di contestare la natura inesistente del credito per ricondurla a non spettante: se ci riesce, un eventuale atto emanato oltre il quinto anno sarebbe decaduto e quindi nullo.
Va evidenziato che il D.Lgs. 87/2024, nel ridefinire le nozioni, ha confermato gli effetti sui termini: oggi la distinzione è ancora più netta. Se il credito è inesistente, l’Agenzia ha più tempo e la violazione può essere contestata anche oltre il termine ordinario, mentre se il credito è non spettante vale il regime ordinario (salvo casi eccezionali). La Cassazione penale, con una pronuncia molto recente (Cass. pen. Sez. III n. 19868 del 28 maggio 2025), ha anche riconosciuto che la nuova definizione legislativa di credito non spettante (più favorevole agli imputati in certi casi) ha carattere interpretativo e retroattivo, recependo quanto la giurisprudenza aveva già elaborato . Ciò significa che, anche per fatti passati, i giudici tenderanno ad applicare la distinzione attuale se comporta un trattamento più benigno. In termini di termini di accertamento: se un atto è stato notificato quando già sarebbero decorsi 5 anni, la difesa punterà a dimostrare che il credito non era “fantasma” ma solo “irregolare” (non spettante), in modo da eccepire la decadenza dell’accertamento.
Atto di recupero vs Avviso di accertamento: Il recupero di crediti d’imposta indebitamente compensati può avvenire con diversi atti formali. Spesso l’Agenzia emette un “atto di recupero di credito d’imposta” ai sensi dell’art. 1, comma 421, L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) o altre disposizioni simili, specificamente volto a recuperare l’importo del credito utilizzato indebitamente, oltre interessi e sanzioni. Si tratta di un atto paragonabile a un accertamento, ma mirato al credito indebito. In altri casi può essere notificato un Avviso di accertamento (soprattutto se la compensazione indebita si inquadra in una più ampia verifica sul periodo d’imposta, magari con altre riprese a tassazione). Ai fini difensivi, cambia poco: entrambi vanno impugnati avanti al giudice tributario nei termini di legge (60 giorni dalla notifica), e in entrambi occorre contestare nel merito la pretesa.
Una differenza è che l’atto di recupero credito, essendo spesso assimilato a un atto di imposizione tributaria, segue le regole ordinarie per la notifica (anche via PEC) e per la motivazione, ma in qualche caso la giurisprudenza ha dibattuto se fosse applicabile il rito breve delle sanzioni (30 giorni). Ad oggi si ritiene pacificamente che anche l’atto di recupero vada impugnato in 60 giorni come un accertamento.
Motivazione degli atti: L’atto con cui si contesta il credito indebito deve indicare chiaramente i motivi per cui il credito è ritenuto non spettante o inesistente. Ad esempio, potrebbe recitare: “Credito d’imposta XY anno #### utilizzato in F24 del [data] per € __, privo di riscontro nella dichiarazione di riferimento (credito inesistente)”; oppure: “…utilizzato in eccesso rispetto al massimale di legge (credito non spettante)”. Se la motivazione è carente o generica, ciò può costituire motivo di nullità dell’atto per difetto di motivazione. Tuttavia, spesso gli Uffici dettagliano bene le ragioni, anche allegando documenti (es. copia del prospetto di indebito utilizzo, riferimento a verbali di verifica, relazione del curatore fallimentare nel caso di società fallite, ecc.).
Nel caso particolare di crediti provenienti da società fallite, l’accertamento dell’Agenzia spesso si basa su segnalazioni della Guardia di Finanza o su risultanze di procedure concorsuali. Ad esempio, nella nota Operazione “Good job” della GdF, si scoprì un sistema in cui società operative compensavano i propri debiti con crediti IVA fittizi creati da società poi dichiarate fallite . In tali contesti, l’Agenzia può avvalersi delle relazioni dei curatori fallimentari, che evidenziano l’inesistenza sostanziale dei crediti portati a compensazione. Nella sentenza Cass. pen. n. 36383/2019, ad esempio, si legge che il sequestro preventivo fu confermato perché era emerso (anche dalla relazione del curatore) che due società già dichiarate fallite avevano fatto da “soggetti generatori di crediti IVA fittizi”, utilizzati poi da altre società accollate per non pagare le imposte dovute . Queste informazioni tipicamente vengono riportate anche nell’avviso di accertamento, per sostenere la tesi che il credito era del tutto artificioso.
Onere della prova: in giudizio, l’onere di dimostrare che il credito era inesistente grava sull’Amministrazione finanziaria, trattandosi di un fatto costitutivo della maggiore pretesa tributaria (assenza del presupposto del credito). Il contribuente dal canto suo ha l’onere di provare l’esistenza e spettanza del credito se ne reclama la validità. In pratica, se l’ufficio porta elementi (es. mancanza di documenti giustificativi, attestazioni di frode) che fanno presumere il credito inesistente, spetterà al contribuente fornire evidenze contrarie (es. documentazione contabile, contratti, pagamenti effettuati a giustificazione del credito). Nel caso di crediti legati a società fallite, spesso i contribuenti si difendono sostenendo la propria buona fede e l’estraneità alle frodi perpetrate dai falliti, ma devono comunque fronteggiare il fatto oggettivo che il credito non era di loro spettanza (se proveniva formalmente da altro soggetto).
Riassumendo, verificare i termini e la tipologia del credito è fondamentale: se il Fisco agisce fuori termine o con atto inappropriato, il contribuente può ottenere l’annullamento senza neppure entrare nel merito. Se invece l’azione è tempestiva e formalmente corretta, la difesa dovrà concentrarsi sul merito (spettanza del credito, qualificazione come non spettante) e sul quantum delle sanzioni.
Sanzioni amministrative e profili penali
La contestazione dell’utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti in compensazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative tributarie molto salate e, per i casi più gravi, può far scattare anche conseguenze penali. È importante conoscere l’entità di queste sanzioni e le condizioni al contorno, sia per valutare il rischio complessivo sia per impostare correttamente la strategia difensiva (incluso eventualmente il ricorso a cause di non punibilità in ambito penale).
Sanzioni amministrative tributarie
Le sanzioni amministrative pecuniarie per indebita compensazione sono previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che disciplina le sanzioni sugli omessi versamenti e utilizzi di crediti in violazione. Tali sanzioni hanno subìto modifiche con la riforma del 2023-2024, in particolare il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto gli importi base (prima erano più elevati) e introdotto nuove aggravanti in caso di frode conclamata. Vediamole in dettaglio:
- Credito d’imposta non spettante: la sanzione amministrativa è pari al 25% del credito utilizzato indebitamente . Questa è la misura ridotta introdotta dalla riforma (prima del 2024 la sanzione era del 30%). Dunque, ad esempio, se ho compensato 50.000 € di credito non spettante, rischio una sanzione di 12.500 €. La sanzione è proporzionale all’importo e non fissa (salvo eccezioni, vedi oltre). Va ricordato che, come per tutte le sanzioni tributarie, se il contribuente paga entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto (acquiescenza) ha diritto alla riduzione ad 1/3 della sanzione. Inoltre, se vi sono cause di non punibilità (es. errori formali sanati tempestivamente), la sanzione può ridursi a un importo fisso (vedi seguito).
- Credito d’imposta inesistente: la sanzione base è il 70% dell’importo compensato . Questa percentuale è stata notevolmente abbassata rispetto al passato: fino al 2023 la sanzione per crediti inesistenti era dal 100% al 200% del credito, mentre ora è fissata al 70% (con possibilità di aumento in casi aggravati) . La riduzione è stata motivata dal legislatore con l’intento di rendere più proporzionata la pena pecuniaria, compensandola però con un giro di vite sui profili penali per i casi fraudolenti. Dunque, se un contribuente ha compensato 50.000 € di crediti inesistenti, la sanzione base è 35.000 € (che può essere definita ridotta a 1/3 in caso di pagamento agevolato, quindi ~11.667 €). Si noti che, fino al 31/8/2024, vigeva ancora la regola che se il credito era rilevabile da controlli automatici allora non era “inesistente” in senso tecnico e la sanzione era del 30% (come non spettante) . Dal 1/9/2024 questa distinzione è caduta, quindi si applica il 70% ogniqualvolta manchino i requisiti del credito (salvo che sia un mero errore formale sanato, come vedremo).
- Aggravante per crediti inesistenti da frode documentale: la grande novità è l’introduzione di una super-sanzione quando il credito inesistente deriva da una frode con documenti falsi o altri artifici. In tali casi, la sanzione del 70% può essere aumentata dalla metà fino al doppio . Ciò significa un range dal 105% al 210% del credito indebitamente usato . Questa circostanza si ha, ad esempio, quando il contribuente ha formato o utilizzato documentazione falsa per far risultare il credito (fatture per operazioni inesistenti, perizie fasulle, attestazioni mendaci di professionisti compiacenti, ecc.). Sono proprio le situazioni tipiche dei crediti fittizi creati da società cartiere: in tali casi il comportamento è giudicato più grave, per cui il contribuente non solo subisce le conseguenze penali, ma in sede amministrativa gli viene irrogata una sanzione molto più pesante. Attenzione: l’aumento metà-doppio si applica al soggetto che utilizza il credito in compensazione anche se la falsità sia materialmente opera di terzi. Ad esempio, se una società operativa compra un credito inesistente generato da una società fallita con false fatture, e lo compensa, la sua sanzione potrà essere aggravata al 105-210% poiché si tratta di credito inesistente basato su artifici fraudolenti. In sede di contestazione, tuttavia, la società potrà tentare di dimostrare la propria buona fede per evitare l’aggravante (argomentando che la rappresentazione fraudolenta è opera di altri e lei ignorava la falsità). Ma formalmente l’aggravante è oggettiva: se il credito era sorretto da falsi, la sanzione aggravata si applica , a meno che il contribuente provi di non aver avuto alcun vantaggio dalla frode e di essere stato vittima (cosa molto difficile).
- Violazioni formali sanabili: vi è un’ultima importante previsione, a favore del contribuente in buona fede che abbia commesso solo errori procedurali. L’art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/97 (introdotto già nel 2015 e confermato) prevede che se il credito, pur essendo considerato “non spettante” per violazione di modalità d’uso, era fondato su fatti reali e rientranti nella disciplina, e l’errore consiste solo nella mancata osservanza di adempimenti formali non essenziali, sanata entro certi termini, allora non si applica la sanzione proporzionale ma solo una sanzione fissa di €250 . In pratica, se il contribuente si accorge di aver ad esempio omesso una comunicazione e la presenta tardivamente entro la dichiarazione successiva, e regolarizza la posizione, la violazione viene “annullata” pagando 250 euro. Questa è una norma di clemenza per chi collabora e corregge spontaneamente errori innocui. Ad esempio, un contribuente che aveva un credito spettante ma non aveva inviato la prevista istanza nei tempi, e poi la invia in ritardo ma prima che l’errore sia contestato, può usufruire di questa forte mitigazione . Se invece l’adempimento non viene sanato nei termini, la sanzione torna al 25% ordinario .
In conclusione, dal punto di vista amministrativo conviene moltissimo rientrare nella categoria “non spettante” piuttosto che “inesistente”, per via delle sanzioni minori e della minor infamia fiscale. Difatti, molte strategie difensive puntano proprio a far derubricare la contestazione da credito inesistente a non spettante (quando possibile), così da ottenere sanzioni ridotte e magari far valere la scadenza dei termini .
Ricordiamo che le sanzioni tributarie possono essere definite in via agevolata (riduzione a 1/3 con acquiescenza, oppure conciliazione giudiziale con riduzione a 1/3 o 1/2 a seconda della fase). Inoltre, con la riforma fiscale 2023, non c’è più il divieto di definizione agevolata per i crediti inesistenti (prima era vietato rateizzare o definire transattivamente queste sanzioni, ora è consentito) . Questo per favorire la chiusura delle liti con pagamento.
Rilievi penali (reato di indebita compensazione)
L’utilizzo indebito di crediti può configurare il reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 (disciplina dei reati tributari). Si tratta di un delitto introdotto nel 2015 e inasprito negli anni successivi, volto a colpire penalmente i casi più gravi di mancato versamento di imposte dovuto a compensazioni fittizie. È importante capire quando scatta il penale, perché questo influenza molto la strategia difensiva (ad esempio, la possibilità di estinguere il reato con il pagamento).
Soglia di punibilità: Il reato scatta solo se l’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione supera una certa soglia in un anno d’imposta. Attualmente la soglia è di 50.000 € per periodo d’imposta . Ciò significa che se in un anno il contribuente compensa crediti non spettanti/inesistenti per importi superiori a 50mila euro totali, oltre alle sanzioni amministrative potrà essere perseguito penalmente; sotto tale soglia vi è solo l’illecito amministrativo. Attenzione: la soglia si riferisce all’importo non versato per effetto della compensazione, quindi equivale all’ammontare del credito indebito utilizzato.
Distinzione non spettante/inesistente nel penale: L’art. 10-quater prevede due fattispecie penali: al comma 1 punisce chi non versa importi dovuti utilizzando in compensazione crediti non spettanti, al comma 2 punisce chi fa lo stesso con crediti inesistenti. Le pene sono diverse: per i crediti non spettanti la reclusione è da 6 mesi a 2 anni , mentre per i crediti inesistenti (più grave) la reclusione è da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni . Dunque, usare crediti completamente fittizi è considerato un comportamento assimilabile alla frode fiscale, punito severamente, mentre usare crediti esistenti ma non spettanti (ad esempio per errore o interpretazione errata) è considerato meno grave, con pene minori. Questa distinzione, come visto, non era chiarissima all’inizio e ha generato dibattiti su quali crediti rientrassero in quale categoria. Oggi, dopo il D.Lgs. 87/2024, le definizioni penali sono allineate a quelle amministrative , e la Cassazione penale (sent. 19868/2025) ha confermato che le nuove definizioni valgono anche per i fatti pregressi in quanto più favorevoli . Ciò significa che se un caso del passato era borderline, verrà giudicato con la lente attuale (che tende a qualificare come “non spettante” certe situazioni dubbie). Ad esempio, in passato l’uso anticipato di un credito poteva essere trattato da alcuni giudici come “inesistente” ai fini penali, oggi sarebbe chiaramente “non spettante” e dunque fuori dalla fattispecie delittuosa più grave.
Consumazione del reato: il reato di indebita compensazione è consumato al momento della presentazione dell’F24 in cui viene effettuata la compensazione illecita (reato istantaneo a consumazione eventualmente frazionata se sono più versamenti). I termini di prescrizione decorrono da allora (6 anni base, aumentabili a 8 per interruzioni, per la forma semplice; 8 anni base per la forma aggravata oltre 50k con crediti inesistenti, che diventano fino a 10+ anni con atti interruttivi).
Cause di non punibilità (pagamento del debito): l’art. 13 D.Lgs. 74/2000 prevede una speciale causa di non punibilità per alcuni reati tributari in caso di integrale pagamento del debito tributario. In particolare, oggi (dopo modifiche del 2019) sono non punibili i reati di omesso versamento (art. 10-bis e 10-ter) e anche il reato di indebita compensazione limitatamente ai crediti non spettanti (art. 10-quater comma 1), se il contribuente paga tutto il dovuto prima dell’apertura del dibattimento . Ciò significa che se un imputato per indebita compensazione di crediti non spettanti provvede a versare le somme inizialmente non pagate (comprensive di sanzioni e interessi) prima che inizi il processo penale, il fatto non è più punibile. Attenzione: questo vale per i crediti non spettanti (comma 1). Per i crediti inesistenti (comma 2) invece la non punibilità non opera – segno che il legislatore considera questi ultimi come frode vera e propria e non vuole esentare dall’azione penale neanche a debito sanato. Tuttavia, anche nei casi di crediti inesistenti, il ravvedimento operoso e il pagamento integrale possono costituire circostanze attenuanti significative in sede penale (spesso portano la pena vicino al minimo edittale, e in caso di patteggiamento a una sanzione sospesa).
In pratica, se un contribuente riceve un processo penale per indebita compensazione su crediti non spettanti, ha tutto l’interesse a pagare subito il dovuto al Fisco: in tal modo evita il carcere perché il reato viene estinto. Se invece i crediti erano fittizi, pagare aiuta ma non estingue il reato; comunque è consigliabile farlo per dimostrare pentimento e ridurre le conseguenze (ad esempio evitare misure cautelari, ottenere la sospensione condizionale, etc.).
Responsabilità personali: va sottolineato che il reato penale viene contestato alle persone fisiche che hanno commesso il fatto. Nel caso di società, risponderanno gli amministratori o i soggetti che hanno materialmente deciso e attuato la compensazione indebita (es. il titolare della ditta individuale, il legale rappresentante della società, o un direttore amministrativo delegato, ecc.). Anche un consulente esterno può rispondere per concorso nel reato se ha attivamente contribuito (es. il caso Cass. 36383/2019 dove un commercialista intermediario è stato ritenuto corresponsabile per aver trasmesso F24 fraudolenti ). Le società in quanto tali generalmente non rispondono penalmente (non rientra tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 al 2025, sebbene si sia discusso di includere i reati tributari: attualmente l’indebita compensazione non pare inclusa, contrariamente ad alcune frodi IVA). Quindi la sanzione penale è personale.
Esempio di caso penale: riprendiamo un caso tipico per capire le implicazioni: un imprenditore ha compensato 600.000 € di IVA usando crediti fittizi provenienti da fatture false di una società poi fallita. Il fisco lo scopre: abbiamo 600k di crediti inesistenti > soglia (quindi reato). Penalmente, scatta art. 10-quater co.2, con pena massima 6 anni; essendo evidente la frode (documenti falsi) potrà essere contestata anche l’aggravante del “mezzo fraudolento” (documenti falsi) in sede amministrativa. L’imprenditore, se paga l’intero 600k+interessi, non evita il reato (perché credito inesistente), ma eviterà magari l’arresto in flagrante e potrà chiedere patteggiamento con pena attorno a 2 anni, sospesa. Se invece i 600k fossero stati un credito reale ma non dovuto (non spettante) – ipotesi teorica perché 600k di errore è strano, ma poniamo fosse ricerca & sviluppo contestata – allora pagando prima del dibattimento si estinguerebbe il reato di indebita compensazione (restano le sanzioni amministrative).
In sintesi: il penal tributario entra in gioco per importi rilevanti e distingue nettamente tra condotte fraudolente (crediti finti) e condotte “solo” elusive o negligenti (crediti veri ma usati indebitamente). Dal punto di vista del debitore che si difende, è fondamentale – se c’è il rischio penale – attivarsi tempestivamente: valutare il pagamento integrale per usufruire della non punibilità (se applicabile), oppure predisporre una difesa volta a dimostrare l’assenza di dolo fiscale, magari sostenendo che si trattava di un errore interpretativo (cosa che può escludere il dolo e portare all’assoluzione, se credibile). In ogni caso, va coordinata la difesa nel processo tributario con quella nel processo penale, poiché le risultanze dell’uno possono influenzare l’altro (ad esempio, una sentenza tributaria passata in giudicato che afferma che il credito era spettante potrebbe far venir meno il presupposto del reato; viceversa una sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto potrebbe giovare nel processo tributario, anche se formalmente indipendenti).
L’utilizzo di società fallite nei meccanismi di compensazione indebita
Chiarito il contesto generale, focalizziamoci ora sul fenomeno specifico delle società fallite usate per compensazioni indebite. Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza hanno scoperto diversi schemi fraudolenti in cui le società “fallite” (o decotte) giocavano un ruolo chiave nella generazione o veicolazione di crediti tributari fittizi. Dal punto di vista civilistico, queste società spesso erano meri gusci vuoti (talora definite “società cartiere”), utilizzate dai promotori delle frodi per creare artificiosamente crediti d’imposta – tipicamente crediti IVA da inesistenti operazioni commerciali, oppure crediti da bonus fiscali gonfiati. Tali società venivano poi fatte fallire (anche per sottrarsi alle responsabilità) o erano già in dissesto, e fungevano da fornitrici di crediti per altre aziende.
Possiamo individuare due macro-tipologie di scenari:
- Società fantasma generatrici di crediti fittizi: Una o più società (spesso S.r.l.) vengono utilizzate per emettere fatture false o creare operazioni fittizie al fine di maturare sulla carta un grosso credito IVA o altri crediti d’imposta (es. crediti da ricerca & sviluppo con costi inventati). Queste società poi non versano l’IVA o non pagano debiti, accumulano debiti erariali e finiscono in fallimento. I crediti però vengono “monetizzati” trasferendone il beneficio ad altre aziende compiacenti prima che la frode sia scoperta. Come avviene il trasferimento? Non potendo formalmente cedere un credito IVA (che non è cedibile liberamente), si ricorre ad accordi illeciti: ad esempio, schema di accollo fiscale, oppure utilizzo di modelli F24 “a saldo zero” in cui la società fallita funge da accollante. Nel caso analizzato in Cass. pen. 36383/2019, due società poi fallite (E.P. srl e M.) avevano generato crediti IVA fittizi e, in concorso con i loro amministratori e un consulente fiscale, li utilizzavano in F24 a saldo zero per compensare i debiti di altre società (società accollate) . In pratica, facevano risultare che le società fallite pagavano le imposte delle società terze usando i propri crediti IVA (inesistenti). Lo scopo era duplice: le società terze si liberavano del debito fiscale senza esborso, mentre i promotori della frode guadagnavano probabilmente una commissione o un vantaggio (spesso infatti l’accollante chiede un compenso inferiore al debito, creando un lucro illecito).
- Accollo di debiti tributari a società inattive/fallite: In altri casi, l’architettura era leggermente diversa. Un imprenditore debitore (persona fisica o società attiva con debiti tributari) si rivolgeva a un intermediario che gli proponeva: “Non pagare le tasse, ci pensiamo noi tramite una società XY che ha crediti fiscali inespressi”. La società XY in questione spesso era un soggetto in crisi o già fallito (o destinato a fallire), magari controllato dagli stessi promotori. Veniva stipulato un contratto di accollo del debito tributario: la società XY si obbligava verso l’Erario a pagare i debiti dell’imprenditore, e poi presentava F24 in compensazione usando i propri crediti (inesistenti) per estinguere quei debiti. Il debitore originario pagava all’intermediario una percentuale del debito (ad esempio 50% o 70%), ottenendo un apparente risparmio. Tuttavia, come già spiegato, questo meccanismo è illecito. Appena l’Agenzia se ne accorge, disconosce la compensazione: il debito fiscale originario risorge in capo al debitore originario, che riceve quindi la cartella o l’accertamento per omesso versamento. La società XY nel frattempo è spesso nulla dal punto di vista patrimoniale (fallita, senza beni), quindi il Fisco può solo rifarsi sul debitore originale. Di fatto, quell’imprenditore ha subito una truffa: ha pagato dei soldi per estinguere un debito che invece non si è estinto affatto. Questo scenario è tristemente comune in certe aree e periodi: vi sono state “agenzie” che pubblicizzavano servizi di pagamento di tasse altrui con sconti, ovviamente basati su crediti inesistenti. Dopo il 2019, con il divieto normativo, queste pratiche sono calate, ma casi antecedenti continuano ad emergere nelle aule di tribunale.
Inquadramento civilistico delle società fallite coinvolte: Dal punto di vista del diritto societario e fallimentare, queste società spesso si presentano come entità giuridiche formalmente distinte, con limitata responsabilità per i soci (tipicamente Srl, talora cooperative o ditte individuali). Quando interviene il fallimento, la società viene spossessata e le redini passano al Curatore fallimentare, sotto la vigilanza del Giudice Delegato. La società fallita diventa dunque un “debitor comune” i cui beni (inclusi eventuali crediti verso l’Erario) servono a soddisfare i creditori secondo le regole concorsuali. È importante notare che qualsiasi credito d’imposta maturato dalla società prima del fallimento entra nella massa attiva fallimentare: ad esempio, se davvero esistesse un credito IVA, spetterebbe al Curatore richiederlo in compensazione con debiti della stessa società fallita (art. 56 L.F. prevede la compensazione tra crediti e debiti reciproci alla data del fallimento) o chiederne il rimborso. Non potrebbe certo essere usato da terzi. Dunque, già solo da questa prospettiva, l’utilizzo da parte di terzi di crediti di una società fallita è giuridicamente indebita perché quei crediti (se reali) erano parte dell’attivo fallimentare indisponibile. Se invece i crediti sono fittizi, allora civilisticamente non c’è attivo: anzi, il Curatore likely li contesterà, e potrebbe promuovere azioni di responsabilità.
Responsabilità degli amministratori e soci della fallita: Nel caso in cui la società fallita sia stata utilizzata per frodi fiscali, gli amministratori della stessa vanno incontro a molteplici responsabilità. In ambito fallimentare, la produzione di crediti fittizi e l’aggravamento del dissesto potrebbero configurare reati fallimentari (come la bancarotta fraudolenta documentale se hanno tenuto contabilità falsa, o bancarotta semplice per aver aggravato il passivo). Possono inoltre essere chiamati dal Curatore in azione di responsabilità (ex art. 146 L.F.) per i danni arrecati alla società/creditori, ad esempio per le sanzioni irrogate o per aver sviato risorse. Se i soci hanno beneficiato di distribuzioni di utili fittizi o di somme derivanti dalla vendita di crediti falsi, potrebbero essere coinvolti anch’essi: di regola i soci di una Srl rispondono solo col capitale conferito, ma in caso di abuso della personalità giuridica (società schermo usata per illeciti) la giurisprudenza ammette azioni per far valere la loro responsabilità indiretta. Ad esempio, se la società fallita ha incassato denaro cedendo “crediti” falsi e poi quei soldi sono spariti verso i soci, il Curatore può agire per farli restituire (azione di revocatoria o azione ordinaria per pagamento di utili illegittimi). Inoltre, i soci/amministratori potrebbero essere perseguibili per concorso nei reati tributari (come nel caso citato, gli amministratori delle società fallite erano indagati per concorso nell’indebita compensazione insieme ai beneficiari) .
Responsabilità dell’impresa o contribuente beneficiario (debitore originario): Chi ha usufruito della frode – ossia la società operativa o il contribuente che ha evitato di pagare tasse grazie ai crediti della fallita – da un lato è la “vittima” del raggiro (se era in buona fede, dovrà comunque pagare il dovuto una seconda volta), dall’altro potrebbe essere considerato corresponsabile se ha volontariamente partecipato. Molto dipende dalla consapevolezza: in alcuni casi questi soggetti sapevano bene di aderire a uno schema illegale (allora c’è dolo e concorso nel reato); in altri casi sono stati ingenuamente convinti che fosse tutto regolare. Civilisticamente, il Fisco non può pretendere da loro più di quanto dovuto (cioè devono pagare le imposte evase, con interessi e sanzioni), ma non può chiedere altri danni. Diverso è se emergono legami societari: spesso società fallite e società operative avevano amministratori comuni o soci collegati, il che indica un gruppo di fatto. In tal caso, la responsabilità morale e legale dei registi della frode è evidente e i vari soggetti giuridici possono essere considerati come una regia unitaria.
Ruolo dei professionisti terzi: Spesso in questi scenari compaiono professionisti (commercialisti, consulenti, avvocati) che hanno facilitato l’operazione – p.es. predisponendo contratti di accollo, apponendo visti di conformità falsi sui crediti, trasmettendo gli F24 “al buio”. Questi professionisti possono incorrere in sanzioni disciplinari (un commercialista che appone un visto infedele rischia sospensione e sanzioni dall’Ordine) e soprattutto in responsabilità penale per concorso. La Cassazione ha affermato che l’intermediario che materialmente invia gli F24 può essere corresponsabile se era consapevole del disegno criminoso . Anche chi assevera falsamente un credito (es. un revisore che certifica crediti inesistenti) commette reati (falso ideologico e concorso in frode fiscale). Dal lato del contribuente che si difende, eventualmente potrà rivalersi civilmente su tali professionisti con un’azione di responsabilità professionale per i danni arrecati (ad es. chiedere loro di pagare le sanzioni subite per loro colpa). Tuttavia, in pratica recuperare qualcosa è spesso difficile se il professionista è finito egli stesso nei guai (e potrebbe non avere assicurazione che copra atti dolosi).
In conclusione, l’utilizzo di società fallite nelle compensazioni indebite configura quasi sempre uno scenario fraudolento complesso, in cui più soggetti a vario titolo concorrono e dove alle responsabilità tributarie si sommano quelle civili e penali. Dal punto di vista di chi subisce l’accertamento (il debitore originario), la priorità è uscire dalle secche fiscali (sanando il debito ed evitando il tracollo economico per sanzioni) e difendersi in sede penale se chiamato in causa, eventualmente anche dimostrando di essere stato ingannato dagli ideatori dello schema. Il quadro civilistico rileva soprattutto per colpire i reali artefici: i curatori fallimentari e i giudici penali cercheranno di ricostruire i flussi finanziari e le decisioni gestionali per attribuire la responsabilità ultima a chi ha concepito la frode, al di là dello schermo societario.
Come avvengono i controlli: dal controllo automatizzato all’accertamento
Affrontiamo ora, in sequenza, il percorso attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate può accertare l’utilizzo indebito di crediti, specie in uno schema con società fallite. Capire questo iter è utile perché la strategia difensiva cambia a seconda della fase in cui ci si trova e dell’atto ricevuto . Possiamo distinguere varie fasi:
Controllo automatizzato (liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/1973)
Il controllo automatizzato è una verifica informatica ex lege che l’Agenzia compie su tutte le dichiarazioni e sui pagamenti F24. Attraverso le banche dati interne, il sistema incrocia i dati dichiarativi e di versamento del contribuente e cerca incongruenze. Un classico esempio: se nel modello F24 è indicato un codice tributo a credito che però non risulta da alcuna dichiarazione o comunicazione di quel contribuente, il sistema segnala l’anomalia. Oppure, se il contribuente ha un carico a ruolo oltre soglia che impedisce compensazioni (norma anti-compensazione in presenza di debiti > €1.500 iscritti a ruolo definitivi), il sistema blocca o avvisa. Nel contesto di crediti “importati” da società fallite, spesso queste compensazioni presentano indicatori anomali evidenti: ad es. il contribuente utilizza un codice tributo o un codice credito particolare (magari di un’agevolazione) che non compare nelle sue precedenti dichiarazioni. In questi casi, entro qualche mese dall’utilizzo in F24, l’Agenzia invia al contribuente una “comunicazione di irregolarità” (avviso bonario) segnalando l’uso di un credito non riconosciuto e calcolando le imposte dovute. Questa è la prima occasione per il contribuente di giustificare o regolarizzare: può rispondere fornendo elementi (se crede di avere ragione) oppure pagare con sanzioni ridotte (10% invece di 30%, se paga entro 30 giorni).
Nei casi di frode più sofisticata, però, è possibile che il controllo automatico non rilevi nulla immediatamente. Ad esempio, se la frode coinvolge la presentazione di una dichiarazione fraudolenta da parte della società fallita (con crediti inesistenti ma formalmente dichiarati e certificati), il sistema può vedere un credito dichiarato e un F24 che lo utilizza – e non segnalarlo come anomalo. Oppure, i frodatori potrebbero attendere l’esito della liquidazione formale di fine anno prima di usare i crediti, per evitare scarti. Questo significa che la frode passa il primo filtro.
In sintesi: se ricevete una comunicazione di irregolarità su una compensazione sospetta, siete ancora nella fase “semi-amichevole”. È il momento per correre ai ripari: se c’è stato un errore formale o un misunderstanding, si può chiarire ora. Se invece effettivamente avete usato un credito inesistente, ignorare l’avviso porterà all’iscrizione a ruolo e alla cartella.
Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973)
Il controllo formale è una fase successiva (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione) in cui l’Agenzia può chiedere al contribuente di esibire documenti giustificativi su alcune posizioni dichiarative . Per i crediti d’imposta, l’ufficio potrebbe ad esempio chiedere: “Gentile contribuente, ci fornisca la documentazione relativa al credito d’imposta XY utilizzato in compensazione, inclusi eventuali certificazioni, modelli o dichiarazioni integrative”. Questa richiesta viene fatta quando la questione non è risolvibile dai soli controlli automatici e c’è necessità di riscontri cartacei. Nel contesto dei crediti da società fallite, è raro che si passi per il controllo formale, perché di solito l’irregolarità è macroscopica (o rilevata dopo tramite verifica). Tuttavia, se ad esempio il contribuente sostiene di aver acquisito il credito in buona fede, potrebbe esibire in risposta i contratti di cessione (che però, lo ricordiamo, non avrebbero efficacia verso il Fisco se si tratta di crediti non cedibili). In generale, il controllo formale offre al contribuente la chance di spiegare e magari far rettificare l’ufficio se vi è un errore. Se il contribuente non risponde o la risposta non convince, si passa alla fase successiva.
Va detto che, dati i tempi stretti, spesso l’Agenzia salta questo step nei casi di frode e va direttamente all’accertamento.
Accertamento e atto di recupero: contestazioni sostanziali
Se la questione del credito è complessa, o l’importo è rilevante, l’Agenzia può bypassare le fasi automatiche/formali e procedere direttamente ad un accertamento sostanziale. Questo avviene tipicamente quando c’è stato un intervento della Guardia di Finanza o comunque un’attività investigativa che ha svelato un disegno fraudolento più ampio. Ad esempio, se la GdF svolge un controllo a monte sulla società fallita e scopre la creazione di crediti fittizi venduti a terzi, redigerà un Processo Verbale di Constatazione (PVC) dettagliato, che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate competente per i vari beneficiari. L’Agenzia, sulla base di quel PVC, manderà forse una lettera di compliance o direttamente emetterà un Avviso di accertamento verso ogni società che ha usato quei crediti, contestando l’indebita compensazione.
L’avviso di accertamento (o atto di recupero) notifica al contribuente il recupero delle somme compensate indebitamente, con allegata motivazione e calcolo di imposte, sanzioni, interessi. È a questo punto che il contribuente-debitore formalmente conosce l’addebito e può far valere le proprie difese dinanzi alla giustizia tributaria. Prima, eventuali comunicazioni bonarie non impugnabili gli avevano solo dato modo di regolarizzare. Adesso c’è un atto impugnabile entro 60 giorni alla Commissione (ora Corte) Tributaria.
Nei casi di società fallite, la motivazione dell’accertamento spesso menziona espressamente la fonte: ad es. “dall’ispezione della Guardia di Finanza (PVC n. …) è emerso che il credito IVA indicato è fittizio, in quanto la società Alfa srl (P.IVA…, fallita il …) che avrebbe ceduto detto credito aveva emesso fatture per operazioni inesistenti per €…; pertanto si recupera l’importo …”. Oppure: “il credito utilizzato non risulta spettante alla società in quanto generato su dichiarazione IVA di Beta srl (P.IVA…), fallita, per operazioni inesistenti. Si configura un utilizzo di credito inesistente ex art.13 co.5 D.Lgs.471/97.”.
È importante leggere con attenzione la motivazione per identificare punti attaccabili: per esempio, se l’ufficio dà per scontato che il contribuente fosse complice ma non lo prova, oppure se classifica come “frode” ciò che potrebbe essere solo un errore. Anche l’esattezza degli importi va verificata (magari contestano 100 ma in F24 erano 80, ecc.).
Cartella di pagamento ed esecuzione forzata
Se il contribuente non impugna l’atto impositivo, o se dopo averlo impugnato perde la causa e la decisione passa in giudicato, l’importo dovuto viene iscritto a ruolo e l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) emette la cartella di pagamento . La cartella ingiunge il pagamento di imposte, sanzioni e interessi (oltre agli aggi e spese di riscossione) entro 60 giorni, altrimenti si procederà ad esecuzione forzata (fermo amministrativo, ipoteche, pignoramenti).
In casi gravi come questi, è possibile che addirittura, in parallelo, la Procura della Repubblica abbia chiesto un sequestro preventivo per equivalente sul patrimonio del contribuente, allo scopo di assicurare la futura confisca fino a concorrenza del profitto del reato (cioè le imposte non versate). Ad esempio, nella citata Cass. 36383/2019 la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo per equivalente nei confronti del professionista coinvolto . Se ciò accade, il malcapitato potrebbe vedersi congelare i beni prima ancora che la cartella diventi definitiva, in ambito penale. Si troverebbe così stretto tra due fuochi: l’Agente che, finita la causa tributaria, spinge per riscuotere, e il giudice penale che blocca i beni per sicurezza.
È fondamentale, per un’azienda o persona che si ritrovi in queste vicende, gestire bene la fase della riscossione. Se vi è oggettiva impossibilità di pagare somme elevate, si possono valutare opzioni come la rateazione della cartella (fino a 6 anni o 10 anni in casi eccezionali) per evitare azioni esecutive asfissianti. Anche la nuova “composizione negoziata” della crisi d’impresa potrebbe essere un’idea se i debiti fiscali sono tali da mettere in crisi l’azienda. L’importante è non subire passivamente: muoversi per tempo con piani di rientro può fare la differenza tra la sopravvivenza e il fallimento (paradossalmente, quello effettivo questa volta) dell’azienda coinvolta.
Strategie difensive e consigli pratici per il contribuente
Dopo aver delineato normative e fasi del procedimento, focalizziamoci sul punto di vista del debitore/contribuente: cosa può fare attivamente per difendersi o per porre rimedio se gli viene contestato l’utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti in compensazione (magari tramite una società fallita)? Si tratta di predisporre una vera e propria strategia difensiva integrata, che tocchi aspetti tributari, procedurali e all’occorrenza penali. Vediamo i principali punti.
1. Prevenzione e compliance
La miglior difesa è evitare di trovarsi in torto. Se state valutando di utilizzare crediti d’imposta in compensazione, specialmente se di importo significativo:
- Verificate attentamente i requisiti prima di compensare. Assicuratevi che il credito esista e vi spetti: ad esempio, se è un credito da agevolazione, controllate di avere tutta la documentazione e di aver rispettato le condizioni. Se è un credito da dichiarazione IVA (tipo eccedenza a credito), verificate di aver presentato la dichiarazione e che il credito sia riportato correttamente.
- Diffidate di scorciatoie o offerte di terzi: se qualcuno vi propone di “acquistare” crediti fiscali di dubbia provenienza o di farvi compensare debiti tramite altre società, nella quasi totalità dei casi è illegale o pericoloso. Le uniche cessioni di crediti legittime sono quelle previste espressamente dalla legge (es. cessione di crediti da bonus edilizi su piattaforma dell’Agenzia). Qualunque altra forma di mercato dei crediti tributari non è riconosciuta e vi espone a gravi rischi.
- Tenete traccia formale dei crediti: ad esempio, se avete un credito da rinuncia a rimborso (caso tipico: avete chiesto rimborso IVA e poi decidete di usare il credito in compensazione), assicuratevi di protocollare la rinuncia e ottenere riscontri. Se è un credito da interpello o da rettifica, conservate tutte le pezze giustificative.
In sostanza, una condotta fiscale improntata alla compliance riduce la probabilità di contestazioni o, se avvengono, vi mette in posizione di forza perché avete le carte in regola.
2. Atteggiamento collaborativo durante i controlli
Se arriva una richiesta di chiarimenti o una comunicazione bonaria dall’Agenzia, non ignoratela. È comprensibile farsi prendere dall’ansia, ma la cosa peggiore è far finta di nulla. Invece:
- Rispondete prontamente, magari con l’ausilio del vostro commercialista o avvocato. Fornite spiegazioni e documenti. Questo spesso può convincere l’ufficio a soprassedere o a ricalcolare correttamente.
- Chiedete un incontro (anche da remoto) con i funzionari, se necessario, per discutere il caso. Mostrare disponibilità e trasparenza gioca a vostro favore. A volte, se l’errore è banale, l’ufficio vi guiderà su come regolarizzarlo tramite ravvedimento evitando sanzioni pesanti.
- Se vi accorgete di un errore vero (ad es. avete usato un credito in buona fede ma scoprite di aver sbagliato), valutate il ravvedimento operoso immediato. Pagare spontaneamente prima dell’accertamento riduce molto le sanzioni e toglie spazio al penale per importi sotto soglia. Certo, significa tirare fuori soldi – ma meglio una piccola sanzione ora che una enorme dopo.
Ricordate che l’Agenzia privilegia la fase bonaria perché consente di incassare più rapidamente e con meno contenziosi. Dunque, se possibile, risolvete la questione prima che diventi un avviso di accertamento.
3. Derubricazione da “inesistente” a “non spettante”
Questa è diventata la parola d’ordine nelle difese dei casi complessi (es. crediti R&S contestati, crediti da bonus) . Significa impostare la difesa in modo da escludere che il credito sia considerato totalmente fittizio e farlo rientrare nella categoria, meno infamante, dei crediti non spettanti.
Come fare? Occorre dimostrare almeno in parte la sostanza economica del credito. Ad esempio, se vi contestano un credito R&S affermando che il progetto non era innovativo (cercando quindi di farlo passare per credito inesistente), voi dovete portare elementi che provano che qualche attività di ricerca c’è stata: presentate perizie tecniche, relazione di un professore universitario che attesta la parziale ricerca, mail e documenti di lavoro… così potete convincere la Corte che il credito derivava da spese reali, solo non qualificate correttamente, e quindi semmai è non spettante ma non inventato.
Analogamente, se il Fisco dice che il vostro credito d’imposta investimenti Sud è inesistente perché l’azienda non aveva i requisiti, voi potete evidenziare che l’investimento c’è stato davvero (macchinari acquistati, pagamenti effettuati) e che la questione è interpretativa su un requisito soggettivo. Questo orienterà il giudice a sanzionarvi come errore non come frode.
La differenza di esito è enorme: non spettante può voler dire annullamento totale se l’accertamento è tardivo di oltre 5 anni, oppure comunque sanzione 25% (magari ridotta ulteriormente) . Inesistente mantiene 8 anni e sanzioni 70-140%. Inoltre in ambito penale, se riuscite a far qualificare il fatto come non spettante, uscite dalla fattispecie più grave (commi 1 e 2 art.10-quater fanno questa distinzione).
Ovviamente, non sempre è possibile: se effettivamente avete usato un credito del tutto inventato e non avete straccio di prova reale, questa strategia non regge. In casi borderline però spesso fa la differenza. Le Sezioni Unite 2023 e la nuova legge 2024 vi vengono incontro in questo, perché l’orientamento attuale è di non chiamare “inesistente” ciò che può essere letto come “irregolare”.
4. Autotutela e strumenti deflativi
Non sottovalutate l’autotutela: se avete argomenti forti (documenti non considerati, errori macroscopici dell’ufficio), anche dopo aver ricevuto un avviso di accertamento potete presentare un’istanza di autotutela all’ufficio chiedendo l’annullamento o la rettifica dell’atto. L’autotutela non sospende i termini di ricorso (che vanno rispettati comunque), ma a volte l’Agenzia, valutati i vostri argomenti, potrebbe annullare in via di autotutela l’atto se effettivamente sbagliato (succede di rado in questi casi complessi, ma tentar non nuoce).
In parallelo, potete valutare strumenti deflativi come l’accertamento con adesione: una procedura che sospende i termini di ricorso e apre un dialogo con l’ufficio per trovare un accordo. Nelle indebite compensazioni, l’adesione potrebbe consistere nel riconoscervi magari una parte del credito come spettante e ridurre sanzioni sul resto. Ad esempio, se contestavano 100 di credito, in sede di adesione potrebbero accordarsi per ridurre l’imponibile a 60 (riconoscendovi 40) e applicare sanzione 25% su 60 ridotta a 1/3 per adesione, con pagamento rateale. È una possibilità da considerare se non avete probabilità altissime di vittoria totale in giudizio e volete limitare i danni.
Altri strumenti: la conciliazione giudiziale (in primo o secondo grado) consente esiti simili all’adesione ma davanti al giudice. Con la conciliazione, oltre alle sanzioni ridotte, ottenete il dimezzamento delle eventuali sanzioni penali accessorie (che tuttavia in questi casi non sono previste, a meno di frodi particolari).
5. Coordinamento con la difesa penale
Se il vostro caso rischia di avere rilevanza penale (importi grandi, elementi di frode conclamata), consultate subito anche un avvocato penalista di fiducia . La strategia tributaria e quella penale devono procedere allineate. Ad esempio:
- Se decidete di pagare tutto per chiudere il penale (nei casi non spettanti), fatelo nei tempi giusti e comunicate all’autorità giudiziaria l’avvenuto pagamento per ottenere l’archiviazione.
- State attenti alle dichiarazioni: tutto ciò che sostenete in sede di accertamento può essere utilizzato (di solito a vostro vantaggio, ma anche contro di voi) nel penale. Se in ricorso tributario affermate “sapevo che il credito era di un’altra società ma pensavo fosse cedibile”, ammettete di sapere: questo in sede penale è quasi un’ammissione di dolo. Magari nel tributario vi giova per non pagare il 140%, ma nel penale vi condanna. Occorre valutare con avvocati come impostare le memorie difensive in modo coerente.
- Chiedete eventualmente la sospensione del processo tributario in attesa dell’esito penale, o viceversa. La legge consente di sospendere il processo tributario se pende un processo penale su fatti rilevanti (art. 6, c.5 D.Lgs. 546/92), quando la decisione penale potrebbe influenzare quella tributaria. Questo può darvi tempo e evitare contraddizioni di giudicati.
- Valutate il patteggiamento penale se non avete via di scampo: chiudere il penale rapidamente riduce l’esposizione mediatica e vi fa concentrare sul tributario. Il patteggiamento però implica riconoscere la colpevolezza, attenzione agli effetti civili (ma nel tributario in teoria vale il principio d’indipendenza dei giudizi, quindi l’accertamento tributario può andare avanti a prescindere dal patteggiamento).
In pratica, una difesa integrata è essenziale nei casi più seri. Molti studi legali tributari collaborano con penalisti proprio per gestire entrambi gli aspetti.
6. Esempi pratici di difesa
Per rendere concreti i concetti, passiamo in rassegna alcuni scenari tipici con indicazione di possibili difese:
- Caso credito IVA inesistente (frode pura): Un imprenditore ha utilizzato in compensazione un ingente credito IVA risultato fittizio (ad esempio, ottenuto emettendo fatture false mediante una società cartiera fallita). Difesa: Siamo di fronte a un caso difficile. Se l’imprenditore era consapevole, la difesa sul merito tributario è debole; può però tentare di dimostrare che credeva il credito provenisse da operazioni reali, oppure che si trattava di un errore contabile e non di frode deliberata . Ad esempio, magari c’erano crediti IVA da anni precedenti non dichiarati correttamente, e lui pensa di averli usati. Se riesce a sostenere ciò con un minimo di pezze d’appoggio, potrebbe ottenere di trattarlo come non spettante da errore invece che frode. In caso contrario (frode evidente), la strada migliore è negoziare una definizione agevolata in sede amministrativa: pagare tutto subito, magari ottenendo sanzioni al minimo ed evitando il contenzioso, così da contenere almeno le conseguenze penali . Sul piano penale, se l’importo è sopra soglia dovrà patteggiare o affrontare un processo per indebita compensazione aggravata.
- Caso credito R&S contestato (requisiti non rispettati): Una società ha usufruito di €100.000 di credito ricerca & sviluppo nel 2018. Nel 2023 l’Agenzia glielo contesta sostenendo che il progetto non era vera “ricerca ammissibile” (magari invocando criteri del Manuale di Frascati). Difesa: Questo è un caso frequentissimo negli ultimi anni. La società dovrebbe fornire una robusta difesa tecnica: ad esempio presentare la certificazione di un ente terzo o di un esperto che attesti la natura R&S del progetto . Poi sottolineare aspetti giuridici: nel 2018 il Manuale di Frascati non era nemmeno richiamato esplicitamente in norma, quindi non può essere usato retroattivamente come parametro vincolante . Far presente, citando Cass. SS.UU. 2023, che anche se l’attività fosse ritenuta non innovativa, si tratterebbe di credito non spettante ma non inesistente (perché spese effettivamente sostenute, solo non qualificabili come R&S) . Quindi chiedere al giudice tributario di annullare l’atto per decadenza (spesso questi atti arrivano dopo 5 anni e se è non spettante sono fuori tempo) o almeno di ridurre la sanzione al 25% . Spesso, in casi analoghi, i contribuenti stanno avendo successo totale o parziale con questa difesa, portando a nulla le pretese del Fisco o quantomeno declassandole a violazioni minori.
- Caso bonus edilizio ceduto, usato indebitamente da cessionario: Nel 2024, una banca compensa crediti da Superbonus edilizio per €60.000 per pagare contributi INPS, ma ciò è vietato dal D.L. 11/2023 (che consente l’uso dei bonus edilizi solo per imposte erariali, non per contributi). L’INPS segnala la cosa. L’Agenzia contesta nel 2025 il credito come non spettante (violazione delle modalità d’uso) . Difesa: Qui effettivamente il credito c’era ma la banca non poteva usarlo in quel modo. È un caso textbook di credito non spettante. La banca difficilmente può farlo passare per inesistente (non le conviene neanche, anzi vuole far vedere che il credito edilizio è reale). Quindi meglio pagare con sanzione 25% ridotta e chiudere la partita . Se per ipotesi l’accertamento fosse arrivato tardivamente, la banca potrebbe sostenere la decadenza del termine quinquennale (ma in questo caso è arrivato l’anno dopo, quindi no).
- Caso errore formale su credito spettante: Un contribuente presenta la dichiarazione dei redditi con un credito d’imposta 2024 ma dimentica di inviare una comunicazione telematica richiesta dalla norma entro il 31/12. L’uso del credito viene contestato nel 2026 come “non spettante” (per difetto di adempimento formale). Però il contribuente, accortosi a fine 2025, aveva presentato in ritardo la comunicazione e corretto l’errore entro la dichiarazione successiva. Difesa: Qui siamo proprio nel campo dell’art. 13 comma 4-ter D.Lgs. 471/97. Si invoca l’applicazione della sanzione fissa di €250 invece del 25% . Probabilmente l’ufficio stesso l’avrà applicata se ha riconosciuto la correzione; ma se per caso ha irrogato 25%, si chiede al giudice di ricondurre la sanzione a €250 . Inoltre si evidenzia che non c’è alcun danno erariale perché il credito era spettante al netto del formalismo ormai adempiuto . È un caso in cui il contribuente dovrebbe vincere agevolmente.
- Caso crediti acquistati da terzi (frode carosello): Un’azienda acquista crediti fiscali (ad esempio crediti d’imposta locazione COVID) da altre aziende tramite una piattaforma online poco trasparente, e li compensa. Poi emerge che quei crediti originari erano fittizi, frutto di frodi a monte (es. crediti fittizi generati con “caroselli” di false locazioni). L’Agenzia contesta all’azienda l’utilizzo di credito inesistente con frode. Difesa: L’azienda acquirente può cercare di dimostrare la propria buona fede: ad esempio, che ha pagato quei crediti su una piattaforma credendo fossero validi, che non conosceva i cedenti e non era complice . L’obiettivo qui è almeno evitare l’accusa di frode deliberata: se riesce a convincere che non c’era dolo, potrebbe sostenere che la super-sanzione al 140% non va applicata perché le “rappresentazioni fraudolente” non sono opera sua, e chiedere la riduzione al 70% (trattandola come condotta colposa) . Questo terreno è scivoloso: difficilmente l’ufficio rinuncerà alla sanzione aggravata, ma in sede penale almeno potrebbe servire a evitare il concorso in frode (dimostrando di non aver avuto intenzione di evadere, riducendo eventualmente il reato a un caso di colpa non punibile, anche se nei reati tributari il dolo è richiesto). Sul piano tributario, comunque, il credito è inesistente e va restituito: su quello non c’è scampo; si può solo mitigare la sanzione e puntare ad evitare guai penali dimostrando la mancanza di dolo .
Ogni caso concreto ha le sue particolarità, ma questi esempi mostrano l’applicazione pratica dei concetti discussi. In particolare, evidenziano come la linea di difesa debba adattarsi al tipo di credito e di violazione contestata: da una difesa sul fatto (es. provare che le operazioni c’erano) a una difesa sulla qualificazione giuridica (es. far rientrare nel non spettante) o sull’elemento soggettivo (buona fede vs dolo).
Domande frequenti (FAQ)
Per chiarire ulteriormente l’argomento, ecco alcune domande e risposte comuni relative alla difesa da contestazioni di crediti indebiti in compensazione:
- Domanda: Che differenza c’è, in sintesi, tra un credito “non spettante” e uno “inesistente”?
Risposta: Un credito non spettante è un credito teoricamente esistente ma di cui si è fruito indebitamente (perché non si aveva diritto, o oltre il limite, o senza seguire le regole). Un credito inesistente, invece, è un credito che in realtà non ha fondamento: manca il presupposto economico-giuridico o è frutto di un artificio/frode. In pratica, il credito non spettante è un uso scorretto di un credito vero, il credito inesistente è un credito “falso”. La distinzione comporta sanzioni e tempi diversi: ~25% di sanzione e 5 anni di accertabilità per il non spettante; 70% (o più, se fraudolento) e 8 anni (o più) per l’inesistente . - Domanda: L’Agenzia delle Entrate può scoprire subito se un credito è inesistente?
Risposta: Dipende. Molte anomalie evidenti vengono scoperte tramite i controlli automatizzati sul modello F24 o sulla dichiarazione annuale. Se il sistema incrociando i dati vede, ad esempio, che un credito utilizzato non risulta da alcuna dichiarazione o comunicazione nota, segnala l’irregolarità nel giro di pochi mesi dall’utilizzo, e l’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità (ad esempio, uso di credito senza aver presentato dichiarazione) . Tuttavia, crediti inesistenti costruiti con astuzia – ad esempio supportati da documenti falsi apparentemente regolari – possono sfuggire al controllo automatico e venire scoperti solo con controlli mirati o verifiche successive . In generale, comunque, l’Amministrazione finanziaria è diventata più efficiente nell’individuare subito le compensazioni anomale, specie dopo che dal 2019 i modelli F24 con compensazioni sopra certe soglie devono transitare obbligatoriamente per i canali telematici Entratel e possono essere scartati se palesemente irregolari . Se il controllo automatico non vede l’anomalia, resta la possibilità di controlli in sede di liquidazione della dichiarazione annuale o verifiche sul campo (spesso svolte dalla Guardia di Finanza). - Domanda: Ho utilizzato un credito fiscale acquistato da una società che poi è fallita. Posso difendermi dicendo che ero in buona fede?
Risposta: La buona fede purtroppo non evita il recupero del credito: se il credito non era realmente spettante a voi, dovrete comunque restituirlo col dovuto. Tuttavia, la buona fede può essere un argomento per ridurre le sanzioni (chiedendo magari la disapplicazione dell’aggravante per frode, come visto) e soprattutto per evitare sanzioni penali. Se dimostrate che avete fatto verifiche ragionevoli e siete stati ingannati, potreste evitare di essere incriminati per il reato di indebita compensazione, mancando il dolo. In ogni caso, dovrete rivalervi eventualmente su chi vi ha venduto il credito (ma se è fallito, sarà difficile recuperare qualcosa). La lezione è sempre di fare estrema attenzione prima di “comprare” crediti fiscali: controllare l’origine, usare piattaforme ufficiali (come cessione crediti sulla piattaforma ADE per bonus edilizi) ed evitare scorciatoie. - Domanda: Se una società fallisce dopo aver ceduto dei crediti d’imposta poi risultati falsi, l’Agenzia può chiedere conto a qualcuno?
Risposta: L’Agenzia delle Entrate recupererà l’indebito utilizzo presso chi ha usato in compensazione quei crediti (il soggetto che li ha compensati nel modello F24). Non potendo più colpire la società fallita (che non esiste più se non come massa fallimentare), il Fisco si concentra sul beneficiario finale. Tuttavia, il Curatore fallimentare della società potrebbe intraprendere azioni di responsabilità verso gli amministratori della fallita per le frodi commesse. E in sede penale, gli amministratori e complici (es. professionisti) della società fallita potranno essere perseguiti. Quindi, se la domanda è: il Fisco può chiedere i soldi ai soci/amministratori della società fallita? Direttamente sul piano tributario, no (i soci di capitali non rispondono dei debiti sociali se non in casi eccezionali come liquidazione volontaria con attivo distribuito ignorando il Fisco). Ma indirettamente, attraverso le vie penali e civilistiche del fallimento, quei soggetti potranno essere chiamati a rispondere dei loro atti illeciti. - Domanda: Quali documenti devo predisporre per difendermi efficacemente se vengo accusato di aver usato crediti indebiti?
Risposta: Dovreste raccogliere tutti i documenti che provano l’esistenza e la spettanza del credito. Ad esempio : le dichiarazioni fiscali da cui il credito emerge (dichiarazioni IVA, UNICO, ecc.), le ricevute di versamenti che hanno generato il credito (es. F24 con doppio versamento poi chiesto a credito), eventuali certificazioni o visti di conformità ottenuti, la documentazione contabile delle operazioni sottostanti (fatture, contratti, estratti conto bancari che provano il pagamento di quelle spese). Se il credito deriva da una norma agevolativa: copia della norma, eventuali circolari esplicative, vostra istanza di interpello se fatta, risposta dell’Agenzia se c’è stata. Insomma, bisogna costruire il dossier che dimostri che quel credito era legittimo. Se ciò non è possibile perché il credito era fittizio, concentratevi su documenti che mostrino almeno la vostra buona fede: ad esempio il contratto di cessione del credito con la controparte, corrispondenza avuta dove loro garantivano la validità, ecc., per mostrare che siete stati tratti in inganno. - Domanda: In caso di contestazione, è utile far effettuare perizie tecniche (es. da parte di esperti indipendenti) sui crediti?
Risposta: Sì, può essere molto utile. Specie per crediti di natura tecnica (R&S, Industria 4.0, ecc.), presentare una perizia giurata di un esperto che supporti la vostra tesi può avere un impatto significativo in giudizio. Anche per crediti IVA, se la questione è capire se c’erano operazioni reali, una perizia contabile o revisione indipendente può aiutare. Naturalmente, la perizia deve essere credibile e preferibilmente redatta da un soggetto terzo qualificato. Non sostituisce le prove documentali, ma le integra dando un parere pro veritate che il giudice può considerare. Ricordate che però la perizia stragiudiziale non è vincolante per il giudice: verrà valutata come elemento di prova liberamente. - Domanda: Se ho già subito un accertamento su crediti indebiti e ho perso in primo grado, c’è speranza in appello o in Cassazione?
Risposta: Dipende dalle motivazioni della sentenza di primo grado. La materia è in evoluzione: ci sono state sentenze di Commissioni Tributarie non allineate alla Cassazione, specialmente prima delle SU 2023. Se ritenete che i giudici di primo grado non abbiano applicato correttamente la distinzione tra non spettante/inesistente, oppure non abbiano considerato qualche prova, sicuramente fare appello ha senso. In secondo grado potreste ottenere una riforma (ci sono stati casi di vittorie dei contribuenti in appello su R&S dopo sconfitte in primo grado, ad esempio). In Cassazione, ora che c’è la pronuncia delle Sezioni Unite, le chance dipendono dall’allineamento o meno della sentenza di secondo grado a quei principi: se il secondo grado ha ignorato i principi delle SU o la nuova normativa, la Cassazione potrà cassare la decisione. Valutate con il legale i costi/benefici: a volte fare appello serve anche solo a transare meglio (magari nel frattempo esce una definizione agevolata liti pendenti). Tenete d’occhio, appunto, possibili sanatorie fiscali: nel 2023 ce n’era una per le liti fino a certi gradi, in futuro potrebbero essercene altre; definire la lite pagando qualcosa potrebbe essere più conveniente che attendere la Cassazione. - Domanda: Dopo la contestazione di crediti indebiti, la mia azienda è a rischio di verifica generale o altri problemi (es. revoca di agevolazioni)?
Risposta: È possibile che diventi un “sorvegliato speciale”. L’Agenzia spesso, quando scopre frodi di crediti, inserisce il contribuente in liste di controlli per il futuro (ad esempio, se avete un credito ancora da utilizzare negli anni seguenti, probabilmente lo controlleranno con più attenzione). Se il caso è eclatante, può scattare anche la segnalazione alla Guardia di Finanza per ulteriori indagini, o ad altri enti (ad esempio se i crediti erano contributivi, l’INPS intensificherà i controlli su di voi). Potrebbero inoltre esservi ripercussioni reputazionali: ad esempio, se partecipate a bandi pubblici o gare, una contestazione di frode fiscale potrebbe incidere sui requisiti di onorabilità. Non ultimo, se facevate parte di un gruppo IVA o consolidato fiscale, gli effetti potrebbero riflettersi sui controlli di gruppo. In generale, è bene dopo un episodio del genere ricostruire la propria compliance: magari richiedere una “tax compliance check” da parte di un professionista, implementare sistemi interni di controllo fiscale per dimostrare discontinuità col passato.
Conclusioni
Difendersi efficacemente da un’accusa di utilizzo di crediti inesistenti in compensazione richiede un’approfondita conoscenza sia delle normative tributarie sia degli strumenti giuridici a disposizione. Abbiamo visto come, specialmente in casi che coinvolgono società fallite e schemi fraudolenti, il contribuente debba destreggiarsi tra distinzioni sottili (credito non spettante vs inesistente), procedure multiple (tributarie e penali) e coinvolgimento di diversi attori (Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Curatori fallimentari, Procura). Il punto di vista del debitore è inevitabilmente quello di chi deve dimostrare la propria buona fede e la correttezza – per quanto possibile – del proprio operato, oppure, in mancanza, contenere i danni di una condotta irregolare.
I punti chiave da portare via sono:
- Preparazione e prevenzione: evitare scorciatoie fiscali e vagliare ogni utilizzo di crediti con occhio critico è la prima linea di difesa. Le società fallite e i crediti “miracolosi” che offrono sono campanelli d’allarme di cui diffidare.
- Conoscenza delle regole del gioco: sapere come l’Amministrazione ragiona (controlli automatici, formali, accertamenti) consente di non farsi cogliere di sorpresa e di reagire per tempo (ad es. sfruttando ravvedimenti o adesioni).
- Chiarezza sulla natura del credito contestato: ogni elemento va orientato per far emergere, se possibile, che il credito non era frutto di invenzione fraudolenta ma di un fraintendimento o errore. Ciò può salvare dall’accusa penale più grave e ridurre nettamente sanzioni e termini.
- Documentazione e argomentazioni solide: in tribunale tributario vince chi porta prove. Non bastano dichiarazioni generiche di buona fede: servono documenti, perizie, riferimenti a circolari, giurisprudenza (come quella recente di Cassazione) per sostenere le proprie ragioni .
- Approccio proattivo: il contribuente non deve subire passivamente l’azione fiscale. Ha strumenti per interloquire (istanze, adesione, autotutela) e per negoziare soluzioni. Spesso mostrare collaborazione (senza arrendevolezza) porta a esiti migliori che fare muro contro muro.
- Coordinamento legale globale: se il caso sconfina nel penale o in ambito fallimentare, è indispensabile che i vari professionisti (tributarista, penalista, civilista) lavorino in sinergia, per evitare passi falsi e per cogliere ogni opportunità (ad es. pagamento entro termini per estinguere il reato, azioni di rivalsa in fallimento, ecc.).
In definitiva, la materia – pur complessa – offre spiragli di difesa anche in situazioni che paiono disperate. Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali hanno anzi rafforzato le tutele per i contribuenti in buona fede, distinguendoli dai frodatori incalliti e uniformando il regime sanzionatorio in modo più equo. Chi ha realmente tentato di truffare l’Erario usando società fantasma e crediti fake troverà oggi terreno meno fertile: per loro, l’inasprimento di certe sanzioni (sul piano penale e amministrativo aggravato) è un segnale chiaro. Ma chi si è trovato coinvolto magari marginalmente, o per errore, ha ora più appigli per uscire dal tritacarne fiscale con conseguenze sostenibili.
Come sempre, aggiornarsi continuamente è cruciale: normative come il D.Lgs. 87/2024 dimostrano che lo scenario può cambiare (in meglio o in peggio). Questa guida, aggiornata ad agosto 2025, ha integrato le ultime novità note; tuttavia, vista la materia in evoluzione, il consiglio finale è di monitorare eventuali ulteriori sviluppi (sentenze di merito, prassi dell’Agenzia, modifiche normative magari introdotte dalla delega fiscale in corso).
In conclusione, “come difendersi” da un’accusa di indebita compensazione tramite società fallite significa conoscere il proprio nemico (l’accertamento fiscale) e le proprie armi (difensive): solo così si può impostare la migliore strategia per tutelare i propri diritti e, auspicabilmente, uscire dalla vicenda con il minor danno possibile e una preziosa lezione per il futuro.
Fonti:
- D.Lgs. 471/1997, art. 13 (sanzioni su omesso versamento e indebita compensazione)
- D.Lgs. 74/2000, art. 10-quater (reato di indebita compensazione di crediti non spettanti/inesistenti)
- Cass., Sez. Un. civ., 11/12/2023 n. 34419 (distinzione crediti inesistenti vs non spettanti)
- Cass., Sez. III pen., 28/05/2025 n. 19868 (applicazione retroattiva definizioni favorevoli di credito non spettante)
- Cass., Sez. Trib., 16/02/2025 n. 3930 (illegittimità dell’accollo fiscale con compensazione di crediti altrui)
- Cass., Sez. III pen., 23/08/2019 n. 36383 (conferma sequestro per compensazioni fittizie con società fallite accollanti)
- Circ. Agenzia Entrate n. 16/E del 28/06/2024 (commento alle novità sanzionatorie introdotte da D.Lgs. 87/2024)
- Cass., sez. trib., 16 febbraio 2025, n.3930
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36383 depositata il 23 agosto 2019 – E’ legittimo il sequestro preventivo per equivalente nei confronti del professionista abilitato alla trasmissione dei modelli F24 a saldo zero che, utilizzando in compensazione crediti Iva inesistenti e falsamente asseverati da altro professionista
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestato l’utilizzo di società fallite per effettuare compensazioni fiscali? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestato l’utilizzo di società fallite per effettuare compensazioni fiscali?
Vuoi sapere cosa rischi e come puoi difenderti da queste contestazioni?
Alcuni soggetti, per ridurre i propri debiti fiscali, utilizzano crediti fiscali derivanti da società fallite o inattive, spesso considerati inesistenti o non utilizzabili. L’Agenzia delle Entrate, in questi casi, può contestare l’indebita compensazione e riqualificare l’operazione come frode fiscale.
👉 Prima regola: dimostra la reale esistenza e legittimità dei crediti compensati, nonché la buona fede del loro utilizzo.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Crediti fiscali utilizzati in compensazione provenienti da società dichiarate fallite;
- Operazioni infragruppo con trasferimento di crediti non validi;
- Società di comodo o cartiere usate per generare crediti inesistenti;
- Mancanza di documentazione che provi la spettanza del credito;
- Anomalie nei flussi di compensazione rilevate dai controlli automatici (modelli F24).
📌 Conseguenze della contestazione
- Disconoscimento della compensazione e recupero delle somme non versate;
- Sanzioni dal 100% al 200% dell’importo indebitamente compensato;
- Interessi di mora;
- Rischio di contestazioni penali per indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- Responsabilità patrimoniale solidale degli amministratori e dei soci coinvolti.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Origine del credito compensato: era realmente esistente e spettante?
- Data di insorgenza del credito: è anteriore alla dichiarazione di fallimento della società cedente?
- Documentazione fiscale e contabile: fatture, dichiarazioni e registrazioni;
- Modalità di acquisizione del credito: è stata regolare e tracciata?
- Motivazione della contestazione: l’Agenzia si basa su prove concrete o su presunzioni?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Dichiarazioni fiscali da cui emerge il credito;
- Certificazioni rilasciate dalla società fallita o dai curatori;
- Contratti di cessione del credito;
- Estratti conto fiscali e modelli F24 di compensazione;
- Comunicazioni ufficiali con l’Agenzia delle Entrate.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare l’esistenza reale del credito e la sua spettanza;
- Contestare la riqualificazione come credito inesistente se vi erano elementi di buona fede;
- Chiarire la regolarità delle compensazioni e la tracciabilità delle operazioni;
- Eccepire vizi dell’accertamento: motivazione insufficiente, errori di calcolo, decadenza;
- Richiedere autotutela se la documentazione era già agli atti;
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni;
- Difesa penale mirata in caso di contestazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza i crediti compensati e la loro origine;
📌 Verifica la legittimità della contestazione e la fondatezza dei rilievi fiscali;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti assiste in giudizio e, se necessario, nei procedimenti penali collegati;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione sicura e conforme delle compensazioni fiscali.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in compensazioni fiscali e crediti tributari;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni su utilizzo di crediti inesistenti o da società fallite;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’uso di società fallite per compensazioni fiscali non sempre sono fondate: spesso si basano su presunzioni o errori di valutazione.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la reale esistenza e validità dei crediti, evitare la riqualificazione come indebita compensazione e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti sulle compensazioni fiscali inizia qui.