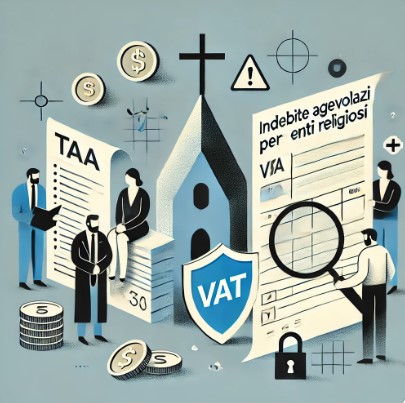Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché alcune operazioni dell’ente religioso sono state considerate fruite con indebite agevolazioni IVA? In questi casi, l’Ufficio presume che l’ente abbia applicato regimi fiscali di favore senza averne i requisiti previsti dalla normativa. La conseguenza è il recupero dell’imposta, con applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è corretta: vi sono strumenti difensivi per dimostrare la legittima applicazione delle agevolazioni.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta le agevolazioni IVA agli enti religiosi
– Se le operazioni agevolate non riguardano attività istituzionali di culto, assistenza o beneficenza
– Se i beni o servizi acquistati con IVA ridotta sono stati utilizzati per attività commerciali
– Se la documentazione fiscale è incompleta o non conforme alle prescrizioni di legge
– Se vi sono incongruenze tra le dichiarazioni fiscali e i dati reali dell’ente
– Se l’Ufficio ritiene che l’ente sia stato usato come “schermo” per attività non religiose
Conseguenze della contestazione
– Recupero dell’IVA non versata sulle operazioni contestate
– Applicazione di sanzioni per dichiarazione infedele o indebita detrazione
– Interessi di mora sulle somme accertate
– Limitazioni future nell’accesso alle agevolazioni fiscali
– Rischio di contestazioni anche per altre imposte collegate alle attività dell’ente
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare con documentazione idonea la natura istituzionale e religiosa delle attività
– Produrre bilanci, registri contabili e atti ufficiali che giustifichino l’applicazione delle agevolazioni
– Contestare la riqualificazione come attività commerciale se le operazioni erano finalizzate a scopi religiosi o assistenziali
– Evidenziare errori di calcolo, vizi di motivazione o difetti di istruttoria nell’accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa fiscale
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la documentazione fiscale e statutaria dell’ente religioso
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta applicazione della normativa IVA
– Redigere un ricorso fondato su prove concrete e vizi formali dell’accertamento
– Difendere l’ente davanti ai giudici tributari contro richieste fiscali indebite
– Tutelare il patrimonio dell’ente e le sue finalità istituzionali da conseguenze sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione o eliminazione di sanzioni e interessi non dovuti
– Il riconoscimento del diritto dell’ente ad applicare le agevolazioni IVA
– La sospensione delle richieste di pagamento già avviate
– La certezza di poter continuare a svolgere le attività religiose e assistenziali senza indebite pressioni fiscali
⚠️ Attenzione: le contestazioni sulle agevolazioni IVA per enti religiosi devono essere impugnate entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se non si agisce per tempo, la pretesa diventa definitiva.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e enti non profit – spiega come difendersi in caso di contestazioni su indebite agevolazioni IVA per enti religiosi e come tutelare i tuoi diritti.
👉 Il tuo ente religioso ha ricevuto una contestazione per agevolazioni IVA ritenute indebite? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo l’atto, confronteremo i dati contestati con le attività reali dell’ente e costruiremo la strategia difensiva più efficace per proteggere i tuoi interessi.
Introduzione
L’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni ha intensificato i controlli sugli enti religiosi (come parrocchie, diocesi, congregazioni e associazioni di culto) che beneficiano di agevolazioni fiscali, in particolare in materia di IVA. Spesso viene contestato l’uso indebito di esenzioni o aliquote IVA agevolate, con la notifica di avvisi di accertamento per recuperare l’imposta ritenuta dovuta e relative sanzioni. Dal punto di vista del contribuente (ente religioso), è fondamentale comprendere quali attività sono effettivamente esenti o non imponibili per legge e come difendersi qualora il Fisco contesti un trattamento fiscale agevolato ritenuto illegittimo. In questa guida affronteremo la normativa IVA italiana (aggiornata ad agosto 2025), gli strumenti di difesa nel contenzioso tributario e la più recente giurisprudenza (italiana ed europea) in materia, con un taglio avanzato ma dal linguaggio chiaro e divulgativo. Troverete tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti e alcune simulazioni pratiche di casi tipici, per offrire un orientamento completo a avvocati, privati e imprenditori che interagiscono con enti religiosi. L’obiettivo è fornire, dal punto di vista dell’ente debitore, gli strumenti per riconoscere le agevolazioni IVA legittime e impostare una difesa efficace contro eventuali accertamenti fiscali.
Quadro Normativo: IVA e Enti Religiosi
Prima di esaminare come difendersi da un accertamento, occorre chiarire il quadro normativo in cui si muovono gli enti religiosi riguardo all’IVA. In Italia l’IVA è disciplinata dal D.P.R. 633/1972 (“Decreto IVA”), integrato dalla normativa UE (Direttiva 2006/112/CE). Gli enti religiosi, in quanto enti non commerciali, godono di alcune previsioni particolari nel Decreto IVA, in primis l’art. 4 comma 4, che fino alle recenti modifiche escludeva dal campo IVA certe operazioni svolte in ambito associativo istituzionale. Tale norma (c.d. “decommercializzazione” IVA) stabiliva che non costituiscono attività commerciali – e quindi non sono soggette a IVA – le prestazioni di beni e servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da enti associativi, compresi quelli religiosi, a beneficio di associati o partecipanti . In sostanza, quote e servizi resi ai membri di associazioni religiose, culturali, sportive, assistenziali, etc., collegati agli scopi istituzionali, non venivano considerati operazioni imponibili ai fini IVA.
Questa deroga al principio di onnicomprensività dell’IVA ha però sollevato perplessità in ambito UE: la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione (n. 2008/2010) contestando il mancato allineamento della norma italiana agli obblighi comunitari . Infatti, il diritto UE prevede sì esenzioni per talune attività di utilità sociale (artt. 132 e 133 Dir. 2006/112/CE), ma richiede che tali operazioni rientrino comunque nel campo IVA (salvo casi di assenza di corrispettivo vero e proprio). L’Italia, dopo anni di rinvii, è intervenuta col D.L. 146/2021 (conv. in L. 215/2021) per riformare il regime IVA degli enti associativi. La riforma – originariamente prevista dal 2024 e poi prorogata al 2026 – elimina la “non imponibilità” di principio per queste operazioni istituzionali, facendole rientrare nel campo IVA ma in genere in regime di esenzione . In altre parole, dal 1° gennaio 2026 le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dagli enti associativi (inclusi quelli religiosi) verso pagamento di corrispettivi specifici ai propri soci o anche a terzi, non saranno più escluse da IVA come ora, ma verranno considerate operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 (salvo alcuni casi che diverranno imponibili) . Ciò comporterà maggiore trasparenza e allineamento al diritto UE, ma anche nuovi adempimenti (fatturazione, registrazione, pro-rata detraibilità etc.) per gli enti religiosi e non-profit che finora operavano fuori campo IVA .
È importante sottolineare che gli enti religiosi “civilmente riconosciuti” (es. diocesi, parrocchie, istituti di vita consacrata con personalità giuridica) hanno da decenni uno status peculiare nell’ordinamento tributario italiano. La legge n. 222/1985 (derivante dagli Accordi di Villa Madama) e le intese con le confessioni “acattoliche” garantiscono loro il perseguimento di finalità di religione o di culto con un regime di favore. Tuttavia, sul piano IVA, tali enti non godono di un’esenzione generalizzata per il solo fatto di essere “di natura ecclesiastica”. La Cassazione ha più volte affermato che la qualificazione soggettiva come ente religioso non basta, da sola, a escludere l’applicazione dell’IVA su tutte le sue attività . Conta la natura concreta dell’attività svolta: le operazioni direttamente attinenti ai fini di religione o di culto spesso non configurano per nulla attività d’impresa (e quindi non rientrano nel campo IVA), mentre attività di carattere commerciale (anche se svolte dall’ente per autofinanziarsi) rientrano nell’ambito IVA, salvo specifiche esenzioni previste dalla legge .
Riassumendo il quadro normativo attuale (fine 2025):
- Attività istituzionali di culto/religione (non lucrative): non sono considerate commerciali ai fini IVA secondo l’art. 4 DPR 633 e la giurisprudenza consolidata. Esse “non hanno rilevanza tributaria” e le relative operazioni non vanno fatturate né dichiarate ai fini IVA . Esempi: celebrazioni liturgiche, catechesi, gestione interna della vita religiosa. Sono attività svolte tipicamente senza corrispettivo (o dietro offerte volontarie) e dunque estranee al presupposto IVA (che richiede un rapporto sinallagmatico di scambio di beni/servizi dietro corrispettivo).
- Attività di pubblica utilità non lucrative (educative, assistenziali, sanitarie, culturali) svolte da enti religiosi: se svolte secondo modalità non commerciali, godono spesso di esenzioni IVA specifiche ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72. Ad esempio, sono esenti le prestazioni educative e didattiche rese da istituti scolastici paritari o legalmente riconosciuti (spesso gestiti da enti religiosi) ; sono esenti le prestazioni sanitarie di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o cliniche convenzionate (ivi incluse opere pie e enti ecclesiastici che gestiscono ospedali, se autorizzati); sono esenti le prestazioni socio-assistenziali rese da enti assistenziali riconosciuti (ad esempio una casa di riposo gestita da un ordine religioso, se accreditata/regolamentata). Queste esenzioni discendono dal diritto UE, art. 132 della Direttiva IVA, recepito nell’art. 10 del Decreto IVA: lo scopo è favorire servizi di interesse generale (istruzione, sanità, assistenza, cultura, sport, religione) prestati da soggetti pubblici o da enti non profit riconosciuti a condizioni particolari. Ad esempio, la direttiva esonera i “servizi connessi alla pratica del culto o dell’educazione religiosa” prestati da enti religiosi riconosciuti (recepiti in Italia in parte come esclusione da IVA se non vi è corrispettivo, oppure come esenzione se configurati come servizi educativi, culturali o assistenziali).
- Attività commerciali (non strettamente inerenti al culto) svolte da enti religiosi: soggiacciono alle regole ordinarie IVA. Se un ente religioso vende beni o presta servizi dietro corrispettivo in modo analogo a un operatore economico, tali operazioni sono imponibili (aliquota ordinaria o ridotta a seconda del bene/servizio). L’ente religioso dovrà aprire partita IVA, emettere fattura (o ricevuta fiscale) e versare l’imposta, salvo rientrare in particolari regimi di esenzione. Esempi tipici: gestione di un negozio di articoli religiosi, gestione di una casa per ferie con pagamento di tariffe, locazione di sale per eventi a terzi, vendita di oggetti o cibo in occasione di sagre non rientranti nelle attività di propaganda previste dalla legge. Per queste attività, l’ente religioso agisce come un soggetto passivo IVA qualunque, con gli stessi obblighi.
Una particolarità: la normativa italiana (DPR 633/72 art. 4 comma 5) elenca alcune operazioni che, anche se svolte da enti non profit, sono sempre considerate commerciali. Nel caso degli enti associativi (inclusi quelli religiosi) le deroghe riguardano ad esempio la cessione di beni e servizi verso pagamento fuori dall’ambito istituzionale. Tuttavia, erano previste (prima della riforma) due eccezioni di favore: 1. la cessione di proprie pubblicazioni da parte dell’ente associativo (ad esempio un ente religioso che vende libri o riviste da esso edite ai propri fedeli/soci poteva considerarla attività istituzionale) e 2. le vendite/servizi occasionali in manifestazioni propagandistiche a fini di autofinanziamento (tipico per partiti politici, ma esteso anche ad altri enti in alcune interpretazioni) . Queste eccezioni permettevano di non considerare commerciali (e quindi non soggette a IVA) certe entrate minori legate allo scopo istituzionale. Ad esempio, molte parrocchie pubblicano bollettini o libri di preghiere: la vendita a offerta libera o a prezzo di recupero spese di queste pubblicazioni proprie è tradizionalmente considerata attività istituzionale, non imponibile IVA (purché i proventi sostengano i fini di religione).
In sintesi normativa: un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è di regola un ente non commerciale. Ciò significa che non perde tale qualifica fiscale nemmeno se svolge alcune attività commerciali (per legge, art. 149 TUIR c.4, gli enti ecclesiastici e le ONLUS non decadono mai dalla qualifica di ente non commerciale in base alla prevalenza delle attività) . Tuttavia, ai fini IVA, ogni singola operazione va analizzata: se si tratta di attività con corrispettivo ed economicamente organizzata, l’operazione rientra nel campo IVA (salvo esenzione specifica); se è attività gratuita o istituzionale priva di scambio economico, resta fuori dal campo IVA. La Cassazione ha chiarito che un’attività economica organizzata è tale anche in assenza di scopo di lucro, basta la tendenziale idoneità dei ricavi a coprire i costi; il fatto che l’ente sia una congregazione religiosa non esclude la natura imprenditoriale dell’attività se viene richiesta una remunerazione dei servizi . Viceversa, solo l’erogazione del tutto gratuita di beni o servizi non può mai considerarsi attività d’impresa . Questo principio, di matrice civilistica (art. 2082 c.c.), permea anche la distinzione fiscale tra attività istituzionale (gratuita o simbolica) e attività commerciale (dietro corrispettivo, anche minimo).
Da questo quadro si evince che gli enti religiosi devono muoversi con attenzione: beneficiare delle agevolazioni IVA è legittimo solo entro i limiti fissati dalla legge. In caso di incertezza sull’inquadramento di una data attività (commerciale vs istituzionale, esente vs imponibile), è prudente verificare la normativa o chiedere un interpello all’Agenzia Entrate. Errori di valutazione possono portare a recuperi d’imposta e sanzioni. Nei capitoli seguenti analizzeremo le principali agevolazioni IVA fruibili dagli enti religiosi (esenzioni, aliquote ridotte) e come predisporre una difesa efficace in sede di accertamento e contenzioso tributario.
Attività istituzionali vs attività commerciali: criteri di distinzione
Uno snodo centrale per capire le contestazioni IVA agli enti religiosi è saper distinguere tra attività “istituzionali” (non commerciali) e attività commerciali dell’ente. Questa distinzione ha rilievo sia per l’IVA che per le imposte dirette. In breve: le attività istituzionali sono quelle che realizzano direttamente i fini primari di religione o di culto dell’ente (o anche finalità di istruzione, beneficenza, assistenza nel caso di enti religiosi con anche scopi caritativi). Le attività commerciali sono quelle aventi natura imprenditoriale, volte all’erogazione di beni/servizi dietro corrispettivo, anche se i proventi sono reinvestiti nell’ente.
In ambito IVA, la differenza si manifesta così: le attività istituzionali pure di un ente religioso non configurano mai operazioni rilevanti ai fini IVA, per assenza del presupposto oggettivo (mancanza di corrispettivo o di organizzazione d’impresa). Ad esempio, la celebrazione di una messa, un pellegrinaggio organizzato gratuitamente, l’adorazione in un monastero, le benedizioni pasquali presso le case (con offerte libere) – sono tutte attività di culto svolte senza prezzo predeterminato: non c’è obbligo di fattura né IVA da applicare. Anche se l’ente riceve oblazioni o questue, queste sono erogazioni liberali, escluse dal campo IVA perché non costituiscono il pagamento di una prestazione specifica.
Le cose cambiano se l’ente religioso offre servizi dietro pagamento. In tal caso occorre capire se quel servizio rientra comunque nelle finalità istituzionali di religione o culto (o di assistenza, istruzione, ecc.) e se la normativa prevede per esso un trattamento di favore (esenzione), oppure se si tratta di un’attività commerciale a tutti gli effetti, tassabile. La Cassazione ha affermato il principio-guida secondo cui bisogna “accertare in concreto le attività svolte dall’associazione e la corrispondenza di tali attività alle finalità statutarie… quindi la loro strumentalità rispetto ai fini di religione o culto” . In altre parole, non basta che l’ente abbia finalità ideali o religiose da statuto: se poi svolge un’attività che per modalità è assimilabile a quella di un’impresa qualsiasi, quella specifica attività è fuori dal “mantello” istituzionale e diviene imponibile. Ad esempio, gestire un ristorante aperto al pubblico a pagamento non può considerarsi attività di culto, anche se a farlo è un monastero: è un’attività commerciale (salvo forse il caso in cui sia riservata ai poveri o sia svolta con volontari e richiesta di contributi simbolici – scenario diverso).
Vediamo alcuni criteri pratici emersi da normativa e giurisprudenza per distinguere attività istituzionale (non tassata) da commerciale (tassata) per un ente religioso:
- Finalità primaria dell’attività: se l’attività è direttamente funzionale al culto o alla missione religiosa (es. sacramenti, pastorale, carità gratuita, istruzione religiosa interna) si tende a qualificarla istituzionale. Se invece l’attività, pur lecita e magari con finalità morale, è simile a un servizio offerto sul mercato (es. gestione di un centro sportivo con quote, gestione di una casa vacanze dietro pagamento), prevale l’aspetto economico-organizzativo e l’attività è commerciale. La Cassazione ha ribadito che occorre guardare alla “effettiva attività espletata”, al di là delle definizioni formali , assimilando ormai gli enti ecclesiastici alle regole comuni proprio sulla base dell’attività concretamente svolta .
- Destinatari dei servizi: se l’attività è rivolta esclusivamente ai membri dell’ente o dell’organizzazione religiosa e risponde a bisogni interni (spirituali, formativi, ricreativi interni), è più facile considerarla istituzionale (specie sotto il vecchio art. 4 DPR 633). Ad esempio un ritiro spirituale organizzato da un ordine religioso per i propri aderenti dietro semplice rimborso spese non è attività commerciale. Viceversa, se il servizio è offerto anche o solo a terzi non legati all’ente, dietro pagamento, assume connotati imprenditoriali. Un caso tipico: la scuola paritaria gestita da religiosi – è aperta alla generalità degli studenti (pur essendo senza scopo di lucro) e richiede rette; per l’IVA viene però in aiuto la specifica esenzione per le attività didattiche riconosciute. Senza quell’esenzione, il servizio sarebbe commercialmente rilevante poiché offerto a terzi dietro corrispettivo.
- Modalità di svolgimento e pricing: la presenza di un corrispettivo pattuito per il servizio è un forte indice di commercialità. Se il corrispettivo è meramente simbolico (ad esempio un’offerta “suggerita” ma non obbligatoria, o un importo che copre solo le spese vive), l’attività può talvolta essere qualificata come non commerciale, specie per i tributi locali. Ad esempio, in materia di IMU la giurisprudenza ha ritenuto che una retta “non meramente simbolica” fa presumere attività commerciale anche per una scuola paritaria no-profit . Allo stesso modo per l’IVA: un prezzo di mercato indica normalmente un’attività economica; un contributo modesto potrebbe, in contesti particolari, essere considerato diverso da un vero corrispettivo (ma è un terreno scivoloso: se c’è un nesso sinallagmatico, giuridicamente è un corrispettivo). La Cassazione 2020 sulle scuole paritarie cattoliche ha osservato che il pagamento di una retta rivela lo svolgimento dell’attività con modalità commerciali, anche se la gestione è in perdita . Il fatto di operare in perdita non conta: ciò che conta è l’attitudine dell’attività a remunerare i fattori produttivi, essendo irrilevante lo scopo di lucro soggettivo . Solo se l’attività è svolta “in modo del tutto gratuito” si esclude il carattere imprenditoriale .
- Organizzazione e mezzi impiegati: se l’attività richiede un’organizzazione complessa, mezzi e personale retribuito similmente a un’azienda, sarà difficile sostenerne la natura meramente religiosa o solidaristica. Ad esempio, un ente religioso che gestisce un ospedale con centinaia di dipendenti, pur essendo un’opera di carità, svolge un’attività economicamente organizzata; infatti gode dell’esenzione IVA (ricoveri ospedalieri) solo perché prevista dalla legge, altrimenti sarebbe attività d’impresa a tutti gli effetti. Se invece l’attività è svolta con volontari o membri dell’ordine, senza struttura imprenditoriale, ciò può sorreggere la tesi che non vi è vera attività commerciale (pensiamo a una mensa gratuita per poveri gestita in parrocchia: niente dipendenti, niente prezzo – è carità, fuori dall’IVA).
In pratica, quando l’Agenzia delle Entrate contesta “indebite agevolazioni IVA” a un ente religioso, spesso lo fa sostenendo che certe entrate dell’ente (magari qualificate da questo come liberalità o quote istituzionali) fossero invece corrispettivi di operazioni commerciali. L’accertamento può dunque riqualificare l’attività: da istituzionale esente/fuori campo a commerciale imponibile. Tipici esempi di situazioni borderline:
- Contributi “pseudo-liberali”: somme versate formalmente come donazione o contributo associativo, ma il Fisco ritiene che mascherino un pagamento per un servizio. Esempio: la parrocchia organizza un doposcuola per bambini chiedendo un “contributo volontario” mensile; se l’importo è fisso e i bimbi sono di fatto tenuti a versarlo, può essere riqualificato come corrispettivo di servizio educativo (e quindi, se non rientra nell’esenzione scuole, IVA imponibile).
- Attività non coerenti con lo statuto: l’art. 4 DPR 633 richiede che le prestazioni ai soci siano “in conformità alle finalità istituzionali” per essere escluse da IVA . Se un’associazione religiosa compie attività non previste dallo statuto o eccedenti gli scopi, queste sono fuori dall’ambito protetto. Ad esempio, uno statuto di associazione religiosa che prevede solo attività liturgiche e formative non copre la gestione di un bar; se l’ente apre un bar per i soci, vendendo cibi e bevande, quell’attività non è strumentale al culto e non gode dell’esclusione IVA (salvo il caso particolare delle APS con bar interno beneficenza, vedi infra). L’Agenzia potrebbe contestare l’IVA non versata sulle consumazioni.
- Locazioni e utilizzo di immobili: un conto è l’uso gratuito di locali ecclesiastici per finalità di culto o attività parrocchiali; altro è affittare spazi a terzi dietro pagamento. Le locazioni di immobili, in generale, sono esenti da IVA (art. 10, n.8) a meno di opzione per l’imponibilità. Però se un ente religioso concede in uso a pagamento un locale per attività commerciali di terzi, pur essendo l’operazione esente IVA, l’ente sta svolgendo attività di impresa locativa (rilevante per altre imposte). L’agevolazione IMU, ad esempio, non spetta se l’immobile è dato in locazione per usi commerciali. La Cassazione ha chiarito che per godere dell’esenzione delle imposte patrimoniali (ICI/IMU) l’immobile dell’ente religioso deve essere destinato esclusivamente ai fini non commerciali propri (es. culto, scuola gratuita, ecc.), altrimenti l’esenzione salta . Analogamente, ai fini IVA, se la locazione è esente ex art. 10 non vi è imposta ma l’ente dovrà considerare l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti relativi a tale attività (attività esente comporta pro-rata).
In definitiva, la linea di demarcazione non è sempre netta e richiede una valutazione caso per caso. Onere della prova: spetta in buona parte al contribuente dimostrare il diritto all’agevolazione fiscale. In tema di esenzioni ed esclusioni, la Cassazione richiede all’ente non profit di provare il possesso dei requisiti oggettivi oltre che soggettivi . Cioè l’ente religioso deve provare non solo di avere natura non commerciale, ma anche che l’attività concreta è svolta in modo non commerciale e direttamente strumentale ai fini istituzionali. Nei contenziosi tributari, i giudici scrutinano attentamente questo aspetto: motivazioni generiche non bastano, servono elementi concreti (statuti, regolamenti, bilanci separati, modalità operative, eventuali autorizzazioni ministeriali se richieste per l’esenzione, ecc.). Più avanti vedremo come documentare tali aspetti in sede difensiva.
Tabella di sintesi: riportiamo alcuni esempi di attività tipiche degli enti religiosi e il relativo trattamento IVA, in base ai criteri di legge:
| Attività svolta da ente religioso | Trattamento IVA | Riferimenti |
|---|---|---|
| Celebrazioni liturgiche, sacramenti, atti di culto (offerte libere dai fedeli) | Fuori campo IVA (non è una prestazione commerciale né vi è corrispettivo contrattuale) | Art. 4 DPR 633/72; Cass. n. 25628/2021 (attività di religione e culto prive di rilevanza tributaria) |
| Catechesi, ritiri spirituali, attività pastorali gratuite (eventuali donazioni) | Fuori campo IVA (come sopra, mancanza di corrispettivo specifico) | Art. 4 DPR 633/72; principio generale attività gratuite non imponibili |
| Scuola paritaria o asilo gestito da ente religioso, con retta scolastica | Esente IVA (prestazioni educative e didattiche riconosciute) | Art. 10, c.1, n.20 DPR 633/72 ; Dir. 2006/112/CE art. 132, co.1, lett.i |
| Ospedale, clinica o ambulatorio gestito da ente religioso (con convenzioni/accreditamento SSN) | Esente IVA (prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e ricovero) | Art. 10, c.1, n.18) e n.19) DPR 633/72; Dir. 2006/112/CE art. 132, co.1, lett.b, c |
| Casa di riposo o comunità di assistenza gestita da ente religioso (eventuale retta degli ospiti) | Esente IVA se rispetto requisiti (prestazioni socio-assistenziali rese da ONLUS o enti autorizzati) – Fuori campo se attività totalmente gratuita | Art. 10, c.1, n.27-ter DPR 633/72 (servizi assistenziali in convenzione o da ONLUS esenti); art. 132 Dir. IVA lett.g, h |
| Mensa per poveri o distribuzione gratuita di beni (carità) | Fuori campo IVA (assenza di corrispettivo) – Eventuali acquisti di alimenti con aliquote ridotte | – |
| Attività ricreative per soci (oratorio, doposcuola) con contributo simbolico | Attualmente non imponibile (attività istituzionale ex art.4 DPR 633 se rivolta ai soci e conforme scopi). Dal 2026 sarà esente IVA se strettamente connessa ai fini istituzionali . Se il contributo non è simbolico, rischio riqualifica commerciale. | Art. 4 DPR 633/72 comma 4; D.L. 146/2021 art.5 modificativo (in vigore dal 2026) |
| Affitto di immobile (es. sala parrocchiale) a un terzo per eventi dietro pagamento | Esente IVA (locazioni di immobili, salvo opzione per IVA) – comunque attività commerciale ai fini delle imposte dirette e IMU (no esenzione IMU) | Art. 10, c.1, n.8 DPR 633/72 (esenzione locazioni); Cass. n. 12928/2025 (recupero ICI su immobili dati in uso commerciale) |
| Casa per ferie / ospitalità religiosa con corrispettivo (tipo foresteria per turisti) | Imponibile IVA al 10% (servizi alberghieri e simili) se offerti verso pagamento. Possibile esenzione solo se l’attività è svolta con modalità non commerciali e destinata a categorie protette (es. accoglienza indigenti) – caso eccezionale. | Art. 3 e 10 DPR 633/72 (ospitalità a pagamento = prestazione di alloggio, imponibile come hotel) |
| Vendita di beni religiosi (rosari, libri, oggetti) in negozio o bancarella stabile | Imponibile IVA (aliquota ordinaria 22%, oppure 4% se libro/editoria) – considerata attività commerciale al pubblico. | Art. 4 c.5 DPR 633/72 individua vendite come commerciali salvo eccezioni per pubblicazioni proprie. |
| Vendita di proprie pubblicazioni (libri, bollettini, immagini sacre edite dall’ente) prevalentemente ai fedeli/soci | Non imponibile (attività istituzionale, non commerciale, per espressa deroga) se rispetta condizioni (pubblicazioni dell’ente stesso). | Art. 4 DPR 633/72 c.5, prima deroga |
| Raccolte fondi occasionali con cessione di beni di modico valore (es. vendita torte, oggettini durante feste patronali) | Fuori campo IVA se effettuate occasionalmente e senza organizzazione d’impresa (il ricavato è liberalità verso offerta di modico valore). Attenzione: queste attività godono di esenzione da altre imposte (art. 143 TUIR) ma l’IVA può essere critica se ripetute o con prezzi fissi. Dal 2026 potrebbero essere imponibili se considerate cessioni non connesse a servizi esenti. | Principio generale occasionalità; art. 4 DPR 633 modificato dal 2026 (cessioni non strettamente connesse diventano imponibili) . |
Nota: La tabella semplifica casistiche comuni ma ogni situazione concreta può presentare sfumature normative da valutare con precisione. Ad esempio, la gestione di una casa per ferie da parte di un ente ecclesiastico potrebbe, in rarissimi casi, essere considerata attività di accoglienza religiosa e non turistico-commerciale (ad es. se limitata a ospitare gratuitamente o con contributi minimi pellegrini e persone disagiate, come espressione di carità). Tuttavia, non appena si richiedono tariffe, si fa pubblicità e si offrono servizi paragonabili a un albergo, l’attività ricade sotto la disciplina IVA ordinaria (aliquota 10% per gli alloggi). Gli enti religiosi devono quindi valutare attentamente come strutturare queste attività, eventualmente separandole tramite enti distinti (cooperative, imprese sociali) se intendono operare sul mercato senza mettere a rischio le proprie agevolazioni istituzionali.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate in un accertamento contesterà l’indebito utilizzo di agevolazioni IVA quando ritiene che l’ente abbia applicato un trattamento fiscale di favore senza averne i requisiti. Tipicamente i rilievi riguardano: (a) operazioni ritenute commerciali su cui l’ente non ha addebitato l’IVA (perché le considerava esenti o fuori campo); (b) applicazione di un’aliquota IVA ridotta non spettante (es. 4% anziché 10% o 22% in fatture di lavori edili, v. paragrafo successivo); (c) detrazione indebità di IVA sugli acquisti utilizzati in attività esenti/non commerciali (il pro-rata di detraibilità). Infatti, se un ente compie sia operazioni imponibili che esenti, può detrarre l’IVA a credito solo in proporzione (art. 19 e 19-bis DPR 633/72): un errore di classificazione può portare l’ufficio a recuperare IVA detratta in eccesso. Un classico esempio: una parrocchia costruisce un nuovo oratorio e si fa fatturare i lavori con IVA 4% come se fosse “nuova costruzione prima casa non di lusso” (aliquota agevolata) – l’Ufficio potrebbe contestare che l’aliquota corretta era il 10% o 22% se l’opera non rientrava nelle agevolazioni edilizie previste.
Nel prossimo paragrafo affronteremo proprio le principali agevolazioni IVA (esenzioni e aliquote ridotte) di cui possono beneficiare gli enti religiosi, approfondendo anche i casi di contestazione tipici e le relative fonti normative e giurisprudenziali a supporto.
Agevolazioni IVA per enti religiosi: esenzioni ed aliquote ridotte
Gli enti religiosi, pur non avendo un regime IVA speciale “ad personam”, usufruiscono in concreto di varie agevolazioni fiscali sotto forma di esenzioni, esclusioni o aliquote ridotte applicabili alle attività di interesse generale che essi spesso svolgono. In questa sezione esamineremo le principali agevolazioni IVA rilevanti e come esse possono essere contestate se utilizzate indebitamente. Sapere cosa prevede la legge aiuta a difendersi mostrando di aver agito nei limiti consentiti, oppure a comprendere l’errore eventualmente commesso.
Esenzioni IVA per attività di religione, educative, assistenziali e simili
Come anticipato, l’art. 10 del DPR 633/72 recepisce varie esenzioni previste dalla normativa UE (art. 132 Dir. IVA) per attività di utilità pubblica. Molte di queste esenzioni riguardano settori in cui tradizionalmente operano anche enti religiosi. Ecco le più rilevanti:
- Esenzione IVA per l’istruzione: l’art. 10, comma 1, n.20) esenta “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse con le precedenti”. Questa esenzione si applica se i servizi educativi sono resa da istituti o scuole riconosciute da pubbliche autorità competenti (Stato, Regione). Dunque una scuola materna, elementare o superiore paritaria gestita da un ente religioso è esente IVA sulle rette scolastiche e servizi connessi (mensa, doposcuola) . Attenzione: l’esenzione richiede il riconoscimento: se un ente religioso organizza corsi privati non paritari (es. lezioni di lingua, corsi musicali interni) tali attività potrebbero non rientrare nell’esenzione e sarebbero imponibili, a meno che si configuri un’attività didattica “di formazione extrascolastica della persona” svolta da associazione culturale (in tal caso dal 2026 esenti ex art. 10 riformato, ma prima potrebbe non esserlo). In caso di accertamento, l’ente dovrà dimostrare lo status di scuola paritaria o ente equiparato (convenzioni con MIUR, registro regionale ecc.), altrimenti rischia un recupero IVA. La Cassazione ha confermato che per godere delle esenzioni su immobili scolastici non profit, occorre provare che la scuola operi senza scopo di lucro effettivo e con rette simboliche , altrimenti il beneficio decade (questa pronuncia era su IMU, ma l’idea di fondo può riflettersi anche in contestazioni IVA in caso di enti non riconosciuti che fanno pagare rette elevate).
- Esenzione IVA per prestazioni sanitarie: l’art. 10, n.18) esenta le prestazioni di ricovero e cura ospedaliera, e n.19) esenta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, se rese da enti ospedalieri, cliniche convenzionate, USL e simili, nonché da ONLUS per determinate attività. Molti enti religiosi gestiscono ospedali, ambulatori, RSA o cliniche private. Se tali strutture operano in regime di convenzione col SSN o comunque con autorizzazione sanitaria, le fatture emesse per rette di degenza, interventi, analisi, visite mediche sono esenti IVA. Caso diverso è un eventuale poliambulatorio privato non convenzionato gestito dall’ente: in linea di massima, le prestazioni mediche sono esenti a prescindere (lo sono anche quelle rese da medici in forma individuale ex art. 10 n.18), quindi in molti casi anche qui non si applica IVA. Le contestazioni potrebbero sorgere se l’ente estende l’esenzione a servizi che non ne hanno diritto – es. servizi estetici o di benessere (non sanitari) venduti come se fossero medici – ma scenario raro per enti religiosi.
- Esenzione IVA per assistenza e beneficenza: l’art. 10, comma 1, n.27-ter) esenta “le prestazioni proprie dei servizi di carattere assistenziale o previdenziale … strettamente connesse con la tutela dell’infanzia, della gioventù, della terza età, dell’handicap, ecc., rese da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS”. Questa esenzione, introdotta nel 1997, copre i servizi socio-assistenziali (dall’assistenza domiciliare, ai centri per disabili, comunità di accoglienza, mense sociali) a condizione però che siano rese da soggetti specifici: ONLUS, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, enti di assistenza sociale riconosciuti pubblicamente. Molti enti religiosi operano in questo campo attraverso la Caritas diocesana, fondazioni o associazioni caritative, spesso costituite come ONLUS (ora in transito nel Terzo Settore). Se un ente religioso ha un “ramo ONLUS” (come consentito dall’art. 10, c.9 D.Lgs. 460/97) o oggi un ramo ETS (Ente Terzo Settore) per le opere di assistenza, può applicare le esenzioni IVA previste per quei soggetti. Ad esempio, la gestione di un centro per anziani dove si paga una retta può essere esente IVA se l’ente è ONLUS/ETS e rispetta i requisiti (attività di interesse generale con assenza scopo di lucro). Attenzione: l’ente ecclesiastico in sé non è automaticamente ONLUS; deve aver costituito apposito ramo e iscrittosi all’Anagrafe ONLUS (finché vigente) o al RUNTS come APS/ODV. In mancanza, il Fisco potrebbe negare l’esenzione: è successo in passato che enti religiosi si vedessero negare agevolazioni ONLUS perché mancava la formale iscrizione all’Anagrafe. La Cassazione ha ribadito che gli enti ecclesiastici possono beneficiare delle agevolazioni ONLUS solo se rispettano tutti i requisiti formali e sostanziali previsti, inclusa la comunicazione di iscrizione, limitatamente alle attività di utilità sociale (art. 10 D.Lgs. 460/97). Dunque, in sede difensiva, un ente religioso dovrà provare di avere effettivamente la qualifica o i requisiti equiparati a ONLUS/ETS per rivendicare l’esenzione IVA su servizi assistenziali. In mancanza, l’ufficio potrebbe contestare l’IVA non applicata. Da notare: dal 2022 le ONLUS sono in fase di trasformazione nel Terzo Settore, ma in attesa dell’autorizzazione UE alcune norme transitorie (esenzione IVA ex art. 10 per certe operazioni) entreranno a regime solo dal 2026. Ciò crea un’intersezione complessa: ad esempio, dal 2026 le operazioni verso non soci di associazioni assistenziali saranno considerate esenti (mentre oggi teoricamente fuori campo se rese ai soci e commerciali se rese a terzi, salvo ONLUS). Un potenziale contenzioso potrà riguardare il periodo di transizione: p.es. un ente religioso che nel 2025 incassa contributi da non soci per attività assistenziali – l’AdE potrebbe sostenere che essendo verso terzi andava applicata IVA (non essendo più esclusa ex art.4 e non ancora esente in vigore). Su questi punti sarà cruciale monitorare i decreti di proroga e le circolari esplicative*: ad esempio la Circolare AE 22/E del 2023 e 9/E del 2023 hanno fornito chiarimenti sul regime IVA transitorio per enti associativi (se disponibili, andrebbero citate come fonti).
- Esenzione IVA per attività culturali ricreative: la direttiva UE consente esenzioni per servizi culturali resi da enti non profit riconosciuti (art. 132, 1°, lett. n). Il DPR 633/72 al n.22 esenta “le prestazioni proprie di biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti visite a musei, gallerie, monumenti, ecc., se rese da enti pubblici o enti equiparati”. Questo non copre espressamente gli enti religiosi privati, ma in pratica molti beni culturali ecclesiastici (chiese, musei diocesani) sono accessibili senza biglietto o con offerta libera. Se però un ente religioso istituisce un museo a pagamento o organizza visite turistiche guidate a pagamento nei propri monumenti, deve valutare se quell’attività rientra in un’esenzione. Spesso, per evitare problemi IVA, le diocesi affidano i servizi museali a fondazioni o associazioni culturali che possono essere considerate enti con finalità culturali riconosciuti. In caso contrario, la vendita di biglietti è imponibile (aliquota 22%). Un recente sviluppo: alcune attività culturali rese da APS/enti culturali potrebbero diventare esenti con la riforma (se rientranti in finalità di formazione extrascolastica, ecc.) . Ma per ora un ente religioso che faccia pagare l’ingresso a una mostra o concerto deve applicare IVA, a meno che riesca a farlo passare come attività istituzionale gratuita (difficile se c’è biglietto). In difesa, l’ente potrebbe rivendicare un’interpretazione estensiva del n.22 art.10 (equiparando magari il proprio museo a un museo pubblico se ha convenzioni col Comune o Ministero). Non è una linea garantita, andrebbe supportata da pareri o norme locali.
- Esenzioni per attività strettamente connesse al culto: la direttiva IVA prevede l’esenzione per “servizi strettamente connessi con la pratica della religione o del culto, prestati da enti religiosi riconosciuti” (art. 132, par.1, lett. l). L’Italia non ha una norma espressa e autonoma su ciò, probabilmente perché molte di queste attività di culto sono già fuori campo (non c’è corrispettivo). Un caso pratico: se una diocesi organizza un pellegrinaggio spirituale e richiede ai partecipanti un contributo per le spese (viaggio, vitto), è quello un servizio turistico imponibile oppure un servizio connesso al culto? In passato la prassi era considerarlo fuori campo se organizzato in modo non imprenditoriale e rivolto ai fedeli, oppure addirittura esente ex art. 10 n.27- bis (agenzie di viaggi? No, non applicabile). Oggi, alcune diocesi si appoggiano a agenzie di viaggi commerciali per i pellegrinaggi, che ovviamente applicano IVA sui pacchetti. Se invece l’ente facesse tutto in proprio, il rischio fiscale c’è. Non risultano però significative controversie su questo, probabilmente perché il fenomeno è contenuto o gestito con attenzione (spesso i pellegrinaggi parrocchiali sono a contributo spese e autogestiti, con fatture intestate ai singoli per viaggio ecc., quindi l’ente non figura come prestatore).
Riassumendo sulle esenzioni: per difendersi da un accertamento, l’ente religioso dovrà identificare qual è l’agevolazione IVA specifica invocata e dimostrare di averne i requisiti. Ad esempio, se l’Ufficio contesta IVA su rette di una scuola cattolica, il difensore mostrerà che la scuola è legalmente paritaria (decreto MIUR) e quindi la retta era esente ex art. 10 n.20 . Se contesta IVA su un affitto a una ONLUS in un immobile ecclesiastico, si farà presente che le locazioni immobiliari sono comunque esenti (art. 10 n.8). Se contesta IVA su un servizio agli anziani, occorre provare che l’attività era svolta come ONLUS (statuto, iscrizione) dunque esente n.27-ter, o se non formalmente ONLUS magari argomentare che era prestata a fronte di contributi simbolici (tentando di qualificare il rapporto come non commerciale).
Un problema frequente è la commistione di attività: molti enti religiosi svolgono contemporaneamente attività esenti e non, usando le stesse strutture. Ad esempio, un convento ospita sia ritiri spirituali gratuiti sia turisti paganti. La legge richiede contabilità separata e corretta ripartizione di costi/ricavi. Se l’ente ha un’unica contabilità confusa, l’Agenzia può presumere che tutta l’attività fosse commerciale. La Cassazione ha sottolineato l’obbligo (anche se non codificato chiaramente prima) di tenere contabilità separata per attività commerciale e istituzionale negli enti non commerciali . Una difesa efficace comprende mostrare che l’ente aveva una separazione (anche solo gestionale) o comunque quantificare chiaramente le diverse attività. La recente ordinanza Cass. n. 25628/2021 ha annullato una decisione di merito che confondeva contabilità separata e bilanci separati, ribadendo che basta adottare sistemi anche semplificati purché distinguano proventi commerciali e istituzionali . Se l’ente lo ha fatto (es. registri interni separati), andrà evidenziato per dare credibilità alla propria ricostruzione.
Agevolazioni IVA in edilizia e per beni immobili degli enti ecclesiastici
Un’altra area delicata riguarda l’IVA nell’edilizia e negli immobili di enti religiosi. Gli enti ecclesiastici possiedono chiese, edifici di culto, case canoniche, oratori, conventi, spesso beneficiando di agevolazioni su altri tributi (esenzione IMU per quelli destinati al culto e alle attività non commerciali, in base all’art. 7 d.lgs. 504/92 come modificato nel 2012 ). In campo IVA, esistono aliquote ridotte (4% o 10%) per determinate operazioni edilizie o cessioni immobiliari di cui possono usufruire anche gli enti religiosi, ma solo in presenza dei requisiti. Eventuali errori nell’applicare l’aliquota agevolata possono portare ad accertamenti per IVA dovuta in più.
Ecco i principali casi di IVA agevolata in cui possono incorrere gli enti religiosi:
- IVA 4% per nuove costruzioni di edifici particolari: L’aliquota super-ridotta del 4% si applica, secondo la Tabella A, Parte II allegata al DPR 633/72, ad alcune ipotesi come la costruzione di case di abitazione non di lusso (n.39 della Tabella) e lavori di eliminazione barriere architettoniche (n.41-ter). Un ente religioso non costruisce “case di abitazione” in senso proprio (una chiesa o un oratorio non è abitazione). Tuttavia, per molti anni si è ritenuto – sulla base di norme di edilizia agevolata – che le opere di urbanizzazione secondaria come le chiese, gli oratori e gli edifici destinati all’educazione religiosa potessero rientrare in regime IVA agevolato. In particolare, la legge Tupini (L. 408/1949) e norme successive hanno concesso agevolazioni per edifici con particolari caratteristiche. Oggi, la prassi consolidata (vedi linee guida della CEI – Conferenza Episcopale Italiana) è applicare l’IVA al 4% agli appalti per la costruzione ex novo di chiese, oratori e case parrocchiali destinati al culto . Ciò avviene perché tali edifici sono assimilati a “fabbricati non di lusso” destinati a finalità sociali e rientrano nelle opere di urbanizzazione secondaria (le quali, in virtù di leggi speciali, godono di aliquota ridotta). La Tabella A, Parte II, n. 24 ad esempio comprende “fabbricati destinati a usi pubblici o di culto” su cui si può applicare il 4% (questo numero 24 deriva dall’art. 13 L. 2/7/1949 n. 408). Tuttavia, bisogna fare molta attenzione: l’agevolazione non è automatica su qualunque edificio di ente ecclesiastico. Serve la destinazione d’uso a edificio di culto o pastorale e spesso un rapporto con un ente pubblico (es. convenzione col Comune che riconosce quell’edificio come opera di urbanizzazione). In caso di controllo, l’Agenzia Entrate potrebbe eccepire l’aliquota 4% se ritiene che l’edificio non rientri nelle categorie agevolate. Ad esempio, un edificio costruito dalla parrocchia ma catastalmente non classificato come luogo di culto (E/7) e utilizzato in parte commerciale, potrebbe non godere del 4%. La Cassazione (ordinanza n. 3699/2025) ha affrontato un caso di decadenza dell’agevolazione “prima casa” per un ente ecclesiastico: l’ente aveva acquistato immobili con IVA 4% dichiarando destinazione assistenziale e poi li aveva dati in locazione commerciale, perdendo il beneficio (qui il contesto era imposta di registro ma il principio di stretta interpretazione dell’agevolazione è analogo). Dunque, un ente religioso che applica l’IVA 4% su una costruzione deve poter dimostrare che l’immobile sarà effettivamente ed esclusivamente destinato a funzioni di religione, culto o attività non commerciali di pubblico interesse. Se l’ufficio riscontra un uso diverso entro 5 anni, può far decadere l’aliquota e richiedere la differenza al 10% o 22% (a seconda dei casi), con sanzioni.
- IVA 10% per interventi di recupero edilizio: Gli enti religiosi spesso realizzano restauri, manutenzioni e ristrutturazioni di chiese ed edifici storici. La legislazione generale prevede l’aliquota del 10% per gli interventi di recupero edilizio su edifici a prevalente uso abitativo privato (manutenzioni ordinarie/straordinarie, restauro su abitazioni – Tabella A, Parte III, n.127-quaterdecies e septies). Una chiesa non è “abitazione privata”, però a fini di tutela del patrimonio culturale ecclesiastico spesso si cerca di accedere all’IVA agevolata tramite norme specifiche o equiparazioni. Ad esempio, per i beni culturali vincolati (molte chiese lo sono), le opere di restauro possono essere fatturate al 10% in base ad interpretazioni estensive (equiparandole a interventi su edifici assimilati). Inoltre, la Tabella A, Parte II, n.41-ter prevede IVA 4% per opere finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche: se una parrocchia installa un ascensore o uno scivolo per disabili in chiesa, ha diritto al 4% . Se esegue invece il rifacimento del tetto della chiesa, probabilmente l’impresa applicherà il 10% richiamando genericamente la categoria “restauro di edifici monumentali”. Bisogna dire che su questo terreno l’Amministrazione finanziaria è stata relativamente tollerante, riconoscendo in alcuni casi l’IVA 10% per interventi su edifici di culto (equiparandoli a immobili non di lusso destinati a uso sociale). Ma non mancano contestazioni: ad esempio, se l’ente avesse dovuto chiedere un’autorizzazione specifica per l’aliquota ridotta e non l’ha fatto, oppure se l’intervento non rientrava strettamente tra quelli agevolati. La difesa consiste nel fornire la base normativa per l’aliquota usata: citare il numero della Tabella applicato sulla fattura e motivare perché l’edificio ne ha i requisiti. È buona prassi in sede di stipula dei contratti di appalto inserire il riferimento normativo all’IVA agevolata applicabile (molte diocesi emanano linee guida e tabelle IVA per manutenzioni rivolte alle parrocchie ). Se ciò è stato fatto, presentarlo all’ufficio come evidenza di buona fede e corretto inquadramento. In assenza, l’ufficio potrebbe sostenere l’aliquota ordinaria. La giurisprudenza in materia di aliquote edilizie è vasta ma di regola applica un criterio strettamente letterale: se l’intervento non rientra espressamente tra quelli agevolati in Tabella A, l’aliquota ridotta non spetta . Quindi, ad esempio, la tinteggiatura di una chiesa non è manutenzione su edificio abitativo (non spetterebbe 10%), ma se quella chiesa contiene anche una canonica (abitazione del parroco) forse l’intervento in parte va al 10%. Sono questioni tecniche ove l’ente può far leva su documenti tecnici (es. accatastamento, destinazione d’uso mista) per sostenere la tesi più favorevole.
- Cessione di immobili a enti religiosi: quando un ente religioso acquista un immobile, può beneficiare di esenzioni/agevolazioni non tanto sull’IVA (che paga eventualmente come acquirente, se dovuta dal venditore) ma sulle imposte di registro/ipotecarie. Ad esempio l’art. 27-bis Tab. B DPR 131/86 esenta da registro gli acquisti di immobili destinati al culto. L’IVA sulle cessioni immobiliari invece dipende dalla natura del cedente: se un’impresa vende un immobile strumentale all’ente religioso, può optare per IVA (22% o 10% se “prima casa” particolari, etc.). Gli enti religiosi non sono consumatori privati, quindi se pagano IVA la possono detrarre? Solo se useranno l’immobile per attività commerciali. Se l’immobile è destinato a culto (attività esente/non commerciale), l’IVA pagata diventa un costo (indetraibile). In passato, su iniziativa parlamentare, l’IVA sulle costruzioni di nuovi edifici di culto veniva rimborsata alla CEI tramite 8×1000, ma non è una norma IVA, è un meccanismo extra-tributario. L’Agenzia Entrate su questi aspetti è rigorosa: non esiste un’esenzione IVA generalizzata per gli acquisti di beni o servizi da parte di enti ecclesiastici. Dunque se un convento compra un pulmino, paga IVA 22% come chiunque (salvo acquistarlo tramite donazioni ex art. 10 n.12, vedi dopo). Una questione interessante è quella delle cessioni gratuite di beni a enti religiosi o caritativi: l’art. 10, c.1, n.12) esenta da IVA le cessioni gratuite a ONLUS, enti di beneficenza e simili di beni per fini di interesse generale . Questo consente, ad esempio, a un supermercato di donare cibo a una mensa Caritas senza applicare IVA sull’uscita. L’ente religioso beneficiario quindi riceve beni senza IVA. Se l’Agenzia contestasse a un’azienda il mancato assoggettamento a IVA di beni dati in regalo a un ente ecclesiastico, la difesa consisterà nel dimostrare che l’ente rientra tra i destinatari legittimati (ONLUS o assimilato) e la cessione è avvenuta nei limiti di legge (documentata e usata per fini sociali). Questo riguarda più il donatore che l’ente religioso, ma è utile sapere che anche le donazioni in natura agli enti religiosi possono essere esenti IVA se effettuate nei binari normativi.
In termini di contenzioso tipico sugli immobili ecclesiastici, va menzionata la lunga vicenda dell’ICI/IMU e aiuti di Stato UE: l’esenzione ICI per gli immobili non commerciali (inclusi enti religiosi) era stata censurata come aiuto di Stato incompatibile. La Corte di Giustizia UE nel 2018 ha confermato che l’esenzione costituiva aiuto illegittimo, ma ha riconosciuto l’impossibilità di recupero retroattivo per oggettiva difficoltà . Questo ha spinto il legislatore a modificare dal 2013 la norma, richiedendo la destinazione esclusiva “non commerciale” dell’immobile per l’esenzione IMU . La Cassazione, ancor prima, aveva “anticipato” un’interpretazione conforme al diritto UE: in sentenze del 2020 (SU 7497/2020, SU 8094/2020) ha sancito che per riconoscere l’esenzione fiscale l’attività svolta nell’immobile deve essere concretamente non commerciale, evidenziando come neppure la perdita economica né la natura religiosa dell’ente bastano a qualificare l’attività come non imprenditoriale, se c’è un pagamento ed organizzazione dei servizi . Queste pronunce riguardano l’ICI/IMU, ma il concetto influenza anche l’IVA: è il medesimo discrimine di cui sopra (attività a pagamento → economica). Dunque in difesa di un ente ecclesiastico, può essere utile citare che la legge nazionale e l’orientamento eurounitario oggi sono chiari: solo le attività svolte con modalità effettivamente non di mercato possono godere delle esenzioni. Ciò però rafforza anche la posizione del Fisco quando contesta abusi: ad esempio, se una casa religiosa affitta camere ai turisti su Booking.com con regolarità, è arduo sostenere che non sia attività commerciale. Un eventuale accertamento IVA su tale attività troverebbe fondamento in questi principi di Cassazione e CGUE.
Enti religiosi vs altri enti non profit: differenze e analogie fiscali
Gli enti religiosi, come sottolineato, condividono molti aspetti fiscali con altri enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ONLUS, APS, ecc.), ma presentano anche particolarità. Nel predisporre la difesa, può essere utile confrontare il trattamento degli enti religiosi con quello di altri enti, per evidenziare eventuali disparità non giustificate (da far valere magari in via equitativa) o al contrario per mostrare che l’ente religioso rientra in categorie agevolative previste anche per altri (segno che il legislatore intendeva agevolare quel tipo di attività indipendentemente dal soggetto).
Ecco un confronto sintetico su alcuni punti chiave:
| Aspetto | Ente religioso civilmente riconosciuto | Altro ente non commerciale (laico) |
|---|---|---|
| Qualifica fiscale di “ente non commerciale” | Per legge non decade mai (art. 149(4) TUIR): l’ente ecclesiastico resta non commerciale anche se l’attività commerciale divenisse prevalente in un anno . Ciò però non lo esenta dal tassare le singole attività commerciali svolte. | Può decadere se l’attività commerciale diviene prevalente (art. 149(1-3) TUIR), perdendo le agevolazioni. Eccezione: ONLUS e APS godono di analoga protezione (norme speciali) finché rispettano requisiti di legge. |
| Disciplina IVA operazioni verso soci | Fino al 2025: esclusione da IVA per servizi ai soci in conformità alle finalità istituzionali, come per associazioni laiche (art.4 c.4 DPR 633/72) . Dal 2026: stesse operazioni considerate esenti IVA (art. 10 nuovo testo) . | Identica disciplina di cui sopra: la norma riguarda tutte le associazioni di tipo associativo (politiche, culturali, sportive, religiose, ecc.). Dunque nessuna differenza: l’oratorio parrocchiale e il dopolavoro laico sino al 2025 escludono IVA sui servizi ai soci, e dal 2026 li esentano. |
| Agevolazioni IVA settoriali | Può beneficiare di esenzioni se svolge attività meritevoli (didattiche, sanitarie, assistenziali) alle stesse condizioni di altri enti. Non ha esenzioni IVA “ad hoc” solo per status religioso. | ONLUS/APS: godono di esenzioni analoghe (educative, assistenziali) se rientrano nei requisiti. Alcune categorie (ASD sportive) hanno esenzione per sport dilettantistico verso associati. In generale, le esenzioni IVA di art.10 valgono per tutti i soggetti qualificati (pubblici o privati senza scopo di lucro). |
| Riduzione aliquota IRES (fuori tema IVA, ma rilevante per contesto) | Sì, art. 6 DPR 601/73: enti ecclesiastici con fini di religione/culto equiparati agli enti di beneficenza o istruzione, aliquota IRES dimezzata (12% anziché 24%) sui redditi da attività istituzionali e connessi . Nota: spetta solo se immobile/ecc. usato direttamente per fini istituzionali non commerciali . | Enti non commerciali laici: aliquota IRES dimezzata spetta a ONLUS, APS, enti di beneficenza o istruzione riconosciuti (l’ente deve rientrare in art. 6 DPR 601). Non spetta a società o enti commerciali. Sul punto, quindi, enti ecclesiastici godono della stessa agevolazione delle ONLUS , ma devono rispettare i requisiti (finalità di culto/istruzione e personalità giuridica) . |
| Esenzione IMU/TASI su immobili | Esenzione se immobile destinato esclusivamente a attività non commerciali di culto, educative, assistenziali, ricettive non commerciali, ecc. (norma vale per tutti gli enti non commerciali). L’ente religioso ha spesso immobili categoria E/7 (edifici di culto) esenti per legge quando destinati al culto. Se usati in parte commerciale perde esenzione su quella parte. | Uguale: qualsiasi ente non commerciale (fondazione laica, APS, ecc.) fruisce esenzione IMU per immobili usati esclusivamente per attività non commerciali previste (sociali, sanitarie, didattiche…). Nessuna differenza, salvo che per gli enti religiosi vi è l’attività specifica di culto equiparata ai fini esentativi. |
| Obbligo di contabilità separata (IVA e redditi) | Sì, devono separare attività commerciali da istituzionali. Normativa generale (art. 144 TUIR, art. 19 DPR 600/73) + richieste giurisprudenziali . Anche Terzo Settore impone agli enti religiosi di tenere contabilità separata per attività “diverse” (art. 4 co.4 CTS) . | Stessi obblighi per enti non profit laici: contabilità separata per eventuale attività commerciale (art. 144 TUIR). Per APS/ONLUS il requisito era già previsto (rendiconti separati per attività de-commercializzate). D.lgs. 117/2017 (CTS) impone contabilità e bilancio per ETS e separazione se ente misto. |
| Soggettività ONLUS/ETS | Ente ecclesiastico non è ONLUS di diritto (non incluso in elenco art. 10 co.8 D.Lgs. 460/97) . Può creare ramo ONLUS o costituire enti partecipati ONLUS/ETS per attività caritative. Può iscriversi al RUNTS come “ente religioso civilmente riconosciuto” limitatamente attività di Terzo Settore (CTS art. 4). | ONLUS (fino al 2022): categoria di enti laici o religiosi (se iscritti) con agevolazioni fiscali ampie (esenzioni imposte indirette, donazioni deducibili). Dal 2022-25 transito in ETS: enti religiosi ammessi nel RUNTS con “patrimonio destinato” a attività di interesse generale . Quindi il quadro normativo tende a parificare trattamenti fiscali su base attività, non più sul tipo religioso o meno. |
Come si vede, le differenze sono più di forma che di sostanza: un ente religioso, per godere di molte agevolazioni extra-culto (istruzione, beneficenza), deve di fatto dotarsi degli stessi requisiti richiesti a un ente laico (es. diventare ONLUS/ETS, ottenere riconoscimenti per scuole e ospedali, ecc.). L’ordinamento italiano riconosce comunque una specificità all’ente ecclesiastico in quanto tale, ma più in àmbito civilistico (personalità giuridica riconosciuta senza seguire il Codice Civile, ecc.) che strettamente tributario. In tribunale tributario non conta la spiritualità dell’ente, bensì la “sostanza economica” delle sue attività. Il giudice tributario normalmente accerterà se l’ente religioso ha operato al pari di un ente non profit laico dello stesso settore e applicherà le stesse regole. Ad esempio, un asilo gestito da suore avrà lo stesso trattamento fiscale di un asilo gestito da una fondazione laica benefica; un negozio di souvenirs in una basilica paga l’IVA come un normale negozio in franchigia, e così via.
Per la difesa, questo confronto può essere utile per: – richiamare prassi o risoluzioni dell’Agenzia Entrate emesse per altri enti non profit, applicabili analogicamente all’ente religioso; – invocare sentenze relative ad associazioni laiche su concetti di non commercialità, per analogia; – evidenziare eventuali disparità di trattamento (ad es. se l’Ufficio fosse più severo con l’ente religioso rispetto a come tratta situazioni analoghe laiche, cosa rara ma ipotizzabile).
Va anche notato che la Corte Costituzionale è intervenuta talvolta su questioni tributarie relative a enti religiosi. Ad esempio, la sentenza n. 20/2025 ha dichiarato inammissibile una questione sull’IMU per immobili ad uso misto (commerciale e non) di enti ecclesiastici , perché nel frattempo il legislatore aveva chiarito la norma consentendo l’esenzione parziale. La Consulta ha però in passato affermato il principio della neutralità e parità di trattamento degli enti di culto rispetto ad altri enti non commerciali, salvo la peculiare finalità religiosa (sent. 346/2003, 2004/2007 su esenzioni). Ciò significa che un ente religioso non dev’essere discriminato, ma nemmeno privilegiato indebitamente rispetto a enti laici analoghi, sul piano fiscale . Questo equilibrio è lo sfondo di tutte le controversie. Per cui, in sede di ricorso, difficilmente pagherà sostenere argomentazioni di carattere “ideologico” (tipo: “la Chiesa è esente perché così prevede il Concordato”): occorre invece dimostrare che l’ente rientra nelle stesse condizioni previste per qualunque ente non profit che svolga quell’attività meritevole, e che l’amministrazione fiscale eventualmente non ha riconosciuto un’esenzione che la legge prevede. Diversamente, se l’agevolazione richiesta non è testualmente prevista, difendersi è molto arduo (il giudice applicherebbe il principio di tassatività delle esenzioni, potendo semmai sollevare questione comunitaria o costituzionale, ma è raro).
Nel prossimo capitolo entreremo nel vivo delle strategie difensive e degli strumenti di tutela a disposizione dell’ente religioso quando riceve un avviso di accertamento per indebite agevolazioni IVA.
Accertamento tributario e strumenti di difesa per l’ente religioso
Quando un ente religioso riceve un avviso di accertamento IVA dall’Agenzia delle Entrate che contesta agevolazioni indebitamente fruite (esenzioni non spettanti, IVA non applicata, aliquote errate, detrazioni non dovute), è fondamentale attivarsi prontamente e in modo organizzato. In questa sezione vediamo come si struttura l’accertamento e quali strumenti difensivi l’ordinamento mette a disposizione, dal contraddittorio iniziale fino al ricorso in Commissione (ora Corte) Tributaria.
Il procedimento di accertamento: verbale e avviso
Prima dell’avviso di accertamento, di solito vi è stata una verifica fiscale o un controllo documentale. Spesso, per enti non profit, l’attività istruttoria può coinvolgere la Guardia di Finanza, che redige un Processo Verbale di Constatazione (PVC) in caso di accesso, oppure la Direzione provinciale Entrate che invia questionari o inviti. È importante che l’ente religioso, in sede di verifica, faccia presenti le proprie peculiarità: ad esempio, segnalare chiaramente quali attività sono a pagamento e quali no, fornire copia di statuti, delibere, autorizzazioni e documenti utili a inquadrare correttamente l’attività. Ogni dichiarazione resa o omissione in sede di verifica poi si riflette nell’accertamento.
L’avviso di accertamento IVA è l’atto formale con cui l’Ufficio rettifica la dichiarazione IVA (o contesta omessa dichiarazione) e chiede il pagamento della maggiore imposta dovuta, più interessi e sanzioni. Deve essere motivato: cioè indicare i fatti, le norme violate e i calcoli effettuati. Ad esempio, un avviso potrebbe dire: “L’ente ha indebitamente qualificato come esente art. 10, n.20 DPR 633/72 i corrispettivi riscossi per attività di doposcuola, non rientrando tale attività tra quelle esenti in quanto non effettuata da istituto scolastico riconosciuto. Si recupera IVA per € X (aliquota 22%) oltre sanzione 90% per infedele dichiarazione”. Oppure: “Contestata l’applicazione dell’IVA 4% anziché 10% sulle fatture di costruzione dell’oratorio, mancando i requisiti di cui alla Tabella A parte II DPR 633/72 n.__; IVA dovuta a conguaglio € Y”. Leggere con attenzione la motivazione è il primo passo: capire cosa esattamente viene contestato e su quale base normativa.
Talvolta, specie per annualità recenti, prima dell’avviso l’ufficio invia un PVC o un invito a comparire per accertamento con adesione, o una contestazione di violazioni: vale la pena aderire a tali inviti, se non altro per comprendere la posizione dell’Ufficio e fornire chiarimenti.
Una volta notificato l’avviso, l’ente ha tipicamente 60 giorni per reagire (termine per presentare ricorso). In questo periodo, si aprono alcune opzioni:
- Istanza di autotutela: è una richiesta all’Ufficio di annullare o rettificare in via di autotutela l’atto, se vi sono errori evidenti (ad es. l’accertatore ha ignorato una norma o un documento decisivo). È uno strumento graciativo: l’Amministrazione non è obbligata ad accogliere, e raramente lo fa in casi controversi di merito. Però, se l’ente individua un errore palese (es: l’avviso dimentica che l’ente era ONLUS iscritta, cosa documentabile), vale la pena inviare subito un’istanza ben argomentata con i documenti, chiedendo l’annullamento. L’autotutela non sospende i termini di ricorso, quindi va fatta subito e comunque predisposto il ricorso se non giunge risposta tempestiva o positiva.
- Accertamento con adesione: è lo strumento deflativo principale. Consiste in una procedura di confronto con l’ufficio per raggiungere un accordo sul contenuto dell’accertamento. L’ente deve presentare un’istanza di adesione prima che scadano i 60 giorni (anche l’ultimo giorno utile va bene). L’effetto immediato è che i termini di impugnazione si sospendono per 90 giorni, dando respiro. Durante questo periodo, l’ufficio convocherà l’ente (o i suoi professionisti) per un incontro. Quando conviene l’adesione? Quando l’ente riconosce almeno in parte la fondatezza della pretesa e vuole limitare danni (riduzione sanzioni a 1/3) o quando vuole negoziare alcuni aspetti (ad es. avere uno sconto su una parte contestata in cambio dell’accettazione del resto). Esempio: se l’ente sa di aver effettivamente sbagliato aliquota IVA su un lavoro ed è incontestabile, in adesione può puntare a farsi annullare o ridurre la sanzione (che scende al 1/3 del 90%, quindi 30%, più un ulteriore abbuono di 1/3 sulla somma delle sanzioni in caso di perfezionamento). Oppure, se l’accertamento copre più annualità o più issue, si può trattare: magari l’ufficio rinuncia a una annualità borderline se l’ente paga le altre. È importante arrivare all’adesione con una chiara strategia: sapere quali elementi di prova presentare, fin dove spingersi nelle concessioni. Se si raggiunge un accordo, si redige un atto di adesione con l’importo concordato, che va poi pagato (imposta + interessi + sanzione ridotta). In caso di adesione, non si può ricorrere poi in commissione su quanto pattuito. Se la trattativa fallisce, l’ente riceve comunicazione di esito negativo e i 60 giorni di ricorso decorrono di nuovo (tenendo conto della sospensione). Nel nostro contesto, l’adesione può essere proficua se, ad esempio, la controversia è su quantificazioni (quanto imponibile era commerciale e quanto no) – un accordo può “spaccare la differenza”. Se invece la divergenza è solo giuridica (es. l’ente dice esente, l’ufficio dice imponibile) e non emergono margini di compromesso, difficilmente l’ufficio aderirà al punto di vista del contribuente senza sentenza.
- Sospensione e misure pre-contenzioso: per gli atti emessi fino al 2023, se il valore era modesto (fino a €50.000 di imposta), era obbligatorio presentare un reclamo/mediazione prima del ricorso, contenente un’eventuale proposta di conciliazione. Dal gennaio 2024 questa procedura è stata abrogata per i nuovi ricorsi . Quindi, per gli avvisi notificati dal 2024 in poi (come sarà il caso di molti accertamenti su 2021-2022), si può ricorrere direttamente senza la trafila del reclamo. Ciò velocizza la tutela giurisdizionale. In ogni caso, l’ente può sempre chiedere all’ufficio una soluzione bonaria anche dopo aver presentato ricorso, tramite l’istituto della conciliazione giudiziale (ne parliamo a breve). Un altro aspetto: l’ente potrebbe aver necessità di sospendere l’esecuzione dell’avviso se le somme richieste sono elevate e vi è rischio iscrizione a ruolo. L’avviso di accertamento per IVA diventa esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica: significa che, scaduto quel termine, l’Agenzia può già iscrivere a ruolo la metà delle imposte contestate + interessi (o un terzo se si tratta di esigibilità differita) e avviare la riscossione coattiva, anche se c’è ricorso pendente, a meno che il contribuente non ottenga una sospensiva. Dal 2022 il pagamento è sospeso automaticamente per importi fino a 3.000 euro in caso di ricorso, ma per importi superiori l’ente deve chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare dell’atto, dimostrando fumus boni iuris (motivi fondati) e periculum in mora (danno grave dalla riscossione immediata). Nel predisporre il ricorso, valutare se chiedere la sospensione: se la somma è grande e l’ente ha pochi mezzi, conviene farlo contestualmente al ricorso. Il giudice fisserà in tempi brevi un’udienza per decidere sulla sospensione (entro 180 gg di regola, ma spesso più celermente se c’è urgenza).
Il ricorso in Commissione (Corte) Tributaria
Se non si è definito prima, l’ente dovrà presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuovo nome dal 2023 delle ex Commissioni Tributarie Provinciali). Il ricorso è un atto scritto, con cui si chiede l’annullamento (totale o parziale) dell’accertamento, spiegando i motivi di diritto e di fatto.
Redazione del ricorso: conviene impostarlo in modo chiaro e didattico, considerando che spesso i giudici tributari potrebbero non essere ferratissimi in materia di enti non profit. Esporre quindi i fatti dettagliatamente: natura e scopi dell’ente, attività svolte, come si sono svolte, quali importi e trattamenti fiscali, e poi la normativa e giurisprudenza a sostegno. Nel caso di indebite agevolazioni IVA, i motivi di ricorso tipici possono essere: – Violazione di legge – es: l’ufficio ha applicato male una norma. Ad esempio, “errata applicazione dell’art. 4 DPR 633/72”: il ricorrente spiegherà che l’ufficio ha considerato commerciale un’attività che invece rispettava le condizioni di non commercialità previste dalla norma (citando eventuali circolari o sentenze pertinenti). – Errata qualificazione dei fatti – es: l’ufficio ha inquadrato l’attività come “prestazione di servizi generica” mentre era un servizio di istruzione esente ex art.10. Qui si tratta di convincere che i fatti (documenti, contesto) rientrano in una categoria esente. – Insubordinazione alle direttive UE – in qualche caso, si può invocare direttamente la direttiva IVA a favore: per esempio, se l’ente avesse prestato servizi strettamente connessi alla religione e la legge italiana non prevedesse l’esenzione, si potrebbe eccepire la diretta applicabilità dell’art. 132, lett.l) Dir. IVA. Questo è però difficoltoso poiché quella disposizione non è self-executing (lascia margini agli stati). Comunque si può citare il principio UE per interpretare la norma domestica in senso conforme (la Cassazione ha parlato di interpretazione eurounitariamente conforme in materia di esenzioni IMU ). Ad esempio: interpretare “attività didattiche esenti” includendo anche corsi para-religiosi se finalizzati a diffusione della religione, ecc. È un’opera di persuasione che può far presa se motivata. – Vizi procedurali – es: mancata allegazione di documenti, difetto di motivazione (se l’avviso non spiega chiaramente perché nega l’esenzione), mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (in materia di tributi non armonizzati serve, per IVA teoricamente non obbligatorio salvo verifiche in cui era previsto). Questi motivi vanno sempre valutati: se l’atto è carente di motivazione (ad es. si limita a dire “attività commerciale” senza spiegare perché non ritiene valide le finalità di culto addotte), si può dedurre nullità per motivazione insufficiente. Raramente le CTP annullano per questo se un po’ di motivazione c’è, ma vale la pena inserirlo come motivo subordinato.
In sede di ricorso, l’onere della prova ricade in parte sul contribuente: l’ente deve produrre documenti che provino la sua versione. Ad esempio: statuto, regolamenti interni, bilanci, delibere, contratti, ricevute delle “offerte” contestate, lettere esplicative inviate ai partecipanti (per mostrare che era contributo volontario), convenzioni con enti pubblici (a riprova di riconoscimento), certificati (di scuola paritaria, di ONLUS, ecc.), fotografie o materiale che mostri la natura non commerciale di un’attività (non è insolito allegare foto dei locali per far vedere che non sono attrezzati commercialmente, etc.). Nel processo tributario vige il principio di libertà di prova, quindi tutto quel che può convincere i giudici è utile.
Udienza e decisione: nella giurisdizione tributaria la presenza personale non è obbligatoria; il difensore può chiedere decisione in camera di consiglio. Tuttavia, date le peculiarità di questi casi, è spesso opportuno chiedere un’udienza pubblica per poter spiegare a voce i punti salienti e rispondere a eventuali dubbi. All’udienza, il difensore dell’ente potrà sottolineare che l’ente non perseguiva finalità lucrative, citare frasi chiave di Cassazione (abbiamo visto prima molte, su cui costruire una arringa), e magari chiarire eventuali aspetti tecnici. Dopo l’udienza, la Corte Tributaria emette la sentenza. Se la sentenza accoglie il ricorso, annulla (in toto o in parte) l’accertamento; se lo rigetta, l’ente deve valutare l’appello.
Gradi successivi: appello e Cassazione
Il contenzioso può proseguire in secondo grado presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale). L’appello va presentato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. In appello si possono riproporre i motivi, contestare errori della CTP, e portare nuovi documenti (ammissibili fino a 20 giorni prima dell’udienza d’appello, salvo il giudice li escluda per colpa grave). Nel frattempo, per evitare che l’ente debba pagare, occorre sospendere la sentenza se sfavorevole: la presentazione dell’appello non blocca automaticamente la riscossione, a meno che la CTP abbia accolto e annullato l’atto (in tal caso l’ufficio appella e chiederà sospensione). In genere, se il primo grado è perso, bisogna versare almeno 1/3 del dovuto per poter appellare (art. 15 D.Lgs. 546/92 modificato dalla riforma 2022). È una novità: la riforma prevede che per impugnare la sentenza di primo grado che ha confermato un tributo, il contribuente debba versare un importo pari al tributo non sospeso (solitamente 1/3 residuo, dato che 2/3 erano già dovuti prima in pendenza). Questo per spingere alla definizione transattiva. In parallelo, l’ente può chiedere alla CTR la sospensione dell’esecutività della sentenza.
L’appello è un riesame nel merito: è possibile portare nuove argomentazioni, ma non nuovi motivi completamente estranei. Si può tuttavia enfatizzare aspetti non colti dal primo giudice. Ad esempio, se la CTP ha negato l’esenzione perché “la retta non era simbolica”, in appello si può cercare di dimostrare con perizie o dati che in realtà la retta copriva appena i costi (fornendo conti economici analitici). Si possono anche chiamare testimoni nel processo tributario? Formalmente no (salvo documenti già in atti, prove testimoniali non ammesse), ma si può allegare dichiarazioni scritte di terzi, con valore indiziario.
Dopo l’appello, resta il ricorso in Cassazione (Corte di Cassazione, sezione tributaria) per soli motivi di diritto. Ad esempio, se la CTR ha applicato male la legge o è andata contra legem. Nel contesto “enti religiosi vs IVA”, potrebbero emergere questioni di massima (es. interpretazione di art. 4 DPR 633 pre/post riforma, compatibilità col diritto UE, ecc.) meritevoli di Cassazione. La Cassazione può anche decidere di investire la Corte di Giustizia UE con rinvio pregiudiziale, se c’è dubbio interpretativo di norma UE (ad esempio sulla portata di art. 132 lett.l direttiva IVA). Finora, per quanto noto, non ci sono pronunce della CGUE specifiche su IVA e enti religiosi italiani: la CGUE si è espressa sul trattamento fiscale come aiuto di Stato (caso Scuola Montessori c. Commissione 2018) e su aspetti di imposte indirette locali, ma sul campo IVA stretto no, segno che la materia è stata gestita internamente.
In ogni caso, arrivare fino alla Cassazione è dispendioso e lungo (può richiedere vari anni). Per questo, durante il giudizio si può valutare la conciliazione giudiziale: è un accordo transattivo tra contribuente e Agenzia che può avvenire in primo grado (con sanzioni ridotte al 40%) o in appello (sanzioni al 50%). Ad esempio, se in primo grado la CTP sembra orientata male, il contribuente potrebbe proporre una conciliazione per chiudere a metà strada: paga parte dell’IVA, elimina il rischio di sconfitta totale, con sanzione ridotta del 60%. La conciliazione richiede il benestare della controparte (Agenzia) e l’approvazione del giudice con apposito verbale. È uno strumento poco usato ma con la riforma 2022 si vuole incentivarlo. L’ente potrebbe considerarlo soprattutto se la controversia verte su importi non altissimi e c’è incertezza sull’esito.
Sanzioni applicabili e loro riduzione
Un ente religioso, quando viene accertato per IVA non versata o indebitamente detratta, incorre nelle sanzioni tributarie amministrative previste dal D.Lgs. 471/1997. In particolare: – Omesso versamento IVA (art. 13 D.Lgs. 471/97): se l’ente ha dichiarato ma non versato, 30% dell’imposta non versata (ma in caso di accertamento normalmente c’è anche infedele dichiarazione). – Dichiarazione infedele (art. 5, c.4): se l’ente non ha dichiarato ricavi imponibili IVA o li ha esposti come esenti indebitamente, la sanzione è dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. L’ufficio di solito applica il minimo (90%). Dunque per ogni 100€ di IVA contestata, 90€ di sanzione base. – Operazioni esenti dichiarate come imponibili (caso opposto, rarissimo qui): sarebbe indebita detrazione, punita col 90% dell’IVA detratta non spettante (art. 6 comma 6). – Aliquota errata: è equiparato a infedele se comporta minore imposta (anch’esso 90%). Spesso in accertamento trovate formule tipo “sanzione art.5 c.4 D.Lgs 471/97 pari al 90%, ridotta a 1/3 in caso di adesione”. – Violazioni formali: se l’ente non aveva separate contabilità, potrebbe aver violato obblighi contabili, ma queste sanzioni sono minori (da €250 a €2.000) e spesso assorbite.
Ci sono circostanze che possono mitigare le sanzioni: – Se l’ente definisce in acquiescenza (paga senza ricorrere entro 60 gg), le sanzioni sono ridotte a 1/3 (quindi 30%). Idem se definisce con adesione, come visto. – Se l’ente aveva dubbi interpretativi seri e la materia era incerta, si può chiedere l’applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa (art. 6, co.2 D.Lgs. 472/97) per escludere la sanzione. Questo è un argomento difensivo: bisogna provare che effettivamente la norma era poco chiara o controversa, magari citando prassi contraddittorie. Ad esempio, sulla definizione di “attività commerciale” per enti religiosi, prima della riforma 2021 c’era chi poteva interpretare in modo estensivo l’art.4. Se l’ente ha seguito una certa interpretazione poi risultata errata, potrebbe invocare che c’era incertezza (p.es. prima delle circolari ministeriali 2009 sugli enti non commerciali, alcuni aspetti erano fumosi ). Non è facile ottenere l’annullamento sanzioni per questo motivo, ma la Cassazione ammette che in presenza di obiettiva incertezza (es. contrasti giurisprudenziali risolti solo dopo il comportamento tenuto) la sanzione va esclusa. – Cause di non punibilità: se l’ente è incappato in violazione per forza maggiore o altro (difficile in materia IVA), oppure se ha già pagato spontaneamente prima dell’accertamento (ravvedimento operoso: allora l’accertamento nemmeno dovrebbe esserci se ravveduto). – Ravvedimento operoso: se l’ente si accorge dell’errore prima di ricevere controlli, può sanare pagando l’IVA dovuta con sanzione ridotta (fino a 1/5 se ravvede tardivamente ma prima di notifica accertamento). Questo però esula dalla fase contenziosa (è prevenzione). Nella fase successiva ormai non c’è ravvedimento.
Nei casi di enti religiosi, di solito si cerca almeno di ottenere la riduzione delle sanzioni, facendo leva su buona fede, mancanza di scopo di lucro (non c’era intento evasivo), cooperazione durante la verifica, etc. L’Agenzia può in adesione ridurre al 90%→30%, e oltre non va. In giudizio, il giudice può ridurre discrezionalmente la sanzione se la ritiene manifestamente eccessiva rispetto alla gravità (principio di proporzionalità europeo). Ad esempio, se l’ente erra su €1.000 di IVA e si becca €900 di sanzione, si può chiedere almeno la riduzione al minimo o sotto (la giurisprudenza consente riduzioni solo entro i minimi edittali però, quindi 90% è il minimo edittale in infedele, non può scendere salvo cause esimenti). Comunque, chiedere la non applicazione per tenuità non è possibile (non c’è soglia di punibilità, tranne che alcune violazioni formali).
E per fortuna qui non si profilano sanzioni penali: l’IVA non versata può costituire reato di omesso versamento IVA se supera €250.000 per anno (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), ma se l’ente non ha nemmeno addebitato l’IVA (perché si riteneva esente), non c’è il reato di omesso versamento (poiché formalmente non dichiarato come dovuto). Potrebbe casomai ipotizzarsi una dichiarazione fraudolenta se uno simula status non profit per evadere, ma è scenario estremo e non si applica di solito a enti religiosi genuini. Quindi, a differenza di altri tributi, le contestazioni IVA agli enti religiosi raramente sfociano nel penale (a meno di frodi organizzate tipo false ONLUS, ma è fuori dal nostro scenario tipico).
Riassumendo gli strumenti di difesa: – In sede pre-contenziosa: autotutela, adesione, eventuale mediazione (fino 2023), accordo bonario. – In sede contenziosa: ricorso motivato, richiesta sospensiva, produzione prove, utilizzo conciliazione se utile, appello se necessario, e riserva di ricorrere fino in Cassazione su punti di diritto (per questo è bene inserire già nei motivi eventuali questioni di legittimità o di diritto UE, altrimenti in Cassazione potrebbero considerarle nuove).
Nel prossimo capitolo, offriremo una sezione Domande e Risposte per chiarire i dubbi più comuni in materia, seguita da alcuni casi pratici simulati che illustrano in concreto come potrebbe svolgersi la difesa di un ente religioso in specifiche situazioni.
Domande frequenti (FAQ)
D: Un ente religioso deve aprire partita IVA per svolgere attività istituzionali (messe, catechesi, oratorio)?
R: No, le attività di religione o di culto in sé non configurano esercizio d’impresa e non richiedono partita IVA. L’ente religioso operante solo nel proprio ambito spirituale/istituzionale non è un soggetto passivo IVA. Deve invece aprire partita IVA (ed emettere fatture o scontrini) se inizia a svolgere attività commerciali abituali: ad esempio, gestisce una libreria, un servizio di ristoro a pagamento, affitta regolarmente sale dietro corrispettivo, organizza viaggi a pagamento, ecc. In questi casi l’ente, pur restando “non commerciale” nel complesso, agisce come soggetto IVA per quelle specifiche attività. È possibile che l’ente abbia doppia posizione: codice fiscale per attività istituzionali e partita IVA per quelle commerciali (con contabilità separata) .
D: Le offerte libere raccolte in chiesa o per servizi pastorali sono mai soggette a IVA?
R: No, le offerte volontarie a fronte di atti religiosi (messe, benedizioni, sacramenti) o anche di attività pastorali (ritiri, corsi spirituali) non costituiscono corrispettivi contrattuali, quindi sono fuori dal campo IVA. Questo vale anche se c’è un importo “suggerito” (stipendio messe, offerta per battesimo) purché non vi sia obbligo giuridico di pagare quella somma. Se invece di un’offerta libera si configurasse un vero pagamento imposto per un servizio, l’operazione potrebbe assumere natura commerciale. Ma per consuetudine ecclesiale, i sacramenti e sacramentali sono offerti senza tariffa obbligatoria; pertanto nessuna IVA si applica. La Cassazione ha ribadito che l’attività di religione e culto non ha rilevanza tributaria in quanto tale .
D: Una scuola paritaria gestita da un ente religioso deve addebitare IVA sulle rette scolastiche?
R: No, se la scuola ha riconoscimento legale (paritaria o parificata), le rette scolastiche e in generale le prestazioni didattiche sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n.20, DPR 633/72 . Ciò include anche i servizi accessori strettamente connessi, come la mensa o il convitto, se forniti dalla stessa entità scolastica. Attenzione però: se la scuola non fosse riconosciuta (es. un doposcuola privato o corso generico di lingua gestito dall’ente senza riconoscimento), l’esenzione non si applicherebbe e le quote sarebbero imponibili (o considerate operazioni fuori campo solo se rese a soci in conformità finalità istituzionali dell’ente associativo, aspetto che però dal 2026 va in esenzione anch’esso). In pratica, scuole paritarie = esenti IVA, corsi non riconosciuti = imponibili salvo incasellarli nelle agevolazioni del Terzo Settore dal 2026.
D: Se un ente religioso svolge attività commerciale (es. vende oggetti religiosi), perde le sue agevolazioni o la qualifica di ente non commerciale?
R: No, l’ente mantiene la qualifica di ente non commerciale (per legge, gli enti ecclesiastici non perdono tale status neppure se l’attività commerciale divenisse temporaneamente prevalente ). Continuerà a godere delle agevolazioni su attività istituzionali (es. IRES ridotta, esenzioni IMU sugli immobili destinati al culto, ecc.). Tuttavia, sulle attività commerciali specifiche dovrà pagare le imposte come qualsiasi impresa (IVA, IRES su quel reddito, IRAP se applicabile). Inoltre, se l’attività commerciale diventa molto rilevante, l’ente potrebbe essere più sorvegliato e dover organizzare contabilità separata rigorosa. In caso di abusi o mancanza di separazione, il Fisco può tassare tutte le entrate dell’ente (come avvenuto in alcuni casi estremi). Ma in generale, fare un po’ di attività commerciale lecita non fa perdere all’ente i benefici sulle sue altre attività. Ad esempio, una parrocchia con un piccolo negozio di libri paga l’IVA e le tasse sul negozio, ma resta non commerciale per il resto e la chiesa rimane esente IMU, ecc.
D: Un ente religioso può scegliere di non applicare IVA alle sue attività commerciali sostenendo che sono marginali o che i proventi sono usati per la missione?
R: No, non è a discrezione dell’ente. Se l’attività rientra tra quelle imponibili per legge, l’IVA va applicata a prescindere dalla destinazione “buona” dei proventi. La legge già tiene conto della missione prevedendo esenzioni per certe attività socialmente rilevanti. Ma se una data attività non rientra in alcuna esenzione, l’ente non può unilateralmente considerarla fuori campo solo perché i soldi vengono usati a fini istituzionali. Ad esempio: la gestione di una casa per ferie dietro corrispettivo, rivolta a chiunque, è attività d’impresa turistico-ricettiva: non importa se l’utile finanzia l’oratorio, deve emettere ricevute con IVA 10%. L’ente non può “auto-qualificare” tutto come istituzionale – se lo fa, è suscettibile di accertamento e recupero imposta. In sintesi: la volontà di lucro soggettiva è irrilevante ai fini IVA ; conta la natura oggettiva dell’attività.
D: In caso di accertamento, l’ente religioso rischia anche sanzioni penali o solo amministrative?
R: Nella maggior parte dei casi, trattandosi di violazioni IVA relative ad agevolazioni, si ricade nell’ambito amministrativo. Le sanzioni penali tributarie (D.Lgs. 74/2000) colpiscono omessi versamenti IVA oltre soglia (€250k) e frodi fiscali. Un ente religioso che erroneamente non applica l’IVA credendo in buona fede di essere esente, di solito verrà sanzionato al 90% amministrativo ma non incriminato penalmente. Potrebbe configurarsi reato solo se vi fosse una condotta fraudolenta (es. emissione di fatture false, uso di artifici per simulare attività non commerciali quando non è vero). Ma questo è raro e doloso. Diverso è l’omesso versamento: se l’ente, pur avendo dichiarato IVA dovuta, non la versa e supera la soglia, allora i legali rappresentanti potrebbero rispondere del reato di omesso versamento. Tuttavia, più spesso l’ente in queste situazioni non aveva proprio dichiarato l’IVA (ritenendola non dovuta), dunque non c’è reato di omesso versamento. In conclusione, nella difesa di solito non c’è risvolto penale, concentrandosi tutto sul piano tributario (salvo casi eccezionali).
D: Se l’ente religioso riceve un avviso di accertamento IVA, deve pagare subito?
R: No, l’avviso concede 60 giorni per pagare o impugnare. Se l’ente fa ricorso entro 60 giorni, la riscossione è sospesa fino a sentenza di primo grado. Fa eccezione la quota di imposta che diventa esecutiva: attualmente la norma prevede che decorso il termine, l’AE può riscuotere il 1/3 delle imposte accertate (non le sanzioni) anche in pendenza di giudizio. Però se si chiede e ottiene una sospensione dal giudice tributario, anche quel terzo viene bloccato. Quindi, presentando ricorso e istanza di sospensione, l’ente in genere non paga nulla finché la Commissione non decide sulla sospensiva (di solito la concedono se il caso è dubbio e l’importo elevato in rapporto alle capacità dell’ente). Se invece l’ente non fa ricorso né adesione, dopo 60 giorni l’avviso diventa definitivo: a quel punto occorre pagare (eventualmente fruendo della rateazione in 8 rate se importo alto). Quindi è fondamentale non ignorare l’avviso: o trovare un accordo o impugnarlo, altrimenti si cristallizza il debito.
D: Quali documenti e prove sono più utili per difendersi in giudizio?
R: Dipende dal caso, ma in genere per provare la natura non commerciale di un’attività valgono: – Lo Statuto dell’ente e l’atto di riconoscimento (mostra finalità di culto e non lucrative). – I bilanci/rendiconti che evidenzino come i proventi contestati sono stati impiegati e la presenza o meno di utili. – Le ricevute e attestazioni delle somme versate: es. se i genitori versavano “offerta doposcuola” con una certa causale, allegarle per mostrare che erano donazioni e non fatture. – Le convenzioni o autorizzazioni pubbliche: es. decreto scuola paritaria, iscrizione Anagrafe ONLUS, convenzione con ASL per casa di riposo – tutti cruciali per rientrare nelle esenzioni. – Corrispondenza e materiale informativo: volantini, lettere ai fedeli, in cui magari si parla di “offerta suggerita” e non di prezzo – ciò dimostra l’intenzione. – Testimonianze scritte: dichiarazioni di frequentatori, se del caso, per avvalorare che un pagamento era volontario. Anche se non testimonianza formale (non ammessa), può far capire al giudice il contesto. – Normativa e prassi: copie di circolari dell’AdE rilevanti, risoluzioni e la giurisprudenza di riferimento (Cassazione, CGUE, Corte Cost.) già pronte per essere esaminate.
In pratica, occorre costruire un dossier che dia al giudice tributario il quadro completo sia giuridico (norme, sentenze) sia fattuale (come operava concretamente l’ente). Spiegare anche “come funziona” l’organizzazione religiosa (non tutti i giudici sanno cos’è ad es. una Caritas parrocchiale o come si finanzia un oratorio). Meglio educarli nel ricorso, così da indurli a comprendere la buona fede e meritevolezza dell’ente.
D: I recenti cambiamenti normativi (riforma Terzo Settore e DL 146/2021) come impattano gli enti religiosi sul fronte IVA?
R: La riforma incide in due modi: 1. Dal 2026 le attività verso pagamento rese dagli enti associativi (religiosi compresi) non saranno più fuori campo ma esenti o imponibili a seconda dei casi . Per gli enti religiosi ciò significa adeguarsi alla nuova disciplina, ma anche che eventuali contestazioni su periodi ante 2026 vanno lette alla luce del vecchio regime. Ad esempio, un accertamento per il 2025 su quote dei soci potrebbe imputare IVA laddove l’ente era convinto di essere fuori campo: ci sarà argomentazione su norma transitoria e buona fede visto che la legge stava cambiando. Dal 2026 comunque l’ente dovrà fatturare queste operazioni (anche se esenti) e non potrà più ometterle dalle dichiarazioni IVA. 2. L’ingresso nel Terzo Settore: enti religiosi possono iscriversi al RUNTS come “enti religiosi civilmente riconosciuti” limitatamente alle attività di interesse generale (art. 4 CTS) . Se lo fanno, beneficeranno (a regime, probabilmente dal 2024/26) di un regime fiscale nuovo: ad esempio alcune attività istituzionali diventeranno esenti IVA per espressa previsione (quelle ex art. 5 CTS). Quindi in futuro avremo enti religiosi-ETS che, se rispettano i requisiti, saranno trattati come ONLUS erano: esenzione IVA su molte attività di solidarietà, e possibilità di optare per regime 398/91 (forfettone) per attività commerciali minori. Questo è ancora in evoluzione. In breve: per ora, l’ente deve gestire con cura il periodo di transizione normativa (2023-2025) dove la situazione non è cristallina e il Fisco potrebbe sfruttare i ritardi attuativi per fare contestazioni (come l’infrazione UE citata ). Aggiornarsi tramite professionisti e linee guida CEI è essenziale.
D: Conviene sempre fare ricorso contro un accertamento o ci sono casi in cui è meglio pagare?
R: Se l’accertamento è chiaramente fondato e l’ente riconosce l’errore, spesso conviene definire subito (adesione o acquiescenza) per godere delle forti riduzioni sanzionatorie (sanzioni al 30% in acquiescenza) e magari evitare spese di lite. Ad esempio, se l’ente ha applicato 0% IVA su vendite di gadget e l’ufficio recupera IVA 22%: non c’è molto da discutere giuridicamente. In tal caso, cercare un accordo sull’importo ed evitare il giudizio (che aggiungerebbe semmai anche spese). Viceversa, se l’ente ritiene di avere buone argomentazioni o se la somma è enorme e metterebbe in crisi l’ente, allora vale la pena ricorrere. Spesso, nelle situazioni miste, la strategia potrebbe essere: aderire parzialmente (sui punti inconfutabili) e ricorrere sui punti controversi se separabili. La normativa consente di definire anche solo alcuni rilievi dell’avviso in adesione e lasciare gli altri al contenzioso. Inoltre, in primo grado non vi è condanna alle spese se il ricorso è parzialmente accolto: quindi un tentativo può costare poco (solo il contributo unificato). In sintesi, valutare con il proprio consulente: – Probabilità di vittoria (in base a prove e giurisprudenza): se alta, ricorrere. – Importo in ballo: se basso, magari pagare per chiudere (anche costi/benefici). – Effetti collaterali: a volte l’ente preferisce evitare la pubblicità negativa di un processo vs Fisco (ma i processi tributari non sono mediatici in genere). – Stato delle finanze: se l’ente non può pagare comunque, tanto vale ricorrere e guadagnare tempo o sperare nell’annullamento.
Nel dubbio, una strada è avviare l’adesione (che sospende termini) e intanto preparare il ricorso; se l’adesione non offre un esito soddisfacente, depositare il ricorso.
Passiamo ora ad alcuni casi pratici simulati, che aiuteranno a comprendere come questi principi si applicano a situazioni reali e quali linee difensive possono adottarsi.
Casi pratici e simulazioni
Di seguito presentiamo quattro scenari ipotetici ispirati a vicende tipiche, illustrando l’approccio difensivo dal punto di vista dell’ente religioso (debitore) di fronte a contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Caso 1: Oratorio parrocchiale con attività ricreative a pagamento
Scenario: La Parrocchia “San Giorgio” organizza per i ragazzi dell’oratorio attività pomeridiane (doposcuola, tornei sportivi) chiedendo ai genitori un contributo mensile fisso di 30€ per coprire le spese. Non viene emessa fattura né scontrino, ritenendo che sia un’attività istituzionale dell’oratorio. A seguito di verifica, l’Agenzia contesta che tali contributi in realtà sono corrispettivi per servizi educativi/ricreativi e andavano assoggettati a IVA (al 22% in mancanza di esenzione specifica). Notifica quindi un avviso chiedendo IVA evasa per gli ultimi 4 anni, sanzione 90% e interessi.
Punti di discussione: Qui l’ente ha fatto leva sull’art. 4 DPR 633/72 (esclusione operazioni verso associati). Tuttavia, attenzione: l’oratorio non ha uno status di associazione distinto (è parte della parrocchia) e i ragazzi non sono formalmente “soci” di un ente associativo con finalità ricreative (a meno che la parrocchia avesse un circolo NOI, CSI o simili). L’AE contesta probabilmente che manca un’entità giuridica associativa distinta e che comunque i 30€ mensili configurano un corrispettivo, non una liberalità. Inoltre, l’attività – pur di finalità formativa – non rientra nell’esenzione scolastica (non è scuola riconosciuta). Dunque, dal punto di vista normativo l’Ufficio potrebbe avere ragione.
Difesa dell’ente: In sede di adesione, la parrocchia potrebbe evidenziare che i proventi servivano solo a coprire i costi vivi (fotocopie, merende, luce) e che nessun utile veniva tratto. Fornire magari i conti da cui risulta pareggio di bilancio. Questo per chiedere clemenza sulle sanzioni (obiettiva incertezza e buona fede). Si potrebbe anche sostenere che l’attività era rivolta ai “tesserati” del gruppo oratorio (se c’è qualche forma di tesseramento via CSI o simili) quindi soggetta a decommercializzazione. Se l’ufficio è rigido, in adesione conviene puntare almeno a ottenere la riduzione delle sanzioni (1/3).
Se si passa al ricorso, la parrocchia argomenterà che: – Giuridicamente, l’oratorio svolge finalità di catechesi e formazione umana, coerenti con quelle di culto; i contributi erano volti al mero recupero spese, senza margine di lucro (da provare con bilanci) . – Richiamerà l’art. 4 c.4 DPR 633 e dirà che i giovani partecipanti erano parte della comunità parrocchiale, quindi assimilabili a “associati” (questa è un’interpretazione estensiva, non garantita, ma da provare). – In subordine chiederà quantomeno di applicare l’esenzione come attività educativa extra-scolastica: la riforma dal 2026 la prevede, a testimoniare che il legislatore intende tali attività meritevoli di non tassazione . Quindi suggerirà una lettura evolutiva già ora. – Allegherà dichiarazioni dei genitori magari, attestanti che il 30€ era facoltativo in caso di difficoltà economiche (se era così). – Potrebbe invocare la Circolare Min. Finanze n.2/DF 2009 che per l’ICI definiva non commerciali le attività svolte in modo gratuito o simbolico, sottolineando che nel novero rientra anche l’oratorio (in quel contesto, come indice di mancanza di fine lucrativo) .
L’obiettivo è convincere i giudici che, se anche formalmente c’è stata una violazione, la sanzione vada annullata per buona fede e magari l’imposta limitata. Ad esempio, potrebbero riconoscere che 30€ mensili a testa è cifra modica, e forse rientra nella sfera “istituzionale”. Non v’è certezza di vittoria. Se il ricorso viene respinto sul tributo, si potrebbe almeno ottenere la riduzione sanzione a 0 per incertezza (non garantito).
Esito possibile: Dato l’importo modesto per ragazzo, l’Ufficio potrebbe in adesione proporre di chiudere facendo pagare l’IVA sugli ultimi anni ma sanzione ridotta al minimo. La parrocchia deciderebbe se accettare. In un eventuale giudizio, la decisione dipenderà dalla sensibilità del collegio: alcune CTP potrebbero dire “era attività commerciale – paga IVA”, altre potrebbero accogliere la buona fede. In Cassazione casi simili (16345/2008) han dato ragione al Fisco sostenendo la necessità di verifica concreta .
Lezione: per il futuro, la parrocchia dovrebbe formalizzare quell’attività sotto un’associazione di fedeli con statuto (o affiliarsi a un ente di promozione sociale cattolico), così da rientrare appieno nel regime agevolato (dal 2026 esente, prima escluso) ed emettere ricevute non fiscali come contributi associativi. La prevenzione organizzativa è la miglior difesa.
Caso 2: Casa per ferie gestita da istituto religioso
Scenario: L’Istituto “Figlie di S. Maria” gestisce presso il proprio convento una casa per ferie aperta a ospiti esterni (turisti, pellegrini). Richiede un contributo di 25€ a notte con colazione. Non applica IVA ritenendo trattarsi di “ospitalità religiosa” collegata alla finalità di accoglienza. Dopo un controllo (magari su segnalazione di albergatori locali per concorrenza sleale), l’Agenzia constata che la casa per ferie ha incassato ad esempio €100.000 in un anno senza addebitare IVA, mentre avrebbe dovuto applicare IVA al 10% (servizi turistici). Emana accertamento per IVA evasa 10k, più sanzioni e interessi.
Analisi: Giuridicamente, l’ospitalità a pagamento di non indigenti è considerata prestazione di alloggio, soggetta a IVA 10%. Non rientra in esenzioni (non è assistenza ai bisognosi se accoglie turisti paganti). L’istituto potrebbe sostenere che i proventi servono al proprio sostentamento e all’opera religiosa, ma come sappiamo ciò non rileva per l’imponibilità .
Difesa possibile: In assenza di appigli normativi forti, una strada è verificare se l’istituto rientrava in qualche convenzione con enti pubblici (es. ospitalità di pellegrini per giubileo, ecc.) – poco probabile. Oppure se qualche ospite era soggetto svantaggiato (accoglienza di gruppi disabili a prezzo ridotto, ecc.) – anche se fosse, è parziale. L’istituto può puntare a ridurre i danni: – Mostrare di non aver agito con dolo: spesso le case religiose sono convinte (erroneamente) di stare in ambito di liberalità. Citiamo magari documenti della CEI che un tempo lasciavano intendere che l’ospitalità dietro offerta fosse permessa (c’è stato vuoto normativo fino al 2011 quando s’è regolamentato con art. 91-bis DL 1/2012 l’obbligo di frazionare spazi commerciali e non) . – Se la casa per ferie non ha licenza commerciale ma solo comunicazione di attività non imprenditoriale (in alcune regioni, gli istituti religiosi comunicano così la loro ospitalità), sfruttare questo per dire che anche la PA locale li considerava diversi dagli hotel. Non incide fiscalmente, ma testimonia incertezza del quadro – che può giovare per chiedere annullamento sanzioni (obiettiva incertezza). – Proporre in adesione di pagare l’IVA dovuta (magari su imponibili ridotti se riesce a provare che qualche ospite non ha pagato il contributo – es. sacerdoti ospitati gratis) e chiedere sanzioni al minimo o condono delle stesse.
Se ricorre: – Ribadirà buona fede e incertezza, allegando magari che in passato qualche ufficio del turismo locale rassicurava che le case religiose non facevano attività d’impresa (ci sono stati casi così). – Potrebbe azzardare l’argomento che la direttiva IVA art. 132 lett.g (servizi assistenziali esenti) avrebbe dovuto includere anche l’accoglienza spirituale, ma l’Italia non ha previsto tale esenzione – ciò crea discriminazione ingiustificata rispetto a ONLUS che gestiscono ostelli gratis. Onestamente, è un argomento debole: l’attività in questione è palesemente economica.
Esito probabile: L’istituto difficilmente eviterebbe di pagare l’IVA: l’infrazione è abbastanza netta. Però c’è buon margine di ottenere sanzioni ridotte. Spesso in questi casi l’Agenzia in adesione propone sanzione 30% e chiusura. Forse è meglio accettare. In tribunale, alcune commissioni hanno in passato annullato sanzioni a enti religiosi su quest’ospitalità ritenendo che fino a chiarimenti del 2012 la situazione fosse confusa (c’erano contenziosi IMU analoghi: se la retta era modica, magari l’ente pensava di rientrare nell’esenzione). Quindi, se la vicenda riguarda anni pre-2012, l’ente può far leva sul cambiamento normativo avvenuto (introduzione art. 91-bis DL 1/2012 che impone distinzione spazi commerciali negli immobili misti) . Ciò prova che prima la norma era lacunosa.
Prevenzione: Ormai è chiaro: chi fa ospitalità dietro pagamento deve avere partita IVA, registri e fatturazione (magari regime 5% forfetario se APS dal 2024 possibile, ma comunque in regola). L’istituto, se volesse continuare, potrebbe costituire un’associazione di promozione sociale per la gestione della casa per ferie destinando eventuali utili a finalità civiche: nel 2026 i soggiorni rivolti ai soci APS potrebbero forse rientrare in operazioni esenti verso soci (ma se sono turisti qualunque, no). In pratica, se l’attività è di fatto come un B&B, va trattata come tale.
Caso 3: Ristrutturazione di una chiesa con IVA agevolata
Scenario: Una diocesi appalta i lavori di restauro di una vecchia chiesa parrocchiale. L’impresa emette fatture con IVA 10% (ritenendo si tratti di intervento di recupero edilizio su immobile storico destinato a pubblica funzione). L’Agenzia, in un controllo successivo, afferma che l’aliquota corretta doveva essere il 22% perché la chiesa non è “abitazione” né intervento previsto dalla Tabella agevolazioni (a loro dire). Chiede quindi alla diocesi (come responsabile d’imposta in solido, eventualmente) o più probabilmente all’impresa, la differenza IVA 12%. La diocesi viene coinvolta perché qualora l’impresa risultasse inadempiente, il Fisco può rivolgersi al committente per il maggior tributo non pagato (c’è un art. 60 DPR 633 in tal senso se la fattura evidenzia IVA inferiore al dovuto).
Analisi: Le opere su edifici di culto tradizionalmente godevano di IVA ridotta, ma in effetti non c’è una voce chiarissima in Tabella A parte III che citi “chiese”. L’impresa ha applicato 10% forse equiparando a restauro di edificio assimilato ad abitazione civile o in base a prassi regionale. L’Agenzia qui fa un’interpretazione rigorosa: se l’immobile non è abitativo, gli interventi di recupero ordinari vanno al 22. Chi ha ragione? Non c’è una disposizione esplicita pro chiese, ma si può argomentare che: – La chiesa è bene culturale vincolato (se lo è): c’è una norma nel codice beni culturali che prevede IVA ridotta? Non esplicitamente, ma spesso Ministero beni culturali stipula accordi con MEF per finanziamenti includendo IVA 10 su restauri. Non automatico però. – Oppure, come è stato fatto: considerare la chiesa come se fosse un edificio pubblico (poiché aperto alla collettività). Non esiste norma chiara, ma c’è l’idea di urbanizzazione secondaria.
Difesa: La diocesi difenderebbe che: – L’aliquota 10% è prassi consolidata per lavori su edifici di culto, richiamando magari la Risoluzione ministeriale 124/E del 1996 (se esiste qualcosa del genere) o interpelli di altre regioni. – Presenterebbe la chiesa come opera di urbanizzazione secondaria per cui l’impresa poteva applicare 10%. Ad esempio, citando il d.m. 2/8/1969 n. 765 che equipara chiese a opere di urbanizzazione (questo vale per esenzione oneri, ma tentare). – Sottolineerebbe che la stessa Agenzia, in analoghi casi (se ci sono risposte a interpello recenti) ha ammesso l’IVA ridotta. Si potrebbe cercare se l’Agenzia ha mai risposto su IVA chiese; in genere su riviste c’è indicazione che 10% è pacifico per restauro chiese (es. “Manutenzioni sugli immobili di culto: aliquota IVA” di qualche ufficio CEI). – Se la parrocchia ha ottenuto contributo pubblico per restauro, spesso quei contributi prevedono IVA 10% ammissibile: è un argomento per dire che la P.A. considerava quell’IVA dovuta al 10.
A mali estremi, la diocesi chiederà quantomeno la non applicazione di sanzioni per obiettiva incertezza, data la matassa normativa delle aliquote edilizie dove neanche i tecnici concordano facilmente.
Esito previsto: Non raro che su queste questioni le Commissioni diano ragione ai contribuenti, specie se in passato l’IVA 10% su chiese era tollerata. Potrebbero riconoscere che la chiesa, pur non abitazione, è edificio a finalità sociale e propendere per interpretazione estensiva di “fabbricati non di lusso” includendola, oppure sfruttare la norma di favore del 4% per nuove costruzioni di chiese (se era ristrutturazione però, non nuova costruzione). La Cassazione non pare abbia un pronunciamento netto su IVA restauro chiese; se non c’è, c’è margine per convincere.
Nota: questo caso evidenzia come l’ente religioso deve prima definire col fisco l’aliquota: sarebbe opportuno fare un interpello prima dei lavori. In assenza, se c’è contestazione, usare tutti i canali (anche mediazione se fosse in vigenza) per far valere la buona fede. L’impresa esecutrice magari si unisce nella difesa (dato che pure lei rischia).
Caso 4: Vendite occasionali per raccolta fondi
Scenario: Un convento di suore produce marmellate e oggetti artigianali, vendendoli durante un open day annuale al pubblico per raccolta fondi pro missioni. Incasso medio 5.000€ annui. Nessuna IVA né scontrino, considerato attività di raccolta fondi occasionale. L’Agenzia durante un controllo vede movimentazioni e ritiene che comunque sia vendita di beni e quindi imponibile (aliquota 22% su oggetti, 10% su alimentari). Contesta IVA evasa su 3 annualità (circa 1.000€ di IVA/anno) più sanzioni.
Analisi: La legge consente a ONLUS/ODV di fare raccolte fondi occasionali esenti da imposte (art. 143 TUIR). Per IVA, però, l’esclusione art. 4 non menziona le raccolte fondi a non soci (il pubblico generico). Dunque, formalmente vendere marmellate a benefattori è cessione imponibile, a meno di considerarla estranea per mancanza di sinallagma (ma c’è, pagano in cambio del bene anche se per beneficenza).
Difesa: – Argomento chiave: “atto di liberalità”. Si può dire che i prezzi erano simbolici e i compratori più che altro facevano una donazione ottenendo in cambio un omaggio. Per reggere, è utile mostrare che nessun prezzo fisso era imposto, ma “offerta minima suggerita”. Se c’era un listino vero, più difficile. – Invocare l’art. 2-bis D.Lgs. 460/97 (ONLUS) analogo per enti religiosi? Purtroppo quell’articolo esentava solo ai fini imposte dirette. Però si può far leva sullo spirito della norma: il legislatore favorisce le raccolte fondi occasionali, quindi punire con IVA va contro tale spirito. Dal 2024, gli ETS avranno esenzione IVA per vendite occasionali? Non esplicito, ma potrebbero fruire di regime forfettario. – Sottolineare la occasionalità e assenza di organizzazione: un solo evento l’anno, tutto volontarie, nessuna struttura stabile di vendita. Ciò per dire: non c’è “attività economica organizzata” ex art. 2082 c.c., rifacendosi a Cassazione – se l’attività è del tutto gratuita (qui non gratuita ma molto sporadica) non è impresa . – Quantomeno, chiedere clemenza sanzioni: è un tipico caso di incertezza. Molti pensano (anche professionisti) che vendite pro beneficenza siano fuori campo. L’Agenzia su questo è stata rigida ma qualche giudice potrebbe definire la sanzione non dovuta per buona fede.
Possibile esito: Data la cifra modesta, magari l’Agenzia stessa in sede di reclamo (se fossimo ante 2024) potrebbe proporre annullamento per antieconomicità (non vale la pena perseguire €3k di imposta in 3 anni? Anche se con sanzioni arriva a 6k). In giudizio, c’è la possibilità che i giudici accolgano la tesi della non imponibilità perché l’evento non aveva natura commerciale continuativa. Non c’è però una norma chiara da citare tranne analogie con ONLUS. Molto dipende dalla narrazione: se appare come “le suore vendono prodotti come un mercatino”, rischia di essere imponibile; se appare come “festa di beneficenza con donazioni in cambio di gadget”, potrebbero propendere per non tassare (magari qualificando il tutto come operazioni occasionali escluse per carenza di abitualità – la definizione di attività d’impresa in IVA richiede una certa abitualità, sebbene concetto più di imposte dirette).
Strategia: evidenziare che non vi era scopo di lucro soggettivo né oggettivo, i margini erano nulli (se sommiamo il lavoro volontario il valore dei beni era alto, quindi in realtà i 5k manco coprono il tempo – far emergere ciò). E citare magari sentenze dove si dice che “non ogni attività economica sporadica integra soggettività passiva IVA, serve organizzazione e continuità”. In diritto UE, una singola operazione isolata di vendita può non considerarsi attività economica abituale soggetta a IVA se non è inserita nell’attività professionale. Questo è un punto: le suore non vendono come professione, l’hanno fatto una volta l’anno – ergo potrebbe essere considerato fuori dal campo soggettivo (non agivano come soggetto passivo ma come privati che alienano beni autoprodotti occasionalmente). La linea non è facile, ma merita tentare.
Prevenzione: formalmente, per stare tranquilli, anche per raccolte fondi andrebbe emessa una ricevuta non fiscale o tenuto un registro. Il CTS prevede che gli ETS documentino le raccolte fondi. FiscO e prassi future potranno magari esentare quell’IVA, ma fino ad allora borderline. Un ente religioso può ridurre rischio accettando offerte senza dare beni in cambio, oppure dando beni di valore molto inferiore all’offerta, per configurare realmente la donazione.
Questi casi mostrano che la difesa dell’ente religioso richiede un mix di: conoscenza fine delle norme, raccolta di evidenze fattuali, e sensibilità nel presentare l’ente come sincero e meritevole, senza ovviamente pretendere immunità assoluta ma nemmeno subire interpretazioni fiscali troppo rigide. La giurisprudenza negli ultimi anni ha chiarito molte regole, ma ogni vicenda concreta fa storia a sé. È essenziale affidarsi a consulenti esperti di fiscalità degli enti non profit e, perché no, utilizzare le risorse disponibili (es. i Centri di Servizio per il Volontariato, uffici diocesani per i problemi giuridici, ecc.) per orientarsi.
Conclusione
La materia delle agevolazioni IVA per enti religiosi è complessa perché si pone al crocevia tra finalità ideali e norme fiscali generali improntate alla neutralità. Oggi, la tendenza del legislatore e della giurisprudenza è quella di riconoscere le agevolazioni solo entro limiti oggettivi precisi, evitando privilegi ingiustificati ma garantendo comunque supporto alle attività non profit di pubblica utilità. Dal punto di vista dell’ente religioso (debitore potenziale in un accertamento), ciò significa che: – Bisogna conoscere bene quali attività godono per legge di esenzione o non imponibilità e quali no, prima di operare, per poter rispettare gli obblighi IVA quando dovuti. – In caso di contestazione dell’Agenzia Entrate, occorre saper dimostrare con fatti concreti che le condizioni dell’agevolazione c’erano (attività effettivamente non commerciale, corrispettivi meramente simbolici, ecc.), poiché il Fisco tende a chiedere la prova rigorosa dei requisiti . – È fondamentale tenere una contabilità separata e trasparente: ciò non solo è richiesto dalle norme (ancor più con la riforma del Terzo Settore ), ma aiuta in sede di difesa a mostrare subito quali proventi sono da attività istituzionale e quali da attività commerciale, evitando che l’ufficio faccia di tutta l’erba un fascio. – In ogni fase (verifica, adesione, ricorso) adottare un atteggiamento collaborativo ma fermo: collaborativo nel fornire dati e riconoscere eventuali errori, fermo nel far valere i propri diritti ove si è nella ragione, citando norme e sentenze con competenza.
La giurisprudenza recente – dalle Sezioni Unite 2020 sulle scuole , alle ordinanze del 2021-2025 – traccia un quadro dove l’ente religioso è trattato alla pari di qualunque altro ente non profit in termini fiscali. Questo va tenuto a mente: nel merito del contenzioso non può essere invocata una “specialità religiosa” astratta, ma bisogna calare il discorso sui binari delle norme tributarie comuni (con la loro interpretazione teleologica). Semmai, l’elemento religioso può apparire nella valutazione dell’intento (un giudice potrebbe essere più benevolo nel credere alla buona fede di suore o preti che non puntavano al profitto personale). Ma la decisione finale si baserà su leggi e prove.
Una nota positiva è che il quadro normativo si sta semplificando e chiarendo: dal 2026 avremo meno zone grigie sul fronte IVA grazie all’eliminazione del regime di esclusione (che tanti dubbi ha generato ). Ci sarà più chiarezza su cosa è esente e cosa imponibile, e gli enti potranno uniformarsi. Nel frattempo, chiudere eventuali contenziosi pendenti con strumenti deflativi potrebbe essere saggio, per evitare di trascinarsi problemi del passato nel nuovo scenario.
In conclusione, “come difendersi” da accertamenti su indebite agevolazioni IVA significa soprattutto prevenire tali accertamenti attraverso una gestione fiscale accurata e, ove necessario, difendersi con cognizione di causa, armati di fonti normative aggiornate e pronunce autorevoli. Le sentenze di Cassazione e della Corte di Giustizia citate mostrano che la linea di confine tra attività non tassata e tassata è tracciata con rigore, ma anche che il sistema tributario riconosce il valore sociale delle opere religiose quando svolte senza deviazioni commerciali. L’ente religioso che opera con trasparenza, limitando le vere attività commerciali e documentando bene la propria missione solidaristica, si troverà in una posizione di forza sia per evitare contestazioni sia per vincerle, eventualmente, in giudizio.
Il panorama presentato in questa guida – fatto di norme, prassi e giurisprudenza aggiornate al 2025, con tabelle riepilogative e casi pratici – speriamo costituisca per i lettori (avvocati, consulenti e operatori di enti religiosi) un utile vademecum per navigare in sicurezza tra le complesse acque della fiscalità IVA, conciliando l’osservanza delle leggi con il proseguimento sereno delle finalità ideali e spirituali.
Fonti: Corte di Cassazione, Sez. Trib., sent. n. 16345/2008 ; Cass., ord. n. 25628/2021 ; Cass., Sez. Un., sent. n. 8094/2020 ; Corte di Giustizia UE, sent. 6/11/2018 (cause C-622/16 e C-623/16) ; D.P.R. 633/1972, art. 4 e art. 10 ; D.L. 146/2021, art. 5 commi 15-quater etc. ; Circolare AE n. 35/E 28.12.2023 ; Interpello AE n. 2/2025 ; Decreto Legislativo 117/2017 (Codice Terzo Settore), art. 4 e 79.
- Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25628 del 22/09/2021
- Ordinanza del 16/07/2020 n. 15248 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 6
- Cassazione, sez. trib. 20 marzo 2025, n. 7495
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestate agevolazioni IVA indebitamente utilizzate da un ente religioso? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestate agevolazioni IVA indebitamente utilizzate da un ente religioso?
Vuoi sapere cosa rischi e come puoi difenderti da queste contestazioni?
Gli enti religiosi possono accedere ad alcune esenzioni o regimi agevolati in materia di IVA, ma solo per attività istituzionali, assistenziali, educative o di culto. Se l’Agenzia delle Entrate ritiene che tali benefici siano stati applicati anche ad attività commerciali o lucrative, procede a contestare l’indebita agevolazione, con recupero delle imposte e sanzioni.
👉 Prima regola: dimostra con documenti chiari la distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale dell’ente.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Fatture emesse senza IVA per attività considerate commerciali;
- Esenzioni applicate a servizi non legati al culto o alle finalità istituzionali;
- Attività miste (istituzionali e commerciali) senza corretta separazione contabile;
- Utilizzo di beni e servizi agevolati per finalità non religiose;
- Mancata iscrizione al registro previsto per le ONLUS/ETS quando richiesta.
📌 Conseguenze della contestazione
- Recupero dell’IVA non versata;
- Sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta dovuta;
- Interessi di mora;
- Perdita temporanea delle agevolazioni fiscali;
- Rischio di ulteriori controlli su tutte le attività dell’ente.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Regolarità della contabilità separata tra attività commerciale e istituzionale;
- Natura delle operazioni contestate: rientrano davvero tra quelle imponibili?
- Autorizzazioni e riconoscimenti ufficiali dell’ente religioso;
- Documentazione interna: statuto, regolamenti, bilanci;
- Motivazione dell’accertamento: l’Agenzia ha portato prove concrete o solo presunzioni?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Statuto e atti costitutivi dell’ente religioso;
- Bilanci e rendiconti con contabilità separata;
- Contratti e fatture relative alle attività contestate;
- Documentazione delle finalità istituzionali (attività di culto, assistenza, istruzione);
- Comunicazioni ufficiali con l’Agenzia delle Entrate.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la natura istituzionale delle attività che hanno beneficiato dell’agevolazione;
- Contestare la riqualificazione come attività commerciale se priva di fondamento;
- Eccepire vizi formali dell’accertamento: motivazione carente, errori procedurali, decadenza dei termini;
- Richiedere autotutela se l’Agenzia non ha valutato la contabilità separata o i documenti già presentati;
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni per ridurre o annullare la pretesa.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza le operazioni contestate e la gestione contabile dell’ente;
📌 Verifica la corretta applicazione delle agevolazioni IVA;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
🔁 Suggerisce procedure preventive per una gestione fiscale trasparente degli enti religiosi.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in fiscalità degli enti non profit e religiosi;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni di indebite agevolazioni IVA;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle indebite agevolazioni IVA per enti religiosi non sempre sono corrette: spesso derivano da errori nella qualificazione delle attività o da presunzioni.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la corretta applicazione delle agevolazioni, mantenere i benefici fiscali ed evitare sanzioni ingiustificate.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti sugli enti religiosi inizia qui.