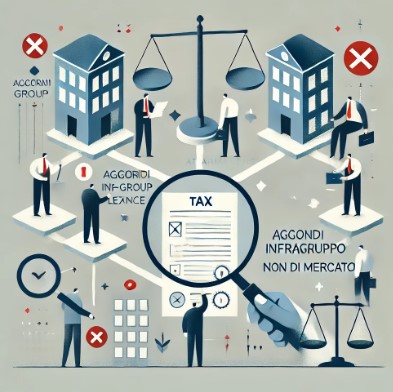Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché gli accordi infragruppo sono stati considerati non allineati ai valori di mercato? In questi casi, l’Ufficio presume che le condizioni pattuite tra società dello stesso gruppo non rispettino il principio di libera concorrenza (arm’s length principle), con l’effetto di ridurre artificialmente la base imponibile in Italia. La conseguenza è il recupero delle imposte, con applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: con una corretta difesa è possibile dimostrare la sostanza economica e la legittimità degli accordi.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta gli accordi infragruppo
– Se i prezzi applicati alle cessioni o prestazioni non sono in linea con quelli di mercato
– Se mancano contratti formali a supporto delle operazioni infragruppo
– Se i margini di utile delle società italiane risultano anomali rispetto al settore
– Se i costi addebitati da società estere non sono adeguatamente documentati
– Se gli accordi appaiono volti a spostare utili all’estero in Paesi a fiscalità più bassa
Conseguenze della contestazione
– Rettifica dei valori infragruppo e recupero dei maggiori redditi imponibili
– Applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione o abuso del diritto
– Interessi di mora sulle somme accertate
– Possibile rischio di doppia imposizione internazionale
– Attivazione di verifiche su ulteriori operazioni del gruppo
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare la conformità degli accordi infragruppo al principio di libera concorrenza
– Produrre transfer pricing documentation (Masterfile e Country File) aggiornata e completa
– Presentare analisi economiche e di benchmark a supporto dei prezzi praticati
– Contestare l’uso di metodi di ricostruzione non appropriati da parte dell’Agenzia
– Ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, attivare procedure contro la doppia imposizione (MAP)
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare gli accordi infragruppo e la documentazione prodotta dal gruppo
– Verificare la legittimità della contestazione e la correttezza dei metodi di valutazione adottati
– Redigere un ricorso fondato su prove documentali e vizi procedurali dell’accertamento
– Difendere la società davanti ai giudici tributari e nelle procedure internazionali
– Tutelare il gruppo da pretese fiscali indebite e da rischi reputazionali
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione o eliminazione delle sanzioni e degli interessi applicati
– Il riconoscimento della legittimità delle politiche infragruppo adottate
– La sospensione delle richieste di pagamento già avviate
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalle norme nazionali e internazionali
⚠️ Attenzione: le contestazioni sugli accordi infragruppo richiedono un’adeguata documentazione preventiva. Senza dossier di transfer pricing aggiornati, la posizione difensiva è molto più debole.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscalità internazionale – spiega come difendersi in caso di contestazioni su accordi infragruppo non di mercato e come tutelare i tuoi diritti.
👉 La tua società ha ricevuto una contestazione sugli accordi infragruppo? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo i contratti, confronteremo i valori con quelli di mercato e costruiremo la strategia difensiva più efficace per proteggere il tuo gruppo.
Introduzione
Gli accordi infragruppo – ossia contratti e operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo – sono una pratica comune nella gestione aziendale. Tuttavia, quando tali accordi non avvengono a condizioni di mercato, possono sorgere contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) o di altri soggetti come creditori e curatori fallimentari. In altre parole, se prezzi, condizioni o termini non riflettono quelli che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti, queste operazioni “in famiglia” rischiano di essere considerate anomale o abusive e quindi poste sotto la lente delle autorità competenti.
Le possibili conseguenze di tali contestazioni sono rilevanti: in ambito fiscale si va dal recupero di imposte e sanzioni amministrative, all’applicazione del principio del valore normale sulle transazioni infragruppo; in ambito civile e fallimentare, si può giungere alla dichiarazione di inefficacia verso i creditori degli atti compiuti (azione revocatoria), alla responsabilità risarcitoria della capogruppo ex art. 2497 c.c., fino a profili penali in caso di condotte distrattive o fraudolente (es. bancarotta). È quindi fondamentale, per chi opera all’interno di gruppi societari, comprendere il quadro normativo e adottare strategie difensive idonee a prevenire e, se necessario, contrastare tali contestazioni.
Questo guida, aggiornata ad agosto 2025, offre un’analisi approfondita ma dal taglio pratico su come difendersi dalle contestazioni relative ad accordi infragruppo non di mercato. L’esposizione è pensata per un pubblico di professionisti legali, imprenditori e privati interessati alla materia, con linguaggio giuridico preciso ma anche divulgativo. Troverete riferimenti alla normativa italiana vigente, alle più recenti sentenze di rilievo (Corte di Cassazione, anche Sezioni Unite, e corti tributarie) tratte da fonti autorevoli, oltre a tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione domande & risposte per chiarire i dubbi frequenti. Il punto di vista è quello del debitore/contribuente: l’obiettivo è spiegare come impostare correttamente gli accordi infragruppo e quali argomentazioni utilizzare in sede di difesa qualora l’operazione venga contestata.
Quadro normativo e definizioni generali
Per orientarsi nella materia, è necessario partire dai principi generali che regolano le operazioni infragruppo e la loro liceità. Bisogna considerare i profili fiscali (abuso del diritto, transfer pricing), i profili civilistici (tutela dei creditori, atti in frode alla legge), le disposizioni specifiche sui gruppi di società (direzione e coordinamento), nonché gli eventuali riflessi penalistici. Di seguito un inquadramento normativo essenziale.
Profili fiscali: abuso del diritto e valore normale
In ambito tributario, il principio cardine è che ogni operazione deve avere una sostanza economica reale e non essere volta unicamente a ottenere vantaggi fiscali indebiti. L’ordinamento ha codificato questo principio nella disciplina dell’abuso del diritto (o elusione fiscale) contenuta nell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal d.lgs. 128/2015 . Tale norma definisce abusive le operazioni “prive di sostanza economica che… realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”, individuandone gli elementi costitutivi: assenza di sostanza economica, conseguimento di un vantaggio fiscale indebito ed essenzialità di tale vantaggio . In breve, si ha abuso quando il contribuente utilizza strumenti giuridici leciti nella forma in modo artificioso e contrario alla ratio delle norme, ottenendo un risparmio d’imposta che la legge non avrebbe inteso concedere . Diversamente dall’evasione fiscale, che comporta una violazione diretta di legge (es. occultamento di ricavi, false fatture, ecc.), l’elusione rispetta formalmente le norme ma ne travisa lo scopo . La risposta dell’Amministrazione, in caso di operazione abusiva, è di disconoscerne i benefici fiscali e riqualificare i redditi secondo la sostanza, applicando imposte e sanzioni dovute (senza che ciò configuri reato tributario, come specifica l’art. 10-bis comma 13) .
Un concetto chiave collegato è quello di “valore normale” o arm’s length nelle transazioni infragruppo. In ambito internazionale, l’art. 9 dei Modelli OCSE (recepito in Italia nell’art. 110, comma 7 TUIR) impone che i prezzi tra società controllate in paesi diversi siano allineati a quelli che sarebbero praticati tra parti indipendenti (arm’s length principle). In ambito domestico, formalmente l’art. 110(7) TUIR non si applica alle operazioni tra consociate entrambe residenti in Italia . Ciò però non significa che tra controllate italiane vi sia “libertà di manovra” assoluta: la Cassazione ha riconosciuto da tempo un principio di transfer pricing interno, fondato sull’art. 9 TUIR, che consente al Fisco di valutare la correttezza dei prezzi infragruppo anche tra società residenti, nell’ottica di reprimere manovre antieconomiche volte a spostare basi imponibili . In altre parole, anche senza una norma specifica ad hoc, l’Amministrazione finanziaria può sindacare operazioni infragruppo interne se effettuate a valori palesemente non di mercato e senza valide ragioni economiche, qualificandole come antieconomiche e procedendo a un accertamento induttivo ex art. 39, co.1, lett. d) DPR 600/1973 . Questo orientamento è stato confermato da Cass. 5859/2024, che ha ribadito la non applicabilità dell’art. 110(7) TUIR in ambito domestico ma al contempo la facoltà del Fisco di verificare genuinità e congruità delle operazioni infragruppo nazionali in base al valore normale di cui all’art. 9 TUIR . Ciò implica, ad esempio, che vendite infragruppo a prezzi irrisori o prestazioni a corrispettivi “fuori mercato” possano essere contestate come antieconomiche, indipendentemente dal fatto che il risultato fiscale di gruppo sia neutrale. La logica di fondo, evidenziata dalla giurisprudenza recente, è che ogni società del gruppo è contribuente a sé e deve perseguire la propria redditività: il perseguimento di un generico “interesse di gruppo” non giustifica perdite o riduzioni di utili su singole società ai fini tributari . Dunque, se un’operazione non avrebbe senso per un imprenditore indipendente (perché comporta una perdita o una rinuncia a ricavi senza adeguato tornaconto), essa può legittimamente insospettire il Fisco. Le Circolari dell’Agenzia delle Entrate (es. Circ. 6/E/2016) hanno fornito esempi di schemi considerati abusivi, come il conferimento di asset seguito da cessione di partecipazioni al solo scopo di evitare la tassazione della plusvalenza – schema ora espressamente colpito dall’art. 10-bis . In definitiva, sul piano fiscale il farro è chiaro: non è vietato operare infragruppo, ma occorre che condizioni e finalità siano allineate al mercato e a logiche economiche genuine, altrimenti l’Amministrazione potrà disconoscere l’operazione o riqualificarla secondo la realtà dei fatti.
Onere della prova: in caso di contestazione fiscale su prezzi infragruppo anomali, l’onere probatorio è tipicamente ripartito. In materia di transfer pricing internazionale (art. 110(7) TUIR), la Cassazione ha chiarito che la norma non è un meccanismo anti-elusivo “speciale” che richiede al Fisco di provare un intento evasivo, bensì uno strumento per riallineare i redditi spostati: è sufficiente che l’Ufficio dimostri l’esistenza di transazioni a valori non di libera concorrenza, senza dover provare un vantaggio fiscale ulteriore . Spetta poi al contribuente, una volta contestata la difformità dai valori di mercato, giustificare le condizioni praticate e fornire evidenze a supporto (studi di comparabilità, documentazione di transfer pricing, ecc.) . Anche nelle operazioni infragruppo domestiche, la giurisprudenza richiede al contribuente uno sforzo probatorio significativo: ad esempio, per la deducibilità di costi da servizi infragruppo, non è sufficiente esibire il contratto o le fatture, ma bisogna provare in modo dettagliato e specifico l’utilità effettiva (o almeno potenziale) che la controllata ha tratto da quei servizi . La Cassazione, in più pronunce ravvicinate del 2024, ha imposto una linea rigorosa sul punto: contratti generici e documentazione lacunosa non bastano, servono elementi oggettivi (descrizione analitica delle attività svolte, personale impiegato, vantaggi conseguiti, ecc.) per riconoscere la spesa come inerente . In sintesi, il contribuente che voglia difendere la legittimità fiscale di un accordo infragruppo “non a valori di mercato” dovrà prepararsi a dimostrare concretamente le ragioni economiche dell’operazione e la sua coerenza con condizioni di libera concorrenza.
Profili civilistici: atti in frode alla legge e tutela dei creditori
Al di fuori dell’ambito tributario, anche il diritto civile offre strumenti per scrutinare e contrastare operazioni infragruppo che, pur formalmente lecite, producano effetti lesivi di interessi meritevoli di tutela (in primis quelli dei creditori). Un principio generale è il divieto di usare strumenti giuridici in frode alla legge (art. 1344 c.c.): un contratto, ancorché valido nella forma, è nullo se costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di norme imperative. Applicando questo concetto, un accordo infragruppo potrebbe essere considerato illecito se rappresenta un escamotage per violare indirettamente disposizioni di legge. Un esempio: una società fortemente indebitata trasferisce beni di pregio a un’altra società del gruppo al solo scopo di sottrarli alle azioni esecutive dei creditori. Formalmente è una compravendita (atto lecito), ma se il prezzo è irrisorio o comunque l’operazione è voluta unicamente per sfuggire ai creditori, essa potrebbe configurare un negozio in frode alla legge (violando il principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.) . In casi del genere, l’ordinamento predispone uno strumento ad hoc: l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). Tramite la revocatoria, un creditore pregiudicato da un atto del debitore può ottenerne la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, se ricorrono alcune condizioni: eventus damni (l’atto arreca pregiudizio alle sue ragioni) e, di regola, la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo contraente. Molte operazioni infragruppo “non a mercato” – specie trasferimenti di asset a titolo oneroso anomalo o a titolo gratuito – soddisfano questi presupposti, e infatti le revocatorie sono frequenti. Si pensi a una società che vende un immobile del valore di 1 milione alla consociata per soli 100 mila euro mentre sta accumulando debiti: i creditori potranno agire ex art. 2901 c.c. per rendere la vendita inopponibile e aggredire l’immobile in mano alla consociata, sostenendo (facilmente) che l’atto era pregiudizievole e che vi era collusione (trattandosi di operazione intra-gruppo, la consapevolezza del debitore è pacifica e quella dell’altro soggetto – essendo parte correlata – è presunta) . Anche atti solutori infragruppo (es. pagamenti anticipati di debiti verso società collegate) possono essere revocati se pregiudicano altri creditori e ricorrono i presupposti di legge (pagamenti a creditori chirografari entro 2 anni dalla fallimento, se insolvenza già esistente, ecc.).
Da notare che la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) può essere esercitata dal singolo creditore anche al di fuori di procedure concorsuali, mentre la revocatoria fallimentare (art. 66 R.D. 267/1942, ora art. 166 Codice della crisi d’impresa) è l’azione promossa dal curatore in caso di fallimento, soggetta a regole speciali e a termini più ampi o più stringenti a seconda dei casi (atti a titolo gratuito revocabili entro 2 anni, atti a titolo oneroso con parti correlate entro 1 anno, pagamenti preferenziali entro 6 mesi/1 anno, ecc.). Le operazioni infragruppo sospette rientrano spesso nel mirino del curatore fallimentare: ad esempio, la vendita a prezzo vilissimo di un bene a una società del gruppo, avvenuta nell’anno precedente il fallimento, potrà essere revocata come atto a titolo gratuito o comunque come atto in frode ai creditori . Le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente confermato che anche un’operazione societaria come la scissione può essere oggetto di revocatoria in quanto atto a titolo oneroso idoneo a pregiudicare i creditori: la sentenza n. 5089/2025 ha risolto ogni dubbio al riguardo, affermando l’ammissibilità della revocatoria dell’atto di scissione ex art. 2901 c.c., con competenza del tribunale delle imprese, mentre la revocatoria fallimentare della scissione spetta al tribunale fallimentare . In sostanza, anche complesse riorganizzazioni societarie non sfuggono alla regola: se l’operazione di gruppo lede la garanzia patrimoniale dei creditori, questi possono reagire in giudizio per neutralizzarla.
Gruppi societari e responsabilità ex art. 2497 c.c.
Nel diritto societario italiano esiste una disciplina specifica per le situazioni in cui una società subisce l’influenza dominante di un’altra nell’ambito di un gruppo. L’art. 2497 c.c. prevede la responsabilità della società (o ente) che esercita attività di direzione e coordinamento su altre società, qualora agisca violando i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle eterodirette, arrecando danno ai soci di queste ultime o ai loro creditori . In pratica, se la capogruppo (o un soggetto terzo che di fatto svolge funzioni di holding) impone scelte che avvantaggiano sé stessa o altre società del gruppo ma pregiudicano la redditività e il patrimonio di una controllata, potrà essere chiamata a risponderne. Si noti che la norma introduce una sorta di deroga al principio di autonomia patrimoniale: normalmente la capogruppo (se distinta come persona giuridica) non risponde dei debiti delle controllate, ma l’art. 2497 c.c. consente a soci di minoranza e creditori sociali della controllata di chiedere i danni alla capogruppo per averne leso il patrimonio. Ad esempio, se la holding fa vendere alla controllata un asset sottocosto a un’altra società del gruppo, svuotandola, i creditori della controllata potranno agire ai sensi dell’art. 2497 c.c. contro la holding per la lesione dell’integrità patrimoniale della società debitrice . Questa azione si affianca (e talvolta si cumula) con gli strumenti visti prima, come la revocatoria: il creditore potrebbe sia chiedere l’inefficacia dell’atto lesivo, sia il risarcimento del danno residuo.
La responsabilità ex 2497 c.c. è costruita in modo da incentivare una gestione di gruppo corretta: non vi è responsabilità infatti quando il danno risulta mancante “alla luce del risultato complessivo” dell’attività di direzione e coordinamento, ovvero sia integralmente eliminato da operazioni compensative . È il principio dei “vantaggi compensativi”: la capogruppo può anche indurre una controllata a sopportare un sacrificio nell’immediato, purché il disegno di gruppo nel suo complesso compensi quel sacrificio con benefici equivalenti in un ragionevole arco temporale. Se ad esempio la holding impone a una controllata di vendere sottocosto un bene a un’altra consociata, ma ciò è parte di un piano che consente poi alla controllata di ottenere nuovi mercati o vantaggi maggiori (tali da ripianare il danno), non scatterà responsabilità . Questo criterio è riconosciuto anche in sede penale: la Cassazione ha escluso il carattere distrattivo di un’operazione infragruppo ai fini della bancarotta fraudolenta quando esistano vantaggi compensativi che neutralizzano gli effetti negativi per i creditori . Ovviamente, la prova di tali vantaggi e del loro effettivo concretizzarsi spetta a chi invoca l’esimente. Nella pratica processuale, l’azione ex 2497 c.c. viene spesso esercitata dal curatore fallimentare in nome dei creditori (il comma 4 dell’art. 2497 c.c. prevede che, in caso di fallimento della società eterodiretta, l’azione dei creditori sia esercitata dal curatore) . Inoltre, la giurisprudenza ha elaborato figure come la “holding di fatto” o la supersocietà di fatto, per colpire situazioni in cui il controllo è esercitato non attraverso partecipazioni formali, ma tramite persone fisiche o intese occulte tra soci di diverse società. In tali casi, la holding occulta può essere dichiarata fallita anch’essa se viene provata l’esistenza di un unico centro d’interessi e la sua insolvenza (Cass. 5458/2023). Ad esempio, Cass. 5458/2023 ha ritenuto fallibile una holding occulte (di fatto) colpevole di abuso di direzione, con beni spostati tra società, estendendo il fallimento come supersocietà di fatto .
In definitiva, dal punto di vista civilistico, appartenere a un gruppo non esonera dal rispetto delle regole di correttezza verso i creditori e i soci di ogni singola società. Se un accordo infragruppo non a condizioni di mercato causa un depauperamento ingiustificato di una società a beneficio di un’altra, ci si espone a richieste risarcitorie ex art. 2497 c.c., oltre che alle altre azioni già viste.
Aspetti penalistici: reati fallimentari e fiscali
L’abuso del diritto in sé, per espressa previsione legislativa, non costituisce reato tributario. L’art. 10-bis, comma 13, dello Statuto contribuenti sancisce infatti che le operazioni abusive “non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie” . Ciò significa che un’elusione fiscale (ad esempio un’operazione intragruppo artificiosa finalizzata al risparmio d’imposta) comporterà il recupero delle imposte e sanzioni amministrative, ma non potrà, di per sé, portare a incriminazioni per reati come la frode fiscale o l’emissione di fatture false. Tuttavia, è bene fare attenzione: spesso lo stesso fatto che il Fisco contesta come abuso può presentare profili di reato se emergono elementi ulteriori, come l’uso di documenti falsi o lo svuotamento fraudolento di patrimoni sociali. Ad esempio, se per attuare uno schema elusivo intragruppo vengono create società fittizie all’estero con amministratori prestanome e false fatturazioni, si sconfina dall’elusione nell’evasione penalmente rilevante (possibile reato di dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti, art. 2 D.lgs. 74/2000). La Guardia di Finanza svolge un ruolo cruciale nel rilevare questi casi, indagando oltre il profilo civilistico-fiscale per individuare eventuali condotte fraudolente (come false comunicazioni sociali, emissione di false fatture, sottrazione di scritture, ecc.).
Il capitolo penalistico più rilevante nel nostro contesto riguarda però i reati concorsuali (fallimentari). Quando un’impresa fallisce, operazioni infragruppo che ne hanno depauperato il patrimonio possono essere qualificate come bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 comma 1 n.1 RD 267/1942, ora trasfusa nel Codice della crisi). Ad esempio, spostare liquidità o beni dalla società poi fallita a un’altra controllata, senza adeguato corrispettivo, equivale ad aver distratto (sottratto) risorse dai creditori, configurando un reato grave punito con la reclusione . Così anche il pagamento preferenziale di un debito verso una parte correlata poco prima del fallimento può integrare la bancarotta preferenziale. La giurisprudenza ha esaminato diversi casi: operazioni di scissione attuate per segregare asset e lasciare i debiti nella società destinata al fallimento hanno portato a condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva (es. Cass. pen. 46898/2012); analogamente, scissioni o fusioni che hanno favorito alcuni creditori interni al gruppo a scapito di altri hanno configurato ipotesi di bancarotta preferenziale (Cass. pen. 12477/2019). Di contro, in linea col concetto dei vantaggi compensativi, si è escluso il reato quando l’operazione infragruppo, pur formalmente un’anomalia, era accompagnata da elementi tali da riequilibrare la situazione a favore della società fallita .
Un tema delicato è quello delle “cassette fiscali” o società schermo utilizzate per fini illeciti. La Cassazione tributaria, con la sentenza n. 10305/2024, ha definito la società schermo come una costruzione di puro artificio creata al fine di conseguire indebiti benefici fiscali, tipicamente mediante catene di società prive di reale sostanza economica . Indici rivelatori sono: mancanza di un’effettiva organizzazione aziendale, assenza di un’attività economica prevalente nel paese dichiarato, pattuizioni infragruppo che obbligano a retrocedere profitti alla capogruppo, coincidenze temporali sospette nelle operazioni intercompany, e – in generale – l’esclusiva motivazione fiscale dell’operazione . In tali casi, oltre alle sanzioni fiscali (spesso con applicazione dell’art. 44 TUIR per tassare integralmente utili o dividendi provenienti da paradisi fiscali, ecc.), possono emergere profili penali per dichiarazione infedele o frode fiscale, specie se si ravvisa fittizietà nelle residenze o nelle transazioni (reato di esterovestizione o false rappresentazioni).
Da ultimo, occorre menzionare che alcune operazioni finanziarie infragruppo, se condotte nel rispetto di una formale regolamentazione contrattuale, possono escludere illiceità penale. Un esempio è il cash pooling (gestione accentrata della tesoreria di gruppo): i trasferimenti di cassa verso la capogruppo, che a prima vista potrebbero sembrare un drenaggio di liquidità, non costituiscono reato di bancarotta se inseriti in un accordo di cash pooling deliberato dagli organi sociali e con condizioni prestabilite (durata, limiti, interessi, ecc.) . La Cassazione penale ha infatti chiarito che i pagamenti infragruppo effettuati nell’ambito di un contratto di cash pooling non integrano bancarotta fraudolenta patrimoniale, a condizione che il contratto sia formalizzato e approvato dai CDA delle società coinvolte con tutti i dettagli operativi (Cass. pen. 39139/2023). Ciò evidenzia ancora una volta l’importanza di formalizzare e motivare adeguatamente le operazioni infragruppo: la trasparenza e la regolarità procedurale possono fare la differenza tra un’operazione lecita e una potenzialmente criminosa.
Riassumendo, dal punto di vista penale il semplice accordo infragruppo non di mercato non è di per sé un illecito penale, ma diventa critico quando coincide con comportamenti fraudolenti, dolosi o in violazione di doveri verso i creditori in situazione di insolvenza. In sede difensiva, dimostrare la buona fede degli amministratori e l’esistenza di ragioni legittime (documentate da pareri, delibere, consulenze) può aiutare ad escludere l’elemento soggettivo di eventuali reati .
Principali tipologie di operazioni infragruppo a rischio e relative difese
Esaminati i principi generali, passiamo alle principali tipologie di operazioni infragruppo che usualmente vengono contestate quando realizzate a condizioni non di mercato. Per ciascuna tipologia vedremo: una descrizione dell’operazione, i rischi di contestazione fiscale (abuso/elusione, transfer pricing, ecc.), i rischi per creditori e altri profili civilistici/penali, con eventuali esempi pratici, e soprattutto le strategie difensive e cautele da adottare per prevenire o contrastare le contestazioni. Le fattispecie esaminate includono: finanziamenti infragruppo (prestiti, cash pooling, garanzie), trasferimenti di beni (vendite o conferimenti intra-gruppo), prestazioni di servizi infragruppo (management fee, cost sharing), e operazioni straordinarie infragruppo (fusioni, scissioni, ristrutturazioni societarie). Ognuna di queste presenta peculiari profili di criticità, che analizziamo di seguito.
Finanziamenti infragruppo e movimentazioni finanziarie
Descrizione: I finanziamenti infragruppo consistono in trasferimenti di liquidità tra società collegate, ad esempio prestiti erogati dalla capogruppo a favore di una controllata (o viceversa), utilizzo di conti correnti infragruppo per regolare squilibri (come nel cash pooling), oppure finanziamenti infruttiferi (senza interessi) concessi tra consociate. In questa categoria rientrano anche le garanzie infragruppo (fideiussioni, lettere di patronage tra società del gruppo) e le compensazioni intercompany di crediti e debiti. Tali operazioni sono spesso finalizzate a sostenere finanziariamente le varie entità del gruppo in base alle necessità di tesoreria comune. Tuttavia, la struttura e le condizioni di questi finanziamenti possono sollevare dubbi se divergono nettamente da quelle che verrebbero praticate da finanziatori indipendenti sul mercato.
Rischi di contestazione fiscale: I finanziamenti infragruppo possono essere oggetto di rilievi fiscali principalmente per due motivi:
- Sottocapitalizzazione occulta: se i soci finanziano la società in modo abnorme al posto di apportare capitale, cercando magari di sfruttare la deducibilità degli interessi (che non avrebbero se conferissero capitale). In passato l’Italia aveva norme di thin capitalization che limitavano la deducibilità degli interessi verso soci qualificati; oggi quelle regole specifiche sono abrogate, ma esistono comunque limiti generali (interessi passivi deducibili entro il 30% dell’EBITDA) e soprattutto vale il principio dell’inerenza. Se un finanziamento soci appare in realtà come capitale mascherato – ad esempio perché la società era sottocapitalizzata al momento dell’erogazione – l’Agenzia potrebbe riqualificarne gli effetti (in certi casi contestando l’indebita deduzione di interessi come costo non inerente, oppure applicando l’art. 46 TUIR sulla postergazione utili ai soci). Inoltre l’art. 2467 c.c. già prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci in caso di sottocapitalizzazione, il che riflette una sfavorevole considerazione di tali pratiche.
- Non conformità al valore di mercato (tassi non arm’s length): se i finanziamenti infragruppo prevedono tassi di interesse troppo alti o troppo bassi rispetto al mercato. Un caso classico: una società italiana paga interessi elevatissimi su un prestito ricevuto da una consociata estera in paradiso fiscale, riducendo il proprio utile tassabile in Italia. Il Fisco, senza neppure dover invocare l’abuso del diritto, può applicare direttamente le regole sui prezzi di trasferimento: l’art. 110, co.7 TUIR consente di rettificare i corrispettivi infragruppo con l’estero al valore normale, tassando quindi solo interessi in linea con le condizioni di mercato . Ma anche in ambito interno, come visto, l’Ufficio può disconoscere la parte eccedente un tasso ragionevole per antieconomicità o mancanza di inerenza (art. 109 TUIR) . Ad esempio, se una controllata paga interessi al 10% alla holding mentre sul mercato avrebbe ottenuto prestiti al 3%, l’eccedenza 7% può essere contestata: per la controllata come costo indeducibile (non inerente), per la holding perfino come utile occulto distribuito (dividendo mascherato) se la differenza è qualificabile come provento privo di causa contrattuale . Importante anche il caso opposto, cioè finanziamenti infruttiferi: l’Agenzia delle Entrate a lungo ha sostenuto che in ambito internazionale anche il prestito a tasso zero configurasse un’anomalia da rettificare (imputando interessi figurativi al creditore italiano) – si pensi a una capogruppo italiana che presta senza interessi a una controllata estera, abbassando il suo reddito. La Cassazione, con la recente sentenza n. 7361/2024, ha chiarito che anche i finanziamenti infruttiferi rientrano nel campo del transfer pricing, ma che il contribuente può fornire ragioni commerciali di gruppo che giustifano l’assenza di interessi . In altre parole, l’operazione non è automaticamente illegittima: se la società prova che il prestito a tasso zero aveva una valida motivazione economica nell’economia del gruppo (es. sostenere una controllata in difficoltà, investimento strategico, ecc.), la rettifica fiscale potrebbe non essere dovuta . La Corte ha sottolineato che i giudici devono valutare caso per caso le condizioni finanziarie e comparare eventualmente i tassi praticati con quelli di mercato, tenendo conto delle ragioni economiche interne al gruppo .
Oltre agli interessi, anche altre componenti possono destare attenzione: ad esempio, perdite su crediti infragruppo potrebbero essere indagate (una società che presta a una collegata già decotta e poi svaluta il credito potrebbe vedersi negare la deducibilità per carenza di economicità dell’operazione). Nel complesso, la prassi dell’Agenzia è di esaminare se vi sia un utile fiscale trasferito: la Cassazione ha affermato che nel consolidato nazionale non è ammesso un arbitrario spostamento di componenti di reddito tra società allo scopo di ottimizzare il carico fiscale complessivo di gruppo . La recente ord. 17433/2024 ha sancito che la compensazione di costi o ricavi tra società consolidate è illegittima: ogni società deve determinare il proprio reddito come se il consolidato non ci fosse . Questo principio vale anche per oneri finanziari: non si può decidere, ad esempio, di allocare gli interessi passivi su una società diversa da quella che effettivamente utilizza i fondi, al solo fine di sfruttare basi imponibili o perdite . In sintesi, l’uso strumentale del gruppo per “ricollocare” costi o proventi (interessi inclusi) costituisce per la Cassazione un comportamento abusivo/elusivo, anche se il gettito fiscale complessivo apparentemente non cambia . Dunque, il Fisco avrà tolleranza zero verso manovre di questo tipo, specialmente quando coinvolgono differenze di aliquote o situazioni in cui una società ha utili e l’altra perdite.
Rischi per i creditori: Dal punto di vista di creditori e curatori, i finanziamenti infragruppo possono dare adito a diverse problematiche:
- Restituzioni preferenziali ai soci: se un’azienda in crisi rimborsa anticipatamente prestiti ricevuti dalla società controllante (o dai soci) invece di pagare i fornitori esterni, può ledere la par condicio. In caso di fallimento, come accennato, i rimborsi di finanziamenti soci effettuati nell’anno antecedente sono spesso revocati dal curatore in quanto pagamenti di crediti postergati indebiti . Infatti l’art. 2467 c.c. stabilisce che i finanziamenti dei soci eseguiti quando la società era sottocapitalizzata vanno postergati rispetto agli altri crediti: ne discende che se la società ha rimborsato tali prestiti poco prima del fallimento, il curatore li recupera facilmente perché erano somme destinate a restare nel patrimonio finché i creditori chirografari non fossero soddisfatti.
- Svuotamento di liquidità mascherato: se una società versa denaro alla capogruppo con la scusa di un finanziamento ricevuto (restituzione) o di un pagamento infragruppo, ma di fatto priva sé stessa di risorse in momento di insolvenza, i creditori potrebbero sostenere che si tratti di distrazione di beni. Un esempio è il pagamento di dividendi camuffati da rimborso di finanziamento: gli amministratori potrebbero essere accusati di aver di fatto distribuito utili (o capitale) ai soci aggravando il dissesto, il che rileva sia come bancarotta preferenziale/distrattiva, sia come possibile responsabilità ex 2497 c.c. se la holding ha imposto l’operazione .
- Garanzie infragruppo: se la controllante presta garanzia per la controllata (o viceversa) e poi l’escussione si rivale su una società in danno dei suoi creditori, possono sorgere conflitti. Ad esempio, una controllata fallita che aveva fideiussioni attive verso la capogruppo potrebbe vedere il curatore agire contro quest’ultima per onorare gli impegni promessi (anche se il tema esula un po’, attiene più alla responsabilità contrattuale che all’abuso infragruppo).
- Compensazioni e rinunce: se la holding dichiara di rinunciare a un credito verso la controllata insolvente (magari per favorire altri creditori o per evitare che versando si aggravino gli altri debiti), gli altri creditori potrebbero eccepire la natura simulata di tali partite.
In generale, dal lato creditori il sospetto principale è che i movimenti finanziari infragruppo vengano usati per spostare risorse lontano dalla società che poi lascia debiti insoluti. L’esempio pratico seguente illustra bene i rischi: Alfa S.p.A. (holding) concede un prestito di 5 milioni alla controllata Beta S.r.l.; Beta corrisponde interessi annui del 10% (500.000 €), mentre condizioni di mercato sarebbero 3%. Se Beta fallisce successivamente, diverse azioni sono possibili: sul piano fiscale, l’eccedenza di interessi (7% annuo) sarà stata contestata come costo indeducibile per Beta e come utile occulto per Alfa, come detto . Sul piano civilistico/fallimentare, il rimborso di 5 milioni eventualmente effettuato da Beta prima del fallimento potrà essere revocato dal curatore (se avvenuto nell’anno prima, trattandosi di credito soci postergato) , e gli amministratori potrebbero risponderne per bancarotta preferenziale se sapevano dello stato di insolvenza . Inoltre, i creditori di Beta potrebbero agire ex art. 2497 c.c. verso Alfa sostenendo che Beta è stata svantaggiata da quell’operazione (pagare interessi esagerati e restituire fondi che avrebbe dovuto trattenere per risanarsi). Viceversa, se il finanziamento fosse stato concesso a tasso zero e Beta fosse fallita senza restituire nulla, i creditori potrebbero lamentare che Alfa (socia) ha ritardato colpevolmente la capitalizzazione lasciando Beta sottocapitalizzata e poi pretendendo magari la restituzione anticipata non appena incassati pagamenti da clienti (scenario di finanziamento parzialmente restituito mentre altri creditori restano impagati). Insomma, nei gruppi ogni movimento di denaro è potenzialmente scrutinabile da più prospettive.
Difese e cautele: Per prevenire contestazioni su finanziamenti infragruppo non a mercato, è importante adottare alcune buone prassi:
- Documentare contrattualmente a condizioni di mercato: stipulate sempre un contratto di finanziamento infragruppo scritto, in cui si definiscano importo, durata, tasso di interesse, modalità di rimborso, ecc. Il tasso deve essere congruo: conviene ancorarlo a parametri obiettivi (es. Euribor o altro indice di mercato, più uno spread adeguato al merito creditizio della società finanziata). Se la società finanziata ha rischio basso e avrebbe potuto ottenere facilmente credito in banca, lo spread sarà contenuto; se è rischiosa, potete giustificare un tasso più alto, ma sempre basato su criteri oggettivi (rating interni, condizioni di mercato per aziende simili, etc.). Eventualmente corredate il contratto con un parere di congruità di un esperto (es. una perizia di un consulente finanziario) che attesti che il tasso e le condizioni sono in linea con il mercato . Questo sarà una prova preziosa in caso di verifica fiscale o giudiziaria.
- Motivare i finanziamenti infruttiferi: se decidete di non applicare interessi (prestito a tasso zero), predisponete una delibera motivata che spieghi la ragione economica di tale scelta. Ad esempio: “la controllata versa in difficoltà di liquidità; un tasso oneroso aggraverebbe la sua situazione e comprometterebbe il valore della partecipazione della capogruppo, dunque si opta per un sostegno temporaneo infruttifero”. Oppure: “nell’ambito del cash pooling, le eccedenze di Alfa finanziano Beta senza interessi perché poi Beta fornisce servizi in natura ad Alfa” (o altri business reasons). L’importante è poter dimostrare che non c’era un intento elusivo, ma una logica di gruppo plausibile (e, se possibile, nell’interesse anche della finanziatrice, non solo della debitrice). Cassazione 7361/2024, come visto, lascia spazio a queste argomentazioni .
- Evitare spostamenti artificiosi di oneri finanziari: in regime di consolidato fiscale, non fate l’errore di pensare che “tanto i conti si compensano” tra società. Ogni costo (interessi inclusi) deve avere inerenza per la società che lo sostiene. Dunque, non allocate interessi passivi su una società che formalmente risulta intestataria del debito ma di fatto non ha utilizzato i fondi. Questo sarebbe visto come gioco delle tre carte dal Fisco e dalla Cassazione (vedi ord. 17433/2024) . Se avete motivi per far transitare un finanziamento in una certa società, assicuratevi che sia effettivamente quella ad usare la liquidità per i propri scopi imprenditoriali.
- Attenzione alle restituzioni in situazione di crisi: dal lato dei creditori, se siete amministratori di una società in tensione finanziaria, evitate di restituire prestiti ai soci/controllante lasciando impagati i fornitori o le banche. Tali pagamenti “correlati” in pendenza di insolvenza sono molto rischiosi: se l’azienda poi fallisce, verranno con ogni probabilità revocati e potrebbero costarvi un’accusa di bancarotta preferenziale. Se proprio dovete rientrare di un finanziamento infragruppo, fatelo all’interno di un piano concordato con i creditori (es. un accordo di ristrutturazione o concordato preventivo in cui magari la controllante accetta di essere soddisfatta in misura inferiore, ecc.). Ricordate che, nelle procedure concorsuali, spesso i debiti verso la holding o i soci vengono trattati con rango postergato, quindi cercare di dribblare questa regola può configurare un comportamento doloso.
- Cash pooling formalizzato: se attuate un cash pooling, seguite il modello virtuoso: approvazione del contratto da parte dei CDA di tutte le società coinvolte, specificazione di limiti di affidamento, criteri di calcolo di interessi attivi/passivi sulle giacenze di ciascuno, commissioni di servizio, ecc. . In tal modo, eventuali movimenti di tesoreria infragruppo saranno giustificati da un accordo quadro chiaro. In caso di insolvenza di una consociata, poter esibire il contratto di cash pooling può fare la differenza tra un’accusa di “aver mandato fondi alla capogruppo prima del crack” e una constatazione di regolare gestione centralizzata della cassa (come riconosciuto da Cass. pen. 39139/2023) .
Sentenze di riferimento: Cass. civ. 17433/2024 (inammissibile compensare arbitrariamente costi tra società in consolidato, ogni entità deve rispettare regole di autonomia fiscale) ; Cass. civ. 7361/2024 (finanziamento infragruppo infruttifero: ok in transfer pricing se giustificato da valide ragioni economiche di gruppo) ; Cass. pen. 39139/2023 (cash pooling: i pagamenti tra consociate secondo un accordo deliberato non integrano bancarotta fraudolenta) ; Cass. pen. 18333/2022 (esclusa la distrazione fallimentare in presenza di vantaggi compensativi che neutralizzano il pregiudizio ai creditori) .
Trasferimenti infragruppo di beni (cessioni di asset)
Descrizione: Questa categoria comprende operazioni con cui si trasferiscono beni o interi rami aziendali tra società del gruppo. Possono essere vendite a titolo oneroso, conferimenti di beni o partecipazioni (come l’apporto di un immobile a una newco controllata), permute di asset, ecc. Spesso tali operazioni avvengono nell’ambito di riorganizzazioni societarie – ad esempio per concentrare tutti gli immobili in una società immobiliare di gruppo e far pagare affitti alle operative, oppure per separare attività diverse. Altre volte, possono essere finalizzate a isolare cespiti o ottimizzare il carico fiscale. Il punto cruciale è sempre il valore a cui avviene il trasferimento e le sue motivazioni.
Rischi di contestazione fiscale: Il rischio principale, in ambito tributario, è che il trasferimento infragruppo di un bene avvenga a un prezzo inferiore o superiore al valore di mercato per ottenere un indebito vantaggio fiscale. Alcuni schemi noti:
- Sotto-valutazione elusiva di plusvalenze: Un classico è lo schema conferimento + cessione partecipazioni. Ad esempio, Alfa possiede un immobile con forte plusvalore latente; invece di venderlo a terzi pagando imposte sulla plusvalenza, lo conferisce in neutralità d’imposta a una società di nuova costituzione (Beta) – operazione esente da tassazione immediata ai sensi dell’art. 176 TUIR – e poi vende le quote di Beta al terzo, usufruendo magari della participation exemption (PEX, 95% esente) o di un’imposta di registro fissa. Risultato: il bene è passato di mano con tassazione quasi nulla. La giurisprudenza, già prima della norma antiabuso, considerava elusivo questo genere di operazioni prive di sostanza economica (famoso il caso Dolce & Gabbana, in cui conferimento di ramo d’azienda e vendita quote furono ritenuti costrutto elusivo) . Oggi l’art. 10-bis esplicitamente inquadra come abuso operazioni del genere quando l’unico scopo è evitare la tassazione della plusvalenza sul bene ceduto . L’Agenzia delle Entrate, nella Circ. 6/E/2016, cita proprio il conferimento seguito da vendita partecipazioni tra gli esempi tipici di abuso . Un case study recente segnalato su FiscoOggi: una società trasferiva immobili a un’altra consociata pagando registro all’1% (come atto di gruppo) e poi la consociata rivendeva a terzi con imposta proporzionale, ottenendo di fatto un risparmio di registro. L’operazione è stata contestata come rivendita elusiva perché la società acquirente interna non svolgeva reale attività immobiliare ed era un veicolo creato solo per quella transazione .
- Sopra-valutazione per generare basi ammortizzabili: L’opposto – vendere un bene infragruppo a prezzo sovrastimato – potrebbe essere usato per innalzare i valori di carico in una società (che magari ha utili da abbattere con ammortamenti maggiori) e creare una perdita in un’altra (che forse è in perdita fiscale comunque, o può compensarla). Anche questo sarebbe guardato con sospetto: in tali casi l’Ufficio potrebbe rideterminare il corrispettivo al valore normale, tassando l’eccedenza in capo a chi l’ha dedotta. Ad esempio, Cass. 10499/2024 ha confermato che il Fisco può riqualificare componenti di reddito infragruppo secondo il principio di libera concorrenza anche senza provare un intento elusivo specifico, perché l’art. 110(7) TUIR ha finalità anti-transfer pricing in sé . Se dunque Beta vende a un prezzo esagerato a Alfa un macchinario, Alfa non potrà dedurre ammortamenti su quel sovrapprezzo (verrebbero ripresi a tassazione).
- Operazioni infragruppo con IVA o registro agevolata: Alcune transazioni puntano a sfruttare regimi d’imposta indiretta di favore. Ad esempio, trasferire un bene sfruttando esenzione IVA o registro fisso (perché è atto tra società controllate) e poi cambiarne l’uso. La giurisprudenza UE (caso Halifax) e nazionale consente di ignorare i vantaggi IVA ottenuti con operazioni prive di sostanza economica . L’Agenzia potrebbe contestare un abuso di diritto anche in IVA se una cessione infragruppo in esenzione è subito seguita da operazioni a valle che realizzano un credito d’imposta indebito.
In sintesi, a livello fiscale qualsiasi trasferimento infragruppo a valore anomalo accende un faro. Se c’è un risparmio d’imposta significativo collegato alla differenza di prezzo (o al regime applicato) e mancano ragioni extrafiscali robuste, l’operazione rischia di essere riqualificata. Le conseguenze possono includere: ricalcolo della plusvalenza (o minor minusvalenza) per il cedente, diniego di benefici (PEX, registro fisso) se considerati indebitamente fruiti, recupero di eventuale imposta “risparmiata” (es. imposta di registro differenziale), ecc. In Cassazione è consolidato il principio che non conta la mera appartenenza al gruppo: se un prezzo pazzo non ha giustificazione economica, non c’è scudo di gruppo che tenga .
Rischi per i creditori: I trasferimenti di asset sono forse gli atti più pericolosi dal punto di vista della tutela dei creditori, in quanto possono alterare significativamente la consistenza patrimoniale di una società debitrice. Principali rischi:
- Azione revocatoria (ordinaria o fallimentare): Come già spiegato, se una società in difficoltà cede un bene a un’altra società del gruppo a prezzo basso (o addirittura lo conferisce gratuitamente), i creditori possono facilmente agire in revocatoria sostenendo che l’atto è in frode alle loro ragioni. Anche se il prezzo fosse giusto ma il ricavato viene immediatamente fatto uscire dall’orbita dei creditori (ad es. trasferito all’estero o usato per pagare solo alcuni creditori correlati), l’operazione potrebbe essere vista come parte di un disegno fraudolento e dunque revocata. Tempistica: la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) ha termine di 5 anni dall’atto; la fallimentare varia (generalmente 2 anni per atti a titolo gratuito, 1 anno per atti onerosi con parti correlate a condizioni squilibrate, 6 mesi per pagamenti normali). La scissione, trattandosi di atto non sinallagmatico classico ma divisione di patrimonio, per lungo tempo è stata discussa se revocabile: ora, come detto, le Sezioni Unite 5089/2025 hanno confermato l’ammissibilità sia dell’ordinaria sia (ovviamente) della fallimentare .
- Responsabilità e bancarotta per distrazione: Se la società che ha alienato il bene poi fallisce, gli amministratori rischiano l’accusa di bancarotta fraudolenta distrattiva, specialmente se il corrispettivo era “vile”. Ad esempio, vendere un capannone valutato 2 milioni per 500 mila € a una newco del gruppo sarà facilmente visto dal curatore come un’operazione distrattiva. Il fatto che un qualche prezzo sia stato pagato non esclude la distrazione: un prezzo irrisorio rispetto al valore effettivo equivale a una parziale donazione del bene, quindi a una sottrazione di valore ai creditori . Cass. pen. 18333/2022, citata prima, segnala però che se quel bene ceduto a poco prezzo ha comportato contestualmente un vantaggio compensativo (es. la società cedente ha ottenuto un flusso di cassa che le ha permesso di evitare il fallimento per qualche tempo, o ha ottenuto una partecipazione di uguale valore?), allora potrebbe non esserci distrazione . Ma di norma, se la società muore e il bene è stato tolto dal patrimonio, la distrazione appare evidente.
- Preclusione dei creditori all’escussione: Un trasferimento di asset può anche complicare tecnicamente il recupero crediti. Ad esempio, se l’unico immobile su cui i creditori potevano iscrivere ipoteca viene spostato a un altro soggetto, occorre iniziare causa contro quest’ultimo, ecc. Questo peggioramento della posizione creditoria è proprio ciò che la revocatoria intende evitare. In caso di scissione, la legge tutela i creditori con il diritto di opposizione (art. 2503 c.c.), ma se i creditori non vengono informati o non si oppongono in tempo, la scissione riuscita può comunque essere attaccata successivamente con revocatoria se fraudolenta.
- Azione ex 2497 c.c.: se la vendita sottocosto è avvenuta per imposizione della capogruppo nell’interesse di quest’ultima (o di altra consociata acquirente), la holding può rispondere dei danni verso i creditori della venditrice ex art. 2497 c.c. come atto di mala gestio. Ad esempio, Cass. 5458/2023 (già citata) riguardava proprio un caso di beni spostati e la holding di fatto è stata ritenuta responsabile per abuso di direzione .
Un tipico esempio pratico: Tizio S.p.A. (società operativa) intravede difficoltà finanziarie all’orizzonte; nel 2024 trasferisce la proprietà del suo capannone industriale alla Mevia S.r.l. (newco immobiliare controllata al 100%) a un prezzo pari al valore contabile netto (dunque ben inferiore al valore di mercato). Tizio continua ad utilizzare l’immobile prendendolo in leasing o affitto da Mevia. Nel 2025 Tizio fallisce. Quali azioni avremo? – Sul piano civile/fallimentare, il curatore di Tizio quasi certamente eserciterà un’azione revocatoria per far dichiarare inefficace la vendita nei confronti del fallimento (entro 5 anni dall’atto si può: la vendita del 2024 rientra) . Se il prezzo era addirittura irrisorio rispetto al mercato, l’atto potrebbe qualificarsi come atto a titolo gratuito dissimulato, quindi revocabile ipso facto entro 2 anni dal fallimento (più facile ancora). In ogni caso, anche come atto oneroso, la frode appare palese (società controllata, prezzo vile, scopo di spoliazione), quindi i presupposti di revoca ex art. 2901 c.c. ci sono tutti. – Sul piano penale, gli amministratori di Tizio rischiano l’incriminazione per bancarotta fraudolenta distrattiva, avendo di fatto sottratto l’immobile ai creditori trasferendolo a Mevia (persona interposta) . – Sul piano fiscale, se Tizio magari era in posizione di perdita fiscale e Mevia in utile, la vendita a basso prezzo potrebbe essere vista dall’Agenzia come sottovalutazione intenzionale: Tizio avrebbe potuto realizzare una plusvalenza tassabile se avesse venduto a valore pieno, invece l’ha compressa. Non c’è una norma di transfer pricing interno formalmente applicabile (sono entrambe italiane), ma come detto la Cassazione consente di guardare al valore normale in ottica antielusiva . L’Ufficio potrebbe quindi contestare a Mevia (acquirente) un indebito futuro – ad esempio negandole in prospettiva la deduzione di ammortamenti maggiori se avesse pagato di più (ma qui ha pagato poco, quindi semmai Tizio ha una minusvalenza che potrebbe aver usato per abbattere altri utili? dipende dal caso). Insomma, dal lato fiscale il caso è sfaccettato: diciamo che se Tizio era in perdita, la sottofatturazione non ha dato vantaggi fiscali immediati, però Mevia un domani se rivende avrà plusvalenza piccola. Il Fisco potrebbe vigilare su eventuali rivendite. In ogni caso, civilisticamente e penalmente l’operazione è chiaramente illecita: c’è poco scampo. – Situazione opposta: se Tizio fosse stata finanziariamente sana e avesse venduto a Mevia a prezzo congruo, reinvestendo poi l’incasso nella propria attività, difficilmente i creditori (che non erano pregiudicati) avrebbero potuto lamentarsi, né il Fisco (nessun vantaggio fiscale particolare). È per evidenziare come il contesto e le motivazioni contino molto.
Difese e cautele: Ecco come impostare correttamente trasferimenti infragruppo di beni per resistere a eventuali contestazioni:
- Operare a valori di mercato: Sembra banale, ma la prima difesa è la più efficace: assicurarsi che il prezzo di trasferimento sia allineato ai valori di mercato o comunque oggettivamente attendibile. Ciò significa tipicamente far predisporre una perizia di stima indipendente sull’asset da trasferire e attenersi a quella . Ad esempio, se spostate un immobile, fate fare una valutazione da un esperto (ingegnere/CTU) e praticate quel prezzo. Questo rende quasi inattaccabile l’operazione sul piano del valore: il Fisco non potrà parlare di sotto/soprafatturazione avendo voi una perizia a supporto, e per i creditori sarà più arduo dimostrare che li avete pregiudicati (se il prezzo è equo e i soldi rimangono in azienda).
- Documentare valide ragioni extrafiscali: Se l’operazione beneficia di un regime fiscale di favore (es. conferimento neutrale, imposta di registro fissa, PEX su cessione di quote), diventa cruciale evidenziare che esistono motivi non fiscali sostanziali. Predisponete un documento di Business Purpose interno in cui spiegate le ragioni economiche: ad esempio “conferiamo l’immobile in una newco per far entrare un investitore immobiliare nel capitale di quest’ultima, così da ottenere liquidità e focus strategico” oppure “riorganizziamo il gruppo separando business diversi per facilitare future partnership”. Questo serve a dimostrare che non lo fate solo per tasse. In caso di contestazione ex art. 10-bis, poter esibire un progetto aziendale con obiettivi concreti e magari deliberazioni del CDA che ne parlano aiuta a provare le “valide ragioni extrafiscali, non marginali” richieste per escludere l’abuso .
- Evitare rivendite rapide e preordinate: Una red flag per il Fisco è la sequenza ravvicinata conferimento/vendita (o scissione/vendita). Se potete, non rivendete a terzi troppo presto dopo un trasferimento infragruppo. E se succede (magari perché un’opportunità di mercato imprevista si presenta), preparatevi a dimostrare che non era pianificato fin dall’inizio. Ad esempio, mantenete separati i processi decisionali: prima fate il conferimento per motivi industriali; solo successivamente, ricevendo un’offerta, decidete di vendere. Se invece dagli atti risulta un disegno unitario (conferisco già con l’idea di vendere le quote subito dopo), l’abuso del diritto è praticamente certo .
- Considerazione dei creditori nella manovra: Dal punto di vista dei debitori diligenti, se avete debiti significativi e non garantiti, è imprudente compiere operazioni radicali sul patrimonio senza coinvolgere o tutelare i creditori. Per esempio, se volete scindere o conferire asset altrove, valutate di informare i creditori e magari offrire loro garanzie o accordi compensativi. L’art. 2503 c.c. in tema di scissione consente di evitare l’opposizione dei creditori se vengono fornite garanzie adeguate agli stessi. Analogamente, nulla vieta in un contesto extra-societario di fare un accordo con i principali creditori in cui spiegate la riorganizzazione e magari vincolate l’uso del corrispettivo a loro tutela (es. mettendo i soldi in escrow a favore dei creditori). Questa è chiaramente una mossa di trasparenza che riduce il sospetto di frode. Se, invece, agite unilateralmente e di nascosto, lasciando i creditori a bocca asciutta, sarà molto difficile poi difendersi dall’accusa di averli voluti danneggiare.
- Atti notarili ben congegnati: Quando fate un conferimento, fusione o cessione infragruppo, c’è spazio per inserire clausole che rafforzano la posizione creditoria: ad esempio, in una scissione, potete prevedere una clausola di responsabilità solidale ampliata (oltre quella pro-quota legale) in cui tutte le società risultanti rispondono per tutti i debiti, tranquillizzando così i creditori (questo mostrerebbe che non volevate sottrarvi ai debiti). Pochi lo fanno, ma è un elemento che in sede di giudizio potrebbe essere valorizzato per escludere intenti fraudolenti.
In definitiva, per difendere un trasferimento infragruppo occorre poter dire: “L’operazione aveva un serio scopo economico, l’abbiamo fatta a valori corretti, senza intenzione di nuocere a nessuno, ed ecco le prove”. Se ciò è vero e documentabile, le contestazioni (fiscali o dei creditori) difficilmente prospereranno.
Sentenze di riferimento: Cass. SU 5089/2025 (revocabilità della scissione come atto lesivo dei creditori – principio esteso per analogia ai conferimenti di azienda) ; Cass. civ. 19704/2015 (schema conferimento + vendita quote considerato elusivo: abuso del diritto); Cass. civ. 30335/2018 (operazione immobiliare infragruppo ritenuta priva di sostanza economica e quindi elusiva); Cass. civ. 26283/2016 e 13294/2017 (altri leading cases sull’abuso nelle riorganizzazioni societarie con cessioni di partecipazioni post conferimento/scissione); Cass. pen. 46898/2012 (bancarotta fraudolenta in caso di scissione distrattiva); Cass. pen. 12477/2019 (bancarotta preferenziale per scissione che aveva favorito indebitamente un creditore interno). – Da segnalare anche la Circolare AdE 6/E del 2016, che all’indomani dell’introduzione dell’art. 10-bis ha indicato tra le operazioni potenzialmente abusive i conferimenti seguiti da cessione di partecipazioni e le scissioni con finalità estranee a valide ragioni extrafiscali .
Prestazioni di servizi infragruppo e addebiti di costi
Descrizione: Molti gruppi adottano una gestione accentrata di talune funzioni, con società (spesso la capogruppo) che forniscono servizi intragruppo alle controllate: ad esempio management fees per attività di direzione, servizi amministrativo-contabili centralizzati, servizi informatici, di marketing, engineering, oppure contratti di cost sharing per ripartire spese comuni (es. pubblicità, ricerca e sviluppo). Rientrano qui anche i royalties per l’uso interno di marchi o know-how del gruppo, gli addebiti per personale distaccato, ecc. In gruppi multinazionali, tali operazioni rientrano nel transfer pricing internazionale (con necessità di documentazione ad hoc, TP Masterfile, etc.), mentre in gruppi domestici spesso sono gestite con minore formalità, talvolta in modo opaco (basti pensare a generiche “fatture di consulenza” dalla holding alle società figlie). Proprio questa categoria è spesso oggetto di verifiche fiscali e accuse di sviamento di risorse.
Rischi di contestazione fiscale: L’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, tende a scrutinare severamente i costi infragruppo di servizi per verificare due aspetti chiave:
- Effettività del servizio reso: Il Fisco vuole accertare che il servizio fatturato sia stato realmente prestato e non sia una mera scrittura contabile per spostare reddito. Dunque, richiede evidenze tangibili dell’attività svolta dalla controllante a favore della controllata: rapporti, corrispondenza, deliverables, risultati concreti ottenuti grazie al servizio. Spesso in passato le holding addebitavano management fees forfettarie, magari calcolate in percentuale sui ricavi delle controllate, senza documentare nel dettaglio quali servizi venivano erogati. La Cassazione è intervenuta più volte affermando che costi così generici non sono deducibili: occorre provare l’utilità specifica che la consociata ha tratto . Ad es., Cass. 17433/2024 (già citata sopra in contesto di consolidato) riguardava proprio consulenze infragruppo generiche: la controllante fatturava servizi di “strategia, organizzazione, finanza e controllo” alla controllata, ma senza indicazione di attività specifiche, personale impiegato, ore dedicate. La Cassazione ha ritenuto legittimo per il Fisco disconoscere quei costi data la genericità della documentazione, ribadendo che non basta l’esistenza di un contratto e di fatture, se poi non si può verificare l’effettiva utilità per la società che paga . In altre pronunce ravvicinate del 2024 (Cass. 6101/2024, 6584/2024, 8010/2024), la Suprema Corte ha consolidato l’orientamento: onere della prova a carico del contribuente nel dimostrare che i servizi infragruppo gli hanno apportato un beneficio concreto, determinabile e congruo rispetto al costo sostenuto . Quindi, fiscalmente, l’abuso tipico è far apparire deducibili costi che in realtà servono solo a ridurre l’utile tassabile di una società trasferendolo in un’altra magari con perdite o fuori dal perimetro impositivo italiano.
- Inerenza e congruità del costo: Anche se il servizio c’è stato, occorre che sia inerente all’attività dell’impresa che lo paga e che il costo sia congruo rispetto al valore ricevuto. Un caso di contestazione frequente è quando la capogruppo “scarica” costi sulle controllate oltre misura, per abbatterne gli utili. Ad esempio, una holding addebita alla sua controllata una “fee” calcolata sui ricavi, che però non riflette un reale valore dei servizi resi (magari la controllata aveva già un proprio staff per quelle funzioni, o comunque il costo appare sproporzionato). Il Fisco in questi casi può contestare la non inerenza: se la spesa non è sostenuta nell’interesse dell’attività del soggetto che la deduce, va ripresa a tassazione . Inoltre può ravvisare una sorta di dividendo camuffato: se soci persone fisiche stanno dietro la holding, il trasferimento di utili dalla controllata tramite fatture per servizi inesistenti potrebbe essere riqualificato come utile distribuito (con tassazione come dividendo in capo al percettore ex art. 89 TUIR) . Ancora, in ambito IVA, fatture per operazioni inesistenti (o esagerate) configurano violazioni gravi: l’IVA detratta indebitamente va recuperata e si rischiano sanzioni per fatture false. Cass. pen. 5463/2014, citata spesso, ha riguardato proprio false fatture infragruppo: è stata confermata la condanna per frode IVA, avendo accertato che la società emittente era una mera “cartiera” interna al gruppo .
In sintesi, il focus fiscale sulle prestazioni infragruppo è: il servizio è reale? è utile per chi paga? il costo è ragionevole? Se la risposta a una di queste domande è negativa, la deduzione verrà negata e si parlerà di operazione abusiva (nel senso di elusiva) o anche evasiva (se proprio è fittizia). Da notare che la Cassazione ha escluso che si possano abbattere utili in modo artificioso anche in presenza di consolidato fiscale: l’ordinanza 17433/2024, oltre al caso di consulenze generiche, ha enfatizzato che ogni società deve tenere conto solo dei costi inerenti la propria attività, non di costi altrui trasferiti artificiosamente . Questo per disinnescare pratiche di “gestione accentrata dei costi” dove la holding caricava su società profittevoli varie spese comuni per ridurne l’imponibile (specie nei regimi di consolidato, confidando che il risultato di gruppo compensi). In pratica, la Cassazione dice: non potete usare la scusa del gruppo unitario per giocare coi conti, ogni entità va analizzata stand-alone .
Rischi per i creditori: Dal lato creditori, le prestazioni infragruppo presentano rischi se usate per drenare liquidità da una società (magari destinata a fallire) verso un’altra. Esempi:
- Pagamenti per servizi fittizi o eccessivi: se un’azienda in difficoltà paga grosse somme alla capogruppo per “servizi” che in realtà non ne giustificano l’ammontare, i creditori del fallimento potranno agire in revocatoria per recuperare quei pagamenti, trattandoli come atti a titolo oneroso anomali a favore di parte correlata (revocabili se nei 6 mesi/1 anno prima del fallimento, a seconda dei casi, e se la controparte era consapevole dello stato di insolvenza). È verosimile che tali pagamenti vengano visti come in frode, specie se la società debitrice non aveva reale vantaggio dal servizio . Inoltre, il curatore può valutare un’azione di responsabilità contro gli amministratori che hanno autorizzato quei pagamenti, per distrazione o dissipazione di risorse sociali (bancarotta semplice se colposa, bancarotta fraudolenta se dolosa).
- Bancarotta preferenziale: se la società fallisce ed emerge che negli ultimi tempi pagava regolarmente le fatture alla controllante per management fee, mentre lasciava insoluti altri debiti, il curatore potrebbe ipotizzare una bancarotta preferenziale (avendo favorito una parte – la holding, peraltro legata – a danno degli altri creditori). Tanto più se quelle fee non erano strettamente necessarie alla continuazione aziendale ma solo un modo di trasferire ricchezza. In alcuni casi, tuttavia, le prestazioni intragruppo possono essere vitali (es. la filiale dipende dal software fornito dalla casa madre): se il pagamento a quest’ultima è essenziale per tenere in vita l’azienda, potrebbe essere giustificabile e non qualificabile come preferenza indebita.
- Azione 2497 c.c.: se la capogruppo ha imposto a una controllata già in crisi di pagarle elevati costi di gruppo aggravandone il dissesto, i creditori (anche tramite il curatore) possono agire ex art. 2497 c.c. contro la capogruppo per lesione dell’integrità patrimoniale. Ad esempio, Beta fallisce e si scopre che negli anni precedenti Alfa le addebitava 1 milione annuo di spese generali nonostante Beta fosse in perdita; ciò costrinse Beta a intaccare capitale e indebitarsi. I creditori di Beta diranno: Alfa ha abusato della sua posizione, caricando costi inutili su Beta e svuotandola a nostro danno . Se Alfa non prova che quei costi erano compensati da vantaggi per Beta (cosa difficile se Beta è fallita), dovrà rispondere dei danni.
In pratica, pagare servizi infragruppo non essenziali quando si è in decozione è pericoloso. Anche qui contesto e proporzionalità sono tutto: pagare alla capogruppo un servizio senza il quale la filiale non può operare (es. licenza software) è difendibile; pagare “consulenze strategiche” superflue mentre si accumulano debiti verso fornitori è quasi automaticamente sospetto.
Difese e cautele: Per evitare (o vincere) contestazioni su costi infragruppo:
- Formalizzare i service agreements: Non stancarsi di ripeterlo: serve un contratto scritto per i servizi infragruppo, dettagliando quali attività vengono svolte, da chi (se possibile nominativi o almeno qualifiche), con quali mezzi, con che frequenza. Prevedere un metodo di calcolo del corrispettivo razionale: ad esempio un sistema cost-plus (si ripartiscono i costi effettivi sostenuti dalla capogruppo per il servizio, aggiungendo un margine ragionevole) oppure una ripartizione pro quota basata su parametri oggettivi (es. ore uomo, numero di dipendenti serviti, percentuale di utilizzo, etc.). Evitare formule del tipo “il 5% dei ricavi” senza base logica: potrebbe andare bene solo se effettivamente quel 5% è stato calcolato a posteriori ed è grosso modo equivalente ai costi + mark-up standard.
- Dimostrare l’effettiva prestazione: Conservare tutti i report, deliverables, e-mail, documenti di lavoro che testimonino lo svolgimento del servizio. Se la holding fornisce accounting centralizzato, avrete report contabili, bilanci predisposti, etc. Se fornisce consulenza strategica, mantenete copie di presentazioni, studi, piani consegnati. In sede di verifica, esibire questa documentazione concreta è fondamentale per convincere che non è fumo.
- Approccio arm’s length anche ai servizi domestici: Producete, se possibile, una sorta di documentazione di transfer pricing interna per i servizi infragruppo . Esempio: se la holding presta servizio di contabilità alla controllata, fate un prospetto con il costo del personale impiegato per quel lavoro, aggiungete un mark-up (es. 5-10%) e ottenete la fee. Questo è esattamente il metodo cost plus raccomandato dall’OCSE; anche se non obbligatorio in ambito domestico, mostrarne l’applicazione conferisce credibilità. Evitare “teste di costo” sproporzionate su società piccole o in perdita: far pagare 500k € di management fee a una controllata che ha 100k € di utile significa azzerarne l’utile – appare anomalo a prescindere . In tali casi, assicuratevi di poter spiegare perché il servizio vale così tanto (magari la controllata, pur piccola, dipende totalmente da sistemi forniti dalla holding che costano effettivamente quelle cifre).
- Mostrare la necessità del servizio per la controllata: Se il Fisco contesta, siate pronti a giustificare la necessità di quei servizi per la società che li riceve . Ad esempio: “La controllata Delta non aveva un ufficio legale interno, dunque ha usufruito del servizio legale centralizzato della holding, ecco le pratiche seguite…”. Dimostrate che, senza quel servizio, la controllata avrebbe dovuto rivolgersi a terzi a costi magari maggiori o con peggiori risultati. Questo elimina l’idea che il costo sia uno spreco.
- Sospendere addebiti non essenziali in crisi: Dal lato creditori/debitori, se l’azienda inizia a scricchiolare finanziariamente, ridurre o sospendere gli addebiti infragruppo che non siano strettamente necessari alla sopravvivenza. Continuare a far pagare la filiale per servizi superflui mentre non paga i fornitori può essere esiziale nella successiva valutazione di dolo. Al contrario, se ci sono servizi cruciali (es. il pagamento alla holding per la licenza software senza cui la filiale si blocca), assicuratevi di poterlo provare – così tale spesa apparirà come causa utile e non mero drenaggio di cassa . In pratica: servizi realmente cruciali e di mercato sono difendibili anche in extremis; servizi generici o fittizi no.
- Coordinare con la pianificazione fiscale: se il gruppo sceglie di fare consolidato fiscale, predisporre policy interne per i costi infragruppo. Ad esempio, stabilire che comunque ogni società pagherà solo costi di sua competenza e eventuali squilibri verranno aggiustati con trasferimenti di utili reali (dividendi) e non con fatture fittizie. Così eviterete di cadere nel tranello di far sembrare fittizio ciò che potrebbe essere risolto diversamente.
Sentenze di riferimento: Cass. civ. 6100 e 6101/2024, 6584/2024, 8010/2024 (serie di pronunce Sez. Trib. di marzo 2024: deducibilità delle management fee infragruppo subordinata a prova rigorosa di utilità e inerenza; contratto e fatture non bastano, servono elementi specifici che mostrino l’utilità effettiva o potenziale per la controllata) ; Cass. civ. 17433/2024 (costi di consulenza infragruppo nel consolidato: no allo spostamento di costi tra società, ogni costo deve essere inerente a chi lo sostiene, anche se il reddito di gruppo è invariato) ; Cass. civ. 14930/2013 (sui contratti di cost sharing: ribadita la necessità di prova concreta dell’utilità dei servizi per le consociate); CTR Lombardia sent. 9/2019 (caso reale di management fee infragruppo: deduzione negata per mancanza di prova dettagliata dei servizi resi); Cass. pen. 5463/2014 (fatture infragruppo inesistenti: condanna per frode IVA, società emittente considerata cartiera) .
Operazioni straordinarie infragruppo (fusioni, scissioni, conferimenti, LBO)
Descrizione: In questa categoria rientrano le operazioni societarie di tipo straordinario all’interno di un gruppo: fusioni tra società controllate (o tra controllante e controllata), scissioni di società in più entità facenti capo al gruppo, conferimenti d’azienda o di partecipazioni seguiti da altre operazioni (come già visto), liquidazioni infragruppo (chiusura di società con trasferimento degli attivi ad altre del gruppo), operazioni di leveraged buy-out interne (es. incorporazione di società acquisite con debiti), ecc. Queste mosse “strutturali” sono spesso motivate da obiettivi di riorganizzazione efficiente (semplificare la struttura societaria, separare linee di business, ottimizzare flussi finanziari, ecc.), ma talvolta vengono strumentalizzate per fini elusivi (ottenere risparmi d’imposta) o per proteggere asset da possibili aggressioni (isolando parti sane da parti in crisi).
Rischi di contestazione fiscale: Sono elevati se l’operazione straordinaria appare costruita principalmente per vantaggi fiscali. Già abbiamo discusso del classico conferimento+cessione come esempio di abuso. Altri scenari tipici:
- Fusioni e utilizzo di perdite fiscali: La fusione di società può permettere di compensare utili e perdite in capo alla società risultante. L’ordinamento prevede limiti (art. 172 TUIR prevede che le perdite fiscali si perdono se manca un minimo di vitalità della società che le porta, salvo possesso di frazioni di patrimonio attivo, ecc.). Tuttavia, gruppi spregiudicati potrebbero combinare operazioni per aggirare tali limiti: ad esempio, fare una scissione per isolare la parte loss company e poi fonderla con la profit company, rispettando formalmente i requisiti ma ottenendo di fatto un vantaggio fiscale. Se la manovra è essenzialmente volta a far circolare le perdite, l’Agenzia può contestare l’abuso ex art. 10-bis . Un esempio: Società A con grossi utili incorpora Società B che aveva solo perdite pregresse e nessun business attivo, col solo scopo di usare quelle perdite per abbattere gli utili di A. Anche se formalmente la fusione rispetta l’art. 172 (magari B aveva ancora un minimo di attivo), l’operazione non ha sostanza economica se B era una scatola vuota comprata solo per le perdite – configurando abuso . Cass. 3738/2018, ad esempio, ha valutato lecita una riorganizzazione infragruppo che comportava benefici fiscali solo perché c’erano valide ragioni extrafiscali documentate; ma altrimenti il rischio di contestazione è concreto .
- Scissioni con finalità elusive: Le scissioni societarie sono operazioni neutre fiscalmente (non generano plusvalenze tassabili) e possono offrire opportunità di pianificazione: es. trasferire asset in una beneficiaria e poi cedere quest’ultima con tassazione ridotta. Un caso tipico: scissione di un immobile in una newco e successiva vendita delle partecipazioni della newco, sfruttando la PEX (5% imponibile) invece della tassazione piena su vendita diretta dell’immobile . Anche qui, la prassi dell’Agenzia è considerare abuso del diritto le scissioni seguite da cessione se mancano motivazioni extra-fiscali credibili. Numerosi accertamenti hanno colpito scissioni spin-off di patrimoni poi venduti. La Cassazione (v. Cass. 13294/2017) conferma che forme diverse, stessa sostanza = stesso giudizio: una scissione finalizzata a realizzare ciò che un conferimento+cessione avrebbe fatto è parimenti abusiva, se l’intento principale era il risparmio d’imposta . Da qui la necessità di dimostrare eventuali ragioni organizzative indipendenti.
- Operazioni combinate e trasformazioni: Qualsiasi concatenazione di atti societari che produce come effetto aliquote più basse o base imponibile erosione è potenzialmente a rischio. Esempio meno comune: trasformare una società di persone (trasparente) in società di capitali prima di vendere partecipazioni, per sfruttare un regime impositivo diverso (ciò potrebbe ridurre l’imposizione in capo alle persone fisiche venditrici). Se fatto senza ragioni se non fiscali, può essere censurato (in passato alcune pronunce hanno guardato a tali escamotage con sfavore, sebbene non siano frontali come altri schemi).
In generale, l’Agenzia delle Entrate applicherà l’art. 10-bis: verifica sostanza economica e ragioni extrafiscali. Una fusione o scissione intragruppo verrà considerata abusiva se priva di sostanza economica reale e atta a generare essenzialmente un risparmio d’imposta (es. evitare imposte su plusvalenze o recuperi di tassazione). Si guarderà ad indizi di artificiosità: ad esempio società interposte senza funzione (veicoli creati ad hoc), circolarità nelle operazioni (attività che tornano al punto di partenza), assets isolati temporaneamente solo per venderli, etc. . Anche qui, come difesa sarà cruciale evidenziare i benefici non fiscali dell’operazione.
Rischi per i creditori: Sul piano della tutela dei creditori, le operazioni straordinarie intragruppo possono essere innocue o molto pericolose a seconda dei casi:
- Fusioni: Una fusione comporta la confusione dei patrimoni di due società. In linea generale, se una società solvibile si fonde con un’altra, i creditori di entrambe si trovano ad avere un unico debitore (la fusione per incorporazione fa subentrare l’incorporante in tutti i diritti e obblighi). Questo di solito non pregiudica i creditori, anzi se la fusione unisce risorse complementari, il debitore risultante è più robusto. Tuttavia, esistono scenari particolari: ad esempio, in un LBO interno, una società viene acquisita con indebitamento e poi fusa con la veicolo debitore, scaricando su di sé il debito contratto per pagarne le quote. I creditori originari della target potrebbero trovarsi con una società indebitata molto più di prima – per questo l’ordinamento (art. 2501-bis c.c.) pone cautele speciali per i LBO, richiedendo relazione di esperti e responsabilità degli amministratori se l’operazione nuoce ai creditori. Se un LBO infragruppo viene fatto eludendo tali regole, i creditori potrebbero contestarlo come atto in frode e chiederne nullità/danni. In caso di fallimento, situazioni del genere possono portare a cause per bancarotta (ci sono stati casi di bancarotta da LBO).
- Scissioni: La scissione è notoriamente più insidiosa per i creditori. In una scissione, la società scissa attribuisce parte del suo patrimonio a una beneficiaria; i creditori hanno per legge diritto di opposizione (60 giorni) e anche una tutela postuma perché, salvo patto contrario, la società beneficiaria risponde dei debiti della scissa nei limiti del patrimonio ricevuto (art. 2506-quater c.c.). Tuttavia, se la scissione spoglia sostanzialmente la società originaria lasciandola vuota o quasi (“scissione di sopravvivenza”, dove la scissa resta con i debiti e pochi asset, e la beneficiaria prende tutta la parte buona) , è ovviamente uno scenario sospetto di pregiudizio ai creditori. I creditori possono opporsi prima (ma se non lo fanno o se l’operazione è fatta di corsa possono non riuscirci), e come visto possono anche agire dopo con revocatoria. Cass. SU 5089/2025 ha appunto confermato questo: la revocatoria ordinaria della scissione è ammissibile, e la competenza è delle sezioni imprese . Inoltre, casi del genere portano a responsabilità ex 2497 c.c. se c’è una capogruppo dietro: ad esempio una holding decide di spostare i beni di Alfa in Beta (beneficiaria) lasciando debiti in Alfa che poi fallisce – i creditori di Alfa potranno fare causa alla holding per abuso di eterodirezione. Anche penalmente, come detto, le scissioni “spogliative” portano accuse di bancarotta distrattiva. Insomma, per i creditori la scissione è l’atto da guardare con più attenzione.
- Conferimenti e liquidazioni infragruppo: Un conferimento di azienda a una newco del gruppo può avere effetti simili a una cessione: sposta asset altrove. Tuttavia, a differenza della cessione, nella scissione e nel conferimento l’ordinamento prevede qualche salvaguardia come la responsabilità solidale (nel conferimento d’azienda la conferitaria risponde dei debiti relativi all’azienda se risultano dai libri contabili, art. 2560 c.c.). Ma se l’intento è frodatorio, spesso queste tutele vengono bypassate (es. si conferisce l’azienda priva dei debiti, lasciandoli in capo alla conferente che poi viene “svuotata”). Il curatore può paragonare un conferimento del genere a una vendita e revocarlo se ne ricorrono i presupposti, specie se fatto a titolo gratuito (conferimento in una società interamente posseduta può essere visto come atto privo di effettivo corrispettivo). Una liquidazione infragruppo (dove una società viene liquidata e il suo attivo trasferito a un’altra del gruppo magari per successione contrattuale) potrebbe essere vista come fusione impropria e avere effetti analoghi.
In conclusione, creditori e curatori diffidano delle operazioni straordinarie infragruppo se queste risultano in una diminuzione delle garanzie o in una confusione che renda più difficile il recupero. Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che possano essere aggredite sia sul piano dell’inefficacia (revocatoria) che su quello risarcitorio (2497) .
Difese e cautele: Quando si pianifica un’operazione straordinaria intragruppo, è fondamentale fare un check-list difensivo sia sul fronte fiscale che su quello civilistico:
- Sul fronte fiscale: preparare un dettagliato Documento di Business Purpose in cui elencare tutte le ragioni economiche dell’operazione e quantificare i benefici non fiscali attesi . Ad esempio, se fondete due società per ottenere economie di scala, riportate stime dei risparmi di costi operativi, delle sinergie di personale, etc. Se incidentalmente l’operazione consente anche un risparmio d’imposta (es. utilizzo di perdite), enfatizzate i motivi principali non fiscali e minimizzate quello fiscale . Valutate, per operazioni dubbie, di ricorrere all’interpello anti-abuso presso l’Agenzia delle Entrate: potete sottoporre il vostro caso prima di attuarlo e chiedere se sarebbe considerato elusivo (art. 11, co.2, l.212/2000). Se l’Agenzia risponde che va bene, avrete tutela (salvo che i fatti differiscano); se risponde negativamente, avrete quantomeno la chance di modificare o rinunciare all’operazione prima di trovarvi un accertamento . L’interpello non è obbligatorio, ma in situazioni borderline (tipo fusioni con perdite, scissioni prima di vendite) è prudente.
- Sul fronte creditori: coinvolgere i creditori nell’operazione se questa incide sulle loro garanzie. Nel caso di una scissione, come accennato, la legge stessa prevede che possiate evitare l’opposizione dando garanzie equivalenti (art. 2503) . Quindi, se state scindendo, pensate a misure come: offrire ipoteche o fideiussioni ai creditori della scissa, accollare formalmente i debiti scissi anche alla beneficiaria oltre i limiti di legge (si può pattuire che la beneficiaria risponda integralmente dei debiti, non solo proporzionalmente al patrimonio assegnato). Queste precauzioni, inserite nel progetto di scissione, rassicurano i creditori e testimoniano assenza di intento lesivo . In generale, fate risultare nei verbali societari che l’operazione è stata valutata non pregiudizievole per i creditori, e spiegatene il perché (ad esempio: “i debiti finanziari restano su Alfa ma la beneficiaria Beta fornirà supporto tramite cash pooling, quindi i creditori non subiranno detrimento”) . Queste annotazioni potrebbero sembrare autoincensanti, ma se un domani un giudice le legge, troverà evidenza che vi siete preoccupati dei creditori, il che mal si concilia con la volontà di frodarli.
- Strategie difensive in giudizio: Se nonostante tutto venite trascinati in contenzioso (fiscale o civile), giocate le carte della buona fede e dell’affidamento professionale. Ad esempio, se avete ottenuto pareri legali o fiscali ex ante che attestavano la legittimità dell’operazione, utilizzateli come prova . Non vincolano il giudice, ma dimostrano che gli amministratori hanno agito con diligenza, non di nascosto. In ambito penale, un parere pro-veritate favorevole può aiutare a escludere il dolo (cioè che vi fosse consapevolezza di illiceità) .
In breve, per operazioni straordinarie intragruppo: trasparenza e correttezza preventiva sono la miglior difesa. Se i documenti societari riflettono genuinità di intenti e protezione delle parti deboli (Erario e creditori), ogni eventuale accusa sarà più facile da respingere.
Sentenze di riferimento: Cass. SU 5089/2025 (Sez. Unite – scissione societaria suscettibile di revocatoria ordinaria; delineata competenza giurisdizionale e confermata tutela dei creditori) ; Cass. civ. 26283/2016 (leading case sull’abuso conferimento + cessione di partecipazioni: enuncia criteri di riconoscimento dell’elusione); Cass. civ. 13294/2017 (scissione seguita da cessione partecipazioni configurata come abuso fiscale in assenza di ragioni extrafiscali); Cass. civ. 3738/2018 (operazione riorganizzativa infragruppo giudicata lecita perché sorretta da valide ragioni extrafiscali, benché generasse risparmio d’imposta); Cass. pen. 46898/2012 (condanna per bancarotta distrattiva a seguito di scissione che aveva sottratto beni ai creditori); Cass. pen. 12477/2019 (bancarotta preferenziale in caso di scissione che aveva soddisfatto in modo anomalo un creditore particolare, trasferendogli asset in garanzia).
Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali tipologie di operazioni infragruppo non a valori normali e i corrispondenti rischi fiscali e civilistici/penali associati:
| Tipologia operazione | Principali rischi fiscali (contestazioni) | Principali rischi civilistici/penali |
|---|---|---|
| Finanziamento infragruppo (prestiti intra-gruppo, cash pooling, ecc.) | – Deduzione parziale negata su interessi eccedenti valori di mercato (transfer pricing interno/estero).<br>– Eventuale riqualificazione del finanziamento in capitale proprio (in caso di sottocapitalizzazione) con tassazione di componenti anomale (utili occulti).<br>– Contestazione di antieconomicità per spostamenti di oneri finanziari tra società (specie in consolidato) . | – Revocatoria di rimborsi ai soci/controllante se fatti in periodo sospetto prima del fallimento (specie se crediti postergati ex art.2467 c.c.) .<br>– Bancarotta preferenziale se i prestiti dei soci vengono rimborsati preferendo la holding ai creditori terzi ; bancarotta distrattiva se prestiti infruttiferi sono usati per drenare cassa senza restituzione.<br>– Azione di responsabilità ex 2497 c.c. se la holding abusa finanziariamente (es. tassi usuranti o ritiro di fondi che lascia la controllata insolvente).<br>– Nessun reato per cash pooling regolare deliberato (Cass. pen. 39139/2023) . |
| Trasferimento di bene (vendita o conferimento di asset, partecipazioni, rami d’azienda) | – Abuso del diritto se effettuato a sotto-prezzo o sopra-prezzo al fine di ottenere vantaggi fiscali (es. schema conferimento + cessione partecipazioni per evitare tassazione plusvalenza) .<br>– Elusione imposte indirette: es. cessione infragruppo con registro ridotto seguita da rivendita a terzi (rivendita elusiva) ; cessioni esenti IVA infragruppo con recupero indebito di crediti IVA (applicazione dottrina Halifax).<br>– Rettifica dei corrispettivi a valore normale ex art. 9 TUIR se prezzo anomalo anche tra consociate italiane (antisottrazione di basi imponibili). | – Revocatoria dell’atto di trasferimento se lesivo della garanzia patrimoniale dei creditori (specie se prezzo vile o atto gratuito) ; ammissibile sia ordinaria (5 anni) che fallimentare (termini ridotti).<br>– Bancarotta distrattiva se l’operazione spoglia il patrimonio del debitore poi fallito (bene venduto sottocosto = distrazione) .<br>– Possibile bancarotta fraudolenta documentale se vengono simulate vendite per nascondere asset.<br>– Responsabilità ex 2497 c.c. della capogruppo se ha imposto la vendita dannosa per la controllata (lesione integrità patrimoniale) . |
| Servizi infragruppo (management fees, cost sharing, royalties interne) | – Indeducibilità dei costi se non inerenti o non adeguatamente provati (onere al contribuente di dimostrare utilità effettiva o almeno potenziale per chi paga) . Contratti generici e fatture non bastano, servono elementi dettagliati .<br>– Contestazione di transfer pricing: se compensi infragruppo eccedono valore normale di mercato, rettifica ai fini imposte dirette (e IVA se fatturati con imponibile sovrastimato) .<br>– Sanzioni IVA e penali tributarie in caso di fatture per operazioni inesistenti tra consociate (es. creazione di società filtro: frode carosello interna, false fatture – reato art. 2 D.lgs.74/2000) . | – Revocatoria dei pagamenti infragruppo per servizi fittizi o di valore sproporzionato effettuati nell’anno antecedente il fallimento (atti a titolo oneroso anomali con parte correlata). Curatore recupera le somme pagate per servizi inesistenti o inutili. <br>– Bancarotta semplice/distrattiva se l’amministratore dissipa risorse pagando servizi inutili gravosi (potrebbe ricadere nell’art. 217 L.F. se colposo, 216 se doloso). Bancarotta preferenziale se in crisi l’azienda paga le fatture alla holding privilegiandola su altri creditori.<br>– Azione ex 2497 c.c. contro la holding se ha sovraccaricato la controllata di costi impropri cagionandone il dissesto .<br>– Penale tributario: se creazione di costi fittizi per evadere imposte, amministratori perseguibili per dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.lgs.74/2000). |
| Fusione (tra società del gruppo) | – Possibile abuso se la fusione è strumentale al traffico di perdite fiscali: es. incorporare società senza attività ma con perdite solo per usarle contro utili (violando finalità art.172 TUIR) . L’antiabusività può scattare anche se formalmente la norma sul riporto perdite è rispettata, qualora l’operazione sia priva di sostanza economica diversa dall’utilizzo delle perdite stesse .<br>– Altri vantaggi fiscali: fusione per far emergere avviamento deducibile in maniera impropria, fusione per ottenere regime di esenzione particolari – se sono l’unico scopo, contestabili ex 10-bis. | – Tutela creditori relativamente elevata: fusione comporta successione universale, quindi in genere i creditori non perdono garanzie (anzi, unione di patrimoni).<br>– Rischio per creditori in casi specifici: es. merger leveraged (LBO) mal eseguito che trasferisce debiti sulla società target e la indebolisce – responsabilità per amministratori e nullità se in frode (art. 2501-bis c.c. e giurisprudenza penal-fallimentare).<br>– In fallimento, se una fusione è servita a confondere patrimoni per sottrarre asset da una procedura concorsuale, potrebbe valutarsi l’estensione di fallimento o un’azione di responsabilità. (Concetto di unitarietà sostanziale del gruppo). |
| Scissione (spin-off di parte di società in altra) | – Abuso fiscale se finalizzata a vantaggi indebiti: es. isolare asset con plusvalori latenti in una beneficiaria e vendere questa beneficiaria per sfruttare esenzioni (PEX) o regimi di favore di registro . Contestabile ex 10-bis se manca vera sostanza economica oltre al risparmio d’imposta.<br>– Elusione di norme antiperdita: scissioni multiple per aggirare limiti al riporto perdite o al consolidato, se costruite artificiosamente.<br>– Eventuale disconoscimento di benefici fiscali applicati (es. ruling disapplicativo negato se si scopre abuso postumo). | – Revocatoria ordinaria e fallimentare ammesse sulla scissione in caso di pregiudizio ai creditori (SU 5089/2025) . Competenza: tribunale imprese per revocatoria ordinaria, tribunale fallimentare per fallimentare .<br>– Bancarotta distrattiva se la scissione ha sottratto patrimoni dalla società originaria poi fallita (es. beni trasferiti a newco e oldco lasciata coi debiti) – casi frequenti in cronaca giudiziaria .<br>– Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c.: se ignorata o elusa, i creditori possono comunque far valere i loro diritti post-scissione (beneficiaria e scissa rispondono nei limiti stabiliti, salvo patti ampliativi).<br>– Responsabilità ex 2497 c.c. della holding se ha orchestrato scissione pregiudizievole (es. rovinando la solvibilità della scissa, vedi sopra). |
| Operazioni miste complesse (es. conferimento + vendita, trasformazione + cessione, ecc.) | – Schema elusivo tipico: conferimento tax-free seguito da vendita partecipazioni in esenzione (PEX) – è considerato abuso dal fisco se privo di ragioni valide, equiparandolo alla vendita diretta evitata .<br>– Altre combinazioni (es. trasformazione società per sfruttare regime fiscale migliore in vista di cessione) sotto lente: se unico scopo è fiscale, contestabili.<br>– In generale, l’Amministrazione scompone la sequenza e ne valuta la causa reale: se l’effetto finale è un risparmio d’imposta altrimenti non ottenibile, e la sequenza di atti non ha senso autonomo, applica l’art. 10-bis (es. abuso del diritto unitario). | – Pregiudizio ai creditori: quando operazioni combinate servono a spostare “la parte buona” dell’azienda altrove, lasciando “la parte cattiva” ai creditori, è classico schema fraudolento. Es.: conferire gli asset sani in Newco e lasciare i debiti in Oldco che fallisce – revocatoria del conferimento e bancarotta distrattiva per Oldco, con eventuale concorso della Newco se consapevole (amministratori di Newco complici).<br>– Responsabilità 2497 e di amministratori: disegni di gruppo complessi che producono insolvenza di una parte generano azioni di responsabilità sia verso chi ha diretto il gruppo, sia verso i singoli amministratori per violazione dei doveri (es. gestione che favorisce alcuni creditori/entità a scapito di altri). |
(Fonti normative e giurisprudenziali: art. 10-bis l. 212/2000; artt. 2497 e 2467 c.c.; Cass. ord. 17433/2024 ; Cass. 29936/2023; Cass. SU 5089/2025 ; Cass. 12823/2024; Cass. 16480/2014; Cass. 8001/2021; Cass. 5458/2023, Cass. 18333/2022; massime Cass. pen. 39139/2023 ; ecc.)
Strategie operative per prevenire e difendersi dalle contestazioni
Alla luce di quanto visto, risulta chiaro che le contestazioni su operazioni infragruppo “non di mercato” si vincono (o si evitano) a monte, attraverso una condotta prudente e ben documentata. Riassumiamo dunque alcune strategie operative generali rivolte a chi, in qualità di consulente legale o di imprenditore, voglia prevenire problemi o prepararsi a difendersi efficacemente:
- Conoscere la normativa e gli orientamenti: Tenersi aggiornati sulle evoluzioni normative e sulle sentenze recenti è fondamentale. Le posizioni della Cassazione dal 2021 in poi indicano un trend di rigore: oneri probatori stringenti per i contribuenti (specialmente su costi infragruppo) , tolleranza zero per spostamenti di reddito in consolidato , piena applicazione della clausola antiabuso anche a operazioni domestiche . Essere consapevoli di queste linee guida consente di progettare le operazioni in modo conforme o almeno difendibile.
- Pianificazione preventiva e compliance: Prima di compiere un’operazione infragruppo rilevante (sia essa finanziaria, straordinaria o di servizi), effettuare un check antielusione e anti-frode. In pratica, chiedersi: Qual è lo scopo economico reale? Ci sono vantaggi fiscali significativi? L’operazione potrebbe apparire sospetta a un occhio esterno?. Se emergono profili di rischio, valutare aggiustamenti (es: modificare condizioni per allinearle al mercato, includere clausole di tutela creditori, ecc.) oppure predisporre documentazione robusta (es. perizie di congruità, pareri legali, verbali motivati) che contrasti eventuali accuse di artificiosità .
- Documentare il Business Purpose: Ogni qual volta un’operazione infragruppo comporti un vantaggio fiscale non trascurabile, è opportuno stilare un memorandum interno sul business purpose, ovvero sulle ragioni extrafiscali. Questo documento – da allegare magari alla delibera consiliare – esplicherà perché l’operazione ha senso a livello imprenditoriale (es: “centralizziamo gli acquisti per ottenere sconti”, “separiamo un ramo d’azienda per attrarre un investitore”, “finanziamo la start-up controllata perché il suo successo aumenterà il valore di gruppo”, ecc.). In caso di verifica, poter esibire un documento del genere, redatto ante operam, è una prova potente di buona fede e di assenza di intenti abusivi .
- Utilizzo oculato dell’interpello anti-abuso: Lo strumento dell’interpello può essere un alleato per dormire sonni tranquilli. Se si prefigura un’operazione sofisticata su cui avete dubbi (es: una fusione che comporterà un forte risparmio d’imposta ma che ritenete giustificata), valutate di presentare interpello all’Agenzia delle Entrate spiegando il caso e chiedendo se configurerebbe abuso. La risposta (vincolante) vi darà certezza: se è negativa, potete rimodellare l’operazione o rinunciarvi; se è positiva, l’Amministrazione non potrà poi contestarla, salvo difformità di fatto . L’interpello è facoltativo, ma mostra un atteggiamento collaborativo che può persino essere valorizzato in sede contenziosa come indice di buona fede (qualora, ad esempio, il contribuente abbia agito conforme a prassi o circolari pur senza interpello, dimostrando di aver fatto di tutto per rispettare le regole).
- Trasparenza verso i creditori e terzi: Dal lato civilistico, ricordatevi che le operazioni che alterano la struttura patrimoniale andrebbero comunicate (o almeno non occultate) ai terzi interessati. Se avete rapporti con banche, ad esempio, informarle di una fusione o scissione prima che avvenga, e magari ottenere il loro consenso, mette al riparo da contestazioni di malafede. Nelle procedure richieste dalla legge (come il deposito del progetto di fusione/scissione e l’eventuale consenso dei creditori), rispettate scrupolosamente i termini e gli adempimenti**. Un creditore che non viene informato correttamente potrebbe successivamente usare ciò a proprio vantaggio in giudizio (sostenendo di non aver potuto opporsi per vizio di comunicazioni).
- Perizia e fairness opinion: Mai sottovalutare l’importanza delle perizie indipendenti. Che si tratti di valutare un immobile da trasferire, di stimare l’avviamento in una fusione, o di determinare un tasso di interesse equo per un prestito, il parere di un terzo esperto conferisce un’aura di obiettività. È difficile per un organo giudicante ignorare una stima tecnica seria a favore di affermazioni generiche di sopravvalutazione/sottovalutazione da parte di chi contesta. In più, se la controparte (Fisco o curatore) volesse confutare la vostra perizia, dovrebbe a sua volta produrne una – scontro in cui spesso si finisce per trovare un compromesso. Quindi investire in perizie e fairness opinion ex ante è spesso un’assicurazione contro future accuse.
- Delibere consiliari e verbalizzazioni accurate: I verbali degli organi sociali (CDA, assemblee) dovrebbero raccontare la storia vera dell’operazione: mettete nero su bianco le motivazioni, le valutazioni fatte, anche le eventuali preoccupazioni e come le avete affrontate. Ad esempio, se un amministratore esprime dubbi sui creditori in una scissione, non nascondeteli: annotate che è stato dibattuto e magari si è deciso di offrire una garanzia (o che la maggioranza ha ritenuto il rischio inesistente per X motivi) . Questi verbali, se onesti, possono dimostrare che non c’era volontà di nuocere. Al contrario, decisioni prese “in silenzio” alimentano il sospetto di consapevolezza dell’illiceità. In campo penale fallimentare, ad esempio, l’accusa spesso cerca di provare il dolo mostrando che certi atti sono stati fatti di nascosto o in fretta prima del crack: se invece voi li avete discussi in CDA apertamente mesi prima, ciò contrasta l’idea del dolus malus.
- Conservare evidenze delle consulenze professionali: Se vi siete avvalsi di consulenti (fiscali, legali) prima di agire, conservate lettere, email, pareri formalizzati. In caso di contestazione, esibire che “il professionista XY ci aveva rassicurato sulla legittimità” può non evitare l’accertamento, ma certamente aiuta sulla non intenzionalità di eventuali violazioni. Ad esempio, nella comminatoria di sanzioni tributarie, la prova di una objective good faith (consulenza qualificata su cui ci si è basati) può portare all’esclusione delle sanzioni per errore scusabile. E in sede penale, come già detto, un parere legale è un argomento forte per escludere il dolo .
- Attenzione alle procedure di gruppo interne: I gruppi di imprese con una certa complessità dovrebbero dotarsi di policy interne per le operazioni infragruppo (c.d. transfer pricing policy, intercompany agreements guidelines, ecc.). Questi documenti interni stabiliscono criteri generali: ad es. “tutte le transazioni infragruppo devono avvenire per iscritto e a condizioni equivalenti a quelle di libero mercato”, oppure “ogni prestazione infragruppo dev’essere dettagliatamente documentata, con report mensili inviati alla controllata e controfirmati”, ecc. Avere tali procedure ed applicarle realmente può essere decisivo nel dimostrare l’atteggiamento compliant dell’azienda. Se in un processo emerge che la società aveva implementato e seguito un sistema di controllo dei prezzi infragruppo (magari certificato da revisori), l’eventuale contestazione apparirà come un’eccezione, non come una prassi voluta di abuso.
- Correzioni e ravvedimenti operosi: Se vi accorgete, magari a seguito di una due diligence interna o di un cambio di consulenti, che qualche operazione passata infragruppo era mal impostata (es. avete dedotto costi infragruppo senza pezze giustificative adeguate), valutate di correggere il tiro spontaneamente. Ciò può voler dire: per il passato, eventualmente fare un ravvedimento operoso sul piano fiscale (se il rischio è alto e c’è ancora tempo per regolarizzarsi con sanzioni ridotte); per il futuro, rettificare i contratti o smettere pratiche dubbie. Ad esempio, se una holding ha caricato costi arbitrariamente su una consolidata, potete decidere di rinunciare a farlo andando avanti. Così, se anche arriva un controllo, potrete dimostrare che non c’era volontà sistematica di eludere e avete cooperato per sanare – elemento che può mitigare le conseguenze.
Applicando queste strategie, molte contestazioni possono essere evitate, e quelle che dovessero comunque sorgere troveranno un contribuente/debitore preparato, con un arsenale probatorio a proprio favore. In ogni caso, è sempre consigliabile farsi assistere da professionisti esperti di diritto tributario e fallimentare nelle operazioni infragruppo più delicate, così da ricevere un parere indipendente sul rischio e sulle misure di salvaguardia da adottare.
Domande e risposte frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande comuni in materia di operazioni infragruppo non a condizioni di mercato, con risposte sintetiche ma puntuali basate sulla normativa e la giurisprudenza analizzate nella guida:
D: Che cos’è esattamente l’“abuso del diritto” in ambito tributario?
R: L’abuso del diritto (o elusione fiscale) è una condotta in cui il contribuente rispetta formalmente le leggi tributarie, ma le utilizza in modo artificioso e contrario alla loro finalità, ottenendo un vantaggio fiscale indebito . In pratica, l’operazione abusiva è priva di sostanza economica reale e serve quasi solo a risparmiare imposte che altrimenti sarebbero dovute. Esempi: creare società fittizie per spostare utili in paradisi fiscali; frammentare un’attività in più società minori solo per restare sotto soglie di esenzione. L’art. 10-bis dello Statuto contribuenti codifica questo principio, permettendo al Fisco di disconoscere i benefici fiscali di tali operazioni . È importante distinguere l’abuso dall’evasione: nell’evasione c’è violazione diretta della legge (es. omessa dichiarazione, false fatture) ; nell’abuso no, tutto è formalmente lecito, ma orchestrato per aggirare lo spirito della legge . L’abuso comporta recupero di imposte e sanzioni amministrative, ma non costituisce reato tributario .
D: In cosa differisce l’elusione fiscale dall’evasione fiscale?
R: Come accennato, l’evasione implica la violazione esplicita di norme fiscali – ad esempio non dichiarare dei redditi, emettere fatture false per costi fittizi, distruggere documentazione contabile – ed è di solito punita anche penalmente (si pensi alla dichiarazione fraudolenta) . L’elusione fiscale (sinonimo di abuso del diritto) invece consiste nel combinare atti leciti per ottenere un risultato che la legge fiscale non intendeva permettere . Un esempio di elusione: un imprenditore anziché vendere un immobile personalmente (tassazione piena) costituisce una società e le vende l’immobile per poi cederne le quote dopo un anno sfruttando un regime fiscale di maggior favore; formalmente tutto regolare, ma l’operazione potrebbe essere ritenuta abusiva se fatta solo per pagare meno tasse. Quindi, l’evasione è un illegalità palese, l’elusione è un uso distorto di legalità. Le conseguenze: l’evasione comporta sanzioni amministrative e spesso penali, l’elusione comporta solo il recupero delle imposte e sanzioni amministrative, senza penali . In sintesi: evasione = violare la legge; elusione = aggirarne lo scopo.
D: Il fatto che un’operazione avvenga tra società dello stesso gruppo è già di per sé un indizio di abuso?
R: No, non automaticamente. Non esiste in Italia alcuna presunzione legale che i rapporti infragruppo siano, di per sé, illeciti o abusivi. La Cassazione ha più volte ribadito che la mera appartenenza a un gruppo societario non costituisce di per sé indice di abuso . Ogni operazione va valutata caso per caso nella sua concreta struttura e finalità. Certo, le operazioni infragruppo sono attenzionate dal Fisco e dai creditori perché, essendoci comunanza di interesse, c’è più facilità a spostare basi imponibili o patrimoni “da una tasca all’altra”. Ma se un’operazione infragruppo risponde a logiche di mercato e ha una sostanza economica reale, non c’è nulla di illecito solo perché avviene “in famiglia” . Esempio: se Alfa vende a Beta (controllata) un macchinario a prezzo di mercato, è un’operazione come un’altra, nessun abuso; se Gamma presta soldi a Delta con un regolare interesse come farebbe una banca, nulla di strano. Invece l’abuso scatta quando l’operazione non avrebbe senso economico per entità indipendenti e sembra concepita solo per un vantaggio fiscale . Stesso discorso dal lato dei creditori: un atto infragruppo non è ipso facto in frode, deve presentare i caratteri del pregiudizio e della scientia fraudis. In breve: operare infragruppo è lecito, ma richiede magari maggior trasparenza e aderenza ai valori normali per non destare sospetti. Nessuno vieta di fare affari tra consociate, purché si rispettino le regole delle normali transazioni.
D: Quali sono esempi tipici di operazioni infragruppo contestate come abusive?
R: Tra i casi più ricorrenti nelle dispute fiscali (e non solo) possiamo citare:
- Conferimento + cessione di partecipazioni: come descritto, conferire un bene o ramo d’azienda in una newco del gruppo sfruttando la neutralità fiscale, e poi vendere le quote della newco beneficiando di tassazione ridotta (PEX al 95% esente, o registro fisso). Lo scopo evidente è evitare di tassare la plusvalenza sul bene conferito. Questo schema è spesso contestato come abuso , a meno che non ci siano ragioni extrafiscali sostanziose (ad es., ingresso di un socio di minoranza nella newco per apportare capitale, ecc.). Variante: scissione seguita da cessione (simile effetto via altra via) – anche qui, altamente a rischio se lo scopo è solo il risparmio fiscale.
- Società estere “schermo” (esterovestizione): creazione di una controllata in un paese a fiscalità privilegiata, senza reale presenza economica, allo scopo di dirottare profitti che altrimenti sarebbero tassati in Italia. Ad esempio, un’azienda italiana costituisce in Irlanda una società che formalmente fattura servizi al gruppo, ma in realtà è gestita dall’Italia e non ha struttura. Questo è considerato abuso e spesso anche evasione se si occultano i profitti all’estero. Cass. 10305/2024 ha definito chiaramente la società schermo come una costruzione artificiosa volta solo a benefici fiscali, elencando i segnali di mancanza di sostanza (sede fittizia, retrocessione di utili alla capogruppo, ecc.) . L’esterovestizione di società è bersaglio costante di Agenzia Entrate e GdF.
- Finanziamenti infragruppo anomali: ad esempio, trasformare un conferimento in prestito per dedurre interessi. Se i soci invece di aumentare capitale danno un finanziamento ad alto tasso alla società, deducendo interessi e poi magari convertendo in capitale, può esserci elusione. Oppure far pagare interessi eccessivi a una consociata su un prestito per spostare reddito imponibile (interessi deducibili qui, tassati magari a aliquota minore altrove). Se i tassi non sono di mercato, l’operazione viene contestata, sia attraverso transfer pricing (se cross-border) sia come costo non inerente/antieconomico (domestico) . L’obiettivo tipico è far figurare spese finanziarie elevate in una società per erodere la base imponibile – scenario ben noto e attenzionato (prima c’erano regole di thin cap apposite).
- Triangolazioni IVA infragruppo: schemi complessi per creare crediti IVA o applicare aliquote ridotte in maniera impropria. Ad esempio: Alfa vende beni esenti a Beta (consociata) e Beta li rivende imponibili a terzi generando un credito IVA, il tutto orchestrato per ottenere rimborsi. Oppure creare una finta società di trading in altro paese UE solo per fare viaggiare beni su carta e maturare detrazioni. La Corte UE (caso Halifax) e le autorità nazionali guardano la sostanza: se l’operazione infragruppo non ha scopo economico reale ed è volta ad un vantaggio IVA indebito, viene ignorata (abuso di diritto in materia IVA) .
- Gestione centralizzata dei costi per abbattere utili: la capogruppo concentra su di sé (o su una consociata in perdita) la maggior parte dei costi del gruppo, poi li ribalta con fatture alle altre consociate in utile. In regime di consolidato fiscale, questo può sembrare irrilevante (tanto utili e perdite si compensano), ma Cass. 17433/2024 ha sancito l’illegittimità di spostare costi tra consolidate senza base economica . Dunque far fatturare consulenze o servizi inesistenti da una società all’altra per distribuire utili è un abuso. Addirittura in quel caso la Cassazione ha detto che l’Ufficio ha interesse ad agire anche se il reddito di gruppo non cambia, perché le regole di determinazione del reddito di impresa vanno rispettate singolarmente . Quindi oggi questa strategia di tax planning interno è molto rischiosa.
Riassumendo, il filo conduttore è: l’operazione era formalmente lecita ma sostanzialmente insensata se non per risparmiare tasse? Se sì, c’è altissima probabilità che venga contestata come abuso . E spesso, parallelamente, se ha leso creditori avremo contestazioni sul fronte civile/penale (es. scissione spoglia = abuso per Fisco, bancarotta per GdF).
D: Come valuta l’Agenzia delle Entrate se un’operazione infragruppo è abusiva oppure no?
R: L’Agenzia applica il test dell’art. 10-bis: in pratica verifica due aspetti fondamentali :
- Sostanza economica dell’operazione: guarda se l’operazione ha effetti significativi diversi dal risparmio fiscale. Cioè: ha migliorato davvero la posizione economica del contribuente (o del gruppo) al netto delle tasse? Ci sono indizi di artificiosità? Ad esempio: l’uso di società senza struttura (società schermo) , operazioni circolari (denaro o beni che escono e rientrano senza vero cambiamento), complessità non giustificata (catene di atti che un operatore razionale non farebbe se non per motivi fiscali), incongruenze rispetto alle normali logiche di mercato (ad esempio vendere un bene a una consociata che non ne ha alcun utilizzo funzionale). Se emergono questi elementi, l’Agenzia propende per la mancanza di sostanza .
- Ragioni extrafiscali non marginali: verifica se il contribuente può addurre motivi non fiscali credibili e sostanziali. Le norme stesse dicono che non c’è abuso se l’operazione è giustificata da valide ragioni extrafiscali, anche se poi comporta un risparmio d’imposta . Quindi l’Agenzia esaminerà la documentazione: c’era un piano industriale? C’è evidenza di finalità commerciali, finanziarie, organizzative? Ad esempio: una fusione che effettivamente ha portato a ridurre costi di struttura e migliorare la redditività operativa, anche se ha permesso l’uso di perdite fiscali, probabilmente supera il test (perché ha ragioni economiche sostanziali). Viceversa, un conferimento + vendita fatto su un bene immobile tenuto fermo in società, senza altro scopo se non vendere con meno tasse, difficilmente avrà giustificazione. Gli indizi di mancanza di valide ragioni includono: cronologie sospette (operazioni fatte subito prima di scadenze fiscali o di cessioni pianificate), mancanza di integrazione effettiva post-operazione (es. dopo una fusione di comodo l’attività rimane separata come prima), etc. Se l’Agenzia non trova alcuna motivazione extrafiscale se non magari dichiarazioni generiche, dichiarerà l’abuso.
In sostanza, l’Agenzia fa un’analisi sostanziale: se l’operazione non migliora la posizione economica del contribuente se non per le imposte risparmiate, e non si riesce a giustificarla con motivi validi di business, verrà contestata. Di contro, se l’operazione ha senso di per sé (produce utili, sinergie, crescita, ristrutturazione utile) e il vantaggio fiscale è conseguenza secondaria, allora passerà indenne. Va detto che il contribuente ha possibilità di difendersi nel contraddittorio anche su questo: può portare elementi a supporto delle proprie ragioni (es. perizie, studi di settore, dati ex post che mostrano risultati economici effettivi, ecc.). Infine, ricordiamo che l’Agenzia prima di emettere un atto per abuso deve attivare una specifica procedura: notificare al contribuente la contestazione potenziale e dargli 60 giorni per replicare (come prevede l’art. 10-bis). Quindi c’è uno spazio in cui spiegare le ragioni e magari far recedere dall’accertamento, fornendo le prove richieste.
D: Se la mia società ha documentazione di transfer pricing e accordi infragruppo ben formalizzati, sono al riparo da contestazioni?
R: Sicuramente avere in ordine la documentazione TP (Masterfile, Documentazione Nazionale) e contrattualistica intercompany aiuta moltissimo, specialmente per le questioni di prezzi di trasferimento. Dal 2020 in Italia la predisposizione della documentazione di transfer pricing secondo il Provv. 360494/2020 protegge dalle sanzioni in caso di rettifiche (penalty protection) e costituisce elemento a favore del contribuente. Quindi, se hai documentato i criteri di determinazione dei prezzi infragruppo e l’Amministrazione li ritiene non di libera concorrenza, dovrai pagare l’eventuale maggior imposta ma non sanzioni, a patto che i documenti TP siano considerati idonei . Ciò non significa essere immuni da contestazioni in assoluto: il Fisco potrà sempre sindacare il merito (cioè dire “nonostante la tua analisi comparativa, il margine che hai applicato secondo noi non è arm’s length”), ma tu avrai già esposto le tue argomentazioni ex ante, il che ti pone in posizione difensiva forte. Inoltre, contratti chiari e completi (come raccomandato) rendono oggettivamente più difficile per l’Ufficio dire che un costo è fittizio o un servizio non reso: se hai un contratto + report + deliverables, l’onere di dimostrare l’inesistenza si fa più gravoso per loro. Diciamo che forma e sostanza allineate riducono drasticamente il rischio di contestazione e comunque aumentano le chance di vittoria in contenzioso.
Va tuttavia sottolineato che documentazione e contratti devono riflettere la realtà: non basta avere una carta ben fatta se poi, ad esempio, la funzione non è svolta davvero. Quindi, se c’è coerenza tra quanto scritto e quanto fatto, sei abbastanza al riparo. Un esempio: se hai un Masterfile in cui spieghi che la tua consociata estera è una semplice distribuidora e le riconosci un margine limitato, e poi i bilanci mostrano effettivamente quel margine, difficilmente il TP sarà contestato. Se invece la realtà diverge (documenti dicono una cosa ma i conti ne mostrano un’altra), la difesa si complica.
Riassumendo: la compliance documentale (TP documentation, intercompany agreements, policy interne) è una cintura di sicurezza. Non impedisce al 100% l’incidente (la verifica), ma in caso di incidente evita o limita i danni (niente sanzioni, contestazione ridotta a questioni tecniche su cui hai già contro-argomenti). Per i servizi infragruppo domestici, pur non essendoci obbligo di documentazione TP, avere comunque un dossier con analisi di congruità e utilità (sul modello OCSE) ti mette quasi in una safe zone. Le linee guida OCSE e il DM 14 maggio 2018 in Italia sono parametri di riferimento riconosciuti .
D: In caso di accertamento per prezzi infragruppo non congrui, su chi ricade l’onere della prova?
R: La questione dell’onere della prova nel transfer pricing è stata dibattuta ma ormai la Cassazione ha un orientamento consolidato: in prima battuta spetta al Fisco dimostrare che c’è stata una transazione con consociata a condizioni divergenti dal valore normale di libero mercato . Questo di solito avviene mostrando, ad esempio, che il margine di profitto su vendite verso la consociata estera è la metà di quello su vendite verso terzi, oppure che la consociata pagava un interesse molto più basso rispetto al tasso di riferimento. Non è necessario che il Fisco provi un vantaggio fiscale ulteriore o un disegno evasivo – la differenza di prezzo rispetto al mercato è di per sé la cosa rilevante . Una volta fatta questa dimostrazione (anche con metodi comparativi semplificati), l’onere si sposta sul contribuente, il quale deve provare che le condizioni praticate erano comunque giustificate. Ciò può includere provare che la controparte estera aveva diverse funzioni/rischi (e quindi un margine minore era giustificato), o che c’erano circostanze particolari (ad es. un tasso basso perché la consociata era appena avviata e sostenuta intenzionalmente). Inoltre, se si possiede la documentazione di TP e la si esibisce, l’Ufficio dovrà valutarla: se la ignorasse, il giudice potrebbe ritenerlo un difetto di motivazione dell’atto. In giudizio, comunque, è il contribuente che di fatto deve convincere della legittimità del proprio operato, mostrando con analisi economiche che i prezzi applicati erano in linea con quelli di soggetti indipendenti comparabili . Nei costi infragruppo (ambito leggermente diverso dal TP puro), come visto, la Cassazione chiede espressamente la prova puntuale dell’utilità del costo da parte del contribuente . Dunque, sintetizzando: il Fisco deve indicare la non congruità (in termini di valori o di mancanza di benefici percepibili); il contribuente deve fornire la prova contraria che quel valore è corretto in base alle circostanze o che comunque il costo era effettivo e giustificato. Se rimane incertezza, di solito prevale la posizione del Fisco, a meno che il contribuente non abbia elementi convincenti. Questo sprona, come detto, a prepararsi bene già in sede di operazioni con tutta la documentazione probatoria.
D: Sono un amministratore: quali rischi corro in prima persona se faccio operazioni infragruppo disinvolte?
R: Dipende dalla gravità e dagli esiti di tali operazioni, ma potenzialmente:
- Sanzioni amministrative tributarie: se l’operazione comporta un maggior tributo accertato, la società subirà sanzioni (tipicamente il 90% dell’imposta evitata, riducibili per adesione, ecc.). L’amministratore in sé non paga di tasca propria queste sanzioni (gravano sulla società), a meno che non si provi una sua colpa grave o dolo e la società agisca contro di lui – raro in ambito tributario.
- Responsabilità verso la società (azione di responsabilità): se dall’operazione infragruppo è derivato un danno alla società (ad esempio sanzioni fiscali elevate, o perdita di asset a favore di altre società), i soci o il curatore fallimentare potrebbero agire contro gli amministratori per violazione dei doveri. Ad esempio, l’amministratore di una controllata che approva la cessione di beni sottocosto alla capogruppo potrebbe essere ritenuto responsabile ex art. 2392 c.c. per aver cagionato un danno al patrimonio sociale. In caso di fallimento, il curatore frequentemente cita in giudizio gli amministratori per operazioni distrattive o imprudenti (spesso cumulando più condotte). Quindi un amministratore può trovarsi a dover risarcire di persona i danni (anche rilevanti) se viene riconosciuta la sua colpa/dolo.
- Decadenza e sanzioni societarie: se l’operazione configura violazione di norme societarie (es. operazioni su patrimoni in presenza di perdite rilevanti non trattate come dovuto), l’organo di controllo potrebbe segnalare e portare a revoca l’amministratore. Inoltre, operazioni gravemente imprudenti possono giustificare revoca per giusta causa.
- Conseguenze penali: qui sta il pericolo più importante. Se l’operazione configura un reato (tipicamente in ambito fallimentare o fiscale), l’amministratore rischia processi penali e potenzialmente la condanna. Per i reati tributari, se l’abuso sconfina in reato (es. false fatture), la pena può essere la reclusione (fino a 6 anni per frode fiscale significativa). Per i reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta patrimoniale prevede da 3 a 10 anni di reclusione; la bancarotta preferenziale fino a 2 anni (a volte assorbita dalla fraudolenta se c’è insieme distrazione). La Cassazione ha una posizione severa: se c’è dolosa preordinazione nel sottrarre asset via operazioni societarie, condanna per bancarotta (come nei casi citati di scissioni distrattive) . Bisogna poi considerare l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità a esercitare cariche societarie per un periodo che derivano da condanne penali.
- Estensione del fallimento (caso di holding di fatto): se l’amministratore di più società le ha di fatto usate come un’unica impresa confondendone patrimoni e interessi (la c.d. supersocietà di fatto), potrebbe vedersi dichiarare fallito personalmente (se persona fisica), come socio illimitatamente responsabile di una società di fatto con le altre (ipotesi estrema ma verificatasi: es. caso Parmalat con Tanzi, anche se lì c’erano altre basi).
In sintesi, l’amministratore deve essere consapevole che operare infragruppo in modo non trasparente o dannoso non è affatto senza rischi personali. Il mio consiglio per un amministratore è: fai sempre deliberare collegialmente operazioni delicate (così le responsabilità sono condivise e discusse), chiedi pareri professionali (difesa di buona fede), informa gli organi di controllo (sindaci, revisori) – se taci è peggio, se loro non sollevano rilievi hai un punto a favore – e valuta sempre se l’operazione è nel miglior interesse della società che amministri (ricorda che, pur nel gruppo, ogni società ha la sua autonomia patrimoniale e tu hai doveri fiduciari verso quella). Operando così, minimizzi il rischio di incorrere in profili di colpa o dolo.
D: I creditori sociali cosa possono fare se sospettano che un atto infragruppo li abbia pregiudicati?
R: Un creditore che si ritiene danneggiato da un’operazione infragruppo ha a disposizione principalmente:
- L’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): se il creditore è anteriore all’atto, e quell’atto ha reso più difficile la sua soddisfazione, può chiedere al tribunale di dichiararlo inefficace verso di lui . Deve provare l’eventus damni (che il patrimonio del debitore è stato depauperato in modo pregiudizievole) e, se l’atto è a titolo oneroso, la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato. Con operazioni infragruppo spesso è facile dimostrare la consapevolezza (le parti correlate sanno della situazione l’una dell’altra). Ad esempio, se una società mi deve 500k e vende a metà prezzo un bene a una collegata, posso revocare la vendita. Effetto: se vinco, posso pignorare il bene in mano alla collegata come se fosse ancora del debitore.
- L’azione revocatoria fallimentare: se il debitore è già fallito o in altra procedura concorsuale, è il curatore a agire (non il singolo creditore), ma di fatto lo fa nell’interesse di tutti i creditori. Un creditore può però stimolare il curatore segnalando l’operazione sospetta. Se il curatore inspiegabilmente non agisce, il creditore può talvolta intervenire (es. istanze al giudice delegato) ma formalmente l’azione in quel contesto spetta solo al curatore.
- L’azione risarcitoria ex art. 2497 c.c.: se il danno deriva dall’abuso di direzione e coordinamento, un creditore di una società eterodiretta può agire direttamente contro la società (o ente o persona) che esercita tale direzione e coordinamento . Deve provare che la capogruppo ha violato i principi di corretta gestione causando lesione all’integrità del patrimonio della società debitrice . Ad esempio, se Tizio Srl (debitrice) ha trasferito beni su ordine di Caio SpA (holding) rovinando la propria solvibilità, il creditore di Tizio può chiedere a Caio il risarcimento del suo credito insoddisfatto. Questa azione è utile specie se la società debitrice è insolvente (così si attacca direttamente la cassaforte a monte). In caso di fallimento, come visto, l’azione dei creditori ex 2497 c.c. viene esercitata dal curatore , ma il singolo creditore può comunque insinuarsi per il suo risarcimento.
- Strumenti cautelari: se il creditore ha timore fondato che il patrimonio residuo del debitore si disperda, può chiedere sequestri conservativi o azioni revocatorie in via d’urgenza (quando c’è pericolo nel ritardo). Ad esempio, se scopro che la mia società debitrice sta per fondersi per incorporazione in una newco in modo sospetto, potrei chiedere al tribunale un provvedimento urgente per congelare la situazione (magari ex art. 2378 c.c. analogicamente, o un sequestro sui beni trasferiti).
- Opposizione a fusione/scissione: se l’atto sospetto è una fusione o scissione non ancora conclusa, i creditori hanno il potere di opposizione entro 60 giorni dal deposito del progetto (artt. 2503 e 2503-bis c.c.). Opponendosi in tribunale, la fusione/scissione non può perfezionarsi finché il giudice non rigetta l’opposizione o autorizza comunque se ritiene che il creditore sia adeguatamente tutelato (es. con garanzie). Questa è una tutela ex ante importante, anche se spesso i creditori non ne vengono a conoscenza in tempo.
In pratica, i creditori hanno strumenti robusti per reagire. La revocatoria e l’azione ex 2497 c.c. si possono esercitare anche contestualmente: es. revoco l’atto, e chiedo i danni alla holding per la parte non coperta dal bene revocato. Non è “doppio risarcimento” perché la revocatoria mira a ripristinare la garanzia generica, l’azione di responsabilità risarcisce l’eventuale deficit creato.
Ovviamente, il creditore deve valutare costi/benefici: cause lunghe, spese… però in contesti di fallimento spesso il curatore se ne occupa e il singolo creditore beneficia poi pro-quota.
D: La mia società è stata raggiunta da un “avviso di accertamento” per transfer pricing su transazioni infragruppo: conviene fare subito ricorso o c’è modo di trovare un accordo?
R: In caso di accertamento per transfer pricing o abuso del diritto, hai diverse opzioni da valutare:
- Accordi e adesione: Puoi valutare la via dell’accertamento con adesione, cioè sederti attorno a un tavolo con l’Ufficio per cercare un accordo. Questa strada permette spesso di ottenere una riduzione delle sanzioni (1/3 delle minime se si chiude l’adesione) e magari trovare un punto d’incontro su imponibili. Ad esempio, se l’Ufficio sostiene che mancavano 1 milione di ricavi, potresti negoziare a 600 mila. Nel transfer pricing internazionale, essendoci Convenzioni contro le doppie imposizioni, in caso di adeguamento di reddito puoi anche attivare procedure amichevoli internazionali (MAP) per evitare doppia tassazione, ma sono lunghe. L’adesione sospende i termini e può essere tentata senza pregiudicare poi il ricorso, se non si perfeziona.
- Ricorso in Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado): Se ritieni l’atto infondato e hai solide prove, il ricorso è la via. Considera però che la giurisprudenza, come abbiamo visto, non è tenera con chi ha documentazione carente. Se il tuo caso è che non avevi documentazione di TP e hai caricato costi infragruppo generici, in CT potresti soccombere (Cassazione è molto pro-fisco su onere della prova in quei casi). Se invece hai buone pezze d’appoggio (studi di settore, comparables, etc.), allora puoi farle valere. Spesso conviene far redigere a un consulente tecnico una perizia di TP da produrre in giudizio per dimostrare che i prezzi contestati in realtà erano congrui: il giudice potrebbe sposare la perizia, o comunque è un elemento forte. Ricorda che in primo grado potresti anche chiedere una CTU (consulenza tecnica d’ufficio), ad esempio se la questione è altamente tecnica.
- Definizione agevolata e istituti analoghi: Attualmente (2023-2025) ci sono spesso norme di tregua fiscale: ad esempio, la definizione agevolata delle liti pendenti, o conciliazioni agevolate in appello con sanzioni ridotte. Se il tuo caso rientra (dipende dalle leggi vigenti al momento), potresti chiudere la lite pagando solo il tributo e poco altro. Attenzione però: l’abuso del diritto di solito porta sanzioni al 90%; in certe definizioni si paga un forfait, es. 1/18 del valore se si è in Cassazione… insomma conviene informarsi se sono attive misure straordinarie di pace fiscale.
- Pagamento e ravvedimento: Un’altra valutazione pragmatica: se l’importo non è elevato e la tua priorità è chiudere subito la partita, potresti decidere di pagare (magari usufruendo di riduzioni sanzioni per pagamento entro tot giorni). Spesso con l’accertamento ti offrono il pagamento con sanzioni ridotte a 1/3 entro 60 giorni. Ciò ovviamente comporta accettare il rilievo. Se ritieni di essere chiaramente in torto (es. effettivamente erano costi finti), e vuoi evitare aggravi, potrebbe essere la scelta meno onerosa sul lungo termine.
In definitiva, la convenienza tra accordo e ricorso dipende dalla forza delle tue argomentazioni e dalle prove. Se hai predisposto tutto bene e l’accertamento è troppo aggressivo, difenditi in giudizio (magari puntando a vincere già in primo grado con i documenti). Se invece sai di avere qualche scheletro nell’armadio (documentazione carente, contratti assenti), forse è meglio un accordo che eviti anche la pubblicità di una sentenza negativa. In ogni caso, fatti assistere da un avvocato tributarista esperto di transfer pricing/abuso, perché sono contenziosi complessi dove la strategia difensiva (anche nel decidere cosa concedere in adesione e cosa no) è delicata.
D: La guardia di finanza sta indagando su possibili reati fallimentari legati a una scissione che ho fatto: come posso difendermi?
R: Se sei finito nel mirino della GdF per una scissione infragruppo, probabilmente ipotizzano una bancarotta fraudolenta (distrattiva o documentale) connessa a quella operazione. La difesa in ambito penale passa da alcuni punti:
- Dimostrare l’assenza di dolo: la bancarotta fraudolenta richiede l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori. Se la scissione fu fatta in buona fede per motivi leciti, devi documentarlo. Qui torna utile tutto ciò di cui abbiamo parlato: verbali che attestano le ragioni economiche, eventuali pareri legali ottenuti prima (se un avvocato vi disse che la scissione era legittima e rispettosa dei creditori, è un ottimo elemento di difesa), comportamenti trasparenti (avete informato banche, ecc.). Far emergere che non c’era volontà di frode è cruciale. Magari la scissione era maldestra ma non dolosa: in tal caso potrebbe al limite configurarsi bancarotta semplice (per imprudenza), che è meno grave e anche spesso estinta col fallimento, mentre la fraudolenta è criminale.
- Dimostrare i vantaggi compensativi: come visto, Cass. pen. 18333/2022 ha escluso la bancarotta distrattiva quando l’operazione presentava vantaggi compensativi equivalenti . Se nel tuo caso la scissione aveva anche lati positivi (es. la società beneficiaria ha assunto anche parte dei debiti o ha immesso liquidità che è stata usata per pagare creditori, o comunque c’era un progetto di ristrutturazione non finalizzato solo a nuocere), evidenzialo. Ad esempio, se dopo la scissione la “bad company” ha potuto evitare il fallimento per un certo periodo grazie a un accordo poi saltato, ecc., tutto ciò può far propendere per l’assenza di volontà distrattiva.
- Aspetti formali della scissione: verifica con il tuo avvocato se tutti i passi formali della scissione sono stati seguiti: ad es. relazione degli amministratori, relazione degli esperti sulla congruità del patrimonio assegnato, rispetto del diritto di opposizione dei creditori. Se qualcosa non è stato fatto a dovere, l’accusa potrebbe usarlo come prova di malafede. Al contempo, se tutto è in regola formalmente, sottolinearlo: malintenzionati avrebbero cercato di nascondere, voi avete seguito la legge passo passo, il che contrasterebbe col dolo.
- Perizia retrospettiva: può essere utile far fare ora una perizia contabile che ricostruisca gli effetti della scissione sul patrimonio dei creditori. Se la perizia conclude che anche senza scissione i creditori avrebbero comunque avuto un deficit simile (magari perché i debiti superavano gli attivi a prescindere) o che con la scissione non è peggiorata di molto la soddisfazione complessiva, può essere un argomento. Al contrario, se evidenzia un danno netto, la difesa dovrà puntare su altri fattori.
- Attenuanti e patteggiamento: in ottica realistica, se le prove a tuo carico sono pesanti, potrebbe convenire puntare a riti alternativi (patteggiamento) magari con riconoscimento di attenuanti (tipo l’aver cooperato col curatore per recuperare i beni, o il risarcimento parziale del danno). Bancarotta è reato ostativo quindi niente pene sospese facili, ma col patteggiamento e attenuanti potresti stare su una pena gestibile. Però questa è strategia ultima ratio se la difesa nel merito è debole.
In ogni caso, difendersi sul penale richiede un avvocato penalista esperto di reati fallimentari. Le argomentazioni tecniche (tipo “la scissione era lecita ai sensi del 2506”) in sede penale vanno tradotte in concetti rilevanti penalmente: assenza di dolo, mancanza di evento distrattivo, buona fede, ecc.. Quindi servirà un lavoro di squadra tra un penalista e magari un commercialista forense per predisporre memorie e consulenze tecniche.
L’importante è attivarsi subito: nel penale, se la GdF indaga, probabilmente c’è già un procedimento aperto. Conviene nominare un difensore e magari presentare spontaneamente una memoria con i vostri elementi a discolpa prima che concludano le indagini. A volte convincere già la Procura che non c’è reato può evitare il processo.
D: Un curatore fallimentare mi ha citato come ex amministratore per un’operazione infragruppo di qualche anno fa; può farlo anche se all’epoca la maggioranza dei soci aveva approvato l’operazione?
R: Sì, il curatore fallimentare (che rappresenta la massa dei creditori) può promuovere un’azione di responsabilità contro gli amministratori senza essere vincolato dal fatto che l’operazione fosse approvata dai soci. Nel diritto societario, l’approvazione assembleare di un atto non copre la responsabilità degli amministratori se quell’atto è preterlegale o in frode alla legge. In particolare, l’art. 2393 c.c. vieta l’azione sociale di responsabilità se l’assemblea ha deliberato di liberare gli amministratori (ma ciò non vale per atti specifici in frode) e comunque l’azione del curatore è per conto dei creditori (cosiddetta azione di massa ex art. 146 L.F. che cumula sia l’azione sociale sia quella dei creditori). Anche se magari l’operazione infragruppo era nota e condivisa dai soci, se ha concorso a rovinare la società, gli amministratori rispondono. Per esempio, i soci possono aver approvato una scissione perché erano gli stessi della beneficiaria, ma questo è tipico dei gruppi – non impedisce al curatore di dire “avete danneggiato i creditori sociali”.
In tua difesa, puoi semmai utilizzare l’argomento che anche i soci approvarono l’operazione, quindi tu hai agito senza nascondere nulla e confidando nella correttezza di essa. Questo può servire per escludere dolo e mostrare che non hai agito di nascosto per tuo interesse. Ma se il danno è oggettivo, la delibera dei soci non ti esonera dal risponderne verso i creditori.
Spesso i curatori cumulano all’azione di responsabilità anche la revocatoria o la bancarotta in sede penale, come leve. Tu potresti eventualmente chiamare in causa i soci (se erano di fatto beneficiari) come corresponsabili ex art. 2393 e 2394 c.c., specie se sono persone giuridiche (holding). Ci sono casi in cui la holding stessa viene considerata amministratore di fatto e condannata in solido (ex art. 2497 e 2043 c.c.). Ad esempio Cass. 7262/2023 ha ricordato che i soggetti che consapevolmente beneficiano di atti di mala gestio rispondono nei limiti del vantaggio conseguito . Quindi, nel tuo caso, se la società che ha beneficiato dell’operazione è ancora solvibile, potresti cercare di coinvolgerla in giudizio per dividere la responsabilità.
In definitiva, l’autorizzazione assembleare è più rilevante come fatto per valutare la tua diligenza (ti sei almeno assicurato che i soci fossero d’accordo), ma non è uno scudo giuridico contro le pretese dei creditori rappresentati dal curatore.
D: Se un’operazione viene qualificata come abusiva dal Fisco, devo temere anche conseguenze penali tributarie?
R: No, in linea di massima l’abuso del diritto tributario non comporta reato. L’art. 10-bis, comma 13, Statuto contribuenti è chiaro: le operazioni abusive non possono essere perseguitate penalmente come reati tributari . Quindi, se la tua società viene accertata per un’elusione (ad esempio il Fisco disconosce il vantaggio fiscale di una scissione e recupera imposta), questo accertamento non farà scattare denunce per dichiarazione infedele o altro, anche se l’imposta recuperata supera soglie penali. È proprio una scelta del legislatore: l’elusione si punisce con sanzioni amministrative, non penali.
Tuttavia, bisogna stare attenti a un punto: spesso casi di abuso si accompagnano a elementi di evasione. Esempio: crei una società estera fittizia (abuso) e le fai anche fatture per operazioni inesistenti (questa è evasione). Oppure struttura abusiva + falsità nei bilanci per nasconderla = reato. In tali ipotesi, la presenza di abuso non esclude che si proceda penalmente per i profili di violazione concreta. In pratica, se per realizzare l’abuso hai commesso reati (es. false fatturazioni, occultamento di scritture, ecc.), verrai perseguito per quelli.
Ma se davvero l’unica “colpa” è aver architettato una combinazione legale di atti leciti, senza falsificare nulla, allora le conseguenze penali tributarie non ci sono. Diverso è il fronte penale fallimentare: lì l’abuso non ti salva, anzi può essere letto come indice di dolo. Quindi, ricapitolando: abuso fiscale = niente reato fiscale; abuso civile = potenziale concorso in bancarotta se c’è fallimento. È una differenza importante.
D: In conclusione, qual è la migliore difesa contro le contestazioni su accordi infragruppo?
R: La migliore difesa è la prevenzione tramite correttezza e trasparenza. Se dovessimo riassumere:
- Operare sempre, per quanto possibile, a condizioni di mercato o dimostrabilmente giustificate.
- Documentare tutto: contratti, delibere, analisi economiche, corrispondenza.
- Motivare economicamente le scelte infragruppo: chiedersi “lo farei anche con un terzo?” e in caso negativo, avere una ragione forte sul perché col correlato sì (es. lo aiuto perché poi ne traggo vantaggio come gruppo, ecc., e scriverlo).
- Consultare professionisti ex ante: un piccolo investimento in pareri e studi comparativi prima può risparmiarne di enormi in sanzioni e liti dopo.
- Non forzare la mano: se un’operazione appare troppo aggressiva fiscalmente o rischiosa per i creditori, magari optare per alternative meno vantaggiose ma più sicure (ad esempio pagare qualche tassa in più ma dormire tranquilli).
- Buona fede e collaborazione: se comunque sorge una contestazione, mantenere un atteggiamento collaborativo con le autorità, fornendo chiarimenti, evitando ostruzionismi inutili. Spesso questo porta a soluzioni conciliative o quantomeno a ridurre il contenzioso.
In ambito giudiziario, se sei già in causa/indagine, la difesa come abbiamo visto consiste nel far emergere che hai agito correttamente e senza intenti illeciti, portando tutte le prove a supporto. E se c’è stato qualche errore formale, mostrare che hai comunque perseguito un fine lecito.
Come si suol dire, la forma è sostanza in questi casi: un accordo infragruppo ben strutturato, formalizzato e giustificato è la tua armatura. E conoscere le norme (fiscali, civili, penali) è la tua spada: ti consente di muoverti sapendo dove sono i confini e di reagire appropriatamente se vieni accusato ingiustamente.
In conclusione, difendersi dalle contestazioni significa in primo luogo impostare correttamente le operazioni, e in secondo luogo essere pronti a spiegare e dimostrare ogni scelta. Con questo approccio, un’operazione infragruppo genuina potrà essere compresa e accettata sia dal Fisco che dai creditori; diversamente, se l’operazione era realmente abusiva o lesiva, le armi difensive saranno spuntate. Dunque la miglior difesa è non avere nulla da nascondere, e per il resto affidarsi agli strumenti legali qui esposti per far valere le proprie ragioni.
Fonti
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22700 depositata il 12 agosto 2024 – La deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali relativi ai servizi infragruppo (contratto di cost sharing) è, quindi, subordinata all’effettività ed inerenza della spesa in ordine all’attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che ne sia derivato a quest’ultima, non ritenendosi sufficiente l’esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi (Cass. 22 marzo 2021, n. 8001; Cass. 18 luglio 2014, n. 16480), essendo richiesta la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.
- Cass., Sez. 1, 22 febbraio 2023, n. 5458.
- Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 19512 del 16 luglio 2024.
- Sentenza del 06/03/2024 n. 6101 – Corte di Cassazione.
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestati accordi infragruppo non conformi ai valori di mercato? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestati accordi infragruppo non conformi ai valori di mercato?
Vuoi sapere cosa rischi e come puoi difenderti da queste contestazioni?
Gli accordi infragruppo devono rispettare il principio di libera concorrenza (arm’s length principle), cioè le condizioni che sarebbero state applicate tra soggetti indipendenti. Se l’Agenzia delle Entrate ritiene che i contratti intercompany siano stati utilizzati per spostare utili all’estero, abbattere l’imponibile in Italia o gonfiare costi, può procedere con rettifiche fiscali.
👉 Prima regola: dimostra che i prezzi e le condizioni applicate nei contratti infragruppo erano coerenti con i valori di mercato.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Servizi infragruppo fatturati a prezzi incongrui rispetto al mercato;
- Licenze e royalties con corrispettivi eccessivi o sottostimati;
- Prestiti infragruppo con tassi non allineati a quelli bancari;
- Ripartizioni di costi comuni non giustificate;
- Mancanza di documentazione di transfer pricing.
📌 Conseguenze della contestazione
- Rettifica del reddito imponibile e recupero delle imposte;
- Sanzioni dal 90% al 180% delle maggiori imposte accertate;
- Interessi di mora;
- Doppia imposizione internazionale, se lo Stato estero non riconosce la rettifica;
- Possibile apertura di procedimenti per abuso del diritto.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Esistenza di contratti infragruppo formalizzati: erano regolarmente predisposti?
- Documentazione di transfer pricing: master file e country file erano aggiornati?
- Metodo di calcolo dei prezzi: CUP, resale price, cost plus, TNMM, ecc.;
- Congruità dei valori rispetto ai dati di mercato;
- Motivazione della contestazione: il Fisco ha usato comparabili idonei o presunzioni?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Contratti intercompany sottoscritti;
- Master file e country file di transfer pricing;
- Report di benchmarking con società comparabili;
- Relazioni contabili e documentazione bancaria;
- Comunicazioni interne e verbali assembleari.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la coerenza dei prezzi con studi di mercato e benchmark;
- Contestare la rettifica se basata su comparabili non attendibili;
- Invocare le convenzioni contro le doppie imposizioni per evitare tassazione duplicata;
- Eccepire vizi procedurali: motivazione insufficiente, decadenza dei termini, notifica irregolare;
- Richiedere autotutela se i dati corretti non sono stati valutati;
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni contro l’accertamento.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza gli accordi infragruppo contestati;
📌 Verifica la corretta applicazione del principio di libera concorrenza;
✍️ Redige memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e nelle procedure internazionali di risoluzione delle controversie;
🔁 Suggerisce strategie preventive per impostare accordi infragruppo sicuri e inattaccabili.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in transfer pricing e fiscalità internazionale;
✔️ Specializzato in difesa di gruppi multinazionali contro rettifiche su accordi infragruppo;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sugli accordi infragruppo non di mercato non sempre sono fondate: spesso derivano da valutazioni arbitrarie o da comparabili non idonei.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la correttezza delle politiche di transfer pricing, evitare doppie imposizioni e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti sugli accordi infragruppo inizia qui.