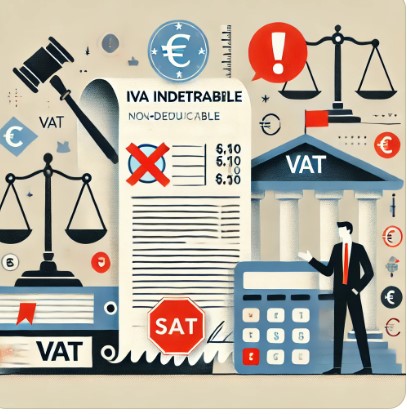Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché alcune spese dedotte sono state considerate non inerenti alla tua attività? In questi casi, l’Ufficio presume che i costi sostenuti non abbiano un collegamento diretto con l’attività d’impresa o professionale e procede a disconoscerli, con recupero delle imposte, applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: il concetto di inerenza è spesso interpretato in modo restrittivo e lascia spazio a margini difensivi.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta le spese dedotte
– Se le spese non hanno un rapporto diretto con i ricavi o l’attività esercitata
– Se sono considerate personali o prive di giustificazione documentale
– Se i costi appaiono sproporzionati rispetto alla dimensione dell’impresa
– Se la natura della spesa non è coerente con l’oggetto sociale o professionale dichiarato
– Se la documentazione (fatture, contratti, ricevute) è carente o irregolare
Conseguenze della contestazione
– Recupero delle imposte dirette (IRES o IRPEF) per i costi ritenuti indeducibili
– Rideterminazione dell’IVA detraibile con maggior debito d’imposta
– Applicazione di sanzioni per dichiarazione infedele o indebita deduzione di costi
– Interessi di mora sulle somme accertate
– Possibile estensione dei controlli ad altre voci di bilancio o ad anni precedenti
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare la connessione tra la spesa e l’attività con contratti, relazioni, documenti di supporto
– Produrre prove dell’effettivo utilizzo dei beni o servizi per finalità aziendali
– Contestare l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia in merito al concetto di inerenza
– Evidenziare vizi procedurali, errori di calcolo o difetti di motivazione nell’accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento della contestazione
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare le spese contestate e la relativa documentazione contabile
– Valutare la legittimità della contestazione secondo normativa e giurisprudenza
– Redigere un ricorso fondato su prove concrete e vizi dell’atto impositivo
– Difendere l’impresa davanti ai giudici tributari contro richieste indebite
– Tutelare il patrimonio aziendale e personale da conseguenze fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La conferma della deducibilità delle spese realmente inerenti
– L’eliminazione di sanzioni e interessi non dovuti
– La sospensione delle richieste di pagamento già avviate
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: il ricorso contro la contestazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se non si agisce per tempo, l’accertamento diventa definitivo e non sarà più possibile difendersi.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – spiega come difendersi in caso di contestazioni su spese dedotte considerate non inerenti all’attività e come tutelare i tuoi diritti.
👉 Hai ricevuto una contestazione per spese ritenute non inerenti? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la documentazione, confronteremo i dati con l’attività svolta e costruiremo la strategia difensiva più efficace per proteggere i tuoi interessi.
Introduzione
In ambito fiscale italiano, uno dei motivi più frequenti di accertamento tributario verso professionisti, imprenditori individuali e società è la contestazione di spese dedotte ritenute “non inerenti” all’attività d’impresa o professionale. L’inerenza è il principio secondo cui un costo è deducibile solo se strettamente collegato all’attività da cui derivano i ricavi tassati. In pratica, l’Agenzia delle Entrate può rettificare il reddito imponibile escludendo costi che considera estranei all’attività e quindi indebitamente dedotti . Queste contestazioni comportano il recupero a tassazione dei costi non ammessi, con maggior imposta dovuta, interessi e pesanti sanzioni amministrative, e nei casi più gravi possono integrare violazioni penali (ad esempio dichiarazione infedele per infedele indicazione di componenti negativi).
Quali spese sono a rischio? Tipicamente sono sotto la lente del Fisco quei costi che, per natura o entità, appaiono di utilità personale o estranei all’oggetto dell’impresa: ad esempio spese di rappresentanza e omaggi oltre i limiti di legge, spese per beni ad uso promiscuo (auto aziendali, telefoni) in misura eccedente la quota ammessa, costi di viaggio e trasferte non giustificati, spese per familiari o amministratori non legate a una prestazione effettiva, spese di lusso o manifestamente sproporzionate rispetto ai ricavi, spese non documentate in modo adeguato, o ancora costi relativi ad attività illecite (questi ultimi comunque indeducibili per espressa previsione di legge).
Dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta), difendersi con successo richiede un’approfondita conoscenza delle normative e della più recente giurisprudenza, nonché un approccio proattivo nella produzione di prove. Questa guida – aggiornata ad agosto 2025 – offre un’analisi avanzata del quadro normativo italiano sul principio di inerenza dei costi deducibili, delle ultime sentenze e orientamenti giurisprudenziali, e degli strumenti processuali di tutela. Adottiamo un linguaggio tecnicamente rigoroso ma di taglio divulgativo, adatto sia ai professionisti del diritto tributario sia a imprenditori e privati ben informati.
Struttura della guida: Dopo aver definito il principio di inerenza e l’onere della prova, esamineremo le tipologie di spese più spesso contestate, con riferimenti normativi, soglie quantitative e pronunce giurisprudenziali di rilievo. Seguirà un focus sugli aspetti procedurali, dal ricevimento di un avviso di accertamento al contenzioso tributario, inclusi i mezzi deflativi (accertamento con adesione, reclamo-mediazione, conciliazione) e le peculiarità probatorie (documenti, presunzioni, prove testimoniali ora ammissibili). Saranno proposte strategie di difesa dal punto di vista del contribuente, con consigli pratici su come documentare le spese e impostare le argomentazioni difensive. Troverete inoltre tabelle riepilogative per una rapida consultazione (ad esempio, requisiti di deducibilità per categoria di costo, fasi del processo e relative tempistiche) e una sezione di Domande e Risposte per chiarire i dubbi più comuni con esempi concreti.
Importante: Ogni affermazione è accompagnata da fonti autorevoli – normative, circolari o pronunce giurisprudenziali recenti – citate secondo il formato 【numero†riferimento】. In questo modo potrete verificare direttamente i riferimenti e approfondire i punti di interesse. L’obiettivo è fornire una guida completa e aggiornata che permetta al contribuente (e ai suoi consulenti) di orientarsi al meglio in caso di contestazione fiscale su costi dedotti come non inerenti, predisponendo un’adeguata difesa nel contenzioso tributario.
Il principio di inerenza: normativa e definizione
Il principio di inerenza è un pilastro del sistema tributario italiano in materia di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo. In sintesi, solo i costi effettivamente e direttamente collegati all’attività svolta e alla produzione del reddito imponibile sono deducibili. Questo criterio, pur non essendo definito espressamente da una singola norma con il termine “inerenza”, si ricava da varie disposizioni del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986) e dalla elaborazione giurisprudenziale.
Norme di riferimento
Per i redditi d’impresa (società e imprese individuali) il riferimento cardine è l’art. 109, comma 5, del TUIR. Tale disposizione stabilisce che “le spese e gli altri componenti negativi […] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito” . In altre parole, vige una condizione di collegamento funzionale tra costo sostenuto e attività o beni produttivi di ricavi imponibili. Questo implica che: (a) la spesa deve avere attinenza con l’attività esercitata, e (b) la deducibilità è limitata alla quota parte effettivamente correlata a tale attività (da cui il “se e nella misura in cui”). L’art. 109(5) di fatto codifica il principio di inerenza , pur non menzionando esplicitamente il termine, fungendo da criterio generale di delimitazione dei costi deducibili.
Per i redditi di lavoro autonomo professionale, manca una formula altrettanto esplicita, ma si applica un principio analogo: l’art. 54 TUIR prevede che il reddito di lavoro autonomo sia determinato sottraendo dai compensi percepiti i costi necessari per la produzione di tali compensi (oltre a quelli specificamente ammessi). Anche senza un comma dedicato come l’art. 109(5), dottrina e prassi concordano che anche al professionista si richiede un rapporto funzionale tra costi sostenuti e attività professionale che genera i compensi . Lo stesso art. 54, comma 5 TUIR, pone un limite alle spese di rappresentanza dei professionisti (deducibili entro l’1% dei compensi annui: v. oltre) confermando indirettamente la necessità di attinenza all’attività. In definitiva, sia per imprese sia per autonomi, la deducibilità è ammessa per i costi inerenti all’attività esercitata, con regole specifiche a seconda della categoria e natura del costo.
Va ricordato che il principio di inerenza esclude comunque a priori alcune categorie di costi, per espressa previsione legislativa, anche se astrattamente collegati all’attività. Ad esempio:
– Oneri fiscali e contributivi propri (es. imposte sui redditi, contributi obbligatori) e multe o sanzioni: non sono deducibili in base a varie norme (art. 109(5) TUIR esclude oneri fiscali e contributivi; le sanzioni amministrative non sono deducibili ex art. 6 co.4 D.Lgs. 472/97);
– Spese di utilità sociale a favore dei dipendenti oltre limiti (es. spese ricreative per dipendenti, viaggi turistici per dipendenti oltre il 5‰ del costo del lavoro sono indeducibili ecc. – queste spese sono regolamentate separatamente come oneri di utilità sociale);
– Costi illeciti: dal 2016, l’art. 14, comma 4-bis della L. 537/1993 (modificata) vieta la deduzione di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti qualificabili come reato (salvo il costo del lavoro regolarmente assunto). Dunque, costi come tangenti, sovrafatturazioni relative a reati, etc., sono indeducibili per legge (i cosiddetti costi da reato, su cui torneremo).
Queste esclusioni specifiche sono frutto di scelte del legislatore e vanno oltre il concetto di inerenza in senso stretto (anche un costo “inerente” all’attività ma palesemente contrario a norme di ordine pubblico – si pensi a una tangente per ottenere un appalto – non è comunque deducibile per divieto ex lege). Tuttavia, nella maggior parte dei casi pratici le contestazioni sui “costi non inerenti” riguardano spese che non rientrano in tali esclusioni automatiche, ma che l’Ufficio considera non sufficientemente collegate all’attività del contribuente.
Definizione qualitativa vs quantitativa dell’inerenza
Un punto cruciale emerso nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale è se l’inerenza implichi anche un giudizio di economicità o congruità della spesa rispetto ai ricavi. In passato, si tendeva a leggere il requisito di inerenza quasi in termini quantitativi, come “correlazione costi-ricavi” da valutare anche sul piano dell’utilità economica dell’esborso. Questo approccio prendeva spunto proprio dall’art. 109(5) TUIR, interpretando la frase “nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi” come necessità di un nesso diretto e proporzionato tra quel costo e specifici ricavi tassati (c.d. inerenza “per destinazione” al ricavo). Ne derivavano contestazioni basate su indici di antieconomicità: spese ritenute eccessive o non redditizie potevano essere riprese a tassazione in quanto considerate non inerenti, sul presupposto che un imprenditore razionale non le avrebbe sostenute per così poco ritorno.
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha però delineato un concetto di inerenza di natura qualitativa e non quantitativa . In particolare, a partire da alcune pronunce del 2018 (Cass. nn. 450/2018 e 3170/2018) e successive conferme, la Suprema Corte afferma che il principio di inerenza:
- Si ricava dalla nozione di reddito d’impresa, più che dalla singola disposizione dell’art. 109(5) TUIR (che attiene piuttosto al principio di correlazione tra costi e ricavi tassabili);
- Esprime la necessità di riferire i costi all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che afferiscono a una sfera estranea ad essa, senza che si debba operare alcuna valutazione circa l’utilità economica del costo o la sua congruità rispetto ai ricavi . In altri termini, “è configurabile come costo inerente anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e [non rileva] la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è qualitativo e non quantitativo” .
Questo principio – ben sintetizzato da Cass. Sez. V, sent. n. 30366/2019 – ha smontato la precedente idea che un costo per essere inerente dovesse “essere utile o proporzionato”. Anche una spesa antieconomica può essere inerente e deducibile, se per natura è relativa all’attività . Ad esempio, una campagna pubblicitaria molto costosa che non ha generato un ritorno immediato può comunque essere inerente all’attività promozionale dell’impresa, restando deducibile nonostante l’apparente sproporzione (Cass., ord. n. 6368/2021 ). Ciò che conta è il collegamento oggettivo della spesa all’attività d’impresa, non il risultato conseguito o l’efficienza economica della stessa. Sul piano pratico, questo orientamento tutela la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore nelle scelte gestionali, evitando indebite ingerenze del Fisco nel merito dell’economicità delle operazioni.
Esempio: Un’azienda vinicola sostiene costi ingenti per sponsorizzare eventi all’estero con l’obiettivo di entrare in nuovi mercati, senza però incrementare le vendite nell’immediato. L’Agenzia potrebbe definire “antieconomica” la spesa rispetto ai ricavi realizzati nell’anno. Tuttavia, secondo la Cassazione l’antieconomicità in sé non rende il costo indeducibile: se la spesa persegue una finalità promozionale inerente all’attività, rimane deducibile in quanto qualitativamente connessa all’impresa (anche se quantitativamente elevata rispetto ai ricavi attuali). Il Fisco potrà semmai usare l’antieconomicità come indizio per approfondire (potrebbe celare costi fittizi o estranei), ma non potrà disconoscere la spesa solo perché “troppo alta” se il contribuente dimostra la sua coerenza con l’attività svolta.
La Cassazione ha comunque chiarito che un’operazione palesemente antieconomica può costituire “elemento sintomatico” di non inerenza, legittimando l’Ufficio a richiedere spiegazioni al contribuente . In altre parole, se un costo appare anomalo (e.g. sproporzionato ai ricavi, o privo di logica economica apparente), ciò suggerisce che potrebbe non essere inerente. Scatta quindi un onere esplicativo a carico del contribuente: dovrà indicare gli elementi che riconducono quel costo all’attività d’impresa (ad esempio, spiegare la strategia o le circostanze che giustificano la spesa). Se il contribuente fornisce tali elementi di collegamento concreto, allora spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare ulteriori elementi contrari, evidenziando l’eventuale inattendibilità o strumentalità indebita della condotta del contribuente . Questo principio – affermato ad esempio dalla Cass. ord. n. 33568/2022 – configura una sorta di dialettica probatoria: l’antieconomicità fa scattare una presunzione semplice di non inerenza (un campanello d’allarme), il contribuente ha l’onere di controbattere con spiegazioni documentate, dopodiché l’onere torna all’Ufficio se vuol sostenere l’indeducibilità, dovendo provare che le giustificazioni addotte non sono credibili o sufficienti.
Possiamo quindi riassumere così il principio di inerenza per come si è consolidato entro il 2025: è il vincolo qualitativo che lega una spesa all’attività svolta, anche in via indiretta o potenziale futura, delimitando l’area dei costi deducibili ai soli oneri afferenti all’impresa o alla professione . Restano esclusi i costi che si collocano in una sfera estranea all’esercizio dell’attività (perché attinenti alla sfera personale del titolare o a finalità del tutto estranee all’impresa). Non rileva la profittevolezza immediata della spesa né la sua proporzionalità ai ricavi (inerenza ≠ congruità), fermo restando che spese macroscopicamente antieconomiche possono indurre un controllo più rigoroso.
Di seguito una tabella che sintetizza i riferimenti normativi e giurisprudenziali chiave sul principio di inerenza:
<table> <thead> <tr><th>Riferimento</th><th>Principio espresso</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art. 109, c.5 TUIR</td> <td>Componenti negativi deducibili solo se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni produttivi di ricavi imponibili (principio generale di inerenza) .</td> </tr> <tr> <td>Art. 54 TUIR</td> <td>(Lavoro autonomo) Deducibilità dei costi necessari alla produzione del reddito di lavoro autonomo; spese di rappresentanza deducibili entro 1% dei compensi (richiesta di inerenza implicita) .</td> </tr> <tr> <td>Corte Cost. n. 262/2020</td> <td>Conferma che il principio di inerenza definisce e delimita i costi deducibili in base al vincolo con l’attività d’impresa, escludendo quelli estranei .</td> </tr> <tr> <td>Cass. Sez. V, nn. 450/2018 e 3170/2018</td> <td>Superato l’orientamento precedente: l’inerenza non si ricava (solo) dall’art. 109(5) TUIR come correlazione costi-ricavi, ma è concetto più ampio legato alla nozione di reddito d’impresa .</td> </tr> <tr> <td><small>Cass. Sez. V, n. 30366/2019</small></td> <td><small>Principio di inerenza di natura qualitativa: vanno esclusi costi estranei all’attività, senza valutazioni di utilità o congruità; anche costi senza vantaggio economico sono inerenti se riferiti all’impresa .</small></td> </tr> <tr> <td>Cass. Sez. V, n. 15860/2018 e sim.</td> <td>Un vecchio orientamento richiedeva anche congruità: es. deducibilità condizionata al fatto che il costo non sia “manifestamente incongruo” o inutile. (Orientamento oggi superato dalla giurisprudenza dominante, ma a volte citato in atti dell’Amministrazione).</td> </tr> <tr> <td>Cass. Sez. V, n. 33568/2022</td> <td>L’antieconomicità di un costo può essere sintomo di difetto di inerenza; se il contribuente prova la correlazione all’attività, l’Ufficio deve provare eventuali elementi contrari (onere della prova rafforzato in capo al Fisco in presenza di giustificazioni del contribuente) .</td> </tr> <tr> <td>Cass. Sez. V, n. 6368/2021</td> <td>Un costo inerente rimane deducibile anche se antieconomico rispetto al ricavo atteso . L’antieconomicità di per sé non basta a negare la deducibilità.</td> </tr> </tbody> </table>
Nota: Sebbene il principio di inerenza si fondi principalmente su norme di natura fiscale (TUIR) e loro interpretazione giurisprudenziale, in alcuni casi la valutazione dell’inerenza di un costo può intrecciarsi con profili civilistici (ad esempio, spese estranee all’oggetto sociale di una società di capitali, oppure costi imputati a una società che in realtà avvantaggiano soci o terzi). In tali ipotesi il Fisco potrebbe eccepire, oltre alla non deducibilità fiscale, anche un’eventuale violazione di norme civilistiche (come l’uso di risorse sociali per fini personali dei soci). Tuttavia, ai fini della deducibilità fiscale, l’oggetto sociale non è di per sé vincolo assoluto: una spesa non prevista esplicitamente nell’oggetto sociale può comunque essere inerente se in concreto funzionale all’attività imprenditoriale esercitata. Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto deducibili costi sostenuti da una società per la manutenzione di macchinari dati in comodato gratuito a clienti, pur se per contratto le spese avrebbero dovuto gravare sui comodatari: ciò che conta è verificare se tali costi abbiano in concreto una funzionalità nella produzione del reddito d’impresa, al di là delle previsioni contrattuali . I giudici di legittimità hanno censurato la Commissione Tributaria che aveva negato l’inerenza basandosi solo sul dato formale del contratto, senza indagare la reale utilità economica di quelle spese per l’attività aziendale (manutenere i macchinari presso i clienti poteva essere strategico per fidelizzarli e incrementare le vendite di caffè) .
In conclusione, possiamo definire operativamente inerente quel costo che presenti una logica di correlazione con l’attività del soggetto economico, in senso ampio: ossia sostenuto nell’esercizio (o per lo sviluppo futuro) dell’attività produttiva di reddito, e non invece per finalità estranee (di natura personale o gratuità verso terzi senza scopo promozionale, etc.). Su questo criterio generale si innestano poi regole specifiche e limiti quantitativi per certe categorie di spese (auto aziendali, rappresentanza, vitto alloggio, ecc.), che approfondiremo nel prosieguo.
Onere della prova dell’inerenza e ruolo delle parti
Una volta chiarito cos’è l’inerenza, occorre affrontare un aspetto fondamentale: chi deve provare che un costo è inerente all’attività? In altre parole, nel caso di contestazione, qual è la ripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Questa questione ha risvolti pratici enormi nel contenzioso tributario, ed è stata anch’essa oggetto di recenti sviluppi normativi (riforma del processo tributario del 2022) e giurisprudenziali.
Orientamento tradizionale: onere sul contribuente
L’orientamento tradizionale, consolidato in giurisprudenza, è chiaro nell’affermare che spetta al contribuente dimostrare la legittimità delle spese portate in deduzione, quindi la loro effettiva esistenza e la loro inerenza all’attività esercitata . Questa impostazione discende dal principio generale per cui, nel diritto tributario, le deduzioni e detrazioni sono beni giuridici di cui il contribuente chiede il riconoscimento e, come tali, rappresentano eccezioni al principio di tassazione del reddito lordo. Pertanto, il contribuente deve essere in grado di provare i fatti che danno diritto all’agevolazione (in questo caso, alla deduzione del costo).
La Cassazione ha reiterato più volte che, in tema di imposte sui redditi: “l’onere di provare e documentare […] la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, grava sul contribuente” . Similmente per l’IVA, ai fini della detraibilità, è il contribuente che deve provare che l’acquisto di beni/servizi presentato a detrazione è inerente in senso oggettivo all’attività economica (come ribadito da Cass. n. 18904/2018) . In pratica, il Fisco inizialmente può limitarsi a contestare la deduzione di un costo che appaia non inerente o non sufficientemente documentato, senza doverne dimostrare dettagliatamente l’estraneità; è poi il contribuente a dover attivamente fornire la prova della connessione con l’attività e dell’effettiva realizzazione della spesa.
Questa impostazione è tuttora valida e confermata nelle pronunce di legittimità più recenti. Ad esempio, Cass. Sez. Trib. 7 marzo 2024 n. 6114 ha ribadito che l’onere rimane al contribuente e che l’art. 109(5) TUIR non disciplina l’inerenza (nozione più ampia di derivazione dal concetto di reddito) ma solo la correlazione costi-ricavi, confermando quindi il quadro ante riforma . Pertanto, anche dopo le novità normative del 2022 (di cui diremo a breve), il principio generale è rimasto che il contribuente deve provare la deducibilità dei costi.
Proviamo a scomporre l’onere probatorio del contribuente in due elementi:
– Prova dell’esistenza e certezza del costo: significa dimostrare che la spesa è stata effettivamente sostenuta, di ammontare determinato, nel periodo di imposta considerato. In genere ciò avviene tramite idonea documentazione contabile e non (fatture d’acquisto, contratti, ricevute di pagamento, DDT, registri etc.). Se un costo non è adeguatamente documentato, l’Ufficio può contestarne non solo l’inerenza ma proprio la certezza, disconoscendolo per mancanza di prova (spesa non documentata = spesa non deducibile). Ad esempio, spese con fatture troppo generiche (senza indicazione chiara di beni/servizi forniti) possono essere considerate non sufficientemente provate né specificamente riferite all’attività .
– Prova dell’inerenza (collegamento all’attività): oltre a esistere, il costo deve avere una destinazione imprenditoriale o professionale. Il contribuente deve quindi mostrare “la corrispondenza tra la spesa e l’attività d’impresa” , ossia spiegare il nesso di causalità o funzionalità tra quel costo e i ricavi o l’oggetto della sua attività . Ciò può richiedere, oltre alle pezze giustificative di spesa, anche documenti che illustrino l’uso o la finalità: ad esempio, un rapporto di servizio che colleghi l’acquisto di certi materiali a uno specifico cantiere o commessa, una relazione che spiega l’utilità di una consulenza ricevuta, ecc. Se questi elementi mancano, la mera esibizione della fattura (soprattutto se generica) potrebbe non bastare a convincere il giudice dell’inerenza .
Dal lato dell’Amministrazione finanziaria, il suo onere consiste inizialmente nel fornire una contestazione motivata: l’Ufficio deve indicare perché ritiene il costo indeducibile, evidenziando gli elementi di fatto da cui emerge la presunta non inerenza (ad es. “fattura n. X: descrizione generica del servizio, nessun riscontro sull’effettivo utilizzo nella produzione”; oppure “spesa per autovettura ad uso privato dell’amministratore, non strumentale all’attività”, etc.). In sostanza, il Fisco non può limitarsi a dire “questo costo non è inerente” in modo apodittico: deve motivarne la ripresa a tassazione, pena l’illegittimità dell’accertamento per difetto di motivazione. Tuttavia, tale motivazione può essere anche sintetica e mutuata da un verbale della Guardia di Finanza (PVC) richiamato per relationem, se il PVC era noto al contribuente . Forniti questi indizi o elementi sintomatici, la palla passa al contribuente per la controprova.
Questo schema tradizionale onere al contribuente – controllo del Fisco è stato a lungo immutato. I Giudici tributari di merito generalmente si sono uniformati, respingendo molti ricorsi di contribuenti che non erano stati in grado di produrre prove convincenti dell’inerenza dei costi contestati. Un esempio concreto lo si trova in una recente controversia decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (sent. n. 7241/2024): un’azienda aveva dedotto costi di materiali edili documentati solo da fatture generiche e preventivi, senza contratti o indicazioni dei cantieri di destinazione; i giudici hanno confermato il recupero a tassazione perché la società “non ha fornito prove idonee a dimostrare la concreta inerenza e la certezza delle spese”, sottolineando che fatture generiche e preventivi non bastano a provare che gli acquisti siano effettivamente avvenuti e utilizzati nell’attività . In sintesi, l’azienda ha perso il caso perché non è riuscita a soddisfare il proprio onere probatorio sul collegamento dei costi all’attività.
Novità della riforma 2022: art. 7, c. 5-bis D.Lgs. 546/92
Nel 2022 il legislatore è intervenuto sul tema dell’onere della prova nel processo tributario introducendo, con la L. 130/2022 (riforma del processo tributario), un nuovo comma 5-bis all’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 (la legge che disciplina il contenzioso tributario). Tale disposizione, entrata in vigore dal 16 settembre 2022, recita in sostanza che nelle controversie di impugnazione di atti impositivi l’onere della prova è a carico dell’Amministrazione finanziaria, relativamente alla fondatezza della pretesa, fatte salve le presunzioni legali stabilite dalla legge a favore della stessa Amministrazione. Questa modifica ha fatto pensare a molti ad un “ribaltamento” dell’onere probatorio generale: in altre parole, alcuni interpreti hanno ritenuto che d’ora in poi sarebbe il Fisco a dover provare ogni fatto costitutivo della propria pretesa, mentre il contribuente si avvantaggerebbe di una posizione più passiva.
Tuttavia, occorre molta cautela nell’applicare questa novità al tema specifico dell’inerenza dei costi. Innanzitutto, la norma non ha efficacia retroattiva: si applica solo ai giudizi relativi ad atti emessi dopo la sua entrata in vigore (settembre 2022) . Nel caso sopra citato (azienda edile), l’accertamento era precedente e infatti i giudici hanno escluso di poter applicare il nuovo regime . Ma soprattutto, anche nei nuovi giudizi, la portata dell’art. 7, c.5-bis è da interpretare. Esso va letto sistematicamente: “nelle azioni di annullamento l’onere della prova grava sempre sull’Amministrazione”, significa che l’ente impositore deve dimostrare la legittimità dell’atto impugnato. Ma ciò non elimina il dovere del contribuente di provare i fatti a lui favorevoli, specie quando – come per la deduzione di costi – si tratta di diritti soggettivi che il contribuente afferma e su cui chiede tutela. In altre parole, la nuova norma obbliga il Fisco a provare in giudizio la fondatezza della propria pretesa (ad esempio, se contesta ricavi non dichiarati, dovrà provarne l’esistenza; se applica una sanzione, dovrà provare il fatto sanzionato e il dolo/colpa, ecc.), ma non intacca le regole sostanziali sui presupposti di deducibilità. Dunque, se la legge sostanziale richiede che un costo sia inerente e documentato per essere dedotto, e il contribuente non porta prove di ciò, l’Ufficio ha gioco facile a dimostrare la “non fondatezza” della deduzione semplicemente evidenziando la mancanza di prova contraria. La Cassazione ha infatti chiarito che il nuovo art. 7, c.5-bis “non ribalta l’onere probatorio di base”, né deroga ai criteri generali in materia di oneri e presunzioni . È più corretto dire che la norma codifica principi già insiti nel sistema: l’Amministrazione deve motivare e portare quantomeno indizi a sostegno della sua contestazione, non può pretendere che il giudice le dia ragione senza uno straccio di prova; ma resta al contribuente l’onere di confutare tali rilievi con idonea documentazione e argomentazioni . In sintesi, il contribuente non può limitarsi a stare alla finestra, confidando che la controparte non riesca a provare un fatto negativo (“che quel costo non c’entra nulla”): dovrà comunque provare il fatto positivo che gli dà diritto alla deduzione (che quel costo attiene alla sua attività).
Possiamo quindi affermare che, alla luce della riforma, nel contenzioso sulle spese dedotte:
– L’Agenzia delle Entrate dovrà sempre inquadrare e motivare la contestazione (es.: spiegare perché ritiene un costo non inerente, magari sottolineando l’assenza di contratto o l’evidente estraneità rispetto all’oggetto sociale, etc.), fornendo almeno una base fattuale alla ripresa;
– Il contribuente resta gravato della prova contraria, dovendo portare elementi concreti (documenti, spiegazioni) che colleghino la spesa all’attività. Se il contribuente adempie a questo onere e le sue prove risultano convincenti, l’Amministrazione per prevalere dovrà a sua volta rafforzare le proprie argomentazioni (ad es. dimostrare che i documenti prodotti sono falsi o che l’utilizzo dichiarato è implausibile). In tal senso si può parlare di onere “dinamico” o rafforzato a carico del Fisco dopo che il contribuente abbia assolto il suo iniziale onere di allegazione .
Un’altra novità collegata alla riforma 2022 da menzionare è l’ammissibilità, ora, di una forma di prova testimoniale nel processo tributario (sia pure nella modalità della “testimonianza scritta” ex art. 7, c.4-bis D.Lgs. 546/92). Prima era totalmente preclusa. Questo può giovare al contribuente in alcuni casi di onerosità probatoria: ad esempio, se l’inerenza di una spesa dipende dal fatto che un certo servizio è stato effettivamente reso nell’interesse dell’impresa, e non vi sono documenti contrattuali chiari, potrebbe essere ammessa la testimonianza di un soggetto terzo che confermi la resa del servizio e la sua utilità. La testimonianza è ammessa solo se il giudice la considera necessaria ai fini della decisione e su fatti non provabili altrimenti; resta vietata, ad esempio, per provare il contenuto di documenti che la legge impone in forma scritta (principio che limita la testimonianza in ambito tributario). Nonostante questi limiti, si tratta di uno strumento in più che, in casi particolari, la difesa potrà valutare. Ad esempio, in una controversia su spese di consulenza contestate come inesistenti o non inerenti, la deposizione di un consulente che illustri il lavoro svolto per l’azienda potrebbe aiutare a dimostrarne la pertinenza.
Riepilogando, dal punto di vista pratico il debitore d’imposta (contribuente) deve essere pronto a sostenere con prove robuste la deducibilità dei propri costi. Egli non può attendersi che il solo dubbio sollevato sul’atto dell’Agenzia (magari qualche vizio formale) basti a vincere il ricorso: servirà entrare nel merito e convincere i giudici che ogni spesa contestata era effettivamente funzionale all’attività e debitamente supportata da documenti. La sezione successiva sarà dedicata proprio alle principali tipologie di spese “a rischio” di contestazione e ai relativi requisiti, così da capire prima facie quali elementi probatori sono attesi per ciascuna di esse.
Tipologie comuni di spese contestate per difetto di inerenza
Non tutte le spese aziendali/professionali presentano le stesse criticità in termini di inerenza. Alcune categorie di costi sono fisiologicamente inerenti (es. materie prime per un’industria, cancelleria per uno studio professionale, utenze per l’ufficio, ecc. – difficilmente contestabili salvo abusi evidenti). Altre, invece, per loro natura o per la presenza di regole fiscali particolari, generano spesso contenzioso. In questa sezione analizziamo le macro-categorie di spese più frequentemente oggetto di rilievi da parte del Fisco, evidenziando per ciascuna: la normativa rilevante (soglie di deducibilità, limitazioni), gli indizi tipici di non inerenza secondo la prassi accertativa, e gli spunti difensivi ricavati da giurisprudenza e prassi. L’obiettivo è fornire al contribuente un quadro per autodiagnosi – capire quali spese nel proprio bilancio potrebbero essere viste come “sospette” – e per preparare adeguatamente la documentazione e le giustificazioni relative.
Per comodità espositiva, distingueremo le seguenti categorie: spese di rappresentanza e spese promozionali, spese per automezzi e trasporti, spese di vitto, alloggio e trasferte, spese per beni ad uso promiscuo (telefonia, immobili), spese per compensi a familiari o soci, altre spese generali e consulenze, e infine spese escluse per legge (multe, illeciti). Va da sé che esistono molte altre tipologie, ma quelle elencate coprono la stragrande maggioranza dei casi di contestazione per non inerenza.
Spese di rappresentanza e omaggi
Le spese di rappresentanza meritano un trattamento a parte perché sono regolate da una disciplina specifica e sono oggetto di frequenti verifiche. Per definizione normativa (art. 108, comma 2 TUIR e relativo D.M. 19/11/2008), si considerano spese di rappresentanza quelle erogazioni gratuite di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, idonee a generare potenziali benefici economici per l’impresa, ma senza un rapporto sinallagmatico specifico con i destinatari (cioè senza un corrispettivo diretto) . Esempi tipici: omaggi a clienti, spese per feste ed eventi aziendali (inaugurazioni, anniversari), sponsorizzazioni di convegni, viaggi promozionali, catering per presentazioni commerciali, ecc. Si tratta di costi sostenuti a fini di immagine o relazione, non legati ad uno specifico ricavo immediato.
Deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza:
– Per le imprese (soggetti IRES e imprenditori IRPEF): le spese di rappresentanza sono deducibili entro certi limiti quantitativi annuali, calcolati in percentuale sui ricavi dell’attività caratteristica. Dal 2016 i plafond annui sono: 1,5% dei ricavi fino a 10 mln €, 0,6% dei ricavi eccedenti fino a 50 mln €, 0,4% dei ricavi eccedenti oltre 50 mln . Ad esempio, un’impresa con 5 milioni di fatturato annuo può dedurre spese di rappresentanza fino a 75.000 € (1,5% di 5 mln); con 20 mln di fatturato, il plafond sarà 1,5% di 10 mln + 0,6% di 10 mln = 150k + 60k = 210.000 €. Le eventuali spese eccedenti tali soglie non sono deducibili . Inoltre, piccole spese unitarie sotto 50 € (es. gadget, regali di modico valore) sono sempre deducibili al 100% nell’esercizio ; le spese di ospitalità ai clienti (ristoranti, alberghi per clienti) prima di essere computate nel plafond vanno ridotte al 75% (regola introdotta dal 2008) . Questo perché le spese di vitto e alloggio sono deducibili al 75% per definizione, e se rientranti nella rappresentanza subiscono il duplice filtro: prima riduzione al 75%, poi conteggio nel limite annuo.
– Per i professionisti (lavoro autonomo): il TUIR fissa un limite unico pari all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta . Ad esempio, un avvocato che in un anno incassa €100.000 di compensi potrà dedurre al massimo €1.000 di spese di rappresentanza (cene offerte a clienti, omaggi, ecc.). Questo limite è molto stringente. La ratio è evitare che un professionista scarichi costi esagerati di relazioni pubbliche rispetto al suo giro d’affari. Non sono previsti scaglioni come per le imprese; l’1% si applica sull’ammontare complessivo dei compensi effettivamente incassati (principio di cassa) .
Requisiti qualitativi: Oltre ai tetti quantitativi, la norma e il regolamento prevedono che siano deducibili solo le spese di rappresentanza che rispondono a criteri di inerenza e congruità. Il D.M. 19/11/2008 stabilisce che devono essere “coerenti con pratiche commerciali del settore” e finalizzate, anche solo potenzialmente, a generare benefici economici futuri . Questo ribadisce che la spesa deve avere una finalità promozionale ragionevole e proporzionata. Ad esempio, se un’azienda con fatturato modesto organizza un evento di lusso spendendo enormemente rispetto alla sua dimensione, il Fisco potrebbe ritenere la spesa non congrua e quindi non deducibile (pur rientrando nel plafond in astratto). La congruità nel contesto delle rappresentanza è concetto previsto dalla norma regolamentare: il costo va valutato in funzione dell’obiettivo promozionale e delle pratiche del settore .
Fino al 2024 i presupposti principali erano tre: gratuità, inerenza (finalità promozionale) e ragionevolezza/congruità. Dal 2025 si aggiunge un quarto requisito: la tracciabilità. La Legge n. 197/2024 (Legge di Bilancio 2025) all’art. 1, comma 81, ha infatti disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, le spese di rappresentanza siano deducibili solo se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili (bonifico, assegno, carta, ecc.) . Ciò per contrastare possibili abusi o difficoltà di verifica su spese effettuate in contanti. In pratica, per dedurre le rappresentanza d’ora in avanti l’impresa dovrà poter provare il pagamento con metodo tracciabile (norma analoga a quella già esistente per altre detrazioni fiscali). Riassumendo: “Gratuità, inerenza, ragionevolezza e tracciabilità costituiscono i quattro pilastri che consentono la deducibilità delle spese di rappresentanza” , e solo se tutti rispettati la spesa è deducibile dal reddito d’impresa.
Aggiornamento 2025 – Tracciabilità: se un’azienda sostiene spese di rappresentanza in contanti (oltre 1.000 € peraltro vietati dal limite generale sul contante), non potrà dedurle. Ad esempio, regalare a un cliente un orologio di valore pagato in contanti non consente la deduzione, anche se l’omaggio in sé sarebbe inerente e sotto il plafond, per violazione del nuovo requisito di tracciabilità.
Dal punto di vista della contestazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate nelle verifiche sulle spese di rappresentanza controlla tipicamente:
– Riconducibilità all’attività e finalità promozionale: se una spesa etichettata come rappresentanza non mostra un legame con l’attività dell’impresa, viene contestata come non inerente. Ad esempio, viaggi o cene che sembrano più di natura personale che di lavoro, contributi elargiti senza attinenza con l’oggetto sociale, regalie a soggetti estranei all’ambito commerciale, ecc.
– Rispetto dei limiti quantitativi: ogni costo eccedente il plafond (oggi 1,5/0,6/0,4%) viene ripreso a tassazione in sede di controllo automatizzato o verifica. Non c’è discrezionalità su questo: il supero è matematicamente indeducibile.
– Documentazione dell’attività promozionale: in caso di spese per eventi o viaggi, l’ufficio verifica se c’è evidenza che durante l’evento sia stata effettivamente svolta attività promozionale (es. presentazione prodotti, stand fieristico, ecc.). Il DM 2008 infatti dice che nei viaggi turistici promozionali “il concreto svolgimento dell’attività promozionale va documentato” . Se manca questa prova, la spesa può essere disconosciuta perché la trasferta viene vista come vacanza mascherata.
– Congruità e coerenza: se le spese appaiono sproporzionate ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, il Fisco può eccepire un abuso. Ad esempio, una piccola società edile che deduce €100.000 di spese per viaggi e cene potrebbe subire la contestazione che tali costi non sono giustificati dall’attività svolta (magari coprono in realtà svaghi personali dei soci). Attenzione: la Cassazione ha chiarito che anche in presenza della disciplina specifica, le spese di rappresentanza restano soggette a verifica di inerenza qualitativa . Ciò significa che anche se l’importo è sotto il plafond e rientra formalmente nella definizione, l’Ufficio può comunque negarne la deduzione se riscontra mancanza del nesso di inerenza o mancata effettiva finalità promozionale . In una recente ordinanza (Cass. n. 28724/2024), la Corte ha ribadito che, ai fini di negare la deducibilità di costi sproporzionati ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (sintomo di antieconomicità), l’Amministrazione finanziaria è chiamata a verificare e contestare l’assenza del nesso di inerenza, la non congruità delle spese sostenute e l’eventuale mancata esecuzione delle attività promozionali connesse . Dunque non basta dire “costo troppo alto”, bisogna ancorare la contestazione ai concetti di inerenza e congruità previsti dalle norme.
Difendersi: in caso di contestazioni sulle rappresentanza, la difesa ruota attorno a:
– Provare che la spesa aveva effettivamente una finalità promozionale: esibire foto dell’evento, brochure, lista invitati, feedback dei clienti, contratto di sponsorizzazione, ecc. Dimostrare insomma che quell’esborso ha avuto uno scopo di business (anche se non ha generato subito vendite).
– Evidenziare la coerenza settoriale: se nel vostro settore è normale investire molto in certi eventi o regali, documentate usi e statistiche. – Verificare i calcoli del plafond: spesso le contestazioni nascono da errori nel calcolo delle percentuali o nel non aver escluso certe voci (es. fatture da ridurre al 75%). Assicuratevi che l’Agenzia abbia applicato correttamente le regole di quantificazione prima di accettare l’addebito per “sforamento soglia”.
– Dal 2025, fornire prova dei pagamenti tracciati: in sede di controllo, preparate estratti conto, contabili di bonifico o ricevute carta per ogni spesa di rappresentanza significativa. La mancanza di tracciabilità ora è motivo certo di indeducibilità , quindi è un aspetto formale ma decisivo.
In caso di dubbio sulla qualificazione, potrebbe essere utile valutare se talune spese contestate come rappresentanza fossero invece spese di pubblicità o propaganda, che godono di deducibilità integrale (se direttamente volte a pubblicizzare prodotti/servizi con rapporto sinallagmatico, es: acquisto di spazi pubblicitari). La linea di confine è sottile e spesso discussa in giudizio. Ad esempio, regalare gadget con logo aziendale a una fiera è rappresentanza o pubblicità? Se riuscite a sostenere che è pubblicità (mezzo per diffondere il marchio con aspettativa diretta di incremento vendite), quel costo potrebbe essere dedotto interamente. La Cassazione però è tendenzialmente restrittiva nel riqualificare: guarda alla sostanza dell’erogazione (gratuita? allora di solito rappresentanza). In ogni caso è un argomento talvolta utilizzabile.
Omaggi: rientrano nelle rappresentanza se gratuiti e senza controprestazione. Per gli omaggi ai clienti (es. cesti natalizi, regali vari) valgono i limiti generali visti sopra. Se di valore unitario entro 50 €, sono sempre deducibili integralmente (anche fuori plafond) perché considerati di modico valore . Se superiori a 50 €, vanno a plafond. Gli omaggi ai dipendenti, invece, non sono rappresentanza ma costi di lavoro dipendente (deducibili al 100% come spese per personale, ma potrebbero avere riflessi come fringe benefit se superano certi importi per dipendente – altro tema). Occhio anche all’IVA: l’IVA sugli omaggi a clienti è detraibile solo per beni di costo unitario fino a €50 (oltre no).
Riassumendo, le spese di rappresentanza possono essere dedotte con moderazione e solo se chiaramente finalizzate al business. Il contribuente che affronta un accertamento su questi costi dovrà mettere in campo un doppio livello di difesa: da un lato tecnico-contabile (verifica dei limiti, natura delle spese, rispetto dei requisiti di legge, come tracciabilità dal 2025) e dall’altro sostanziale (dimostrare l’utilità economica potenziale e la coerenza con l’attività). La giurisprudenza è generalmente severa nell’appoggiare il Fisco quando vede spese di rappresentanza usate per coprire eccessi o benefici personali (es: la mega festa di compleanno del titolare spacciata per evento aziendale). Però, se documentate bene la vostra posizione (ad esempio portando testimonianze di clienti che hanno partecipato e poi hanno fatto ordini, ecc.), avete chance di far prevalere la deducibilità.
Spese per autovetture e mezzi di trasporto
Le spese relative alle autovetture aziendali o professionali sono un classico terreno di scontro. Le auto possono avere un utilizzo promiscuo (business/personale) e per questo la normativa fiscale pone limiti alla deducibilità, proprio per evitare che si scarichino sul reddito d’impresa costi che in realtà soddisfano esigenze private (auto usata dall’amministratore anche per fini personali, etc.).
Disciplina fiscale delle auto (art. 164 TUIR):
– Per le imprese:
– Autovetture ad uso non esclusivamente strumentale (le auto “aziendali” generiche, assegnate ad amministratori o dipendenti per uso promiscuo, o comunque non legate all’attività caratteristica – es. auto aziendale per direzione): deducibilità limitata al 20% del costo, entro un costo massimo fiscalmente riconosciuto di circa €18.075,99 (per auto a benzina/diesel; soglia maggiore per elettriche/hybrid aggiornata negli ultimi anni). Ciò vale per una sola autovettura per socio/amministratore o per ogni dipendente cui sia assegnata. In pratica, se una società acquista un’auto da €30.000 e la dà in uso al direttore commerciale, potrà dedurre al massimo €3.615 (20% di 18.075) come ammortamento annuo. Le spese di gestione (carburante, manutenzione, bollo, assicurazione) sono anch’esse deducibili al 20%.
– Autovetture assegnate a dipendenti in uso promiscuo (uso sia lavoro che personale) come fringe benefit: in tal caso la deducibilità sale al 70% dei costi (sempre costi nei limiti massimi). Ciò perché il legislatore considera che l’uso promiscuo a un dipendente (contro imputazione di fringe benefit in busta paga) abbia comunque una prevalente finalità aziendale.
– Autovetture strumentali all’attività: se l’attività d’impresa stessa consiste nell’utilizzo di veicoli (es. società di noleggio auto, taxi, autoscuola) oppure se il veicolo è bene strumentale per natura (es. un furgone officina, un camion per autotrasporti, etc.), allora la deducibilità è 100% (integrale). Ad esempio, l’auto di una scuola guida o i camion di una ditta di traslochi sono costi integralmente inerenti.
– Autocarri (veicoli categoria N1) immatricolati come tali: in linea di massima, se rispettano i requisiti tecnici per essere considerati beni strumentali (niente assetti da autovettura di lusso), sono deducibili al 100%. Però l’Agenzia a volte contesta la qualifica di autocarro se il veicolo è in realtà usato come auto. Conta la destinazione d’uso effettiva.
– Per i professionisti (lavoro autonomo):
– È deducibile al 20% una sola autovettura (o motociclo) per ogni professionista, sempre entro il limite di costo di legge (circa €18.075). Se lo studio ha più di un professionista associato, vale per ciascuno. La ratio è che il professionista singolo difficilmente giustifica più di un’auto per la sua attività; eventuali seconde auto non sono considerate inerenti.
– Le spese di gestione anche qui al 20%.
– Se il professionista usa l’auto esclusivamente come bene strumentale** (casi rari: es. un rappresentante di commercio – che però fiscalmente è impresa, non autonomo – o un fotografo che usa un van attrezzato come ufficio mobile), si potrebbe tentare la deduzione integrale, ma in genere per i professionisti l’auto si presume mista.
NB: Le percentuali di deducibilità di cui sopra (20%, 70%) sono previste dalla normativa (art. 164 TUIR) e non hanno direttamente a che fare con l’inerenza in senso qualitativo, bensì con una stima forfettaria della parte di costo considerata inerente. In altre parole, il legislatore presume che il 20% dell’uso sia lavorativo e 80% personale, salvo particolari condizioni. Anche l’IVA sulle auto è detraibile al 40% forfettariamente (presunzione di uso promiscuo) salvo auto strumentali al 100%.
Contestazioni tipiche sulle auto:
Nonostante la presenza di norme chiare, le contestazioni sorgono quando:
– L’azienda deduce più auto di quelle ammissibili. Ad esempio, in una micro-società con un solo dipendente e un amministratore, trovare 5 autovetture intestate alla società fa scattare l’ovvio dubbio: chi le utilizza? Il Fisco potrebbe requalificare le spese di 4 auto come non inerenti (in realtà auto personali dei soci).
– Il tipo di veicolo non è compatibile con l’attività dichiarata: classico, l’auto di lusso (Porsche, Ferrari) in una società che nulla ha a che vedere con il settore auto/motorsport. Spesso l’Ufficio contesta che quell’auto serva solo al piacere dell’amministratore. Se l’azienda non dimostra uno specifico uso d’affari (es. l’auto di lusso per colpire clienti top – difficile), la spesa può essere disconosciuta.
– Carburanti e pedaggi e manutenzioni in eccesso: a volte l’Agenzia verifica i chilometraggi dichiarati, soprattutto se vengono dedotti importi di carburante eccessivi rispetto alle missioni note dell’azienda. Se emergono incongruenze, possono contestare che una parte di quei costi sia stata sostenuta per usi personali non inerenti. Ad esempio, se un amministratore dichiara di usare l’auto solo per lavoro in zona locale ma ha rimborsi carburante per 50.000 km l’anno e pedaggi autostradali in località turistiche, è ovvio che c’è del personale.
– Auto date in uso a familiari non dipendenti: se la società compra auto e le lascia ai figli del titolare che non lavorano in azienda, i costi non sono inerenti. Il Fisco spesso li tratta come utili extracontabili ai soci (benefici personali pagati dalla società).
– Mancata dimostrazione dell’uso strumentale al 100%: se il contribuente deduce al 100% sostenendo che l’auto è “strumentale”, l’onere è suo di dimostrarlo. Ad esempio un agente di commercio deve provare l’iscrizione alla Camera di Commercio in tale qualifica (gli agenti hanno regimi loro), o un’altra attività particolare. Se non ci riesce, l’Ufficio ricondurrà al 20%.
Difendersi sulle auto:
– Rispetta i limiti di legge: la miglior difesa è prevenire. Dedurre solo la quota consentita, e se hai più veicoli, metti a libro paga i beneficiari (così passi al 70% per dipendenti o eviti contestazioni di utili occulti).
– Log di utilizzo: tenere un registro dei viaggi/movimenti dell’auto aziendale può essere utile. Annota i km iniziali e finali, le destinazioni di lavoro, ecc. Questo diario di bordo, se accurato, può servire a convincere che l’uso personale è limitato.
– Dimostrare necessità effettiva: se contesta il numero di auto, spiegare l’utilizzo di ciascuna: es. “Auto A per il tecnico installatore, Auto B per il commerciale zona 1, Auto C per l’amministratore che gira su cantieri ecc.” e magari produrre contratti di comodato o policy interne che assegnano i mezzi a specifici dipendenti per compiti lavorativi.
– Fringe benefit: se un’auto è usata anche per scopi personali di un dipendente o amministratore, conviene talvolta regolarizzarla come fringe benefit (in busta paga o delibera compenso amministratore), pagando le relative imposte sul benefit. In tal modo la società rende “fiscalmente trasparente” l’uso promiscuo e avrà più margine di difendibilità sul costo (dedurrà 70% e non rischierà il disconoscimento totale).
– Veicolo di lusso: in giudizio, a meno che l’oggetto sociale non giustifichi quell’auto (es. attività di rappresentanza di prodotti di alta gamma, dove l’auto di lusso è marketing di per sé), è dura difendere una supercar come inerente. Un approccio è ammettere la parziale indeducibilità ma contestare la pretesa di disconoscere tutto: far valere almeno la deduzione al 20% come da art. 164. In genere, il Fisco stesso applica comunque il 20% e non disconosce oltre, salvo casi di uso totalmente personale.
– Documentazione dei costi: conservare tutte le fatture di manutenzione, carburante, leasing ecc. intestate alla società e con riferimento all’auto targata. Questo almeno attesta che l’auto è a carico dell’azienda (e non che l’azienda deduce spese magari di auto private intestate ai soci).
– Eventuali percorrenze per lavoro: biglietti di parcheggio in sede di clienti, pedaggi verso sedi di lavoro, possono supportare la tesi che l’auto era impiegata nell’attività.
La giurisprudenza sulla deducibilità delle auto è ampia ma non troppo favorevole ai contribuenti in casi di abusi: spesso si riscontrano conferme di indeducibilità quando l’auto è chiaramente usata come benefit sine titulo. Se l’auto aziendale genera benefit non tassati in capo a nessuno, i giudici tendono a considerarla distribuzione utili occulta o comunque costo non inerente.
Caso particolare – Agenti e rappresentanti: Gli agenti di commercio (che però fiscalmente dichiarano reddito d’impresa) hanno limiti di deducibilità più elevati per le auto: 80% fino a circa €25.000 di costo. È una deroga prevista in riconoscimento dell’uso intensivo dell’auto nell’attività di agenzia. Anche per i professionisti che fanno trasfertismo, l’auto può essere essenziale: tuttavia la legge non distingue, quindi anche il consulente che macina chilometri per clienti può dedurre solo 20%. Può però dedurre altre spese di viaggio (treni, aerei) se non usa l’auto.
In conclusione, le spese auto vanno gestite con attenzione. Spesso non è tanto un tema di “inerenza sì/no” (perché la legge già ne limita la percentuale deducibile), ma di eventuale abuso oltre i limiti. Una volta nei parametri (1 auto 20%, etc.), raramente l’Ufficio contesterà l’inerenza residua di quel 20%. Contestazioni robuste emergono quando, ad esempio, un’azienda deduce interamente il leasing di 3 SUV di lusso sostenendo che servono tutti all’attività: scenario dove difficilmente si regge in giudizio.
Spese di vitto, alloggio e trasferte
Le spese di vitto e alloggio (ristoranti, alberghi) e in generale le spese di viaggio e trasferta sono anch’esse soggette a disciplina specifica e spesso ridotte forfettariamente perché suscettibili di commistione personale.
Regime fiscale:
– Per le imprese: le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte di dipendenti fuori dal territorio comunale sono deducibili al 100% come costi di lavoro dipendente (fino ai limiti di deducibilità previsti per le diarie giornaliere in caso di rimborso a forfait). Se invece l’azienda paga direttamente alberghi e ristoranti per i propri dipendenti in viaggio, tali spese sono integralmente deducibili (ma non oltre il “ragionevole”, se mandasse un impiegato in hotel 5 stelle potrebbe emergere antieconomicità).
Quando le spese di vitto/alloggio non sono per trasferte dipendenti ma ad esempio per ospitalità di clienti o per il titolare, allora si applica la regola generale: deducibilità al 75% del loro importo . Questa regola vale in via generale dal 2005 per limitare deduzioni troppo facili: il legislatore presume che il 25% sia spreco o uso personale e lo taglia. Inoltre, se tali spese rientrano in rappresentanza (esempio: cena di gala per clienti = rappresentanza), come detto vanno prima ridotte al 75% e poi conteggiate nel plafond di rappresentanza . Se invece sono spese di pubblicità (esempio: buffet offerto durante un evento promozionale in cui si presentano prodotti – borderline con rappresentanza), potrebbero essere deducibili al 100% (ma bisogna sostenere fortemente la tesi pubblicitaria).
– Per i professionisti: fino al 2017 esisteva un doppio limite (75% entro 2% dei compensi). La normativa è stata semplificata e oggi il professionista deduce il 75% delle spese di vitto e alloggio sostenute per sé stesso o per i clienti, purché inerenti all’esercizio dell’attività (art. 54 TUIR). Non c’è più il tetto del 2% dei compensi annui, eliminato dal 2017. Ad esempio, un avvocato che va a pranzo col cliente per discutere una causa può dedurre il 75% del conto, documentandolo con fattura intestata al suo studio (non uno scontrino generico). Se però addebita quella spesa al cliente in parcella (come spesso avviene: spese anticipate), allora entra tra i costi riaddebiti e si deduce al 100% perché retribuita dal cliente. Insomma, se il costo è refundable non è un costo tuo. Diversamente, se è a tuo carico, 75% deducibile.
Contestazioni tipiche:
– Spese di ristorante elevate e frequenti: l’Ufficio tende a guardare con sospetto pranzi e cene troppo onerose o continue. Se un imprenditore deduce cene tutti i weekend in ristoranti di lusso, potrebbe scattare la domanda: erano davvero per lavoro o è vita privata scaricata sull’azienda? In caso di verifica, chiedono spesso di indicare chi partecipava a quei pasti e con quale scopo. Non c’è un obbligo formale di riportare i nomi in fattura, ma è buona pratica annotarlo. Se non si riesce a giustificare (es: “era cena con tale cliente per trattativa, ecco magari una mail di invito”), possono contestare non l’intero costo (visto che comunque il 75% è ammesso di default) ma l’inerenza stessa di quell’uscita: ovvero dire “questa cena era un fatto privato, quindi non rientra proprio tra i costi aziendali deducibili”.
– Scontrini non intestati: un errore comune è presentare come costi fatture non intestate alla ditta/professionista (ad esempio, ricevute o scontrini generici). Fiscalmente, per dedurre serve fattura intestata (dal 2019 anche elettronica) se sopra €77,47 euro, altrimenti non è un documento valido. Se in sede di verifica esibisci ricevute senza intestazione, l’Ufficio disconosce quei costi come non documentati (prima ancora che non inerenti).
– Trasferte inesistenti o miste a vacanza: esempio, l’amministratore porta la famiglia in vacanza a Dubai e deduce il viaggio aereo e l’hotel come “missione esplorativa per aprire mercato estero”. Queste situazioni, se non adeguatamente suffragate da incontri d’affari, contratti o altre prove, vengono contestate. Il Fisco può confrontare i giorni di viaggio con eventuali contratti conclusi, nominativi dei partner incontrati, etc. Se appare come vacanza mascherata, disconosce tutto (anche il 75%). Anche qui può scattare la riqualificazione come utilità ai soci.
– Spese di trasferta a collaboratori non giustificate: se rimborsi spese a un collaboratore part-time cifre esorbitanti di viaggi senza pezze d’appoggio o con motivazioni vaghe, possono considerarle compensi in nero o uscite non inerenti.
Difesa e prevenzione:
– Sempre fattura: per ogni albergo e ristorante chiedere fattura elettronica intestata alla propria partita IVA, con indicazione di “spesa vitto per… (causale)”. Questo toglie almeno l’appiglio formale.
– Annotare lo scopo: tenere un registro interno delle trasferte, con date, luogo, persone incontrate/motivo (meeting con cliente X, ecc.). In caso di controllo, se fornite una lista ben fatta di giustificazione di ogni trasferta, smontate la tesi “era una vacanza”.
– Documenti allegati: se fate missioni, conservate biglietti da visita dei clienti visitati, brochure degli eventi seguiti, email di appuntamenti fissati, qualsiasi cosa. All’occorrenza potrete presentarli.
– Moderazione e coerenza: una cena aziendale per 10 persone da 1000€ può avere senso a Natale con i dipendenti (quella per dipendenti in realtà rientra nel costo lavoro, non rappresentanza). Una cena da 500€ al ristorante stellato ogni settimana con lo stesso socio… be’, è difficile farla passare. In giudizio l’onere di provare l’inerenza è vostro: se non potete nominare nemmeno un cliente presente, siete scoperti.
– Trasferte miste: se unite lavoro e vacanza, cercate di separare le spese (fatturate a parte quelle di eventuali accompagnatori non lavorativi, pagate personalmente i giorni extra). Dedurre solo la quota effettivamente di lavoro. Ciò rende più credibile la vostra posizione e riduce la materia del contendere.
– Diario di viaggio: per trasferte lunghe, preparate un breve report di ciò che avete fatto e appoggiatelo a eventuale relazione interna. Non è obbligatorio, ma se poi arriva la domanda “cosa ha prodotto questo viaggio?”, potrete esibire un report (inviato magari all’ufficio) dove spiegate i contatti avviati, etc., corroborando la genuinità della trasferta.
Un caso giurisprudenziale interessante: Cass. 21903/2015 (Sez. Trib.) riguardava una società che aveva dedotto spese di viaggio e soggiorno ritenute dal Fisco non inerenti. La Cassazione, confermando l’indeducibilità, disse che la contribuente non aveva fornito alcun elemento per ritenere quei viaggi funzionali all’attività, né prova di incontri d’affari: dunque erano verosimilmente viaggi di piacere. Ciò ribadisce come tutto torni all’onere probatorio: se non fornisci spiegazioni, perderai. Contrariamente, in altre pronunce, laddove il contribuente aveva prodotto documentazione di fiere estere e incontri professionali collegati ai viaggi, la deducibilità è stata riconosciuta (purché nei limiti normativi).
In definitiva, le spese di vitto, alloggio e trasferte sono inerenti se correlate a viaggi di lavoro o all’ospitalità legata all’attività, ma proprio perché facilmente confondibili con spese personali, vanno supportate da robusta documentazione e da comportamenti coerenti (ad esempio, evitare l’anomalia di dichiarare zero ricavi esteri e poi dedurre 50k di viaggi all’estero per “cercare clienti” – in quel caso meglio attendersi domande dal Fisco).
Spese per beni ad uso promiscuo (telefono, abitazione, utenze)
Oltre alle auto di cui si è detto, altre spese possono essere promiscue tra sfera lavorativa e personale. Le più comuni: utenze telefoniche, connessioni internet, e spese per immobili utilizzati in parte come ufficio e in parte come abitazione (nel caso di imprese individuali o professionisti che lavorano da casa).
Telefonia e telecomunicazioni: La normativa fiscale ammette una deducibilità forfettaria all’80% per le spese di telefonia (fissa e mobile) e internet, salvo dimostrazione di un uso esclusivo aziendale. Questa regola è stata introdotta anni fa (art. 102, comma 9 TUIR per imprese, art. 54 per autonomi per analogia) per semplificare: si assume che il 20% sia di uso personale o comunque inefficiente. Dunque, se deducete l’80% delle bollette telefoniche, siete allineati con la norma e di solito non avrete problemi. Se pretendete di dedurre il 100% sostenendo che non c’è uso personale, l’onere è vostro di provare l’esclusività: ciò è fattibile solo se, ad esempio, la linea telefonica è intestata all’ufficio e non vi è commistione (per un cellulare è arduo convincere che non lo usate mai per una chiamata privata). La via più prudente è attenersi all’80%.
Canoni e spese per immobile ad uso misto (studio in casa): Molti professionisti o piccoli imprenditori lavorano da casa, deducendo parte dei costi domestici. La regola generale: se un immobile è promiscuo (uso sia lavorativo che abitativo), è deducibile il 50% delle spese relative (art. 54 co. 3 TUIR per autonomi). Per le imprese individuali c’è un criterio simile in pratica. Ad esempio, un professionista che utilizza una stanza della propria abitazione come studio può dedurre il 50% dell’affitto, delle bollette, TARI, ecc., purché l’uso promiscuo sia attestato (la norma fissa forfettariamente 50%, indipendentemente che lo spazio lavorativo sia il 20% o 70% della casa). Per dedurre è necessario inviare una comunicazione all’Agenzia (una sorta di autocertificazione dell’uso promiscuo, di solito inserita in Unico) e ovviamente possedere titoli (contratto affitto intestato a lui, fatture utenze). Le contestazioni su questo fronte sorgono se uno deduce costi oltre il 50% o per immobili non effettivamente utilizzati per lavoro. Se uno deducesse il 100% dell’affitto di casa dicendo che l’ha adibita tutta a studio, il Fisco potrebbe verificare. Anche qui la prova è difficile: se ti ci abiti, il 100% non regge.
Altre utenze: Energia elettrica, acqua, gas, se riferiti a locali promiscui, stesso discorso: in teoria 50% se ben dichiarato. Se invece parliamo di utenze per locali esclusivamente aziendali (es. capannone, negozio), allora 100% ovviamente. L’importante è poter dimostrare che quell’utenza è davvero per quell’uso (intestazione contratti, ubicazione, ecc.).
Contestazioni e difesa:
– Telefono: se deduci 80%, difficilmente ti faranno osservazioni (è la quota di legge). Se deduci 100%, preparati a mostrare magari i dettagli traffico evidenziando che il telefono è usato da centralino, ecc., ma può non convincere. Alcuni provano a dedurre 100% per centralini aziendali e 0% su cellulari personali – approccio ragionevole se c’è distinzione netta.
– Internet: similare, se la linea è in casa e la usi anche per Netflix, in teoria 50% se spesa casa, o 80% se considerata telefonia. Anche qui meglio tenersi prudenti (in genere molti deducono 100% internet per ufficio, ma se è casa potrebbe essere contestato – dipende).
– Casa-ufficio: la difesa migliore è documentare l’esistenza di uno studio domestico: foto della stanza adibita ad ufficio, targa sul citofono, magari ricevimento clienti lì (se succede). Se l’Agenzia volesse contestare più del 50% dedotto, avreste elementi. Comunque mai dedurre oltre 50% perché la norma quello prevede come massimale forfettario. – Affitto intestato alla società ma immobile usato dal socio: a volte capita nelle piccole srl: la società paga affitto (o mutuo) per casa del socio fingendo sia ufficio. Se l’ufficio in realtà non c’è o è minoritario, il Fisco può non solo negare il costo per intero ma considerare il socio beneficiario di un fringe benefit non tassato (o addirittura distribuzione utili occulta). Quindi attenzione: se la società affitta un immobile dal socio stesso o dai suoi familiari, e lì c’è in parte l’abitazione del socio, la situazione è ad alto rischio. Bisogna formalizzare contratti, delimitare gli spazi ad uso aziendale, magari fare due contratti distinti (uno per ufficio, uno per abitazione a carico del socio). In mancanza, gli accertatori leggono subito l’abuso e riqualificano.
In sintesi, i beni ad uso promiscuo devono essere gestiti con criteri pro-rata prestabiliti dalla norma. Se segui quelle percentuali, sei relativamente al sicuro. Se te le contesta qualcuno, citi la norma e in genere finisce lì. Se invece tenti di forzare (dedurre di più), devi avere giustificazioni straordinarie e aspettarti comunque resistenza.
Compensi e spese a favore di familiari, soci o amministratori
Un’altra area grigia in cui spesso si giocano cause di inerenza riguarda i compensi corrisposti a soggetti “correlati” all’imprenditore: membri della famiglia, soci della società, amministratori che coincidono coi proprietari, ecc. Per legge, i compensi agli amministratori sono deducibili nel limite della loro congruità e a condizione che siano deliberati e corrisposti regolarmente. Tuttavia, il Fisco può contestare certi pagamenti sostenendo che non c’è una vera prestazione sottostante o che sono sproporzionati.
Esempi comuni:
– Stipendio al coniuge o figli: l’imprenditore individuale spesso assume il coniuge o i figli in azienda. Questo è lecito, ma deve corrispondere a un lavoro effettivo. Se il familiare non risulta mai presente o non ha mansioni identificabili, i relativi stipendi possono essere considerati indeducibili per carenza di inerenza (spesa non necessaria all’impresa ma destinata ad arricchimento familiare). A volte l’Agenzia contesta questi costi come antieconomici se sproporzionati rispetto a mansioni base (es. moglie segretaria pagata come quadro dirigente). È essenziale quindi poter dimostrare che il familiare lavorava e il compenso è allineato ai prezzi di mercato.
– Compenso all’amministratore unico (socio): in società di capitali, i compensi amministratori sono deducibili. Tuttavia, la Cassazione (vecchia ris. Min. Finanze 1997 e alcune sentenze) aveva ammesso una sindacabilità di compensi esorbitanti come non inerenti se strumentali a ridurre utili (specie in contesti di soci di famiglia che si attribuiscono compensi anomali per ripartire utili senza tassazione da dividendo). Una risoluzione dell’Agenzia (113/E 2012 citata in dottrina) affermava proprio la sindacabilità di compensi ad amministratori “insoliti, sproporzionati o strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi” . Quindi il Fisco può contestare parte di un compenso amministratore se appare gonfiato a fine anno per azzerare l’utile e non giustificato da un reale lavoro. La giurisprudenza in materia è altalenante: a volte riconosce libertà d’impresa nei compensi, a volte (in casi di compensi abnormi e ingiustificati) li ha ridotti.
– Fatture da società dei familiari: a livello di gruppi familiari, succede che l’impresa X paghi consulenze o affitti alla ditta Y del cognato. Se il Fisco sospetta che Y non abbia fornito reale servizio a X (magari è scatola vuota per drenare utili), contesterà l’inerenza di quelle fatture. È simile al caso delle false fatturazioni, ma può essere borderline (servizi sovrafatturati). Inerenza e antieconomicità si intrecciano qui: se X paga 100k per una consulenza che appare farlocca, l’Ufficio dirà che non è inerente (spesa fittizia per portare soldi fuori tassazione). Starà a X provare che la consulenza c’è stata e serviva.
– Spese personali del socio: a volte i soci usano la società per pagare proprie spese personali (viaggi familiari, feste, acquisti vari) che vengono contabili come costi aziendali. Queste sono chiaramente non inerenti e indeducibili. Il Fisco quasi sempre se ne accorge (specie nei controlli bancari: bonifici azienda a agenzie viaggio, etc.) e in sede di verifica le requalifica come utili ai soci o spese extracontabili. La difesa qui è impossibile se il fatto è palese: la strategia è più che altro negoziare sulle sanzioni, perché è un abuso conclamato.
Difendersi:
– Quando il Fisco contesta un costo per difetto di inerenza a causa del legame tra le parti, la difesa deve provare la realtà e necessità della prestazione. Ad esempio, per difendere il salario della moglie impiegata, portare buste presenza, mansioni svolte, risultati ottenuti, magari testimonianze di colleghi, e mostrare che lo stipendio è in linea col CCNL per quella mansione. Se la moglie non lavorava affatto, è indifendibile.
– Per compensi amministratori molto alti: giustificarli con dimensione e risultati aziendali. Se l’amministratore ha portato l’azienda da zero a milioni, il premio elevato può avere senso. Evidenziare delibere assembleari che approvano il compenso, per formalità. In giudizio sottolineare che la legge non pone limiti quantitativi ai compensi e che l’assemblea sovrana ha deciso così (principio di insindacabilità delle scelte imprenditoriali, salvo abuso). Citare eventualmente precedenti dove la Cassazione ha negato ingerenze del Fisco su compensi se formalmente corretti.
– Per operazioni infragruppo: presentare contratti, relazioni tecniche che spieghino il servizio ricevuto, e dimostrare che il prezzo è allineato al mercato (magari mostrando preventivi di terzi o il margine di utile ragionevole della consociata). Far vedere che non era un modo per spostare utili ma un vero rapporto.
– Evitare autogol: se il familiare non lavora, meglio non creare costi fittizi. Magari usare altri strumenti (prelievi di utili). Insomma, in fase di pianificazione fiscale conviene ridurre le situazioni attaccabili.
Giurisprudenza: In passato, ad esempio, la Cassazione con la sent. n. 16713/2007 affermò che era indeducibile l’eccesso di compenso all’amministratore unico rispetto al lavoro svolto, in quanto considerato distribuzione occulta di utili. Tuttavia sentenze più recenti sono meno interventiste, soprattutto dopo l’orientamento qualitativo sull’inerenza: se il compenso è deliberato e corrisposto (certezza), l’inerenza c’è perché è un atto di gestione volto a remunerare l’attività gestoria (che è funzionale all’impresa). L’antieconomicità può emergere solo in casi macroscopici (amministratore che prende 10 volte l’utile dell’azienda in stipendio – chiaro segnale di abuso).
Altre spese generali e consulenze
Tra le altre spese che possono essere contestate come non inerenti, segnaliamo:
– Spese per consulenze e servizi vari: se l’azienda paga per studi, ricerche di mercato, consulenze professionali, ecc., deve esserci un risultato o almeno un report che dimostri l’utilità. Il Fisco spesso chiede di vedere il deliverable: se paghi €50k per “consulenza strategica” e non hai uno straccio di relazione o documento prodotto, l’inerenza viene messa in dubbio (forse era un modo di prelevare utili tramite un consulente compiacente, oppure fattura falsa). La difesa: esibire il contratto, i documenti consegnati dal consulente, email di scambio. Se la consulenza era orale, almeno testimonianze o risultati tangibili (es. incremento vendite grazie ai consigli).
– Spese legali e di difesa: qui l’inerenza di solito c’è (difendere l’azienda in giudizio è attività inerente). Attenzione però a un caso particolare: le spese legali per difendere penalmente amministratori accusati di reati personali. La Cassazione (e anche l’Agenzia, v. FiscoOggi) ha ritenuto non detraibile IVA e non deducibile la spesa legale sostenuta da una società per difendere in un processo penale i propri amministratori, se il procedimento concerne fatti penalmente rilevanti non connessi con l’interesse sociale . Ad esempio, società paga avvocato per difendere l’amministratore accusato di frode fiscale a proprio vantaggio: qui di solito dicono non inerente (perché l’azione è nell’interesse personale dell’amministratore, anzi contraria a quello sociale). Viceversa, se il procedimento penale è per fatti avvenuti nell’esercizio delle funzioni societarie a vantaggio della società, la spesa può essere inerente. Quindi, in caso di spese legali per amministratori/dipendenti, valutare bene: potrebbero essere contestate come estranee all’impresa (soprattutto se trattasi di reati dolosi).
– Oneri finanziari o straordinari: per esempio, perdite su crediti volutamente causate (condoni di debiti a parti correlate), oppure penali su contratti rescissi per motivi personali: anche queste possono essere disconosciute se risultano scelte extragestionali. La linea di difesa in questi casi è sottolineare le ragioni economiche: es. ho condonato quel credito perché era inesigibile comunque, quindi scelta imprenditoriale (inerente alla gestione prudenziale).
Spese illecite e sanzioni (indeducibilità per legge)
Chiudiamo la rassegna con le spese che non sono inerenti perché contrarie all’ordinamento e dunque mai deducibili, come previsto da norme ad hoc:
– Sanzioni e multe: come già detto, le sanzioni amministrative e pene pecuniarie non sono deducibili (art. 6 co. 4 D.Lgs. 472/97). Ciò rispecchia un principio: non si può far “pagare allo Stato” (mediante risparmio d’imposta) la propria violazione di legge. Non ha quindi senso difendersi su questo: se un accertamento contesta il tentativo di dedurre sanzioni, va ceduto. Idem per multe stradali intestate alla società: non vanno a costi deducibili ma a un conto non deducibile. Se erroneamente dedotte, verranno riprese.
– Costi da reato: l’art. 14, c.4-bis L. 537/93 (mod. dal D.L. 16/2012) vieta la deduzione di costi relativi a fatti qualificabili come reato non colposo. Esempi: tangenti, sovraprezzi in fatture false, beni destinati a corrompere, spese per attività illegali (es. contrabbando). Su questo tema c’è stata di recente (2025) conferma dalla Cassazione che anche i cosiddetti “costi da reato” (come le fatture per operazioni inesistenti, spesso usate per evadere) non sono deducibili e anzi la loro presenza integra reato tributario a sua volta . In passato c’era dibattito: la Corte Costituzionale con sent. 247/2011 aveva mitigato per i costi da reato riferiti a ricavi occultati (principio simmetria), ma poi il legislatore è intervenuto rendendoli indeducibili con poche eccezioni. Quindi, se contestano costi illegali, inutile opporsi sulla deducibilità – la legge lo impedisce espressamente. Casomai la difesa sarà nel campo penale, non tributario.
– Donazioni, liberalità: non sono deducibili perché non inerenti (non dirette a produrre ricavi). Solo alcune erogazioni liberali specifiche danno diritto semmai a deduzioni o detrazioni separate (verso ONLUS, partiti, etc., entro limiti), ma se un’azienda elargisce soldi senza contropartita a un amico o altro, non può dedurli.
Abbiamo dunque passato in rassegna le principali categorie. Per facilitarne la memorizzazione, ecco una tabella riepilogativa di alcune spese “a rischio” e relativi requisiti/deduzioni massime:
<table> <thead> <tr><th>Tipologia di spesa</th><th>Deducibilità ammessa (sintesi normativa)</th><th>Principali rischi di contestazione (non inerenza)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spese di rappresentanza (omaggi, eventi, pranzi con clienti, ecc.)</td> <td>Deducibili entro:<br>- Imprese: 1,5% fino 10 mln ricavi; 0,6% tra 10-50 mln; 0,4% oltre 50 mln . <br>- Professionisti: 1% compensi .<br> + Requisiti: gratuità, finalità promozionale, congruità, pagamento tracciabile (dal 2025) .</td> <td>– Costo non attinente all’attività (evento non collegabile all’oggetto sociale, omaggi a soggetti estranei al giro d’affari).<br>– Spesa eccessiva rispetto ai ricavi (antieconomicità: es. spese rappresentanza altissime in azienda piccola).<br>– Mancata prova dell’attività promozionale (es. viaggio “promozionale” senza documentazione di meeting).<br>– Violazione nuovo obbligo tracciabilità (pagamenti in contanti).</td> </tr> <tr> <td>Autovetture aziendali/professionali</td> <td>Imprese:<br>– Uso promiscuo: deducibile 20% costi (max imponibile €18.076) .<br>– Assegnata a dipendente uso promiscuo: 70%.<br>– Veicolo strumentale (uso esclusivo attività): 100%.<br>Professionisti:<br>– 1 autovettura deducibile 20% (stesso limite costo).<br>IVA detraibile 40% (salvo uso esclusivo).</td> <td>– Più auto del necessario (es. auto intestate in numero sproporzionato ai dipendenti).<br>– Uso personale prevalente non dichiarato (es. auto di lusso per amministratore, spese carburante per vacanze).<br>– Manca correlazione con attività (es. auto sportiva in azienda non attinente).<br>– Nessuna assegnazione formale dell’auto a dipendenti/soci ma utilizzo privato (rischio utili in natura non tassati).</td> </tr> <tr> <td>Vitto e alloggio, trasferte</td> <td>– Imprese: 75% dell’importo (se spese per clienti o titolare) . 100% se per trasferte dipendenti fuori comune (o rimborsi dentro soglie).<br>– Professionisti: 75% (senza più limite 2%).<br>– Se riaddebitate al cliente: 100% (niente costo netto).<br>IVA detraibile 100% su spese alberghi/ristoranti (ma costo ded. 75%).</td> <td>– Uso personale mascherato (cene/viaggi di piacere spacciati per lavoro).<br>– Fatture mancanti o non intestate (scontrini non fiscalmente deducibili).<br>– Nessuna evidenza di appuntamenti di lavoro o finalità professionale nel viaggio (es. trasferta estera senza incontri documentati).<br>– Frequenza/entità cene incoerente con attività (es. troppe cene di lusso senza concreti affari legati).</td> </tr> <tr> <td>Telefonia e internet</td> <td>Forfait 80% deducibile (uso promiscuo presunto). 100% solo se uso esclusivo dimostrabile (raro).<br>Linee dati/telefoniche ad uso abitazione/studio promiscuo: in pratica 80% su 50% (cioè 40%) se già ripartite.</td> <td>– Deduzione integrale senza prova esclusività (difficile da difendere).<br>– Linee intestate all’azienda ma usate da familiari per scopi privati (non inerenti).<br>– Spese anomale (es. bollette altissime non giustificate da esigenze aziendali: può segnalare uso privato). </td> </tr> <tr> <td>Immobili ad uso promiscuo (abitazione + ufficio)</td> <td>Spese (affitto, utenze, manutenzione) deducibili al 50% se immobile promiscuo (per autonomi per definizione art. 54, co.3).<br>Nessuna deduzione oltre 50% anche se la percentuale di uso lavoro fosse maggiore (forfait).</td> <td>– Deduzione >50% (non ammessa, a meno di destinazione esclusiva di porzione con autonoma categoria catastale/contratto separato).<br>– Assenza di spazio effettivo dedicato all’attività (es. nessuna stanza adibita a studio nonostante deduzioni dichiarate – l’Ufficio potrebbe contestare l’inerenza persino del 50%).<br>– Immobile di lusso intestato all’azienda ma di fatto abitazione del socio (costo interamente non inerente, riqualificato come utile occulto).</td> </tr> <tr> <td>Compensi a familiari/soci (stipendi, consulenze)</td> <td>Deducibili se realmente corrisposti e congrui.<br>Per amministratori: deducibili se deliberati dall’assemblea (società di capitali) o da atto per imprenditore individuale; soggetti a contribuzione INPS se dovuta; non esistono tetti normativi, ma v. rischi.</td> <td>– Mancata prestazione effettiva: familiare pagato ma non lavora in azienda (costo non inerente).<br>– Sproporzione evidente: compensi troppo alti rispetto a mansione/mercato (Fisco li vede come distribuzione utili mascherata).<br>– Operazioni con parti correlate senza giustificativo (consulenza pagata a società del socio senza output tangibili).<br>– Compensi non formalizzati (es. amministratore di fatto pagato senza delibera o contratto: deduzione contestabile anche per violazioni civilistiche).</td> </tr> <tr> <td>Spese legali per cause penali di esponenti azienda</td> <td>Deducibili solo se il procedimento penale riguarda atti compiuti nell’interesse dell’azienda o ad essa strettamente connessi.<br>NON deducibili se riguardano condotte personali, fraudolente o contrarie all’interesse sociale (orientamento giurisprudenziale e Agenzia Entrate) .</td> <td>– Procedimenti per reati fiscali o societari a carico di amministratori: spesso ritenuti non inerenti (perché l’illecito fiscale è a vantaggio dell’azienda ma la Cassazione è altalenante; in molti casi spesa negata).<br>– Reati extraziendali (es. amministratore imputato per fatti privati): difesa assolutamente non inerente all’attività.<br>– Manca delibera autorizzativa della società a farsi carico delle spese legali (potrebbe già implicare non inerenza perché non c’è interesse sociale deliberato).</td> </tr> <tr> <td>Multe, sanzioni</td> <td>Sempre indeducibili (anche se inerenti all’attività, per legge non si deducono costi da illecito) – art. 6 c.4 D.Lgs.472/97.</td> <td>– N/A: se dedotte erroneamente, verranno riprese senza appello.<br>(Difesa possibile solo contestando che l’importo non era una sanzione ma altro, se applicabile.)</td> </tr> <tr> <td>Costi “illeciti” (es. tangenti, sovrafatturazioni, beni usati per reati)</td> <td>Indeducibili ex lege (art. 14, c.4-bis L. 537/93) salvo costi di reati colposi o costo del lavoro dipendente regolarmente assunto anche se impiegato in fatti illeciti (unica eccezione).<br>In pratica, nessuna deduzione ammessa per costi da attività illecite intenzionali.</td> <td>– N/A sul piano tributario: la difesa si sposta sul penale (spesso questi costi emergono da indagini penali).<br>L’unica strategia è negare la qualificazione come “reato” del fatto (ma se è accertato, il costo è perso).<br>Esempio: fattura falsa, costo indeducibile e magari sanzione penale per dichiarazione fraudolenta oltre €> fattura soglia.</td> </tr> </tbody> </table>
Importante sulla documentazione
Un filo conduttore emerso in tutte le tipologie è la qualità della documentazione di supporto. Già prima abbiamo visto come, in un caso concreto, i giudici abbiano sottolineato che “fatture generiche e preventivi non bastano” a provare l’inerenza . Ecco quindi alcuni consigli generali validi per qualsiasi tipo di spesa dedotta:
– Conservare contratti, ordini, relazioni, report relativi a ogni costo importante. Non limitarsi alla fattura. Se è una consulenza, pretendere dal consulente una relazione finale scritta. Se è un acquisto di materiali, tenere traccia di dove sono stati utilizzati (commessa, magazzino, ecc.). Questa documentazione di contesto può rivelarsi decisiva in giudizio .
– Fatture analitiche: cercate di ottenere fatture dettagliate. Una descrizione precisa (es. “fornitura 100 pezzi componente X per cantiere Y”) vale oro rispetto a “fornitura materiali vari”. Più dettaglio = più facilità di collegare il costo al reddito .
– Tracciabilità dei pagamenti: non solo perché in alcuni casi è obbligatoria (rappresentanza dal 2025), ma in generale pagare con mezzi tracciabili permette di dimostrare che il costo è effettivamente uscito dalle casse aziendali e a chi è andato . In contenziosi su costi fittizi, l’Agenzia spesso segue il flusso di denaro: se un pagamento torna al titolare magari in nero, la deduzione crolla. Avere tutto tracciato e lineare aiuta a dissipare sospetti .
– Coerenza contabile: registrare le spese nei corretti conti di costo (es. non infilare spese di casa in “spese ufficio” in modo surrettizio). Una contabilità trasparente, con voci separate (magari sottoconti per “spese auto 20% deduc.”, “spese rappresentanza”) mostra che l’azienda è consapevole delle regole e le segue. Questo mette l’Ufficio in posizione di maggiore fiducia durante eventuale istruttoria.
– Non nascondere documenti: attenzione che dal 2020 la normativa (DL 124/2019) prevede che documenti non esibiti in verifica non sono producibili in giudizio, a meno che il contribuente non provi che la loro mancata esibizione non gli sia imputabile. Questo è stato attenuato di recente per le fatture elettroniche, considerate comunque conosciute al Fisco (e dunque sempre producibili) . In ogni caso, è buona prassi collaborare e fornire tutto subito al verificatore: se poi “spuntate” carte nuove in giudizio rischiate l’inutilizzabilità.
Aspetti processuali: dal ricevimento dell’accertamento al giudizio
Dopo aver analizzato il “cosa” (i costi contestati e come difenderne l’inerenza), spendiamo ora qualche parola sul “come” procedere quando l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) muove una contestazione. Vedremo il percorso del contenzioso tributario e gli strumenti a disposizione del contribuente, con particolare riguardo al processo così come riformato nel 2022 (oggi le Commissioni Tributarie si chiamano Corti di Giustizia Tributaria, di I e II grado).
Avviso di accertamento e fase pre-contenziosa
Tipicamente, l’iter inizia con un Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di una verifica in azienda, oppure con un avviso di accertamento emesso direttamente dall’Agenzia delle Entrate (spesso dopo controlli da remoto o segnalazioni). Nel PVC o nell’avviso verranno elencate le spese ritenute indeducibili per difetto di inerenza, con l’indicazione dell’anno d’imposta interessato e dell’importo recuperato a tassazione per ciascuna. Troveremo anche il calcolo delle maggiori imposte dovute (IRES/IRPEF, IRAP se applicabile) e delle sanzioni (di norma per dichiarazione infedele, pari al 90% della maggiore imposta o, se i costi sono ritenuti inesistenti, sanzioni più severe del 90-180%).
Alla ricezione di un avviso di accertamento, il contribuente ha 60 giorni di tempo per reagire (il termine è per presentare ricorso, ma conviene usare questo periodo anche per tentare soluzioni deflative). Ecco le opzioni nella fase pre-contenziosa:
- Richiesta di riesame in autotutela: Si può provare a contattare l’ufficio accertatore segnalando errori evidenti o allegando documenti chiarificatori, chiedendo l’archiviazione o la rettifica dell’atto in autotutela. Questo strumento non sospende i termini di ricorso e non costituisce un diritto, è solo una possibilità. In materia di inerenza, raramente l’Ufficio annulla in autotutela a meno di palesi sviste (es. contestato costo X perché non avevano visto un documento poi esibito). Vale la pena provare se avete elementi nuovi forti, ma senza illudersi.
- Accertamento con adesione: È un procedimento deflativo che consente al contribuente di discutere con l’ufficio per raggiungere un accordo sull’accertamento, riducendo sanzioni (1/3 del minimo in caso di successo). La presentazione dell’istanza di adesione entro 60 giorni sospende i termini di ricorso per 90 giorni. Nel contraddittorio dell’adesione, potete esporre le vostre ragioni, portare documenti, citare sentenze, e l’ufficio potrà formulare una proposta di conciliazione (es. riconoscere parte dei costi come deducibili e parte no). In tema di costi non inerenti, l’esito dipende molto dalla forza delle prove che presentate: se convincete il funzionario, potrebbe concedervi un abbattimento delle riprese o delle sanzioni. Spesso l’adesione va a buon fine su questioni in cui c’è margine interpretativo (es. spese parzialmente inerenti) trovando un compromesso economico. Se l’accordo si chiude, pagherete le imposte rideterminate e sanzioni ridotte, e la questione finisce lì senza processo. Se non si chiude, potrete comunque fare ricorso entro la nuova scadenza (60 gg + sospensione).
- Reclamo-mediazione: Se il valore della causa (imposta + interessi senza sanzioni) è entro €50.000 (limite valido fino alle liti instaurate sino al 2022; con la riforma 2023 il limite dovrebbe elevarsi a €100.000, ma verificate la normativa attuale), il ricorso in Commissione Tributaria di I grado è preceduto obbligatoriamente da un reclamo all’Ufficio, con contestuale proposta di mediazione. In pratica, per liti minori il contribuente deve prima presentare il ricorso come “reclamo” e l’Agenzia ha 90 giorni per valutare se accoglierlo in tutto o in parte o fare una proposta transattiva. Spese su inerenza rientrano spesso in liti di importo sotto soglia (a meno che non siano grossi importi multi-annuali). La mediazione è un’altra chance per evitare il giudizio: l’Ufficio provinciale esaminatore potrebbe rivedere l’atto o proporre sanzioni ridotte se accettate un pagamento parziale. Ad esempio, se vi contestano €20k di imposte per costi auto, potreste proporre di pagarne €10k e chiudere la questione. Se accettano, si redige un accordo di mediazione con sanzioni ridotte a 1/3. Se rifiutano o non rispondono, dopo 90 gg il reclamo diventa ricorso e la causa prosegue.
In queste fasi, è fondamentale mettere già in campo la strategia difensiva: preparare un dossier con tutte le prove a supporto dei costi contestati, corredato da un memoriale difensivo che illustri punto per punto perché la pretesa dell’Ufficio è infondata o eccessiva. Un atteggiamento collaborativo e tecnicamente solido può convincere l’Ufficio a rivedere almeno parzialmente la sua posizione. Molti funzionari preferiscono chiudere in adesione evitando l’incertezza del giudizio, purché abbiano elementi per giustificare l’atto modificato. Ad esempio, se mostrate contratti e documenti che in verifica non erano stati visti, l’Ufficio potrebbe riconoscere l’inerenza di alcuni costi inizialmente ripresi.
Va detto però che su questioni di principio (es. l’Ufficio è convinto che l’auto di lusso non sia deducibile), spesso la posizione è rigida e solo il giudice terzo potrà dirimere.
Il processo tributario: primo e secondo grado
Se non si definisce prima, occorre presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) entro il termine utile. Il ricorso va notificato all’ente impositore e poi depositato, anche tramite il portale telematico. Da quel momento si instaura il contenzioso vero e proprio.
Il processo di primo grado in tema di inerenza ruoterà intorno:
– alle prove documentali che le parti produrranno (il contribuente dovrebbe allegare già al ricorso tutte le prove a suo favore, l’ufficio allegherà suo fascicolo con PVC, copie fatture esaminate, ecc.);
– alle argomentazioni giuridiche sul concetto di inerenza e onere della prova (ciò che abbiamo ampiamente trattato).
Il giudice tributario deciderà in base a quanto risulta dagli atti e dall’eventuale udienza di discussione (il processo tributario è in buona parte scritto). Dal 2023, su istanza di parte, le udienze possono essere svolte da remoto o in presenza, e in alcuni casi possono essere omesse se le parti rinunciano a discutere. Ma per temi complessi come questo, è utile discutere per enfatizzare alcuni aspetti di fronte al collegio.
Prove ammissibili e recenti sviluppi
Come accennato, oggi è finalmente possibile, in casi particolari, ricorrere a testimonianze scritte. Se avete un teste chiave (es: un cliente che conferma che quell’evento rappresentanza ha portato affari) potete chiedere al giudice di ammettere deposizione scritta. Il giudice valuterà se la reputa indispensabile. È uno strumento nuovo, pertanto la giurisprudenza applicativa è scarsa. Non c’è garanzia venga ammessa. In ogni caso, il grosso della causa lo fanno i documenti. E’ quindi cruciale depositare tutto ciò che volete sia considerato.
Attenzione: se nella fase pre-contenziosa avete mostrato documenti all’Ufficio, ma non li avete poi depositati in ricorso, il giudice non li conoscerà (il processo in CT è chiuso negli atti: non è automatico che ciò che avete dato all’AdE arrivi al giudice). Dunque, assicuratevi di allegare al ricorso (o comunque entro i termini processuali) tutti i documenti rilevanti. Solo le fatture elettroniche (come detto) fanno eccezione: sono considerate già esibite perché note al Fisco, quindi paradossalmente potete produrle anche in corso di causa se l’Ufficio le aveva e non le ha allegate, senza incorrere in inammissibilità . Ma per evitare rischi, meglio prevenire e mettere tutto dall’inizio.
Il primo grado si conclude con una sentenza, che può: accogliere totalmente il ricorso (annullando l’atto), accoglierlo parzialmente (es. annullare solo una parte delle riprese e confermare il resto), oppure rigettarlo (convalidando l’intero operato del Fisco). Nelle controversie su costi, spesso si vedono esiti intermedi: ad esempio, la Commissione riconosce come inerenti alcune spese e non altre, oppure riduce le sanzioni se c’erano margini di incertezza.
Chi risulta soccombente (perdente) in primo grado può appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale). L’appello va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. In appello non si possono introdurre nuovi documenti salvo circostanze eccezionali; perciò è un giudizio focalizzato su eventuali errori del primo e su diversa valutazione delle prove già fornite. Se avete trascurato di depositare prove in primo grado, difficilmente potrete rimediare in appello (a meno che motiviate che non ne eravate in possesso prima senza colpa). Quindi, la preparazione dev’essere massima già nel ricorso iniziale.
Nel nostro ambito, l’appello spesso viene proposto dall’Ufficio se perde in primo grado: l’Agenzia è combattiva su certe questioni di principio e porta avanti la causa fino in Cassazione, specie se teme l’effetto di precedenti sfavorevoli. Anche il contribuente ovviamente appellerà se ritiene di avere ragione sugli aspetti non accolti.
Giudizio di legittimità in Cassazione
Dopo il secondo grado, resta la Corte di Cassazione come ultimo giudice, ma solo per motivi di diritto (interpretazione di norme, vizi di motivazione gravi). La Cassazione non rivede i fatti né valuta nuove prove: si occupa di uniformare l’interpretazione. Nel nostro tema, la Cassazione ha avuto un ruolo fondamentale nel definire l’inerenza qualitativa, come visto. Spesso avvisi di accertamento su costi arrivano fino in Cassazione, producendo quelle ordinanze che abbiamo citato.
Come contribuente, arriverete in Cassazione se avete perso nei gradi di merito ma ritenete che ciò sia dipeso da un’erronea interpretazione del concetto di inerenza o dell’onere della prova. Ad esempio, se il giudice di appello ha negato deducibilità di un costo solo perché “antieconomico”, in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte, questo può essere valido motivo di ricorso in Cassazione per violazione di legge . Oppure se il giudice ha invertito l’onere della prova rispetto a come delineato dalla legge (anche se, come detto, in pratica il contribuente deve sempre provare, ma se vi fossero pronunce creative, la Cassazione può correggerle).
Va detto però che arrivare in Cassazione significa tempi lunghi (diversi anni) e costi ulteriori; per importi modesti forse non conviene. Spesso conviene cercare di chiudere prima, anche valutando strumenti straordinari come la conciliazione giudiziale.
Conciliazione giudiziale e definizione agevolata
Nel corso del processo, le parti possono sempre trovare un accordo transattivo: nel processo tributario esiste l’istituto della conciliazione giudiziale, sia in primo sia in secondo grado. Le sanzioni in caso di conciliazione sono ridotte (al 1/3 del minimo se si concilia in primo grado, 1/2 in appello). Se vi rendete conto che la causa è incerta e l’importo in gioco elevato, potrebbe essere saggio proporre all’Ufficio una conciliazione. Ad esempio, se avete 100k € di imposte in ballo, potreste offrire di pagarne 60k ed evitare rischi ulteriori. L’Agenzia spesso accetta in corso di giudizio se teme di perdere su tutto, oppure se ha troppe cause arretrate e c’è una circolare interna che incentiva a conciliare. Dovrete comunque convincerli che la vostra posizione ha qualche merito, altrimenti aspetteranno la sentenza.
Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto anche misure di definizione agevolata delle liti pendenti (cosiddetto “condono liti”): ad esempio, nel 2023 la L. 197/2022 ha permesso di chiudere le cause tributarie pagando un importo ridotto a seconda dell’esito (100% se perso in primo grado, 40% se vinto in primo grado, ecc.). Queste sono opportunità da cogliere se capitano, per chiudere contenziosi annosi su cui non si vuole più investire tempo e denaro, ottenendo uno sconto sulle sanzioni o sul merito. Bisogna però aspettare che il governo le riproponga (nel 2025 non sappiamo se ci sarà un’altra tornata di pacificazione).
Esecutività e riscossione: un elemento da non scordare è che l’avviso di accertamento, trascorsi 60 giorni senza ricorso né adesione, diventa esecutivo. Significa che l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme e l’Agente della Riscossione può attivarsi per il recupero coattivo. Se fate ricorso, potete chiedere la sospensione dell’atto impugnato, presentando un’istanza motivata di sospensione all’organo giudicante (o all’AdE in sede di reclamo). Dovete dimostrare sia il fumus boni juris (ragioni fondate nel ricorso) sia il periculum in mora (danno grave e irreparabile se doveste pagare subito). Nel caso di costi dedotti, se l’importo è alto potrebbe essere un problema per la liquidità dell’azienda pagare prima di sapere se vincerete; conviene dunque chiedere sospensione. Le Corti spesso concedono la sospensione almeno parziale se vedono che la pretesa non è chiaramente dovuta o c’è rischio per l’azienda. In mancanza, dovrete pagare 1/3 delle imposte contestate entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (gli altri 2/3 sono sospesi in attesa del giudizio di primo grado). Se poi perdete in primo grado, dovete versare un ulteriore importo fino a 2/3 del totale per proseguire. Se vincete, vi rimborsano quanto eventualmente pagato.
Tutto ciò per dire che la gestione finanziaria del contenzioso è un altro aspetto: valutare costi/benefici, rischio di aggravio (le sanzioni raddoppiano se perdete in Cassazione su reati penali tributari, ma su inerenza di solito si resta nel 90%).
Durata del processo: con le riforme la giustizia tributaria dovrebbe esser più celere, ma realisticamente un primo grado può durare 1-2 anni, appello altri 1-2 anni, Cassazione 2-3 anni. Quindi mettete in conto tempi lunghi. Questo impatta su strategie: se siete nel giusto conviene resistere, se siete al limite può convenire accordarsi per chiudere prima e togliere il pensiero.
Infine, cosa succede se perdete definitivamente: dovrete pagare imposte, interessi (circa 3-4% annuo), sanzioni (che però magari avete ridotto se avete fatto adesione, conciliazione o definizione). Attenzione che se l’imposta evasa (dal costo indeducibile) supera certe soglie (€100k di imposta evasa e 10% del dichiarato) c’è il rischio di penale tributaria per dichiarazione infedele. In molti casi di costi indebiti, però, le soglie penali non si superano (perché l’imposta evasa su singoli costi è modesta). Ma se capitasse, la definizione tributaria non estingue il penale, a meno di condoni penali specifici. Valutate quindi anche il profilo penale con un legale se siete in situazioni di grandi importi di costi disconosciuti (es. milioni di euro di fatture false dedotte).
Ricapitolando, il processo tributario è un percorso a ostacoli dove conta arrivare preparati: i fatti (prove dell’inerenza) e il diritto (norme e sentenze a vostro favore) devono essere esposti con chiarezza sin dal primo grado, e aggiornati nei motivi di appello se necessario. Conviene inoltre sfruttare ogni occasione di accordo bonario quando il caso non è totalmente a vostro favore – pagare qualcosa con sanzione ridotta può essere meglio che rischiare di pagare tutto con sanzione intera più spese legali.
Per avere uno schema visuale, ecco una tabella di sintesi del percorso contenzioso e strumenti:
<table> <thead> <tr><th>Fase / Strumento</th><th>Descrizione</th><th>Vantaggi per il contribuente</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verifica & PVC (GdF)</td> <td>Accesso in azienda, controllo conti, rilievi su costi non inerenti nel PVC.</td> <td>Possibilità di chiarire subito dubbi ai verificatori; fornire documenti integrativi prima che formalizzino rilievi (spesso efficace).</td> </tr> <tr> <td>Invito a contraddittorio (AdE)</td> <td>Prima di accertamento, AdE può invitare a fornire spiegazioni su costi anomali.</td> <td>Presentare memorie, spiegare l’inerenza e magari evitare l’atto o ridurne la portata mostrando collaborazione.</td> </tr> <tr> <td>Avviso di accertamento</td> <td>Atto impositivo che recupera a tassazione i costi indeducibili. Dettaglia anni, imposte, sanzioni, motivazioni.</td> <td>Termine 60 gg per reagire; leggere attentamente motivazione (es. richiami a PVC) per impostare difesa mirata. Nessun pagamento immediato se si fa ricorso entro termini (solo 1/3 dopo, salvo sospensioni).</td> </tr> <tr> <td>Autotutela (entro 60 gg)</td> <td>Istanza di annullamento/riesame volontario da parte AdE.</td> <td>Può risolvere velocemente se c’è un errore palese nell’accertamento. Non sospende termini, ma utile tentare parallelamente.</td> </tr> <tr> <td>Accertamento con adesione (istanza entro 60 gg)</td> <td>Procedura di accordo: incontri con Ufficio, sospende termini per 90 gg.</td> <td>Possibilità di negoziare: esporre prove integrative, ottenere riduzione sanzioni 1/3. Si evita il giudizio se accordo raggiunto.</td> </tr> <tr> <td>Reclamo-mediazione (per importi minori)</td> <td>Ricorso iniziale trattato come reclamo: proposta di mediazione all’AdE stessa.</td> <td>Chance di accordo con sanzioni ridotte 35% (normativa 2023) senza andare in giudizio. Obbligatorio tentare se valore <= soglia (50k/100k).</td> </tr> <tr> <td>Ricorso 1° grado (CGT provinciale)</td> <td>Atto introduttivo del processo tributario. Affermazioni e prove a sostegno.</td> <td>Esponi per iscritto tutta la tua difesa. Puoi chiedere sospensione esecuzione (stop riscossione). Giudice terzo esamina ex novo.</td> </tr> <tr> <td>Conciliazione giudiziale (anche in primo grado)</td> <td>Possibilità di accordo durante il processo (fino a sentenza) su proposta parte o giudice.</td> <td>Sanzioni ridotte (1/3 in primo grado). Flessibilità: puoi chiudere anche solo parte delle contestazioni se convenuto.</td> </tr> <tr> <td>Sentenza di 1° grado</td> <td>Decisione collegiale (3 giudici) su merito e spese.</td> <td>Se favorevole, chiude questione (salvo appello AdE). Se sfavorevole, dà motivazioni utili per tarare appello.</td> </tr> <tr> <td>Appello 2° grado (CGT regionale)</td> <td>Riesame su quanto deciso. Non si possono produrre nuove prove salvo eccezioni.</td> <td>Corregge errori di giudizio del primo grado. Sanzioni eventualmente ridotte a metà se conciliazione in appello.</td> </tr> <tr> <td>Sentenza 2° grado</td> <td>Decide sull’appello; se nessuno ricorre oltre, diventa definitiva.</td> <td>Può ribaltare l’esito o confermarlo. Se favorevole a contribuente e AdE non ricorre, vittoria finale.</td> </tr> <tr> <td>Ricorso in Cassazione</td> <td>Ultimo grado (motivi di diritto). Nessuna sospensione automatica esecutività sentenza impugnata (va chiesta al giudice appello o Cassazione).</td> <td>Uniforma interpretazione: utile se in gioco principi controversi (es. interpretazione inerenza vs antieconomicità, onere prova). Tempi lunghi, ma può annullare decisioni errate in diritto.</td> </tr> <tr> <td>Definizione agevolata liti (se prevista da legge)</td> <td>Condono della lite pagando percentuale imposta e sanzioni ridotte, in base a stato del giudizio.</td> <td>Chiude rapidamente col contenzioso, risparmiando su sanzioni e interessi. Valutare se conviene in base a probabilità vittoria e costo sanzioni piene.</td> </tr> </tbody> </table>
Costi del contenzioso
Un aspetto conclusivo da valutare “dal punto di vista del debitore” è il costo stesso di intraprendere la difesa: spese legali (onorari dell’avvocato tributarista o commercialista abilitato), eventuali consulenze tecniche (perizie di parte se servono a dimostrare qualcosa), il contributo unificato da pagare per il ricorso (commisurato al valore della lite: es. 30€ fino a 3k€, 60€ fino 26k€, 120€ fino 52k€, 250€ fino 260k€, etc.), e il tempo/risorse da dedicare. Se l’importo contestato è relativamente basso, conviene fare bene i conti: a volte pagare e chiudere il debito conviene più che spendere il doppio in avvocati e attese. Fortunatamente, per liti piccole il sistema del reclamo mediazione e la possibilità di definire con sanzioni minime offrono soluzioni poco dispendiose.
Diverso se la questione di inerenza ha ampio impatto (magari un principio che riguarda più anni o un contenzioso che farebbe giurisprudenza utile per l’azienda). In tal caso, investire nella difesa è doveroso.
Ricordarsi infine che, in caso di soccombenza in giudizio, il giudice può condannare la parte perdente al pagamento delle spese di lite a favore della controparte (di solito liquidate secondo parametri forensi). Se perdete, oltre a imposte e sanzioni, potreste dover pagare qualche migliaio di euro di spese all’Agenzia. Se invece vincete totalmente, di regola avrete diritto voi a un rimborso spese (non sempre automaticamente: il giudice può compensarle in caso di novità giurisprudenziale o incertezza). Nell’ordinanza Cass. 13043/2024 ad esempio l’Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio perché ha perso .
Con questo panorama processuale delineato, passiamo ora a una sezione più discorsiva di Domande e Risposte per fissare i concetti in forma breve e applicativa.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa significa in concreto che un costo sia “inerente all’attività”?
R: Significa che la spesa deve avere un nesso diretto con l’attività economica esercitata, ossia dev’essere sostenuta nell’interesse dell’impresa o della professione, per lo svolgimento, il mantenimento o lo sviluppo della stessa. Non è necessario che generi un ricavo specifico, basta che sia funzionale all’attività in senso lato (anche come investimento per il futuro o per esigenze organizzative) . Ad esempio, la bolletta dell’energia elettrica dello stabilimento è inerente perché senza corrente non produci; una sponsorizzazione può essere inerente perché mira a far conoscere il tuo marchio (beneficio potenziale futuro). Viceversa, una spesa è non inerente se afferisce alla sfera personale del titolare (es. vacanza personale pagata coi fondi aziendali) o a finalità estranee (es. donazione benefica fatta dall’azienda, che per il fisco non ha scopo di produrre reddito). In sintesi: è inerente ciò che appartiene alla sfera dell’impresa, non ciò che ne è fuori.
D: L’Agenzia può contestare un costo solo perché “antieconomico”, ossia troppo elevato rispetto all’utilità?
R: Da sola, l’antieconomicità (spesa sproporzionata ai ricavi) non basta a negare la deducibilità . L’antieconomicità può far sorgere il sospetto di non inerenza e giustificare un’indagine più approfondita . Ma se il contribuente dimostra che, nonostante il costo alto, c’era un motivo imprenditoriale valido (anche solo strategico o potenziale) e fornisce riscontri, la spesa rimane deducibile. Per esempio, se spendi molto in pubblicità e quell’anno le vendite non aumentano, l’ufficio non può disconoscere quel costo solo perché non “ha reso”: dovrà accettarlo come inerente se era ragionevolmente finalizzato all’attività. Diverso il caso in cui la spesa antieconomica nasconda un costo fittizio o personale: lì l’antieconomicità è sintomo di altro (frode, distrazione di utili) e porta a disconoscere il costo perché non vero o non inerente, non per il mero importo eccessivo . In pratica: un costo può essere alto e deducibile, ma se è assurdo dovrai giustificarlo meglio per vincere le resistenze del Fisco.
D: In caso di contestazione, chi deve provare l’inerenza o la non inerenza?
R: Spetta al contribuente provare che la spesa è inerente e che è stata effettivamente sostenuta . Il Fisco deve inizialmente motivare perché la considera non inerente (ad esempio, “manca documentazione” oppure “non attiene all’oggetto sociale” ecc.), ma una volta sollevata la questione, è onere del contribuente fornire la documentazione e le spiegazioni che dimostrino il collegamento tra costo e attività . Il nuovo art. 7, c.5-bis del processo tributario non ha invertito questo principio di base : l’Amministrazione deve portare elementi per sostenere la ripresa, ma se lo fa (anche solo indizi), rimane al contribuente l’onere di controbattere con prove contrarie . Quindi in concreto, nel processo tu contribuente devi arrivare con le carte in mano a dimostrare ogni costo; se non lo fai, quasi certamente perderai la causa e il costo sarà dichiarato indeducibile.
D: Quali prove posso portare per dimostrare che un costo è inerente?
R: Prima di tutto le fatture e i documenti contabili che attestano il costo (registrazioni, pagamenti). Poi, fondamentale, tutto ciò che collega quella fattura all’attività: contratti (es. contratto di consulenza, da cui si vede l’oggetto e lo scopo), rapportini (es. DDT per merce consegnata a un cantiere specifico), corrispondenza (email con cui si ordinava il bene/servizio per esigenze aziendali), relazioni o elaborati prodotti a fronte della spesa (es. il report della società di marketing che hai pagato). Anche elementi esterni: per esempio, per un pranzo di lavoro, potresti allegare una email del giorno in cui invitavi il cliente o una successiva in cui fate riferimento all’incontro avuto. Per una trasferta, i biglietti dell’evento fiera a cui hai partecipato. Insomma, devi documentare il “contesto” del costo . Se restano zone d’ombra, oggi hai anche la possibilità di testimoni scritti: ad esempio, una dichiarazione firmata dal cliente che conferma che eri da lui in trasferta tal giorno per motivi d’affari. Il giudice potrebbe ammetterla come prova (è una novità, va chiesta espressamente). Inoltre, è importante produrre eventuali norme di settore o prassi che spieghino il costo: ad esempio, se operi in un campo dove è prassi offrire certi benefit ai clienti, un documento associativo o articolo di rivista di settore potrebbe corroborare che quella spesa è usuale (quindi inerente) nel tuo business. Infine, portare giurisprudenza (sentenze di Cassazione) favorevole al tuo caso può aiutare sul piano giuridico: es. citare la frase “anche ciò che non reca vantaggio economico immediato è costo inerente” per contrastare un’eccezione dell’ufficio sull’utilità. In sintesi: più prove, meglio. Preparati un dossier per ogni voce contestata.
D: L’Ufficio mi contesta costi per difetto di inerenza basandosi sul fatto che nel mio oggetto sociale non c’è quell’attività (o dice che la spesa non rientra nelle mie attività dichiarate). Può farlo?
R: L’oggetto sociale (per le società) o il campo di attività dichiarato (per ditte individuali) è un elemento indicativo ma non vincolante in assoluto per la deducibilità. Se sostieni un costo per un’attività collaterale che, pur non essendo esplicitamente nell’oggetto sociale, è comunque finalizzata a far guadagnare l’impresa, quel costo può essere inerente. Ad esempio, una società immobiliare che fa una sponsorizzazione sportiva: nell’oggetto non c’è lo sport, ma lo fa per farsi pubblicità, quindi c’è attinenza economica. Certo, se l’attività è radicalmente fuori dallo scopo (una SRL che si occupa di software e acquista una barca da diporto: è difficile sostenere che inerisce a software), il Fisco contesterà. Dovrai allora provare un nesso (la barca la uso per incontrare clienti top? Rischioso come argomento). In generale, l’assenza dal oggetto sociale non preclude deduzione se dimostri che quella spesa era comunque finalizzata a produrre reddito per la società . La Cassazione in più casi ha dato ragione ai contribuenti su questo, dicendo che conta la funzione economica del costo, non la coerenza letterale con l’oggetto scritto nello statuto . Ovviamente, se l’attività extra diventa sistematica, faresti bene a aggiornare l’oggetto sociale per evitare discussioni. Per le imprese individuali, l’analogo è la dichiarazione di attività all’Agenzia: se sei iscritto come “commercio abbigliamento” e deduci costi per “servizi di ristorazione”, suonerà strano. Potresti svolgere due attività (negozio + catering)? Sì, ma avresti dovuto dichiararle. Se non l’hai fatto, in contenzioso dovrai spiegare che quell’attività accessoria era comunque connessa (es. organizzavi rinfreschi per promuovere il negozio). Diciamo che inerenza implica coerenza economica, non burocratica: però se c’è incoerenza burocratica, il sospetto di mancanza di inerenza aumenta.
D: È vero che le spese per l’abbigliamento (vestiti) del professionista non sono deducibili?
R: Nella generalità dei casi, no, non sono deducibili perché considerate spese di natura personale, anche se attinenti al decoro professionale. La giurisprudenza recente (CTR Veneto 177/2023) ha escluso la deducibilità dei vestiti “generici” per il professionista, affermando che non basta dire che servono a fare bella figura . Fanno eccezione gli indumenti da lavoro tecnico (es. camice per un medico, toghe per avvocato, divise, DPI) che sono strumenti necessari: questi sono inerenti al 100% . In passato c’è stato un caso (CTP Milano 2016) in cui fu ammessa deducibilità 50% per abiti di rappresentanza, trattandoli come costi promiscui . Ma è un precedente isolato e pre-riforma; attualmente prevale la linea dura: l’abito elegante, l’orologio di lusso, la borsa di marca, anche se aiutano l’immagine del professionista, sono visti come esigenze personali non indispensabili e quindi costi non inerenti . L’unica strada per provare a dedurli sarebbe dimostrare che quei capi sono usati esclusivamente in occasioni di lavoro e non altrove (ma chi può provare che non indossi l’abito anche a una cena privata?). Alcuni suggeriscono di trattarli come costo promiscuo con deduzione parziale , ma è comunque rischioso. Quindi la prudenza consiglia: vestiti, trucco, parrucchiere, etc., no deduzione – salvo casi come costume di scena per artisti, o abbigliamento tecnico come detto. Meglio non sfidare l’Agenzia su questo fronte.
D: Se perdo in commissione tributaria la causa sui costi indeducibili, rischio anche conseguenze penali?
R: Dipende dall’entità dell’imposta evasa per via di quei costi indebitamente dedotti. La contestazione di costi non inerenti configura in genere una dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se l’imposta evasa supera €100.000 e il reddito sottratto a tassazione supera il 10% di quello dichiarato (con minimo €2 milioni). Facciamo un esempio: avevi dedotto €500k di costi non inerenti, l’ufficio li toglie e genera €140k di maggior imposta accertata. Sei sopra €100k, quindi potenzialmente è reato di dichiarazione infedele. Tuttavia, l’avvio o meno del penale dipende da vari fattori: se l’Agenzia aveva trasmesso la notizia di reato alla Procura (di solito lo fanno a fine verifica se vedono i limiti superati) oppure se la superi solo a consuntivo in sentenza. In genere, se la vicenda è controversa (es. inerenza è concetto interpretativo), non c’è dolo specifico di evasione come in altri reati (tipo fatture false). La dichiarazione infedele richiede la consapevolezza di indicare dati falsi. Un imprenditore può dire “io pensavo sinceramente che quei costi fossero deducibili”. Questa linea può evitare sanzioni penali se manca il dolo. In pratica, casi penali per inerenza sono rari e spesso archiviati se il contribuente ha tenuto documenti regolari e la questione è tecnica. Più insidioso è se i costi contestati in realtà erano fittizi (inesistenti): allora il reato può essere dichiarazione fraudolenta con fatture false (limite più basso, € 50k imposta, punito severamente). Ma lì si parla di fatture false, non semplicemente di inerenza. Se i costi erano reali ma non inerenti, al massimo infedele. In conclusione: se la somma è grossa, una denuncia potrebbe scattare; conviene attivarsi con un avvocato penalista per spiegare la buona fede. Inoltre, pagando il debito col fisco, per l’infedele c’è causa di non punibilità se versato intero il dovuto prima del dibattimento. Quindi, qualora vi fosse un penale, si può rimediare pagando (depenalizzazione per importi fino a 200k imposta, se fatto prima dibattimento).
D: Un costo indeducibile comporta anche IVA indetraibile?
R: In linea di massima sì: se una spesa non è inerente all’attività, l’IVA su di essa non spetta in detrazione (perché per detrarre IVA l’acquisto dev’essere effettuato “nell’esercizio dell’impresa o professione” secondo le norme IVA). Quindi spesso gli accertamenti contestano sia il maggior reddito per costi indeducibili sia la ripresa a tassazione dell’IVA detratta su quei costi. Esempio: deduci fattura €10.000+IVA, l’ufficio la toglie: ti chiederà 10k tassazione diretta e 2,2k di IVA da restituire, con relative sanzioni (e interessi). Ci sono casi particolari: se il costo è parzialmente inerente (es. auto al 20% deducibile) allora l’IVA è detraibile 40%. Se l’ufficio ti nega inerenza al 100%, negherà IVA 100%. Tu puoi controbattere che al limite era uso promiscuo (quindi 40% andava bene), cercando di salvare almeno quella. L’importante è non dimenticare l’IVA: va difesa parallelamente. Nota: l’IVA segue criteri UE, a volte leggermente diversi sulla nozione di inerenza (neutralità IVA). Ma la Cassazione ha detto che se un’operazione è manifestamente antieconomica o estranea, il contribuente deve provare la destinazione reale all’attività per detrarre l’IVA . Quindi per semplificare: costo non inerente = IVA indetraibile; vanno insieme. In difesa, se il giudice tributario riconosce la deducibilità del costo, automaticamente dovrà riconoscere anche la detraibilità IVA correlata (o viceversa, se neghi deduzione neghi IVA).
D: Cosa posso fare per prevenire contestazioni su inerenza?
R: Ecco alcuni consigli ex ante:
– Pianificazione e consulenza: confrontati con un commercialista prima di sostenere spese atipiche. Valuta con lui la deducibilità, i limiti e come documentarle. Ad esempio, se vuoi fare un evento marketing, il consulente ti dirà di preparare una relazione, di fare fatture separate per la parte conviviale (75%) e quella promozionale pura, ecc.
– Regole interne: se hai dipendenti, adotta policy per uso auto, note spese, omaggi, cosicché ci sia traccia autorizzativa e limite (es. “cena di lavoro max 50€/persona” – se poi in verifica vedono rispettati i limiti, appare tutto più consono).
– Contabilità separata: tieni distinti i conti di spesa per categoria (auto, rappresentanza, trasferta…). Questo aiuta a monitorare i plafond (non sforare) e a fornire in caso di controllo situazioni chiare.
– Documenta subito: non aspettare la verifica per raccogliere pezze. Ogni volta che fai una spesa importante, archivia insieme alla fattura anche i documenti giustificativi (contratto, email, foto dell’evento). Oggi in era digitale, potresti anche scrivere due righe e salvarle: es. “Cena del 15/09 con ing. Rossi di Alfa SpA per negoziazione contratto X, costo 200€”. Queste note, anche se auto-prodotte, se dettagliate e credibili possono essere esibite a supporto.
– Evita commistioni: non far pagare all’azienda cose tue personali. Se proprio vuoi usare l’auto societaria la domenica, metti un fringe benefit e paga le tasse su quel benefit; se fai un viaggio di famiglia, non mescolare le carte con viaggi di lavoro. Più sei pulito, meno appigli dai.
– Aggiornati sulle norme: ad esempio ora dal 2025 per rappresentanza serve pagamento tracciato: se non lo sapevi e pagavi in contanti, ti creerai un problema evitabile. Quindi segui le circolari, le novità (magari iscriviti a newsletter fiscali come FiscoOggi dell’Agenzia o riviste di settore). In materia tributaria, essere informati è la prima difesa.
D: In sintesi, quali sono i punti chiave da ricordare se l’Agenzia contesta spese come non inerenti?
R: Riassumiamo i punti chiave:
1. Valuta il fondamento: chiediti onestamente se la spesa è davvero aziendale o se il Fisco ha (in parte) ragione. Se hai forzato la mano su qualcosa di personale, considera di trovare un accordo (adesione) prima che esploda anche il penale o sanzioni alte. Se invece sei convinto della bontà, preparati a combattere.
2. Onere della prova tuo: raccogli tutte le prove possibili e organizza le argomentazioni. Non aspettare che “siano loro a provare che non c’entra” – questo non avverrà. Devi essere proattivo .
3. Chiedi contraddittorio: usa l’adesione o reclamo per presentare memoria difensiva dettagliata. A volte risolvi prima, o comunque prepari il terreno per il giudizio.
4. Focus su documentazione: la causa si vince sui documenti. Meglio avere 10 allegati in più che uno in meno. Se qualcosa non è stato esibito in verifica, spiegane il perché e tiralo fuori appena possibile.
5. Strategia processuale: nel ricorso evidenzia eventuali errori di metodo dell’accertamento (motivazione carente? Hanno copiato il PVC senza valutazione propria? – Puoi eccepirlo ). Sottolinea la giurisprudenza di Cassazione a supporto (ce ne sono diverse pro contribuente come abbiamo visto). Sfrutta anche la carta della non retroattività art.7 c5-bis: se l’atto è pre-2022, blocca eventuali tentativi dell’Ufficio di dire che spetta a te in toto l’onere (in realtà anche post-2022 spetta a te, ma pre-2022 sicuramente sì; comunque quell’articolo non ti aiuta granché se non come argomento teorico, perché anche i giudici oggi dicono che non ha cambiato la sostanza ).
6. Valuta conciliazione: se in giudizio emergono segnali negativi (es. il giudice è ostile su certe posizioni), prova a trattare una chiusura, magari pagando solo una parte o togliendo le sanzioni. Meglio a volte un male minore certo che una possibile vittoria in Cassazione 5 anni dopo.
7. Impara per il futuro: infine, comunque vada, fai tesoro della vicenda. Se alcuni costi li hai persi perché non inerenti, saprai di non ripetere l’errore; se li hai salvati, continuerai ma sapendo come motivarli. Le verifiche fiscali, per quanto dure, insegnano molto su come gestire l’azienda in modo più compliance.
Con queste risposte, speriamo di aver chiarito i dubbi più frequenti.
Conclusione
Le contestazioni relative a spese dedotte e ritenute non inerenti sono tra le più insidiose, perché toccano la zona grigia delle scelte imprenditoriali e della libertà del contribuente di gestire i propri costi. Si è visto come l’evoluzione normativa e giurisprudenziale abbia delineato confini più netti: l’inerenza è un concetto qualitativo, che richiede un collegamento con l’attività, ma non impone un giudizio sull’efficacia o sul profitto ottenuto . Ciò ha dato maggior tutela ai contribuenti su spese atipiche ma strategiche. Tuttavia, parallelamente, l’onere della prova in capo al contribuente è rimasto stringente e la documentazione è regina incontrastata delle cause tributarie .
Dal punto di vista del debitore d’imposta, la miglior strategia è giocare d’anticipo: conoscere le norme (plafond e limiti deducibilità), tenere la contabilità in ordine separando ciò che è personale da ciò che è aziendale, e predisporre sin da subito evidenze a supporto delle spese dubbie. Quando l’accertamento arriva, occorre mantenere un atteggiamento collaborativo ma fermo sui propri diritti, presentando in sede amministrativa tutte le ragioni e, se necessario, proseguendo nel contenzioso con determinazione.
I giudici tributari oggi hanno a disposizione nuovi strumenti (testimonianza, definizioni più ampie dell’onere probatorio) e soprattutto un corposo orientamento giurisprudenziale di legittimità che funge da guida: nella nostra trattazione abbiamo citato diverse sentenze recenti – dal 2018 al 2025 – che costituiscono riferimenti fondamentali per l’impostazione di ogni difesa in tema di inerenza (Cass. 2019 n.30366, Cass. 2021 n.6368, Cass. 2022 n.33568, Cass. 2024 nn.6114 e 13043, Cass. 2025 n.23095 in arrivo ecc.). Conoscere e richiamare tali precedenti può fare la differenza nell’esito del giudizio, orientando la Commissione verso una corretta applicazione del principio (ad esempio, evitando arbitrarie valutazioni di merito sull’utilità delle spese e concentrandosi sul nesso qualitativo).
Non va poi dimenticato l’aspetto procedurale: molte contestazioni potrebbero essere risolte in sede di contraddittorio preventivo o di adesione, risparmiando tempo e sanzioni. Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate ha l’interesse a chiudere le controversie più deboli in mediazione, concentrandosi sui casi di reale abuso. Far emergere in quella sede la bontà della propria posizione – attraverso memorie ben costruite e documentate – spesso evita di dover arrivare davanti al giudice.
In conclusione, “come difendersi” efficacemente in materia di costi indeducibili per difetto d’inerenza si può riassumere in: conoscenza, preparazione e prontezza. Conoscenza delle regole (sapere cosa è deducibile e come), preparazione delle prove (dossier chiaro per ogni spesa) e prontezza nel far valere i propri diritti in ogni fase (non subire passivamente la contestazione, ma rispondere colpo su colpo, supportati se necessario da consulenti esperti). Seguendo questo approccio, si massimizzano le chance di successo, ovvero di vedere riconosciute in sede fiscale quelle spese che effettivamente sono state sostenute nell’interesse dell’attività e che, giustamente, il contribuente ha ritenuto di dedurre dal proprio reddito.
In un sistema tributario complesso come il nostro, la linea tra legittimo risparmio d’imposta e abuso può essere sottile: questa guida ha cercato di fornire gli strumenti interpretativi e pratici per distinguere le due ipotesi e per far valere le proprie ragioni quando ci si colloca nel giusto. Difendersi è possibile e spesso doveroso: armati di buona fede, documenti e delle giuste argomentazioni, il contribuente può far valere la verità sostanziale delle proprie operazioni contro presunzioni e automatismi. Come affermato in una recente sentenza: “le spese vanno riferite all’esercizio dell’impresa escludendo ciò che è estraneo, senza aprioristiche valutazioni di utilità, spettando al contribuente dimostrarne la concreta destinazione all’attività” . Questa frase riassume la sfida: focalizzarsi sulla destinazione concreta (che noi conosciamo meglio di chiunque, essendo i nostri affari) e saperla dimostrare. Vincere la sfida significherà veder riconosciuto il sacrosanto principio che tutte le spese effettivamente sostenute per produrre il reddito devono ridurre il reddito imponibile, in ossequio al principio di capacità contributiva e di corretta determinazione del reddito netto.
Fonti: Normativa: D.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 54, 109; D.M. 19/11/2008; L. 130/2022. Prassi: Circolare AdE 53/E/2008; Risoluzione AdE 113/E/2012. Giurisprudenza: Corte Cost. 262/2020; Cass. civ. Sez. V nn. 450/2018, 3170/2018, 15860/2018, 30366/2019, 18904/2018, 6368/2021 , 33568/2022 , 6114/2024 , 13043/2024 , ord. 28724/2024 , ord. 23095/2025; CTR Veneto 177/2023 ; C.G.T. Lazio 7241/2024 ; ecc. (v. note). Questa guida riflette lo stato dell’arte aggiornato ad agosto 2025, ma si raccomanda di monitorare future evoluzioni normative o giurisprudenziali in materia di inerenza dei costi.
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta spese dedotte ritenute non inerenti all’attività? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta spese dedotte ritenute non inerenti all’attività?
Vuoi sapere quali rischi corri e come puoi difenderti da queste contestazioni?
Il principio di inerenza stabilisce che un costo è deducibile solo se strettamente collegato all’attività d’impresa o professionale e finalizzato alla produzione di reddito. Quando il Fisco ritiene che una spesa sia personale, sproporzionata o non giustificata, la disconosce come costo deducibile, con recupero di imposte e applicazione di sanzioni.
👉 Prima regola: documenta sempre le spese e dimostra il loro collegamento concreto con l’attività.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Spese di viaggio, vitto e alloggio ritenute personali;
- Acquisti di beni e servizi di lusso non proporzionati all’attività;
- Spese di rappresentanza non documentate o eccedenti i limiti;
- Compensi a consulenti o collaboratori senza giustificazione contrattuale;
- Costi intestati ai soci o amministratori ma registrati come aziendali.
📌 Conseguenze della contestazione
- Indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette;
- Recupero dell’IVA detratta sulle fatture contestate;
- Sanzioni per dichiarazione infedele;
- Interessi di mora;
- Rischio di ulteriori controlli su altre voci di spesa.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Connessione economica della spesa con l’attività esercitata;
- Documentazione probatoria: contratti, fatture dettagliate, report di utilizzo;
- Congruità dei costi rispetto al volume e al tipo di attività;
- Motivazione della contestazione: l’Agenzia deve provare perché considera la spesa non inerente;
- Eventuali precedenti giurisprudenziali favorevoli in casi simili.
🧾 Documenti utili alla difesa
- Fatture, ricevute e quietanze;
- Contratti e ordini collegati all’acquisto;
- Relazioni tecniche e report sull’utilizzo del bene/servizio;
- Documenti che dimostrino la finalità aziendale (es. partecipazione a fiere, eventi, sponsorizzazioni);
- Comunicazioni interne ed esterne che provano l’inerenza.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare l’effettiva inerenza delle spese contestate;
- Contestare la natura soggettiva della valutazione dell’Agenzia delle Entrate;
- Eccepire vizi procedurali (motivazione insufficiente, notifica irregolare, decadenza dei termini);
- Richiedere autotutela se la documentazione a supporto era già agli atti;
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni, per annullare o ridurre l’accertamento;
- Mediazione tributaria per limitare sanzioni e interessi.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza le spese contestate e la documentazione disponibile;
📌 Verifica la legittimità della contestazione fondata sul principio di inerenza;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi per far riconoscere la deducibilità dei costi;
⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nei giudizi tributari;
🔁 Suggerisce procedure preventive per una gestione sicura e documentata delle spese aziendali.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in accertamenti fiscali e deducibilità dei costi;
✔️ Specializzato in difesa di imprese e professionisti contro contestazioni su spese non inerenti;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle spese dedotte come non inerenti non sempre sono fondate: spesso si basano su valutazioni arbitrarie.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la connessione delle spese con l’attività, tutelare la deducibilità dei costi ed evitare sanzioni fiscali indebite.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti sulle spese non inerenti inizia qui.