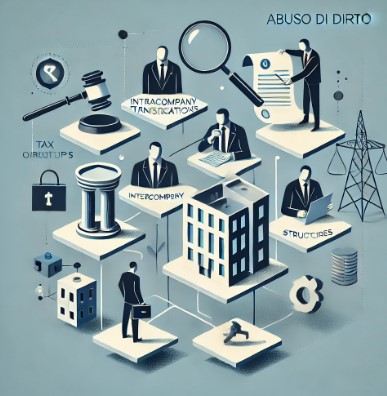Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché alcune operazioni infragruppo sono state qualificate come abuso di diritto? In questi casi, l’Ufficio presume che le operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo siano state poste in essere non per ragioni economiche, ma con il solo obiettivo di ottenere indebiti vantaggi fiscali. La conseguenza è la riqualificazione dell’operazione, con recupero delle imposte, sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: ci sono strumenti difensivi per dimostrare la legittimità delle scelte imprenditoriali.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta le operazioni infragruppo
– Se vi sono trasferimenti di beni o servizi a valori non in linea con quelli di mercato
– Se i finanziamenti infragruppo sono strutturati in modo anomalo (prestiti infruttiferi, interessi irrisori)
– Se le cessioni di rami d’azienda o partecipazioni appaiono finalizzate solo a generare vantaggi fiscali
– Se l’allocazione di costi e ricavi tra società del gruppo appare artificiosa
– Se le operazioni non hanno giustificazione economica ma solo fiscale
Conseguenze della contestazione
– Riqualificazione delle operazioni come elusive o abusive
– Recupero delle imposte ritenute indebitamente risparmiate
– Applicazione di sanzioni per abuso del diritto ed elusione fiscale
– Interessi di mora sulle somme accertate
– Rischio di controlli più ampi su bilanci, rapporti infragruppo e attività internazionali
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche, organizzative e gestionali alla base delle operazioni
– Produrre documentazione contrattuale e contabile che giustifichi i valori applicati
– Contestare la presunzione di abuso se l’operazione ha avuto reali effetti positivi sull’attività del gruppo
– Evidenziare vizi di motivazione, errori di valutazione o decadenza dei termini dell’accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento della contestazione
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare le operazioni contestate e la documentazione societaria collegata
– Verificare la legittimità della contestazione rispetto alla normativa e alla giurisprudenza
– Redigere un ricorso fondato su prove concrete e vizi dell’accertamento
– Difendere le società del gruppo davanti ai giudici tributari
– Tutelare soci e amministratori da conseguenze fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– Il riconoscimento della legittimità delle operazioni infragruppo
– L’eliminazione di sanzioni e interessi non dovuti
– La sospensione delle richieste di pagamento già avviate
– La certezza di gestire le operazioni societarie senza indebite interferenze fiscali
⚠️ Attenzione: il ricorso contro la contestazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se non si agisce nei termini, l’accertamento diventa definitivo e non sarà più possibile difendersi.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e societario – spiega come difendersi in caso di contestazioni sulle operazioni infragruppo e come tutelare i tuoi diritti.
👉 La tua società ha ricevuto una contestazione per operazioni infragruppo considerate abuso di diritto? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo l’atto, valuteremo la legittimità della contestazione e costruiremo la strategia difensiva più efficace per proteggere il tuo gruppo societario.
Introduzione
Le operazioni infragruppo – ossia gli atti e i contratti posti in essere tra società appartenenti allo stesso gruppo – sono prassi comune nella gestione aziendale, ma possono finire sotto la lente delle autorità fiscali o dei creditori. In Italia, l’ordinamento prevede strumenti per contestare tali operazioni quando risultino abusive, cioè finalizzate ad aggirare norme imperative o a ottenere indebiti vantaggi (tipicamente fiscali) senza una reale sostanza economica. Si parla, in questi casi, di abuso del diritto o elusione. Le conseguenze possono essere gravi: dal recupero delle imposte non versate, all’inefficacia degli atti verso i creditori, sino a possibili implicazioni penali in caso di condotte fraudolente.
Questa guida, aggiornata ad agosto 2025, fornisce un quadro avanzato – ma con linguaggio chiaro e divulgativo – della normativa italiana in materia, arricchito con sentenze recenti, fonti istituzionali autorevoli, tabelle riepilogative e casi pratici. L’analisi è svolta dal punto di vista del debitore (sia esso contribuente, imprenditore o società), al fine di comprendere come prevenire e difendersi da contestazioni di abuso del diritto relative a operazioni infragruppo.
Cosa troverete in questa guida:
- Un inquadramento normativo dell’abuso del diritto in ambito tributario, civilistico e penale, con riferimenti alle fonti di legge e ai principi giurisprudenziali più recenti.
- L’analisi delle principali tipologie di operazioni infragruppo a rischio (finanziamenti intragruppo, trasferimenti di beni, prestazioni di servizi, operazioni straordinarie come fusioni/scissioni) e dei motivi per cui possono essere contestate.
- Le strategie difensive e le cautele operative da adottare per dimostrare la legittimità di tali operazioni (documentazione di supporto, valide ragioni economiche, ecc.).
- Un formato domande e risposte (FAQ) per chiarire i dubbi frequenti e una check-list operativa e modelli indicativi di atti difensivi (memorie, comparse) per affrontare concretamente il contenzioso.
L’obiettivo è offrire un supporto completo a professionisti legali, imprenditori e privati che si trovino ad affrontare (o a prevenire) contestazioni relative ad abusi del diritto in operazioni infragruppo, fornendo gli strumenti giuridici avanzati per una difesa efficace.
Segue un’esposizione dettagliata, con riferimenti normativi e giurisprudenziali puntuali.
Quadro normativo e definizioni generali
Per affrontare la materia è indispensabile chiarire cosa si intende per abuso del diritto nell’ordinamento italiano e come questo concetto si applica alle operazioni infragruppo. In sintesi, si ha abuso del diritto quando un soggetto realizza una o più operazioni, formalmente nel rispetto della legge, ma prive di sostanza economica, conseguendo essenzialmente un vantaggio indebito in contrasto con lo scopo della norma aggirata . L’operazione abusiva è dunque lecita nella forma, ma elusiva nella sostanza: il contribuente (o il debitore) abusa di strumenti giuridici leciti per ottenere un risultato pratico che la legge non intendeva consentire.
In ambito tributario, il principio è stato codificato nell’art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal d.lgs. 128/2015. Tale norma definisce l’abuso del diritto come le operazioni “prive di sostanza economica che… realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”, precisando gli elementi costitutivi: assenza di sostanza economica, conseguimento di un vantaggio fiscale indebito ed essenzialità di tale vantaggio fiscale . Sono considerati indici di mancanza di sostanza economica, ad esempio, l’uso incoerente di strumenti giuridici rispetto alla normale logica di mercato e la struttura negoziale anomala volta solo al risparmio d’imposta . Per converso, non costituisce abuso l’operazione giustificata da valide ragioni extrafiscali (cioè motivazioni economico-gestionali effettive, non marginali) anche se comporta un risparmio di imposta . In altre parole, la legge traccia una linea di confine tra il legittimo risparmio d’imposta e l’abuso: è sempre legittimo scegliere il regime fiscale meno oneroso o strutturare le proprie operazioni in modo da pagare meno tasse, purché ciò avvenga in coerenza con la ratio delle norme tributarie e non tradisca il loro scopo . Solo il risparmio d’imposta indebito, ottenuto aggirando lo spirito della legge, configura abuso .
In ambito civilistico, fuori dal campo tributario, il concetto di abuso del diritto assume connotati diversi. Non esiste una norma generale equivalente all’art. 10-bis, ma il principio di buona fede e correttezza vieta di esercitare i propri diritti in modo distorto o emulativo (si pensi all’art. 833 c.c. che vieta gli atti emulativi). In particolare, rispetto ai rapporti obbligatori, l’ordinamento offre strumenti per reagire a operazioni che violino la parità dei creditori o siano volte a eludere norme imperative. Un caso tipico è il negozio in frode alla legge (art. 1344 c.c.), in cui un contratto, pur lecito in astratto, è usato per realizzare in modo indiretto un risultato vietato da una norma imperativa: tale contratto è nullo perché elusivo della legge. Ad esempio, se una società trasferisce beni a un’altra società del gruppo con l’unico scopo di sottrarli alle azioni esecutive dei creditori, potrebbe profilarsi un uso distorto dello strumento contrattuale, in violazione del principio di conservazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.). Più concretamente, il codice civile predispone l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) per dichiarare inefficaci verso il creditore gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni: questo è il rimedio tipico per contrastare operazioni infragruppo che spostino beni o risorse rendendo più difficile il soddisfacimento dei creditori, come dettagliato oltre.
Infine, nei profili penalistici, l’abuso del diritto in sé – inteso come mera elusione – non costituisce reato. Il legislatore ha espressamente sancito che le operazioni abusive “non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie” (art. 10-bis, comma 13, L. 212/2000) . Ciò significa che una pianificazione fiscale aggressiva, se qualificata come abuso, comporta sanzioni amministrative (imposte e pene pecuniarie) ma non integra reati come la frode fiscale. Tuttavia, il confine tra abuso (elusione) ed evasione fiscale può essere sottile in pratica. Quando l’operazione trascende la mera elusione ed implica elementi di inganno o artificio, si entra nel campo dell’illecito penale tributario (es. dichiarazioni fraudolente, false fatturazioni, occultamento di attività). Analogamente, se un’operazione infragruppo è utilizzata per distrarre beni e risorse in vista di una futura insolvenza, si possono profilare reati fallimentari (come la bancarotta fraudolenta). In questa guida distingueremo attentamente i due piani: abuso del diritto tributario vs illeciti penali. Anticipiamo che, se è presente un reato vero e proprio (frode fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, bancarotta, ecc.), non si discute di abuso del diritto – che è concetto residuale – ma si applicano direttamente le sanzioni penali previste . Ad ogni modo, conoscere la linea di demarcazione è fondamentale anche per impostare la difesa: dimostrare che un’operazione rientra nell’alveo dell’elusione (abuso) e non della frode può evitare imputazioni penali.
Il contesto dei gruppi societari e il rischio di abuso
Le operazioni infragruppo meritano un’attenzione specifica perché il contesto di gruppo societario facilita potenzialmente condotte elusive o pregiudizievoli per terzi. All’interno di un gruppo, infatti, vi è spesso una regia unitaria (la capogruppo o i medesimi soci amministratori) che controlla entità giuridiche diverse: ciò consente di ripartire costi e ricavi, trasferire utili o perdite, spostare asset o liquidità da una società all’altra con relativa facilità, cose impossibili tra parti indipendenti a normali condizioni di mercato. In altre parole, i rapporti infragruppo possono non avvenire a condizioni di mercato (“arm’s length”), ma essere determinati dall’interesse complessivo del gruppo o di chi lo dirige. Questo non è di per sé illecito – l’ordinamento riconosce la liceità dei gruppi di imprese e persino l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento (artt. 2497 ss. c.c.) – ma diventa problematico quando tramite rapporti infragruppo si aggirano norme fiscali (ottenendo vantaggi indebitamente) o si lede la garanzia patrimoniale dei creditori di una società (spostando attivi a beneficio di altre società).
In ambito fiscale, le operazioni infragruppo rappresentano una vasta area di potenziale elusione: si pensi alle triangolazioni di beni o servizi, alle strategie di transfer pricing, all’allocazione di costi infragruppo, all’uso di società-veicolo o società schermo in paesi a fiscalità privilegiata. Un esempio emblematico è quello della società interposta o società schermo utilizzata per usufruire indebitamente di agevolazioni o regimi fiscali: la Cassazione ha definito la “società schermo” come “una costruzione di puro artificio, diretta… al raggiungimento di un mero beneficio fiscale indebito, attraverso la creazione di catene di società prive di effettività economica” . In particolare, la recente sentenza Cass. 10305/2024 ha elencato vari indici rivelatori di una società schermo e dunque di un abuso: assenza di una struttura economica organizzata, mancanza di attività economica effettiva, pattuizioni infragruppo che obbligano a retrocedere i profitti alla capogruppo, tempistiche sospette delle operazioni intercompany, scelta di localizzazioni societarie estere dettata esclusivamente da vantaggi fiscali . Tali elementi segnalano la mancanza di “genuine economic activity” e fanno scattare l’applicazione della disciplina antiabuso, nazionale o convenzionale che sia. Dunque, creare scatole vuote all’interno del gruppo per abbattere le imposte configura un abuso del diritto evidente.
Dal lato dei creditori, uno scenario tipico è l’utilizzo di società del gruppo per spostare ricchezza lontano dai creditori di una società in difficoltà. Ad esempio, una società indebitata potrebbe cedere rami aziendali o immobili ad altra società del gruppo a prezzo inferiore al valore di mercato (depersonalizzando il patrimonio aggredibile); oppure la capogruppo potrebbe drenare liquidità dalle controllate sotto forma di finanziamenti infragruppo non restituiti o compensazioni intercompany, lasciando insolventi alcune entità. In taluni casi si arriva a vere e proprie manovre straordinarie come scissioni societarie atte a segregare attività e passività: ad esempio, trasferire tutti gli asset “buoni” in una NewCo e lasciare i debiti nella OldCo, che poi viene fatta fallire. Questo tipo di operazioni può essere considerato un abuso degli strumenti societari a danno dei creditori, e l’ordinamento offre loro diversi strumenti di tutela (revocatoria, azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., estensione del fallimento, ecc., che vedremo in dettaglio).
In sintesi, il concetto di abuso del diritto funge da clausola generale anti-elusiva: nel campo tributario è ormai ben definito e codificato, mentre in ambito civile/fallimentare si declina in vari istituti specifici. Per il soggetto accusato (contribuente o debitore), comprendere questa cornice normativa è il primo passo per organizzare la difesa. Nel prossimo paragrafo analizzeremo dapprima i profili tributari dell’abuso del diritto nelle operazioni infragruppo – come avviene la contestazione da parte del Fisco e quali sono le tutele del contribuente – per poi passare ai profili civilistici (tutela dei creditori) e ai profili penali eventualmente connessi. Seguirà l’esame delle principali tipologie di operazioni infragruppo oggetto di contestazione e, infine, le strategie difensive, le check-list operative e gli esempi pratici.
Profili tributari: abuso del diritto fiscale e difesa del contribuente
In materia tributaria, l’abuso del diritto fiscale (detto anche elusione fiscale) è ormai disciplinato in modo organico dall’art. 10-bis L. 212/2000. Vediamo come si articola la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria e come il contribuente può difendersi.
Contestazione fiscale di operazioni infragruppo abusive
Quando l’Agenzia delle Entrate sospetta che un’operazione infragruppo sia abusiva a fini fiscali, procede in base all’art. 10-bis citato. Trattandosi di una clausola residuale, essa si applica solo se l’operazione non è già sanzionabile con altri mezzi (ad es. non ci sono violazioni formali, né si configura una fattispecie di evasione specifica come false fatture) . La verifica si concentra sui tre requisiti chiave: 1) assenza di sostanza economica, 2) vantaggio fiscale indebito, 3) essenzialità del vantaggio. In concreto, l’Ufficio valuta se la o le operazioni infragruppo contestate non producono effetti economici apprezzabili diversi dal risparmio d’imposta ottenuto e se tale risparmio contrasta con le finalità delle norme fiscali invocate dal contribuente. Ad esempio, supponiamo che una società italiana trasferisca i propri utili ad una controllata estera solo cartolarmente, tramite pagamenti infragruppo giustificati da servizi fittizi: formalmente si deducono costi, ma sostanzialmente si stanno spostando utili tassabili all’estero. Se l’unico effetto sostanziale è ridurre le imposte in Italia, l’operazione sarà considerata priva di sostanza economica e volta a un vantaggio indebito, integrando abuso del diritto .
Proceduralmente, prima di emettere un avviso di accertamento basato sull’abuso, l’Amministrazione finanziaria deve inviare al contribuente una richiesta di chiarimenti in cui illustra i motivi di potenziale abuso (art. 10-bis, comma 6). Il contribuente ha 60 giorni per fornire osservazioni e controdeduzioni, spiegando le proprie ragioni economiche e la sostanza dell’operazione . Questa fase è cruciale: è l’opportunità per dimostrare che, al di là del risparmio fiscale, esistevano valide motivazioni extrafiscali, come esigenze organizzative, finanziarie o di mercato. Ad esempio, potrebbe spiegare che il trasferimento infragruppo di un bene era finalizzato a riorganizzare le attività produttive e non solo a spostare il carico fiscale. L’avviso di accertamento finale, se emesso, deve motivare specificamente quali norme sono state eluse, quale vantaggio indebito è stato ottenuto e perché le spiegazioni del contribuente sono ritenute insufficienti (art. 10-bis, comma 8) . Un difetto di motivazione su questi punti può rendere l’atto viziato.
Un elemento fondamentale, chiarito dalla legge e dalla giurisprudenza recente, riguarda l’onere della prova in queste contestazioni. Spetta all’Amministrazione finanziaria provare la condotta abusiva, cioè la mancanza di sostanza economica e lo scopo essenzialmente fiscale dell’operazione (onere della prova a carico del Fisco) . Solo dopo che il Fisco abbia presentato elementi seri in tal senso, ricade sul contribuente l’onere di provare le ragioni extrafiscali adeguate (onere a carico del contribuente) . La Cassazione ha ribadito questo principio in diverse pronunce, ad esempio con Cass. 12823/2024, sottolineando che l’Ufficio deve innanzitutto dimostrare che gli schemi negoziali adottati sono “anomali… irragionevoli” e mirati a un certo risparmio d’imposta; solo successivamente il contribuente dovrà provare che tali operazioni avevano un contenuto economico effettivo diverso dal mero risparmio fiscale . In altre parole, non basta all’Agenzia evidenziare che un’operazione ha comportato risparmio fiscale: deve provare che quella operazione era artificiosa, non giustificata da normali logiche di business. È molto importante tenere presente questo aspetto probatorio nella difesa.
A questo proposito, si segnala un’importante evoluzione: con Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 (Dipartimento Finanze), il Ministero ha fornito linee guida interpretative sull’abuso del diritto. In tale documento, tra i vari chiarimenti, si è ribadito che per configurare abuso il vantaggio fiscale deve essere indebito, ossia in contrasto con la ratio delle norme, e si è specificato che perfino i differimenti dell’imposizione (posticipare la tassazione) possono costituire un vantaggio fiscale rilevante, ma solo se il rinvio è indefinito o molto prolungato, escludendo invece i differimenti temporanei ordinari . Inoltre, il MEF ha indicato che l’analisi antiabuso deve focalizzarsi sulla finalità della norma utilizzata dal contribuente, più che su quella di una ipotetica norma alternativa non scelta . Ciò per evitare di bollare come abuso qualunque scelta che comporti meno tasse rispetto a un’altra, se comunque la scelta operata è conforme alla ratio della sua norma. Questo atto di indirizzo ministeriale, pur non avendo forza di legge, orienta gli uffici finanziari e potrà essere citato dalla difesa per sostenere una lettura restrittiva dell’abuso (ad es. che risparmiare tasse è lecito finché si rimane nel perimetro previsto dal legislatore, essendo l’abuso una clausola residuale).
Effetti della contestazione fiscale: se l’operazione infragruppo è qualificata come abusiva dal Fisco (e confermata in giudizio dal giudice tributario), l’effetto è principalmente recuperatorio. L’operazione viene “disconosciuta” nei suoi effetti fiscali e l’imposta viene ricalcolata “come se” l’operazione elusiva non fosse mai avvenuta (o come se fosse avvenuta nella forma economicamente sostanziale) . Ciò si traduce in un avviso di accertamento che richiede le maggiori imposte dovute. Inoltre, si applicano le sanzioni amministrative tributarie per infedele dichiarazione (generalmente dal 90% al 180% dell’imposta dovuta; in caso di condotta dolosa le sanzioni possono essere aumentate, ma comunque l’abuso non è equiparato a frode ai fini penali) . L’art. 10-bis esclude invece espressamente la rilevanza penale: nessuna sanzione detentiva potrà essere irrogata solo per abuso del diritto . Questo principio garantisce che un contribuente accusato di elusione non venga trattato alla stregua di un evasore fraudolento, salvo che non emergano violazioni specifiche. In pratica, lo scenario per il contribuente in caso di soccombenza è: pagamento delle imposte evitate, interessi e sanzioni pecuniarie, ma nessun casellario giudiziale penale.
Giurisprudenza tributaria recente su operazioni infragruppo
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha prodotto numerose sentenze in tema di abuso del diritto, alcune delle quali riguardano specificamente operazioni infragruppo. Tali pronunce forniscono principi importanti a cui ancorare la difesa.
- Leasing infragruppo e onere della prova (Cass. civ. Sez. V, 27 ottobre 2023 n. 29936) – In questo caso l’Agenzia delle Entrate aveva contestato un contratto di leasing intercorso all’interno di un gruppo societario, ritenendolo uno schema elusivo. La Cassazione ha però cassato la decisione di merito che aveva confermato l’accertamento, affermando due principi fondamentali: (i) la semplice appartenenza a un medesimo gruppo non costituisce di per sé indice di abuso. In tema di elusione, «l’avvenuta stipulazione di un leasing traslativo… benché all’interno di un gruppo societario, non depone, di per sé, per una distorsione dello strumento giuridico utilizzato» . Occorre quindi evitare automatismi: un’operazione come il leasing, usuale nella pratica commerciale, non diventa abusiva solo perché le parti sono correlate, a meno che non vi sia un uso distorto di tale contratto. (ii) In secondo luogo, la Corte ha escluso che dalla semplice prova della stipula di un leasing infragruppo si possa presumere automaticamente l’intento elusivo: non è ammesso un principio di “normalità causale” secondo cui operazioni infragruppo = abuso. Il giudice deve esigere una motivazione puntuale sull’elemento distorsivo e non può colmare le lacune probatorie con generiche inferenze . Questo rafforza quanto detto sul doppio onere probatorio: se l’Agenzia non porta concreti indizi di anomalia (ad esempio un canone di leasing incongruo, o la mancanza di necessità economica del leasing), l’abuso non può essere riconosciuto e l’operazione va ritenuta lecita.
- Operazioni “anomale” e prova contraria (Cass. civ. Sez. V, 10 maggio 2024 n. 12823) – Questa sentenza, già citata in precedenza, riguarda un caso di asserita elusione e ribadisce il corretto approccio nel giudizio di merito: deve valere il principio statutario del doppio onere della prova. La Cassazione ha confermato che spetta all’Amministrazione dimostrare la natura anomala del complesso delle forme giuridiche adottate, evidentemente scelte solo per un vantaggio fiscale, e solo in seguito il contribuente deve provare le sue ragioni economiche reali . Viene ripreso il concetto che il contribuente deve evidenziare la presenza di un “contenuto economico non marginale e diverso dal mero risparmio fiscale” alla base dell’operazione . Questo orientamento, consolidato, è molto favorevole al contribuente: significa che, in mancanza di una solida prova iniziale dell’Ufficio circa l’artificiosità dell’operazione infragruppo (es. contratti incoerenti con lo scopo dichiarato, transazioni circolari, etc.), la semplice ottimizzazione fiscale non può essere sanzionata.
- Confine tra abuso ed evasione in uno schema infragruppo (Cass. pen. Sez. III, 19 aprile 2024 n. 16442) – Pur essendo una sentenza penale, è illuminante sul piano dei fatti: riguardava un sistema di fatturazioni tra società dello stesso gruppo, contestato dall’accusa come frode IVA (reati ex artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000). La Cassazione ha annullato la condanna degli imputati perché i giudici di merito non avevano provato adeguatamente che le società coinvolte fossero mere “cartiere” (società fittizie) né il dolo specifico di evasione . In particolare, è emerso che una delle società, Prodech, svolgeva effettivamente attività economica (era “operativa, validamente costituita, con finalità coerenti col settore industriale di riferimento” ). La difesa degli imputati era riuscita a dimostrare che le società del gruppo non erano gusci vuoti e che le operazioni avevano una parvenza di genuinità operativa. La Cassazione ha così evidenziato che per configurare il reato di frode è necessario provare concretamente l’assenza di una vera attività economica sottostante e l’intento fraudolento . Questo caso conferma dal lato opposto che, se si dimostra sostanza economica, cade l’accusa di fraudolenza: lo stesso scenario, in ambito tributario, potrebbe al più configurare un abuso (se c’era vantaggio fiscale) ma non una frode criminale. Dunque, la linea difensiva vincente fu provare la operatività reale delle società infragruppo, smontando la tesi della “società schermo”. Per un contribuente, ciò insegna che documentare e dimostrare la concretezza delle operazioni infragruppo è la chiave sia per evitare sanzioni penali sia per convincere i giudici tributari dell’assenza di abuso.
In aggiunta a queste pronunce, la Cassazione a Sezioni Unite già dal 2008 (sent. n. 30055/2008) e poi 2011 e 2014 (sent. n. 19667/2011, n. 18624/2014 “Gold Apple”) ha consolidato il principio dell’abuso del diritto fiscale come clausola generale anti-elusiva di rango generale, applicabile anche in assenza di specifiche norme anti-elusive, in linea con gli indirizzi della Corte di Giustizia UE. Le Sezioni Unite 2014 in particolare sottolinearono che non serve attendere un giudicato penale per poter rilevare l’abuso in sede tributaria, e che l’intento fiscale indebito può essere desunto dalla mancanza di valide ragioni economiche. Tali principi sono ora assorbiti nell’art. 10-bis. Oggi la giurisprudenza tributaria, come visto, è più focalizzata sugli aspetti probatori e sul corretto svolgimento del contraddittorio col contribuente.
Difesa del contribuente in ambito tributario
Passiamo ora alle strategie difensive dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta) che veda contestata un’operazione infragruppo come abuso del diritto. In parte, tali strategie emergono già da quanto detto:
- Sfruttare il contraddittorio endoprocedimentale: quando si riceve la comunicazione di possibili rilievi antiabuso (la richiesta di chiarimenti ex art. 10-bis, co. 6), è fondamentale predisporre una risposta scritta puntuale entro 60 giorni, allegando documenti e spiegazioni che attestino la sostanza economica dell’operazione e le ragioni extrafiscali. Questo documento difensivo può evitare l’accertamento se convince l’Ufficio, o costituirà comunque la base della difesa in eventuale contenzioso. Nella risposta bisogna: descrivere il contesto economico in cui l’operazione è avvenuta, le motivazioni (esigenze organizzative, finanziarie, regolamentari, etc.), evidenziare eventuali effetti positivi diversi dal risparmio fiscale (es. miglioramento dell’efficienza, del cash flow di gruppo, ingresso in nuovi mercati, rispetto di requisiti di vigilanza prudenziale, ecc.), sottolineare la conformità a prassi di mercato se applicabile, e contestare eventuali presunzioni dell’Ufficio. Ad esempio, se viene contestata una consulenza infragruppo dedotta come costo, si potrà allegare il contratto, le relazioni prodotte, le email che provano lo svolgimento effettivo della consulenza, per dimostrare che non era fittizia.
- Verificare la correttezza formale dell’accertamento: in sede di eventuale notifica di avviso di accertamento per abuso, controllare che l’atto abbia rispettato le garanzie procedurali: che sia stata inviata la richiesta di chiarimenti concesso il termine di 60 giorni, che l’avviso finale dia conto dei chiarimenti forniti e perché li ritiene non idonei, e che individui specificamente le norme eluse e il vantaggio indebito (omissioni in tal senso possono costituire motivi di nullità dell’atto impositivo). L’art. 10-bis, comma 8 richiede una motivazione rafforzata, dunque ogni lacuna può essere sollevata nel ricorso.
- Far leva sull’onere della prova dell’Amministrazione: nel ricorso in Commissione Tributaria (ora “Corte di giustizia tributaria di primo grado”), richiamare il principio che l’Agenzia deve provare gli elementi di abuso. Se tali elementi appaiono deboli, evidenziarlo. Ad esempio, sottolineare se l’Ufficio si è basato solo su assunti generici (tipo “trattandosi di gruppo, l’operazione è sospetta”) senza analisi economica concreta. Richiamare giurisprudenza favorevole, come Cass. 29936/2023 che esclude automatismi accusatori sulle operazioni infragruppo . Invertire la narrazione: far presente al giudice che la libertà di scelta del contribuente tra diverse strade lecite è un principio riconosciuto (lo stesso Atto MEF 2025 lo rimarca, affermando la residualità dell’abuso) . Dunque, se l’Agenzia non dimostra chiaramente che la scelta fatta fosse antieconomica o artificiosa, il rilievo va respinto.
- Dimostrare le valide ragioni extrafiscali e la sostanza economica: è il cuore della difesa nel merito. Significa fornire al giudice tributario tutte le prove documentali e le argomentazioni fattuali che attestano come l’operazione avesse una logica di business. In pratica, presentare contratti, delibere del CdA, perizie di stima, studi di settore, corrispondenza interna, risultati conseguenti all’operazione, ecc. che confermino la genuinità dell’operazione. Ad esempio, nel caso di un finanziamento infragruppo contestato, portare evidenza che la società ha effettivamente utilizzato quei fondi per investimenti, che il tasso di interesse praticato era di mercato, che il finanziamento era previsto da un piano finanziario approvato dal ceto creditorio (se in ristrutturazione), ecc. Se si dimostra che l’operazione avrebbe avuto senso anche senza il risparmio fiscale (o comunque con un risparmio fiscale non determinante), difficilmente potrà essere qualificata come abuso . Ad esempio, se due società di un gruppo si sono fuse ottenendo un risparmio d’imposta, ma si prova che la fusione ha generato significative sinergie industriali, eliminato costi duplicati e rafforzato la patrimonializzazione, si configura una ragione extrafiscale valida.
- Contestare l’indebito vantaggio fiscale in sé: in alcuni casi, può essere efficace sostenere che il vantaggio ottenuto non è indebito perché previsto dalla norma. Ad esempio, se il contribuente ha usato un’opzione fiscale consentita (es. il regime di consolidato fiscale nazionale, o una agevolazione specifica) in modo magari opportunistico ma conforme alla lettera della legge, si potrebbe argomentare che ciò rientra nel legittimo risparmio d’imposta. Il MEF 2025 ha esplicitamente detto che scegliere un regime opzionale più conveniente è sempre legittimo . Quindi, qualora l’accusa di abuso si basi sul confronto con un’operazione alternativa più onerosa (del tipo: “potevi fare X pagando più imposte, hai fatto Y per pagarne meno”), evidenziare che il contribuente non ha obbligo di scegliere la via fiscalmente più svantaggiosa. Il ricorso può ricordare che in claris non fit interpretatio: se la normativa concede un beneficio al ricorrere di certe condizioni, e il contribuente le ha rispettate formalmente, l’operazione è lecita salvo prova di artificiosità. Questo discorso ovviamente vale se c’è sostanza: se invece l’operazione è una pura costruzione vuota, non ci si potrà schermare dietro la lettera della legge.
- Utilizzare eventualmente gli strumenti deflattivi o il ruling: prima o durante il contenzioso, valutare se opportuno adire strumenti come l’adesione all’accertamento (per ridurre sanzioni) se la posizione è molto rischiosa, oppure per il futuro utilizzare l’interpello preventivo antiabuso (art. 11, co.1, lett. c) L. 212/2000) per operazioni simili future: questo chiaramente esula dalla difesa sul passato, ma è una cautela per il futuro (il contribuente può chiedere all’Agenzia un parere vincolante se una sua operazione costituirà o meno abuso). Nel contenzioso pendente, se emergono margini, si può tentare la strada della conciliazione giudiziale o del settlement con l’ufficio, magari rimuovendo l’operazione o correggendone gli effetti.
Riassumendo i punti di attenzione per il contribuente: 1) rispondere dettagliatamente al Fisco in sede di contraddittorio, 2) fare leva su ogni errore procedurale dell’accertamento, 3) pretendere la prova effettiva dell’elusività (richiamando la giurisprudenza che tutela la libertà d’iniziativa economica), 4) provare in modo convincente che l’operazione aveva ragioni concrete non fiscali. Questa strategia bilanciata giuridico-fattuale è la più efficace. Come conferma la prassi, spesso i giudici tributari accolgono i ricorsi proprio rilevando difetti di motivazione nell’accertamento o mancanza di prova dell’abuso . Inoltre, mostrando una documentazione robusta sulle ragioni economiche, si fornisce al giudice una base per decidere a favore del contribuente esercitando quel giudizio di merito che la Cassazione richiede (niente scorciatoie presuntive, ma valutazione concreta caso per caso).
Profili civilistici e concorsuali: tutela dei creditori nelle operazioni infragruppo
Passiamo ora al versante civilistico, esaminando come le operazioni infragruppo possano essere contestate da creditori (o curatori fallimentari in caso d’insolvenza) quando costituicono un abuso a danno della garanzia patrimoniale. Mentre in ambito tributario l’obiettivo è recuperare imposte, qui l’obiettivo del terzo (creditore) è evitare che il debitore disperda o sottragga beni attraverso società collegate, pregiudicando il soddisfacimento dei crediti.
L’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)
Lo strumento principale è l’azione revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 c.c. Questa azione consente al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti (quindi inopponibili) gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni . In parole semplici, se il debitore ha regalato o venduto sottocosto un bene a un’altra società del gruppo, il creditore può ottenere dal tribunale civile una sentenza che rende quell’atto non opponibile: potrà quindi ignorarlo e aggredire il bene come se fosse ancora del debitore (ovviamente nei limiti del suo credito). L’atto non viene annullato erga omnes, ma solo reso inefficace rispetto al creditore attore: ciò è importante perché ad esempio una vendita rimane valida tra le parti, ma non protegge l’acquirente dall’azione esecutiva del creditore revocante .
Perché la revocatoria sia accolta, devono sussistere alcuni presupposti (art. 2901, comma 1):
- Eventus damni: l’atto di disposizione deve recare danno alle ragioni del creditore, ossia deve comportare una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore tale che risulti più difficile/certo/oneroso il soddisfacimento del credito. Non è necessario che il debitore diventi totalmente insolvente; basta che l’atto lo renda meno solvibile di prima. Nel caso tipico di operazioni infragruppo, è evidente l’eventus damni quando un’azienda trasferisce asset rilevanti (es. immobili, macchinari, partecipazioni) a un’altra società senza ricevere in cambio un corrispettivo adeguato e magari restando esposta ai debiti: i creditori sono pregiudicati perché i beni su cui contavano non sono più nel patrimonio del debitore. L’eventus damni può anche consistere nell’aumento del rischio o dei tempi di realizzo del credito.
- Scientia damni (dolo generico) del debitore: il debitore, nel compiere l’atto, deve essere a conoscenza del pregiudizio che arreca ai creditori. La legge parla di “consapevolezza del danno” e la giurisprudenza specifica che è sufficiente il dolo generico, cioè la semplice previsione che quell’atto possa danneggiare i creditori, anche senza la specifica intenzione di frodarli . Quindi basta che il debitore sapesse (o prevedesse) che così riduceva la sua patrimonialità a scapito dei creditori. Dato che ogni imprenditore è consapevole del proprio stato patrimoniale, in pratica questo elemento si presume spesso dal fatto stesso oggettivo che l’atto fosse pregiudizievole.
- Participatio fraudis del terzo (nei soli atti a titolo oneroso): se l’atto è a titolo oneroso (es. una vendita, un pagamento, un trasferimento controprestazione), occorre anche che il terzo che ha beneficiato dell’atto (l’altro contraente, in genere l’altra società del gruppo) fosse consapevole del pregiudizio ai creditori o, addirittura, che vi fosse dolo concordato col debitore (il cosiddetto consilium fraudis). In altre parole, la società intragruppo che ha ricevuto il bene deve essere quantomeno a conoscenza della situazione debitoria e del fatto che quell’operazione avrebbe potuto danneggiare i creditori. Se l’atto invece è a titolo gratuito (es. una donazione, un trasferimento senza corrispettivo), non è richiesta la malafede del terzo: il creditore può revocarlo più facilmente (basta l’eventus damni e la scientia del solo debitore).
Applicando questi principi alle operazioni infragruppo, vediamo alcuni esempi:
- Una società (A) fortemente indebitata verso banche e fornitori cede a titolo di conferimento il proprio ramo d’azienda profittevole a una nuova società controllata (B), ricevendo in cambio partecipazioni di B (cioè A diventa proprietaria delle quote di B). Subito dopo, A fallisce. I creditori di A scoprono che il ramo d’azienda è ora in B. Possono agire in revocatoria sostenendo che: (a) c’è eventus damni perché A si è privata del ramo produttivo, ricevendo in cambio solo quote (che nel fallimento di A magari valgono poco, e comunque hanno reso più difficile la soddisfazione); (b) A era consapevole del danno (sapeva di essere insolvente e ha compiuto l’atto di scissione del ramo proprio mentre i debiti erano esigibili); (c) B (il terzo) era certamente a conoscenza della situazione, essendo società di nuova creazione sotto lo stesso controllo. Se provati questi elementi, il tribunale potrà dichiarare inefficace il conferimento: il ramo d’azienda verrà considerato ai fini del fallimento come se fosse ancora in A, quindi il curatore potrà recuperarlo o venderlo per pagare i creditori (oppure farne dichiarare la cessione a B inefficace e aggredire le partecipazioni ricevute).
- Una società (X) paga anticipatamente un debito infragruppo che aveva verso la controllante (Y), in un periodo in cui era già in crisi. Se poi X fallisce, quel pagamento preferenziale può essere revocato come atto a titolo oneroso (pagamento di debito pregresso) se Y sapeva dello stato di decozione di X. Questo è un caso di revocatoria fallimentare (perché c’è fallimento e si tratta di pagamento preferenziale entro certi termini), ma concettualmente rientra nelle operazioni infragruppo lesive per i creditori chirografari (Y, che magari è società-sorella o capogruppo, è stata soddisfatta prima degli altri creditori, peggiorando il loro recovery).
Termini temporali: l’azione revocatoria ordinaria si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto impugnato (art. 2903 c.c.). Quindi i creditori hanno fino a 5 anni per agire. Nell’ottica del debitore, se l’operazione incriminata è avvenuta da oltre 5 anni e nessuna azione è stata promossa, non è più revocabile ordinariamente – ciò può costituire una linea difensiva (eccepire la prescrizione). Attenzione però: se interviene fallimento, entrano in gioco anche le azioni revocatorie fallimentari ex art. 66 R.D. 267/1942 (vecchia legge fall.) o le corrispondenti del Codice della Crisi (d.lgs. 14/2019). Queste hanno termini più brevi (in genere 6 mesi, 1 anno o 2 anni a ritroso dalla dichiarazione di insolvenza, a seconda del tipo di atto), ma possono colpire atti anche oltre i 5 anni se compiuti nel “periodo sospetto”. Inoltre, la proposizione di una revocatoria fallimentare da parte del curatore entro i suoi termini sospende la possibilità per i creditori individuali di fare revocatoria ordinaria (che altrimenti sarebbe duplicativa). Approfondiremo a breve la differenza.
Operazioni straordinarie infragruppo e tutela dei creditori
Una menzione a parte meritano le operazioni societarie straordinarie intragruppo – come fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, cessioni di aziende – utilizzate talvolta per separare attività e passività a danno dei creditori. La legge prevede meccanismi di tutela nelle stesse procedure straordinarie: ad esempio, nella scissione i creditori delle società coinvolte possono opporsi all’operazione prima che sia efficace (art. 2503 c.c.), e la legge stabilisce che, salvo diversa pattuizione, le società beneficiarie della scissione rispondono dei debiti della società scissa non soddisfatti, nei limiti del valore effettivo del patrimonio loro attribuito (art. 2506-quater c.c.). Ciò significa che, teoricamente, un creditore pre-scissione non dovrebbe essere danneggiato perché può rivalersi anche sulla società beneficiaria per il suo debito. Tuttavia, nella pratica non sempre questa responsabilità solidale “pro-quota” garantisce piena soddisfazione (specie se i valori assegnati sono stati sottostimati nell’atto di scissione). Inoltre, se il creditore non ha fatto opposizione nei 60 giorni dalla pubblicazione del progetto di scissione, l’operazione diviene efficace.
Ma questo non impedisce di agire in revocatoria successivamente. La Cassazione ha chiarito a Sezioni Unite, con una recentissima sentenza del febbraio 2025 (Cass. Sez. Unite civili n. 5089/2025), che l’atto di scissione societaria può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. qualora rechi pregiudizio ai creditori . Le Sezioni Unite hanno così risolto un contrasto, affermando espressamente l’ammissibilità della revocatoria sulla scissione, parallelamente (o successivamente) all’opposizione preventiva dei creditori prevista dal codice . Hanno inoltre distinto le competenze: la revocatoria ordinaria della scissione spetta al tribunale sezione specializzata in materia d’impresa, trattandosi di un’azione che investe un atto societario tipico (la scissione) ; viceversa, la revocatoria fallimentare di una scissione (promossa dal curatore ex art. 66 l.fall.) spetta al tribunale fallimentare . Questa pronuncia epocale (SU 5089/2025) significa in sostanza che, anche se una scissione rispetta le forme di legge, se è stata fatta in frode ai creditori, potrà essere annullata nei loro confronti a posteriori. Dal punto di vista del debitore e del gruppo, ciò impone grande cautela: operazioni come scissioni o fusioni interne non mettono al riparo dal rischio di inefficacia se c’è stato intento di pregiudicare i creditori.
Ad esempio, se la nostra società A realizza una scissione parziale trasferendo asset a società B, lasciando la maggior parte dei debiti in A, e poco dopo A fallisce, il curatore (o i creditori individuali, se nessun fallimento) potranno agire: con revocatoria fallimentare (se entro 1 anno dalla scissione) o ordinaria (entro 5 anni) per far dichiarare inefficace la scissione relativamente ai creditori pregiudicati. In pratica, potrebbe ottenersi una sentenza che considera gli asset scissi in B come ancora aggredibili dai creditori di A fino a concorrenza del loro valore.
Va detto che l’azione revocatoria di una scissione non è semplice da condurre: bisogna provare gli elementi visti sopra (danno e consapevolezza). Però la giurisprudenza offre appigli: ad esempio ha ritenuto che la sussistenza dell’eventus damni può risultare anche indirettamente dal fatto che, dopo la scissione, la società A si è spogliata di elementi attivi e poi è insolvente; e quanto alla malafede, è spesso intrinseca nell’operazione se fatta in prossimità dello stato di decozione. D’altronde, le operazioni straordinarie di gruppo lasciano tracce documentali (perizia di stima, progetto, delibere) da cui può emergere se c’era uno scopo lecito o se vi sono anomalie (asset trasferiti a valore irrisorio, timing sospetto, ecc.).
Differenza tra revocatoria ordinaria e fallimentare: come anticipato, se l’azienda entra in procedura concorsuale, il Codice della crisi (e prima la legge fallimentare) prevede azioni revocatorie fallimentari esercitabili dal curatore, con presupposti in parte diversi e termini più brevi. Ad esempio, ai sensi dell’art. 166 del Codice della crisi (corrispondente all’art. 67 l.fall. ante 2022), sono revocabili i pagamenti di crediti chirografari avvenuti nell’anno prima del fallimento, gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni prima se con controprestazione sproporzionata oltre un quarto, e gli atti gratuiti compiuti nei due anni. In una prospettiva infragruppo, questo significa che molti atti “anomali” fatti da una società poi fallita verranno impugnati dal curatore in sede fallimentare, piuttosto che dai singoli creditori. La Cassazione SU 5089/2025, sopra citata, chiarisce che se c’è un fallimento, la competenza del tribunale fallimentare sulla revocatoria fallimentare è prevalente e inderogabile . Ciò non toglie che, se un atto non rientra nelle fattispecie specifiche della revocatoria fallimentare (magari perché avvenuto oltre i termini), i creditori possano percorrere comunque la revocatoria ordinaria (previo coordinamento col fallimento).
Per il debitore e il gruppo societario, è importante sapere che:
- Nel caso di difficoltà finanziarie, pagare società infragruppo o spostare beni a società consociate poco prima di un fallimento espone a revocatorie quasi certe. Quindi, meglio evitare o almeno documentare benissimo la congruità di tali operazioni e, se necessario, coinvolgere i creditori per ottenere il loro assenso (ad esempio in un accordo di ristrutturazione).
- Anche fuori dall’insolvenza conclamata, i creditori individuali possono attivarsi in revocatoria ordinaria per colpire operazioni infragruppo sospette. Questo può avvenire, ad esempio, se un creditore ha un decreto ingiuntivo e scopre che il debitore ha trasferito immobili alla holding: può non attendere il fallimento e agire in via ordinaria.
Azione di responsabilità “da direzione e coordinamento” (art. 2497 c.c.)
Oltre alla revocatoria, l’ordinamento prevede un ulteriore strumento in caso di abusi nell’ambito di un gruppo societario: l’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. per violazione dei doveri inerenti l’attività di direzione e coordinamento. Questa norma dispone che la società (o ente) che esercita attività di direzione e coordinamento su altre società del gruppo risponde verso gli azionisti di minoranza e i creditori sociali delle società eterodirette dei danni causati dalla sua gestione unitaria, se “non improntata a correttezza”. In pratica, se la capogruppo (o un’altra società dominante, anche di fatto) impone scelte alla controllata che avvantaggiano il gruppo o sé stessa ma pregiudicano la controllata, e ciò causa un danno patrimoniale ai creditori di quest’ultima (ad esempio perché la controllata si impoverisce e diventa insolvente), i creditori della controllata possono agire contro la capogruppo per ottenere il risarcimento del danno sofferto (fino a concorrenza dei loro crediti insoddisfatti).
Questa è una forma di responsabilità civile per abuso di direzione e coordinamento. Si parla proprio di “abuso” in dottrina e giurisprudenza in quanto la capogruppo ha abusato del suo potere di eterodirezione, sacrificando indebitamente l’interesse della controllata. Ad esempio, se la holding fa vendere alla controllata un asset a prezzo basso a un’altra società del gruppo, oppure la costringe a concedere finanziamenti intragruppo senza garanzie, portandola al dissesto, ciò configura un potenziale caso ex 2497 c.c. I creditori sociali (anche tramite il curatore in caso di fallimento della controllata) possono chiedere i danni.
La Cassazione ha riconosciuto questa azione in varie occasioni e di recente ha ribadito che il curatore fallimentare di una società eterodiretta può agire ex art. 2497 c.c. contro la holding di fatto per abuso di direzione, cumulativamente all’azione di massa fallimentare . È stato anche chiarito che l’azione dei creditori ex 2497 è sussidiaria: se il creditore ha ottenuto soddisfacimento dal patrimonio della società debitrice, non può più agire sulla holding; ma se è rimasto insoddisfatto dal fallimento della controllata, allora può rivolgersi contro la capogruppo per il residuo . In sostanza, si cerca di colpire il vertice del gruppo quando questo ha prosciugato una società a danno di terzi.
Dal lato difensivo, per la capogruppo accusata ex 2497 c.c., esiste una sorta di “esimente”: la legge prevede infatti che essa non è responsabile se prova che il danno arrecato è stato integralmente eliminato (o compensato) entro la fine dell’esercizio in cui si è verificato, o comunque prima che venisse esercitata l’azione risarcitoria (art. 2497, ultimo comma). Ciò significa che se la capogruppo ha fatto scelte inizialmente svantaggiose per la controllata ma poi l’ha compensate con vantaggi equivalenti (ad es. facendole ottenere altre opportunità o supporto finanziario), allora non è tenuta al risarcimento. Questa difesa – provare la compensazione dei vantaggi nell’ambito del gruppo – è cruciale in un giudizio ex 2497.
È importante notare che l’azione ex 2497 non rende inefficaci gli atti compiuti (non è una revocatoria), ma mira a risarcire il danno. Quindi può coesistere con la revocatoria: il creditore potrebbe ad esempio revocare un atto infragruppo e contestualmente chiedere danni alla holding per la parte di credito rimasto insoddisfatto.
Difesa del debitore nelle azioni dei creditori
Se un debitore (società o imprenditore) si trova bersaglio di un’azione revocatoria o di altre azioni dei creditori relative a operazioni infragruppo, come può difendersi?
- Contestare l’assenza di eventus damni: dimostrare che l’atto non ha pregiudicato i creditori. Ad esempio, provare che il corrispettivo ricevuto era adeguato e rimasto nella disponibilità del debitore per pagare i debiti. Se l’azienda ha venduto un bene a mercato a una consociata e ha usato il denaro per ridurre le esposizioni, il credito del singolo attore non ne è stato leso (anzi, magari il debitore è diventato più liquido). In un’azione revocatoria, se si persuade il giudice che dopo l’atto la situazione dei creditori non è peggiorata (o addirittura migliorata), manca un presupposto fondamentale. Ad esempio, si può evidenziare che il patrimonio residuo del debitore era comunque superiore ai debiti, oppure che la società acquirente ha assunto anche i debiti (nel caso di cessione d’azienda con accollo, ecc.), quindi il creditore non è rimasto privo di garanzie.
- Negare la scientia fraudis: sostenere che il debitore non aveva affatto intenzione né percezione di nuocere ai creditori, ma ha agito per motivi legittimi. Questo è credibile soprattutto se l’atto è avvenuto in un momento in cui la società non era in stato di difficoltà conclamata. Se si dimostra che al tempo dell’operazione il debitore era solvibile e l’atto rientrava nell’ordinaria gestione, non si può pretendere che avesse la consapevolezza di ledere qualcuno. Spesso nella revocatoria si discute se il credito fosse già scaduto, se c’erano procedure in corso, ecc.: se si prova che il creditore aveva un credito futuro o eventuale, e il debitore non poteva prevedere problemi, la scientia damni viene meno. Ad esempio, se una società nel 2019 (in bonis) trasferisce un immobile intragruppo e poi la crisi arriva con la pandemia nel 2020, il contesto può aiutare a sostenere che nel 2019 non c’era alcun dolo o consapevolezza di insolvenza futura.
- Assenza di consilium fraudis del terzo: soprattutto in operazioni intragruppo a titolo oneroso, può essere determinante mostrare che la società controparte (spesso comunque collegata) non aveva specifica conoscenza dello scopo fraudolento. Talvolta, quando le strutture di gruppo sono articolate, si può sostenere che gli amministratori della società ricevente erano diversi e ignari delle condizioni finanziarie della cedente. In realtà nei gruppi ristretti la compenetrazione di conoscenze rende difficile questa linea, ma non impossibile se c’è formalmente distinzione.
- Eccezioni procedurali e di competenza: come visto, questioni di competenza possono sorgere (ma SU 2025 su scissione le ha chiarite: revocatoria ordinaria a sez. impresa, fallimentare al tribunale fall.). Verificare comunque se l’attore ha rispettato i termini (sollevare la prescrizione 5 anni se trascorsi), se l’atto impugnato rientra o meno tra quelli revocabili ex lege (es. non sono revocabili gli adempimenti di debiti scaduti, art. 2901 co.3 c.c., quindi se il pagamento era a scadenza naturale non è revocabile ordinariamente). Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo basato su revocatoria, oppure se i creditori tentano pignoramenti presso terzi (es. delle somme trasferite), occorre far valere tempestivamente in quei procedimenti la mancanza dei presupposti.
- Argomentare valide ragioni di business per l’operazione: analogamente al discorso fiscale, anche qui “raccontare la storia” dell’operazione può aiutare a convincere il giudice che non si trattava di una manovra subdola. Ad esempio, affermare (e provare) che un trasferimento di beni intragruppo è avvenuto come parte di una ristrutturazione aziendale necessaria per salvare l’attività e magari con l’intento di soddisfare i creditori (ad es. ottenere finanza fresca sulla nuova società), e non per sottrarre risorse. A volte, sebbene formalmente i presupposti di revocatoria possano sussistere, il giudice può essere influenzato dal contesto: se percepisce che l’operazione non aveva natura fraudolenta ma anzi era finalizzata a evitare un male peggiore o a massimizzare la soddisfazione del ceto creditorio (es. in un concordato preventivo poi non riuscito), potrebbe propendere per una maggiore indulgenza. Ovviamente ciò non è un argomento di diritto, ma fa parte dell’attività di convincimento istruttorio.
- Compensare il danno o regolarizzare la situazione: se possibile, un debitore potrebbe sanare in parte la situazione, ad esempio facendo ottenere al creditore attore garanzie aggiuntive o pagamenti parziali, per convincerlo a ritirare la causa revocatoria o a transigere. Una volta che l’atto è fatto, questa è più una strategia di negoziazione che processuale, ma in pratica spesso i contenziosi revocatori si risolvono con accordi: il terzo acquirente (magari un’altra società del gruppo) paga qualcosa al creditore per evitare la revoca dell’atto.
- Nel caso di azione ex art. 2497 c.c.: qui la difesa della capogruppo sta nel dimostrare che non c’è stato abuso della direzione e coordinamento. Come? Provando che le scelte erano giustificate da un interesse di gruppo positivo e che alla controllata sono stati arrecati vantaggi compensativi. Bisogna mostrare che la gestione unitaria è stata nel complesso equilibrata. Inoltre, spesso si contesta la sussistenza stessa di una direzione e coordinamento di fatto, se la capogruppo non aveva formalmente tale ruolo. Se la holding è di fatto (non dichiarata), la difesa potrà contestare le prove dell’attore su questo punto (non facile, ma è un punto: l’attore deve dimostrare il controllo e l’abuso). Infine, come detto, l’art. 2497 offre scappatoie: se la società controllante riesce a eliminare il danno prima della fine dell’esercizio successivo, ad esempio finanziando la controllata per ripianare, può evitare responsabilità. Quindi anche tardivamente, offrire rimedi (finanziamenti postumi, accolli di debiti) può essere usato in giudizio per dire “abbiamo già neutralizzato il danno”.
In generale, prevenire è meglio che curare: un gruppo che pianifica operazioni potenzialmente pregiudizievoli per alcuni creditori dovrebbe coinvolgerli o informarli, ottenendone se possibile il consenso, o predisporre contestualmente misure di salvaguardia (fideiussioni, accolli, ecc.). Documentare con delibere assembleari e piani finanziari le ragioni dell’operazione può servire a mostrare buona fede.
Dal punto di vista pratico per l’impresa, come sottolinea una nota di commento alla SU 5089/2025, è cruciale in fase di pianificazione di una scissione o operazione straordinaria valutare il rischio di impugnazioni e predisporre adeguate difese documentali e contrattuali fin da subito . Ciò implica, ad esempio, inserire clausole di salvaguardia per i creditori, fare periziare i beni a valori congrui, mantenere trasparenza. L’adozione di tali misure di trasparenza e di adeguata documentazione degli atti societari è raccomandata per minimizzare i rischi di azioni revocatorie .
Riassumendo, il debitore che fronteggia iniziative dei creditori su operazioni infragruppo dovrà focalizzarsi nel negare gli estremi della frode ai creditori (nessun danno, nessuna consapevolezza) e nel legittimare l’operato con ragioni valide, oppure risolvere in via transattiva. La legge offre spazi di difesa, ma molto dipende dalla prova: spesso i documenti e le circostanze temporali parleranno da soli. Se un atto è compiuto alla vigilia di un default, per un corrispettivo palesemente incongruo, la difesa sarà ardua. Se invece è un’operazione più vecchia e inserita in un progetto industriale genuino, le chance di successo aumentano.
Profili penalistici nelle operazioni infragruppo
Come già accennato, le operazioni infragruppo in sé non configurano reato, a meno che non siano parte di condotte fraudolente più ampie. Tuttavia, quando si discute di abuso del diritto è necessario considerare anche i possibili riflessi penali che possono emergere in certe situazioni limite, perché dal punto di vista del debitore ciò incide enormemente sulla strategia (passare da un piano “amministrativo/civile” a uno penale cambia radicalmente lo scenario).
Le due aree principali sono: i reati tributari (evitare o ostacolare il pagamento di imposte) e i reati fallimentari (frodi ai danni dei creditori in contesto concorsuale).
Reati tributari correlati
Il D.Lgs. 74/2000 elenca i principali reati fiscali. Tra questi, uno in particolare può coinvolgere operazioni infragruppo: la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Questo reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere il pagamento di imposte o relativi interessi/sanzioni, “compie atti fraudolenti sui propri o sull’altrui beni” idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione. In pratica, è il classico caso di distrazione di beni per non farli pignorare dal Fisco. La pena base è la reclusione da 6 mesi a 4 anni, che sale da 1 a 6 anni se l’ammontare delle imposte o sanzioni non pagate supera 200.000 euro . Ad esempio, se una società ha un grosso debito IVA e, ricevuta la notifica di cartella esattoriale, trasferisce tutti i fondi alla consociata o vende simulatamente immobili alla holding per evitare l’esproprio, gli amministratori possono essere incriminati per sottrazione fraudolenta. Qui l’elemento chiave è la fraudolenza: non basta alienare beni, deve esserci un quid pluris di inganno o simulazione (atti simulati o spoliazioni volutamente occulte). Una vendita a prezzo di mercato prima di un accertamento, se genuina, non costituirebbe reato; ma vendere sotto banco a un correlato, oppure fingere leasing o affitto, ecc., sì.
Va evidenziato il rapporto con l’abuso del diritto: se un’operazione infragruppo ha la sola finalità di non pagare imposte ma è trasparente e reale (non occulta beni, ma ad esempio sfrutta un cavillo per ridurre l’imponibile), ricadrà nell’abuso (no reato). Se invece implica occultamento (ad esempio uso di fatture false o schermature), allora non si parla più di abuso, ma di reato fiscale specifico (dichiarazione fraudolenta o appunto sottrazione fraudolenta). La Cassazione penale continua a condannare chi attua sistemi di false fatturazioni e scatole vuote per evadere l’IVA , ma come visto nel caso 16442/2024, esige che sia provata la natura simulata/inoperativa delle strutture societarie coinvolte per configurare il dolo di frode . Dunque, dal lato difensivo, dimostrare la reale operatività delle società e l’assenza di artifizi è determinante anche in sede penale (ciò può evitare la qualificazione come frode e ricondurre la vicenda al mero illecito amministrativo tributario) .
Oltre all’art. 11, altri reati potrebbero tangere operazioni infragruppo: ad esempio la dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3) se si creano passività fittizie infragruppo per abbattere il reddito, oppure la emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) se si interpunge una società cartiera del gruppo per generare costi falsi. Ma qui entriamo in condotte apertamente delittuose, ben oltre l’abuso del diritto. Basti sapere che se la contestazione fiscale evidenzia elementi di falsità o simulazione, scatta la denuncia penale.
Viceversa, se un contribuente si vede inizialmente indagato penalmente ma riesce a dimostrare che le operazioni erano reali e semplicemente elusivo-aggressive, può ottenere la derubricazione ad abuso del diritto (con tutte le garanzie che ne derivano, incluso il comma 13 di esenzione penale). È successo in alcuni casi complessi di esterovestizione (società spostate all’estero fittiziamente): in certi processi si è discusso se fosse elusione (quindi no reato) o evasione (falsa dichiarazione). La differenza la fa la sostanza economica e la trasparenza: se c’è gestione occulta, tende a essere evasione; se tutto è dichiarato ma contestato come indebito, è abuso.
Reati fallimentari correlati
Sul versante fallimentare, il reato tipico che può emergere è la bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 e 223 R.D. 267/42, ora art. 322 Codice della Crisi). Consiste in atti di distrazione, dissipazione, occultamento di beni del fallito compiuti dagli amministratori prima del fallimento, con dolo di recare pregiudizio ai creditori. È punita severamente (reclusione da 3 a 10 anni, aumentabile se più fatti). Nel contesto infragruppo, classici esempi di condotte che la magistratura può qualificare come bancarotta fraudolenta:
- Aver distratto attivi verso altre società del gruppo, ad esempio vendendoli a prezzo simbolico o trasferendoli senza corrispettivo, determinando l’insolvenza della società poi fallita. Anche un’operazione formalmente lecita come una scissione può essere letta come una grande distrazione organizzata se il risultato è che la società fallita è stata svuotata degli asset. La linea tra lecito e doloso sta nell’intento: se l’operazione era manifestamente squilibrata e la società era già in crisi al momento, l’intento fraudolento viene presunto.
- Aver favorito taluni creditori infragruppo a scapito di altri – questo potrebbe configurare bancarotta preferenziale (meno grave della fraudolenta distrattiva, ma pur sempre reato, con pene fino a 2-3 anni). Ad esempio, se l’amministratore di una società poi fallita ha estinto un debito verso la società consociata pochi mesi prima del fallimento, sapendo di creare un favoritismo, può rispondere di bancarotta preferenziale (art. 216 comma 3 l.fall.).
In definitiva, ogni operazione infragruppo fatta in periodo di insolvenza imminente o conclamata diventa sospetta penalmente: i curatori e i PM la guarderanno per valutare se fu fatta con coscienza del dissesto e volontà di frodare i creditori. Nei gruppi, inoltre, può emergere la figura della holding di fatto occulta, con possibili estensioni del fallimento ad essa (fenomeno delle cosiddette supersocietà di fatto). La Cass. 5458/2023 ha distinto la supersocietà di fatto (più società perseguono un interesse comune) dalla holding di fatto (società controllate perseguono interessi della persona fisica di vertice), affermando che questa holding di fatto può essere dichiarata fallita autonomamente se insolvente, e comunque su di essa può agire il curatore ex 2497 c.c. . Ciò significa che, in casi estremi, le manovre di gruppo possono portare a un coinvolgimento penale e concorsuale anche della capogruppo (ad es. dichiarandola fallita insieme alle controllate e perseguendone gli amministratori).
Difendersi penalmente in questi scenari significa principalmente dimostrare l’assenza di elementi fraudolenti. Dal punto di vista dell’indagato (amministratore, direttore di gruppo):
- Sostenere e provare che l’operazione contestata aveva motivazioni lecite e non l’intento di sottrarre beni ai creditori o al Fisco. Se si viene accusati di bancarotta fraudolenta per una vendita infragruppo, portare evidenze che il prezzo era congruo e la vendita mirava a continuare l’attività (ad esempio, fu autorizzata dal tribunale in concordato preventivo, o fu fatta per ottenere liquidità). Se le circostanze supportano questa ricostruzione (magari c’è stata trasparenza con i creditori, consultazione con esperti, etc.), il fatto può essere derubricato a bancarotta semplice o escluso il dolo.
- Evidenziare eventuali mancate prove del nesso causale: talora si accusa che l’operazione ha causato il dissesto; se la difesa riesce a dimostrare che il dissesto sarebbe avvenuto comunque e l’atto non l’ha aggravato, può indebolire l’accusa (non elimina il reato se c’era distrazione, ma sull’entità del danno può incidere, e sul dolo specifico).
- In ambito fiscale penale, se si è accusati di reati come frode, un approccio è cercare di patteggiare o applicare cause di non punibilità (ad esempio il pagamento integrale del debito tributario prima del dibattimento può estinguere alcuni reati tributari, ma non la frode). Alternativamente, convincere che era un caso di elusione: qui conta la predisposizione iniziale (ad esempio, se l’imputato aveva chiesto pareri legali o rulings, dimostra che riteneva la condotta lecita, escludendo il dolo).
In conclusione, per il debitore-imprenditore la miglior difesa sul piano penale è non oltrepassare quella linea: mantenere le operazioni infragruppo reali, giustificate e documentate. Come principio, finché c’è sostanza economica e trasparenza, si resterà al più nell’ambito amministrativo (abuso del diritto) ; se subentra la simulazione e l’inganno, si cade nel penale . Questa distinzione rispecchia anche la filosofia della normativa: colpire penalmente l’evasione/frode, ma riservare all’abuso un trattamento sanzionatorio solo amministrativo.
Tipologie di operazioni infragruppo a rischio e casi pratici
In questo capitolo analizziamo più da vicino le principali categorie di operazioni infragruppo frequentemente oggetto di contestazione come abusi del diritto o atti in frode, illustrandone le caratteristiche, i motivi di rischio e alcuni esempi pratici. Per ciascuna tipologia, indicheremo anche i riferimenti normativi o giurisprudenziali specifici e i possibili profili di difesa.
Finanziamenti infragruppo e movimentazioni finanziarie
Descrizione: I finanziamenti infragruppo consistono in prestiti, apporti di liquidità o regolazioni di conto corrente tra società collegate (es. capogruppo che finanzia controllata, cash pooling centralizzato, prestiti infruttiferi da una consociata all’altra, ecc.). Rientrano qui anche le garanzie infragruppo (fideiussioni, lettere di patronage) e le compensazioni di crediti/debiti tra società del gruppo.
Rischi di contestazione fiscale: Tali operazioni possono essere contestate dal Fisco soprattutto per due ragioni: 1) sotto-capitalizzazione occulta (ad esempio finanziamenti soci usati in luogo di capitale per sfruttare deducibilità degli interessi), 2) non conformità al valore di mercato (transfer pricing sui tassi). In passato esistevano norme di thin capitalization che limitavano la deduzione degli interessi verso soci qualificati; oggi la deducibilità degli interessi passivi è in generale limitata (30% EBITDA), ma rimangono le logiche di verifica dell’inerenza e dell’arm’s length. Ad esempio, se una società italiana paga interessi elevatissimi a una consociata estera su un prestito infragruppo, l’Agenzia potrebbe disconoscere la parte eccedente il tasso di mercato come costo indebito (anche senza scomodare l’art. 10-bis, bastano le norme ordinarie sui prezzi di trasferimento o l’inerenza ex art. 109 TUIR). Cass. 17433/2024 ha affrontato un caso di consulenze infragruppo in ambito consolidato fiscale: la controllante addebitava costi alla controllata per servizi generici, e la CTR aveva annullato l’accertamento perché tanto in consolidato i redditi si compensano. La Cassazione ha invece dato ragione all’Agenzia, affermando che non è ammissibile lo spostamento artificioso di componenti di reddito tra società consolidate, perché ogni società deve determinare il proprio reddito secondo regole di autonomia fiscale . Non si può dunque usare il gruppo per “ricollocare” costi o ricavi a piacimento, nemmeno se il risultato complessivo d’imposta di gruppo non cambia . Ciò vale anche per gli oneri finanziari: se, ad esempio, un gruppo trasferisse gli interessi passivi su una società che ha base imponibile positiva per far emergere meno utile, e corrispondentemente riducesse i proventi nell’altra, sarebbe elusivo.
Rischi per i creditori: Se un’azienda in crisi restituisce anticipatamente prestiti infragruppo o versa dividendi mascherati da rimborso finanziamento, può ledere i creditori terzi. Anche il caso in cui la holding non onora la promessa di versamento (come una lettera di patronage “distratta”) può creare contenziosi. Inoltre, i finanziamenti dei soci a favore di società sottocapitalizzate sono subordinati ex lege (art. 2467 c.c.): in caso di fallimento, il rimborso ottenuto dai soci nell’anno precedente è revocabile come pagamento postergato indebito.
Esempio pratico: La società Alfa (holding) concede un prestito infragruppo di 5 milioni alla società Beta (operativa). Beta paga interessi annuali al 10%, per 500.000 €. Il tasso di mercato per aziende simili sarebbe 3%. L’Agenzia Entrate può contestare a Beta la deducibilità dell’eccedenza di interessi come costo anomalo non inerente, e a Alfa potrebbe contestare una distribuzione occulta di utili per la parte eccedente. Se Beta fosse in regime di consolidato con Alfa, comunque – come afferma Cass. 17433 – non può giustificare l’operazione dicendo “tanto è tutto in famiglia”, perché la legge richiede separata osservanza delle regole fiscali per ciascuna società . Dal lato civilistico, se Beta fallisce dopo aver restituito ad Alfa i 5 milioni di capitale poco prima, il curatore agirebbe in revocatoria (pagamento di credito soci in periodo sospetto) e forse vedrebbe quella restituzione come bancarotta preferenziale o distrattiva a favore della holding.
Difese e cautele: Per evitare contestazioni, i finanziamenti infragruppo devono essere documentati a condizioni di mercato. È bene stipulare contratti di finanziamento con tasso in linea ai parametri (es. Euribor + spread congruo), eventualmente corredati da pareri di congruità. Se il tasso è zero (prestito infruttifero), evidenziare la ragione economica (es. sostegno temporaneo per cassa comune, convenienza di gruppo) e tener traccia scritta delle decisioni. In caso di consolidato, ricordare che non si possono “barattare” costi tra società: ogni spesa deve avere inerenza per chi la sostiene. Dunque, evitare di allocare interessi passivi a una società che formalmente risulta debitrice ma non utilizza quei fondi. Dal lato dei creditori, un debitore prudente eviterà di restituire prestiti ai soci se ha esposizioni verso terzi in sofferenza, salvo farlo in esecuzione di accordi omologati (in un concordato, ad esempio, certe restituzioni possono essere autorizzate se funzionali).
Sentenze di riferimento: Cass. 17433/2024 (infragruppo e consolidato) ; Cass. 29936/2023 (leasing infragruppo, per analogia sul principio “appartenenza al gruppo non implica abuso” per i contratti finanziari) .
Trasferimenti infragruppo di beni (cessioni di asset)
Descrizione: Include vendite, conferimenti, permute di beni tra società del gruppo – immobili, macchinari, partecipazioni, marchi, rami d’azienda. Spesso avvengono come parte di riorganizzazioni oppure per centralizzare proprietà (ad es. mettere tutti gli immobili in una società immobiliare del gruppo e far pagare affitti alle altre).
Rischi di contestazione fiscale: Il rischio principale è l’elusione di imposta tramite sotto/sopra- valutazioni o regimi agevolativi. Un caso classico, oggetto di varie contestazioni, è il conferimento di un bene in neutralità fiscale seguito dalla cessione delle partecipazioni: schema noto con cui si evitava la plusvalenza diretta sul bene. Ad esempio, conferisco un immobile in Newco (operazione tax free ai sensi dell’art. 176 TUIR), poi vendo la quota di Newco (che godeva di participation exemption 95%): risultato, trasferimento effettivo del bene pagando pochissima imposta. La Cassazione per anni ha considerato questo schema elusivo salvo reali ragioni extra-fiscali (v. caso “Dolce & Gabbana” ecc.). Oggi l’art. 10-bis formalizza che se l’unico scopo è evitare la tassazione della plusvalenza, c’è abuso. Un caso recente: cessione di immobili con imposta di registro all’1% intra-gruppo, e successiva rivendita a terzi, per risparmiare registro (c.d. rivendita elusiva). L’Agenzia ha ritenuto abuso perché la società acquirente infragruppo non svolgeva reale attività immobiliare ed era un veicolo per pagare imposta fissa . Casi simili sono stati segnalati su FiscoOggi. Dunque, vendite interne seguite da rapide rivendite esterne con risparmio fiscale sono sotto la lente.
Altro fronte: transfer pricing domestico sui beni. Per beni scambiati con l’estero ci sono regole TP obbligatorie; per beni scambiati internamente nel gruppo italiano, formalmente non c’è una norma di TP, ma l’Agenzia può comunque contestare operazioni a prezzi anomali invocando il valore normale in casi di evidente antieconomicità (specie in consolidato). Cass. 17433/2024, come visto, nega la libertà di compensazione tra consolidate . Inoltre, in ambito IVA, il principio anti-elusivo è utilizzato: ad es. cessioni esenti o imponibili a aliquota ridotta infragruppo seguite da operazioni diverse potrebbero essere considerate schemi di abuso IVA (la Corte UE caso Halifax fornisce il criterio: se c’è vantaggio IVA contrario a scopo della direttiva e mancanza di sostanza economica, si disconosce).
Rischi per i creditori: I trasferimenti di asset sono precisamente gli atti che più spesso i creditori colpiscono in revocatoria o considerano distrazioni in bancarotta. Una vendita di bene a prezzo vilmente basso a un’altra società controllata è l’esempio lampante di atto in frode ai creditori. Anche a prezzo giusto può essere revocata se il pagamento non è poi rimasto per i creditori (ad es. venduto immobile e incasso portato all’estero). Un conferimento d’azienda è equiparato in sostanza a una vendita: i creditori possono seguirlo con l’azione revocatoria se peggiora la garanzia (come spiegato con Cass. SU 5089/2025 per la scissione, principio analogo vale per conferimenti).
Esempio pratico: La società Tizio S.p.A., prevedendo difficoltà finanziarie, trasferisce nel 2024 la proprietà del capannone industriale alla immobiliare Mevia S.r.l. (controllata al 100%) ad un prezzo formalmente uguale al valore di carico storico, nettamente inferiore al mercato. Tizio continua ad usarlo in leasing o affitto. Nel 2025 Tizio fallisce. Il curatore di Tizio certamente agirà: sul piano civile, azione revocatoria per inefficacia della vendita (entro 5 anni, l’atto 2024 rientra; se la vendita era a prezzo irrisorio probabilmente integrava atto a titolo gratuito salvo formalità, dunque revocabile ex se). Sul piano penale, gli amministratori di Tizio rischiano l’imputazione per bancarotta distrattiva (aver sottratto l’immobile ai creditori). Dal lato fiscale, se Tizio era in perdita e Mevia in utile, la vendita a basso prezzo potrebbe essere vista come cessione infragruppo con possibile sottofatturazione (ma se entrambe soggetti italiani, l’Agenzia potrebbe contestare a Mevia l’indebita deduzione di maggiori ammortamenti futuri – ma se prezzo basso, anzi Mevia dedurrà poco; piuttosto contesterà a Tizio la eventuale perdita fittizia su cessione?). È uno scenario dove l’abuso civilistico/penale è evidente. Viceversa, se Tizio stava bene e ha venduto a Mevia come riorganizzazione (prezzo congruo, incasso investito), i creditori non avrebbero ragione di agire e il Fisco nemmeno.
Difese e cautele: In caso di cessioni infragruppo assicurarsi di operare a valori di mercato o comunque oggettivi. Far fare perizie di stima indipendenti sugli asset trasferiti e attenersi a quelle. Se si applicano regimi fiscali di favore (conferimenti neutrali, registro fisso ecc.), predisporre una sostanziosa motivazione extrafiscale: es. conferimento per creare una sub-holding focalizzata, con successiva apertura del capitale a investitori, ecc. – insomma, dare un senso economico autonomo. Evitare di rivendere a terzi troppo presto dopo l’operazione infragruppo, oppure se succede, tenere traccia che non era pianificato fin dall’inizio (altrimenti pare un disegno elusivo unitario). Dal lato creditori, come debitore prudente, evitare operazioni radicali su asset se esistono debiti significativi non garantiti: se proprio necessario, coinvolgere i creditori (ad esempio proponendo accordi in cui il trasferimento avviene ma il ricavato va in escrow per loro, etc., in modo da non incorrere in frode).
Sentenze di riferimento: Cass. SU 5089/2025 (revocabilità scissione, per analogia conferimenti) ; Cass. 5458/2023 (holding di fatto responsabile per abuso direzione – caso di società di fatto con beni spostati, v. massima) ; Cass. 19704/2015 (conferimenti seguiti da cessioni quote: abuso); Cass. 30335/2018 (operazione immobiliare infragruppo considerata elusiva). Inoltre circolari AdE n. 6/2016 hanno trattato conferimento + cessione come potenziale abuso ex art. 10-bis.
Prestazioni di servizi infragruppo e addebiti di costi
Descrizione: Riguarda i rapporti di servizi tra consociate: management fees della holding alle controllate, servizi amministrativi centralizzati, royalties per uso di marchi interni, addebito di costi di personale distaccato, ripartizione spese di pubblicità, ecc. In gruppi multinazionali rientra nel transfer pricing; in gruppi domestici, spesso non regolati con la dovuta formalità.
Rischi di contestazione fiscale: L’Agenzia delle Entrate verifica che tali costi siano realmente sostenuti e inerenti all’attività del percettore. Un abuso tipico è quando la capogruppo “scarica” costi sulle controllate per abbattere i loro utili (ad es. una fee calcolata sui ricavi anche se i servizi resi sono generici). Oppure creazione di società di servizi in paesi a bassa tassazione che fatturano alle consociate: qui entra il TP internazionale, ma se è domestic può configurarsi abuso se privo di sostanza (società di comodo). Cass. 17433/2024, come analizzato, ha stabilito chiaramente che non è lecito spostare utili tra società consolidate tramite addebiti infragruppo arbitrari . In quel caso specifico, la controllante addebitava “consulenze generiche” alla controllata, e la Cassazione ha detto che il Fisco poteva riprendere a tassazione i costi indebitamente dedotti perché non dettagliati né misurabili . L’abuso si annida quando tali servizi non hanno un corrispettivo determinato secondo logiche di mercato o addirittura quando sono inesistenti (allora si arriva al reato di false fatture se sono simulati).
In materia IVA, inoltre, se i servizi infragruppo sono costruiti con schemi artificiosi (ad es. fatturare servizi esenti per detrarre IVA altrove), può scattare l’abuso IVA (la Corte UE ha vari casi sull’uso di società per sfruttare esenzioni IVA, dichiarandoli abuso se manca sostanza economica, cfr. casi Halifax, Part Service, Cantiere Navale, etc.).
Rischi per i creditori: Meno immediati forse, ma comunque presenti. Ad esempio, se una società in crisi paga grosse somme alla capogruppo per “royalties” o “servizi amministrativi” invece di conservare cassa per i creditori, quei pagamenti (specie se periodici) possono essere attaccati come atti a titolo oneroso con consilium fraudis (se fatti scientemente per svuotare). Il creditore potrebbe sostenere che erano pagamenti privi di giustificazione reale, quindi distrazioni di risorse. In fallimento, se quei pagamenti sono avvenuti entro l’anno, il curatore li revoca come pagamenti anormali a società collegata (spesso riesce se importi ingenti e natura non strettamente dovuta).
Esempio pratico: Gruppo Gamma ha una capogruppo che fornisce “servizi di gestione” alle controllate, addebitando annualmente una fee pari al 5% del fatturato di ciascuna controllata. Una delle controllate, Delta Srl, comincia ad avere perdite ma continua a pagare la management fee. Se il Fisco analizza Delta, potrebbe contestare che quella fee del 5% non è correlata a servizi effettivamente resi (magari la holding non ha personale adeguato o i servizi sono duplicati con quelli già interni a Delta). Quindi potrebbe riprendere a tassazione tali costi come indeducibili per difetto di inerenza (oppure inquadrare come dividendi occulti se soci persone fisiche dietro). Se Delta poi fallisce, il curatore potrebbe dire: la holding ha estratto liquidità da Delta sotto forma fee mentre l’azienda andava male, e chiederne la restituzione (azione ex 2497 c.c. per mala gestio di gruppo o revocatoria dei pagamenti delle fee più recenti).
Difese e cautele: Le società devono formalizzare con contratti scritti i service agreements infragruppo, specificando le attività svolte, i criteri di determinazione del corrispettivo (cost plus, ripartizione pro-quota, ecc.), e soprattutto dimostrare l’effettiva prestazione. Conservare report, corrispondenza, deliverables dei servizi centrali. Sul piano fiscale, può essere utile predisporre documentazione di transfer pricing anche per servizi domestici, applicando il principio del valore normale: ad esempio, se la holding presta un servizio di contabilità, giustificare la fee in base al costo del personale + markup ragionevole. Evitare “teste di costo” sproporzionate su società in perdita o di piccole dimensioni, che suonano anomale. Se il Fisco contesta, mostrare analisi economiche che supportino la necessità di quei servizi per la controllata (es. la controllata non ha certe funzioni in house e quindi riceve vero supporto). Dal lato creditori, per difendersi da revocatorie su pagamenti infragruppo, conviene che i servizi siano reali e a prezzi di mercato: un pagamento che il debitore avrebbe comunque dovuto fare a un terzo per quel servizio difficilmente è “in frode”. Invece pagamenti per servizi fittizi sono indifendibili. Quindi, se l’azienda inizia a scricchiolare, meglio sospendere addebiti infragruppo non essenziali o documentare che sono cruciali per mantenere in vita la società (es. pagamento del software gestionale condiviso: se non pagasse la holding, la filiale non funzionerebbe). Ciò può configurare causa utile e non semplice drenaggio.
Sentenze di riferimento: Cass. 17433/2024 (costi servizi infragruppo non dettagliati indeducibili) ; Cass. 14930/2013 (inerenti i cost sharing agreements infragruppo); C.T. Reg. Lombardia 9/2019 (ha negato deduzione di “management fee” prive di prova). Sul fronte penale, Cass. pen. 5463/2014 ha riguardato false fatture infragruppo: condanna per frode IVA dove la società emittente era di comodo.
Operazioni straordinarie infragruppo (fusioni, scissioni, cessioni di partecipazioni)
Descrizione: Include fusioni tra società del gruppo, scissioni (divisione di società in più entità del gruppo), conferimenti di azienda o rami seguiti da altre operazioni, liquidazioni infragruppo (chiusura di società con trasferimento attivi ad altre), LBO intragruppo, ecc. Sono mosse “strutturali” spesso fatte per riorganizzare il gruppo, ma talvolta strumentalizzate per fini elusivi o per isolare debiti.
Rischi di contestazione fiscale: Molto elevati se l’operazione appare costruita principalmente per vantaggi fiscali. Abbiamo citato il classico conferimento + cessione partecipazioni come esempio di elusione (abuso del diritto) noto in giurisprudenza . Anche la fusione tra società può essere abusiva se fatta per usufruire di perdite fiscali altrimenti non utilizzabili: l’art. 172 TUIR pone limiti al riporto perdite nelle fusioni, ma se si cerca di aggirarli tramite scissioni e fusioni combinate, il Fisco può intervenire ex art. 10-bis. Un esempio: la società A con ingenti utili incorpora la società B che aveva solo perdite pregresse e nessuna attività, col solo scopo di utilizzare quelle perdite per abbattere gli utili di A. Formalmente se i requisiti di continuità economica non ci sono, il TUIR già lo vieta; ma anche se rispettati formalmente, se l’operazione è solo mirata al risparmio d’imposta (acquisire una “bare societaria” con tax losses), potrebbe configurare abuso .
Le scissioni, come detto, hanno profili di elusione quando usate per trasferire assets e conseguire vantaggi fiscali (es. evitare l’imposizione su plusvalori trasferendo beni in una beneficiaria e vendendone poi le quote con PEX, simile al conferimento). L’Agenzia ha spesso contestato scissioni spin-off seguite dalla cessione dell’intera partecipazione della beneficiaria come abuso del diritto (caso tipico: scissione di un immobile in una newco e vendita quote newco tassando solo il 5% ai fini IRES – schema analogo al conferimento, e parimenti abusivo se l’unico scopo era risparmiare imposta di registro o sulle plusvalenze).
Un altro esempio: trasformazioni societarie combinate a cessioni di partecipazioni per sfruttare aliquote diverse (meno comune, ma es. trasformare società di persone in capitale prima di vendere per ridurre imponibilità per i soci).
Rischi per i creditori: Molto elevati soprattutto per scissioni e fusioni asimmetriche. La scissione abbiamo visto può essere revocata se in frode (SU 2025) . La fusione, essendo unire patrimoni, di solito non pregiudica i creditori (anzi somma asset e debiti); tuttavia, ci sono scenari di fusione inversa o leverage buyout dove la società target assume debiti per far incassare soci e poi si fonde: i creditori potrebbero lamentare un impoverimento. La legge infatti prevede specifiche tutele per i creditori nel LBO (art. 2501-bis c.c.), richiedendo relazione esperto e responsabilità per chi delibera se l’operazione reca danno. Se un LBO interno non rispetta queste regole, i creditori possono attaccarlo come atto illecito.
Le scissioni sono più insidiose: i creditori di norma hanno diritto di opposizione (60 giorni) se ritengono la scissione lesiva. Ma come visto, anche dopo possono agire in revocatoria. Le scissioni “di sopravvivenza” (in cui la società originaria rimane con pochi asset e la beneficiaria prende il grosso) sono quelle tipicamente sospette di spoliazione.
Esempio pratico: Gruppo Zeta: la controllata Omega ha molti debiti bancari garantiti da immobili. La capogruppo realizza una scissione parziale: trasferisce gli immobili da Omega a una NewCo appena costituita (Beta), lasciando in Omega i debiti verso banche. Formalmente, per legge, Omega e Beta sono solidalmente responsabili verso i creditori di Omega pre-scissione, nei limiti del valore attivo rimasto/ricevuto. Ma supponiamo che Omega rimanga praticamente vuota, e Beta riceva immobili per 10 milioni a fronte di zero debiti trasferiti. I creditori banche (se non hanno specifiche garanzie su quegli immobili – se le avevano, peggior scenario: la scissione potrebbe averle pure estinte se non trascritte correttamente) faranno opposizione o, se tardivo, revocatoria. In giudizio, come difendersi? Difficile sostenere genuinità se la tempistica coincide con default incipiente. Il giudice probabilmente dichiarerà la scissione inefficace: Beta dovrà rispondere dei debiti di Omega quantomeno per 10 milioni (valore ricevuto). Se Omega fallisce, il curatore userà la revocatoria fallimentare o l’azione di responsabilità di gruppo per colpire Beta e la holding. Sul piano penale, gli amministratori e i consulenti rischiano l’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione (scissione come mezzo per distrarre immobili). Questa è la dinamica di molti casi giudiziari post-scissione.
Viceversa, consideriamo un’operazione lecita: la fusione per incorporazione di una società interamente controllata con lo scopo di semplificare la struttura e senza impatto negativo su creditori (che anzi ora avranno un unico debitore più robusto). Di solito non viene contestata, a meno che emergano aspetti elusivi particolari (p.es. incorpori una società con crediti d’imposta di dubbia spettanza? ma sarebbe evasione se falsi crediti, non abuso).
Difese e cautele: Quando si pianifica un’operazione straordinaria infragruppo, è fondamentale eseguire un check antielusione e un check anti-frode:
- Sul fronte fiscale: predisporre un Documento di Business Purpose in cui si elencano tutte le ragioni economiche e organizzative dell’operazione e si quantificano i benefici non fiscali. Se, ad esempio, una fusione produce risparmi di costi operativi per X euro e solo incidentalmente consente di compensare utili con perdite, enfatizzare i primi e minimizzare l’aspetto fiscale. Eventualmente valutare di presentare un interpello disapplicativo se si teme la qualifica di abuso (l’interpello anti-abuso può essere presentato per avere certezza che l’operazione non sarà contestata: se l’Agenzia risponde positivamente, immunità; se negativamente, si può ancora rinunciare o modificare l’operazione).
- Sul fronte creditori: se l’operazione incide su garanzie, informare e ottenere il consenso dei principali creditori. Ad esempio, in una scissione, offrire garanzie aggiuntive (art. 2503 c.c. consente di evitare l’opposizione dei creditori prestando garanzie equivalenti). O prevedere nella scissione stessa clausole di solidarietà più ampia di quella legale, per rassicurare i creditori (si può pattuire che tutte le società, e non solo pro-quota, rispondono dei debiti scissi). Documentare che non c’è intento di nuocere: ad esempio, se un consigliere o un socio si oppone in assemblea perché preoccupato per i creditori, e la maggioranza comunque approva, quell’atto interno può poi essere prova a sfavore. Meglio che nel verbale risulti che l’operazione non pregiudica i creditori e perché (ad es. “i debiti finanziari restano su Alfa ma Beta, beneficiaria, fornirà supporto con cash pooling” etc., se vero).
- In caso di contenzioso: per difendersi, oltre alle strategie generali (negare dolo, etc.), portare eventuali pareri professionali acquisiti ex ante. Se la società si era fatta assistere da un legale/fiscalista e ha un parere che l’operazione era legittima e non abusiva, questo non vincola il giudice ma dimostra buona fede e diligenza degli amministratori (utile anche penalmente per escludere dolo).
Sentenze di riferimento: Cass. SU 5089/2025 (scissione e revocatoria) ; Cass. 26283/2016 (abuso conferimento + cessione); Cass. 13294/2017 (scissione+cessione partecipazioni come abuso); Cass. 3738/2018 (riorganizzazione infragruppo con benefici fiscali valutata lecita per valide ragioni extrafiscali). Sul penale: Cass. pen. 46898/2012 (condanna per bancarotta in scissione distrattiva), Cass. pen. 12477/2019 (bancarotta preferenziale per scissione che soddisfaceva un creditore garantendogli beni).
Tabella riepilogativa delle principali operazioni e rischi associati:
| Tipologia operazione | Principali rischi fiscali (abuso) | Principali rischi civilistici/penali |
|---|---|---|
| Finanziamento infragruppo | Deduzione interessi eccedenti valori di mercato; riqualifica in capitale; movimenti anomali in consolidato . | Revocatoria restituzione soci (entro 1 anno); bancarotta preferenziale se ripagato socio prima di fallimento; azione 2497 se svantaggia creditori. |
| Trasferimento bene (vendita/conferim.) | Abuso se sotto/sovra-prezzo per vantaggi fiscali (es. conferimento + cessione quote) ; elusione imposte registro/IVA con schemi infragruppo. | Revocatoria atto in frode se pregiudica creditori ; bancarotta distrattiva se spoglia società poi insolvente; possibile responsabilità ex 2497 della holding. |
| Servizi infragruppo (management fee) | Indeducibilità costi non inerenti o non provati ; contestazione transfer pricing (valore normale) su compensi infragruppo; possibili sanzioni IVA se artificiosi. | Revocatoria pagamenti per servizi fittizi o eccessivi (entro 1 anno in fallimento); bancarotta semplice o preferenziale se dissipano risorse; 2497 c.c. se holding abusa (es. caricando costi inutili). |
| Fusione | Uso strumentale di fusioni per far circolare perdite fiscali (limiti art.172 TUIR, ma possibili contestazioni extra-legge se scopo esclusivo = vantaggio fiscale). | In genere tutela creditori con subentro universale; rischio se finalizzata a confondere responsabilità (potenziale estensione fallimento a società superstite se era unitaria?). In LBO, nullità se in frode a legge, responsabilità amministratori. |
| Scissione | Abuso per conseguimento vantaggi fiscali indebiti (es. isolare plusvalenze in newco e cederla); possibili interventi anti-elusione su scissioni disomogenee. | Azione revocatoria ordinaria o fallimentare ammessa ; bancarotta distrattiva se volta a sottrarre patrimoni; opposizione creditori in sede civile; responsabilità ex 2497 se rovina società scissa. |
| Operazioni miste (es. conferimento + vendita) | Schema tipico di elusione (conferimento tax-free, rivendita partecipazioni con esenzione) – contestato come abuso senza valide ragioni . | Se porta pregiudizio a creditori (conferita parte buona altrove), revocatoria e possibili profili di bancarotta; se holding orchestrata, azione ex 2497. |
(Fonti: art. 10-bis L.212/2000; Cass. 17433/2024 ; Cass. 29936/2023 ; Cass. SU 5089/2025 ; Cass. 12823/2024; Cass. 16442/2024 .)
Strategie operative per prevenire e difendersi dalle contestazioni
Dopo aver esaminato i vari aspetti normativi e le tipologie di operazioni a rischio, riassumiamo ora le strategie operative che un debitore (contribuente o società) può adottare per prevenire contestazioni di abuso del diritto e, se queste insorgono, per difendersi efficacemente. Si fornisce di seguito una check-list operativa e successivamente alcuni modelli indicativi di documenti difensivi.
Check-list operativa (prevenzione & difesa)
- Analisi preliminare dell’operazione: prima di effettuare un’operazione infragruppo straordinaria (es. trasferimenti di beni, scissioni, ecc.), svolgere un’analisi con esperti legali/fiscali. Verificare se l’operazione può comportare risparmi fiscali significativi e se questi appaiono come il motivo principale. In caso affermativo, valutare contromisure (es. modificare la struttura dell’operazione, ottenere un interpello, accumulare documentazione di supporto sulle ragioni extrafiscali).
- Documentare le ragioni economiche (Business Purpose): per ogni operazione infragruppo rilevante, redigere un documento interno che spieghi in dettaglio le motivazioni di business. Includere dati e previsioni: ad esempio, “la fusione Alfa-Beta porterà a risparmi di €X in 3 anni tramite sinergie di produzione e riduzione di costi duplicati, e migliorerà la posizione sul mercato Y” ecc. Evitare di menzionare tra le ragioni il risparmio fiscale (che se anche presente, non va enfatizzato). Questa relazione sarà preziosa da esibire al Fisco o in giudizio per mostrare la sostanza economica .
- Operare a condizioni di mercato: assicurarsi che prezzi, tassi di interesse, canoni, corrispettivi in operazioni infragruppo siano allineati a valori di mercato (arm’s length). Se necessario, commissionare perizie di stima indipendenti per beni immobili, aziende o rami ceduti. Per servizi e finanziamenti, predisporre analisi di transfer pricing o utilizzare benchmark (es. tassi di mercato per prestiti simili). Conservare tali perizie e analisi. Questo non solo aiuta sul piano fiscale (diminuendo la possibilità di contestazione) ma anche sul civile: un creditore troverà più difficile sostenere che un bene è stato svenduto se c’è una perizia a supporto del prezzo.
- Evitare operazioni last-minute in situazioni di crisi: se la società è già in difficoltà finanziarie (o con grossi debiti scaduti), è altamente sconsigliabile compiere atti di trasferimento di ricchezza verso correlate senza coinvolgere i creditori. Piuttosto, valutare soluzioni concordate (piani di ristrutturazione, concordati preventivi) in cui le operazioni infragruppo siano eventualmente parte di un progetto autorizzato dal tribunale e noto ai creditori. Operazioni “d’emergenza” fatte unilateralmente (es. spostare la cassa alla holding, o scindere asset) saranno quasi certamente viste come atti in frode e attaccate con successo.
- Trasparenza e coinvolgimento dei creditori chiave: in operazioni straordinarie come fusioni o scissioni, considerare di informare preventivamente i principali creditori (es. banche) e, se necessario, ottenere il loro consenso o fornire garanzie. Ad esempio, proporre di garantire i debiti della vecchia società anche con il patrimonio della nuova (oltre i limiti legali), formalizzandolo in accordi. Questo potrà evitare opposizioni in sede di registro imprese e costituirà elemento a favore in caso di successiva contestazione (“i creditori erano consapevoli e d’accordo, quindi nessun intento fraudolento”).
- Conservare traccia di ogni prestazione infragruppo: se la holding fattura servizi gestionali, mantenere relazioni periodiche, report di attività, email, qualsiasi prova tangibile del lavoro svolto. Se un dirigente opera per più società, formalizzare contratti di distacco o service, con dettaglio di costi e mansioni. Una delle difese migliori è poter presentare, a fronte di un costo infragruppo contestato, un dossier di documenti che ne provi l’effettività (es. consulenza: ecco il report e il progetto implementato; royalty: ecco il marchio registrato e l’uso che la consociata ne ha fatto). Questo approccio è consigliato anche da prassi – i giudici tributari richiamano spesso la mancanza di prova dei benefici nei costi infragruppo per confermare gli accertamenti .
- Verifica degli obblighi procedurali del Fisco: in caso di contestazione di abuso, controllare che l’Agenzia abbia rispettato l’iter (richiesta di chiarimenti con 60 gg, motivazione specifica nell’accertamento) . Se qualcosa manca, prepararsi a eccepirlo. Ad esempio, se non è stato notificato l’invito a fornire chiarimenti, l’accertamento potrebbe essere nullo per violazione del contraddittorio obbligatorio. Queste “forme” sono tutele sostanziali del contribuente e vanno fatte valere.
- Predisporre una difesa tecnica articolata: qualora si arrivi a contenzioso (tributario o civile), redigere memorie difensive solide, citando la normativa e la giurisprudenza a proprio favore. Ad esempio, nel ricorso tributario citare art. 10-bis comma 9 sul riparto onere prova e giurisprudenza (Cass. 12823/2024) a supporto ; nel costituirsi in revocatoria, citare i limiti di art. 2901 e spiegare perché mancano (nessun eventus damni, ecc.). In sostanza, dimostrare al giudice di conoscere la materia e incanalare la decisione sui punti giuridici più favorevoli.
- Mantenere un approccio collaborativo con le autorità: nel penale, se si è sotto inchiesta, valutare con i legali la possibilità di regolarizzare la posizione tributaria (pagamento del dovuto) perché in alcuni casi ciò attenua la posizione (per alcuni reati tributari l’estinzione del debito estingue il reato o evita aggravanti). Nel tributario, considerare la definizione agevolata se c’è incertezza elevata sull’esito (spesso una transazione con l’Agenzia al giusto momento evita anni di contenzioso e sanzioni elevate). Ciò non significa ammettere l’illecito, ma valutare rischi/benefici.
Questa check-list può fungere da guida operativa. In breve: pianificazione attenta, massima documentazione, valore di mercato, coinvolgimento trasparente degli stakeholder, vigilanza sui diritti procedurali e difesa tecnico-giuridica accurata. Così ci si costruisce la miglior “armatura” contro accuse di abuso del diritto.
Modelli di documenti difensivi
Di seguito vengono forniti schemi sintetici di documenti difensivi che il debitore o il suo legale potrebbe predisporre in caso di contestazione, da adattare alle specifiche situazioni. Si tratta di modelli orientativi, focalizzati sui punti chiave da trattare.
1. Memoria difensiva in risposta a comunicazione di abuso del diritto (ambito tributario)
Scenario: l’Agenzia delle Entrate ha inviato al contribuente una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis, comma 6, L.212/2000, illustrando ipotesi di abuso su una operazione infragruppo e chiedendo chiarimenti entro 60 giorni. Occorre inviare una memoria per evitare o indirizzare l’accertamento.
- Intestazione: Indicare Ufficio dell’Agenzia, riferimento alla comunicazione ricevuta (numero e data) e al contribuente.
- Oggetto: “Memoria esplicativa ai sensi dell’art. 10-bis, comma 7, L.212/2000 – Operazione … (descrizione sintetica)”.
- Premessa di fatto: descrivere brevemente l’operazione contestata. Es: “In data … Alfa Srl conferiva il ramo X nella newco Beta Srl, usufruendo del regime di neutralità di cui all’art. 176 TUIR; successivamente, Alfa Srl cedeva il 100% di Beta Srl alla società Gamma Spa”. Riportare i dati essenziali (valori, date, coinvolti).
- Richiamo della contestazione: Riassumere le ipotesi di abuso sollevate dall’Ufficio. Es: “L’Ufficio ritiene che tale sequenza configurerebbe un abuso del diritto ex art.10-bis, in quanto operazione priva di sostanza economica volta essenzialmente a evitare la tassazione della plusvalenza latente sugli asset conferiti, eludendo l’art. 86 TUIR”. (Dimostrare di aver compreso quali norme asseritamente eluse e quale vantaggio indebito sono indicati).
- Inquadramento normativo: Riaffermare i principi dell’art. 10-bis: libertà di scelta del contribuente, definizione di abuso, onere della prova. Ad esempio: “Si rammenta che costituisce abuso solo l’operazione priva di sostanza economica e rivolta a vantaggi indebiti (art. 10-bis, co.1) e che non si configura abuso laddove esistano valide ragioni extrafiscali non marginali (co.3) . Inoltre, incombe sull’Amministrazione provare la natura abusiva, mentre il contribuente deve evidenziare le proprie ragioni economiche (co.9) . Tali principi sono stati ribaditi da Cass. 12823/2024 ”.
- Esposizione delle ragioni extrafiscali: Cuore della memoria. Elencare in punti le motivazioni economico-giuridiche genuine dell’operazione:
- Riorganizzazione societaria: ad es. “Il conferimento del ramo X in Beta Srl mirava a concentrare l’attività X in un veicolo separato, così da facilitare l’ingresso di un investitore specializzato (come poi avvenuto con Gamma Spa). Ciò ha permesso all’impresa di ottenere nuovi capitali per lo sviluppo, come da piano industriale allegato.”
- Efficienza operativa: “La separazione del ramo X ha comportato benefici gestionali (X occupava settore diverso, separare ha ridotto complessità amministrativa).”
- Situazione di mercato: “Si evidenzia che al momento dell’operazione il settore X era in contrazione; la cessione a Gamma Spa (player più grande) ha garantito continuità al ramo e mantenimento livelli occupazionali.”
- Assenza di vantaggi indebiti: “Il vantaggio fiscale derivante (differimento della plusvalenza) non era il driver: infatti Alfa Srl avrebbe potuto ottenere analogo risultato vendendo gli asset direttamente approfittando del regime PEX, ma ha preferito la via del conferimento per ragioni legate alla due diligence e al passaggio di personale con continuità (contratto di conferimento).”
- Coerenza col comportamento post-operazione: “Dopo il conferimento, Alfa Srl ha effettivamente reinvestito il corrispettivo incassato nella propria attività core (acquisto nuovi macchinari, cfr. documentazione allegata), segno che lo scopo era finanziare tale attività, non mera elusione.”
- Allegare documenti probatori: verbali CDA che approvano l’operazione menzionando motivi industriali, perizie, piano industriale, offerte investitori, ecc.
- Sussistenza di sostanza economica: Argomentare che l’operazione non è artificiosa: “L’operazione ha prodotto effetti economici reali diversi dal risparmio fiscale . Beta Srl è una società pienamente operativa (n. dipendenti, fatturato …), non una scatola vuota. Gamma Spa ha pagato un prezzo in linea col valore di mercato (v. perizia) – non vi è stata alcuna sovra/sotto-fatturazione. Il complesso aziendale conferito continua a produrre reddito e occupazione, indice di effettività.” Richiamare eventualmente Cass. 29936/2023 in merito: l’essere operazione infragruppo o preordinata non implica di per sé abuso se non c’è distorsione .
- Confutazione specifica delle tesi dell’Ufficio: Riprendere eventuali “indizi” citati dall’Ufficio e smontarli. Es: se l’Ufficio parla di “temporalità sospetta” – rispondere perché la tempistica era dettata da fattori di mercato, non dal voler evitare imposte (es. c’era scadenza di un bando, un’opportunità irripetibile). Se sostiene “mancanza di sostanza” – replicare con dati su personale, mezzi, attività effettiva. Se evoca “contrasto con finalità norme” – spiegare come l’operazione rientra invece nelle scelte lecite (ad esempio, il conferimento seguito da cessione non è vietato da alcuna norma antiabuso espressa; il contribuente ha utilizzato due norme esistenti ciascuna rispettandone i requisiti letterali).
- Conclusione e richiesta: “Alla luce di quanto esposto, si ritiene che l’operazione in oggetto non configuri abuso del diritto. Si invita pertanto codesto Ufficio a voler archiviare la contestazione, in difetto dei presupposti di legge, considerando le evidenti ragioni economiche e la sostanza dell’operazione. Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in sede di contraddittorio.”
- Allegati: Elencare tutti i documenti allegati (perizie, business plan, corrispondenza, delibere, ecc.).
Questo documento dev’essere chiaro e ben strutturato, magari con paragrafi numerati, perché verrà letto da funzionari e, se l’accertamento prosegue, finirà nel fascicolo del giudice tributario (che lo valuterà). Mostrare proattività e trasparenza può persino evitare l’accertamento: l’Ufficio, se convinto, potrebbe soprassedere o ridurre la pretesa.
2. Atto di citazione (o comparsa di risposta) in causa civile di revocatoria (ambito creditori)
A seconda che il debitore sia attore (caso raro, sarebbe il curatore ad agire) o convenuto, cambia l’atto. Supponiamo la situazione standard: un creditore ha citato in giudizio la società debitrice e la società del gruppo beneficiaria dell’atto, chiedendo ex art. 2901 c.c. la revoca di un trasferimento infragruppo. La nostra prospettiva è difensiva, quindi consideriamo la comparsa di risposta del convenuto (debitore o terzo convenuto), ossia l’atto con cui ci si difende in giudizio ordinario.
- Intestazione e dati causa: Tribunale competente (es. Tribunale delle Imprese se riguarda atto societario, secondo Cass. SU 5089/2025 ), numero di ruolo, parti (creditore X attore contro società Y debitore e Z società del gruppo convenute).
- Sintesi della domanda attorea: “Il sig. X (attore) chiede dichiararsi l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di … (es. cessione di ramo) stipulato in data … tra Y e Z, deducendo che tale atto è stato compiuto in frode alle sue ragioni creditorie.” Breve riassunto delle allegazioni: “In particolare l’attore assume: (i) che l’atto ha reso insufficiente il patrimonio di Y a soddisfare il credito di €…, configurando eventus damni; (ii) che Y era consapevole del pregiudizio, essendo già moroso verso l’attore all’epoca; (iii) che Z (cessionaria) era a conoscenza della situazione debitoria di Y, trattandosi di società collegata (madre/figlia) e dunque in consilium fraudis.”
- Eccezioni in rito (se ve ne sono): Verificare se la citazione è tempestiva (entro 5 anni dall’atto) altrimenti eccepire prescrizione. Verificare competenza: Cass. SU 5089/25 dice se atto societario (es. scissione) senza fallimento, competenza sez. impresa ; se attore ha sbagliato sezione, eccepire incompetenza. Oppure mancanza legittimazione attore (es. non è creditore certo, liquido ed esigibile? in revocatoria basta sia eventuale, però se credito è contestato altrove, si potrebbe chiedere sospensione in attesa definizione).
- Contestazione nel merito: suddividere per elementi:
a) Insussistenza di eventus damni: Argomentare che l’atto non ha reso il debitore incapiente verso il creditore. Es.: “Alla data della cessione del ramo d’azienda (…/…/…), la società Y conservava un patrimonio sufficiente e rimane tuttora in bonis. Come risulta dal bilancio post-cessione (doc… all.), Y aveva un attivo circolante di €X e altri beni immobili per €Y, a fronte di debiti complessivi inferiori. Il credito dell’attore ammonta a €…, dunque ampliamente garantito. La cessione del ramo è avvenuta a prezzo di mercato (€… pari al valore di perizia), e l’incasso è stato utilizzato da Y anche per pagare debiti (tra cui parzialmente lo stesso attore, come da estratto conto doc…). Pertanto manca il requisito del pregiudizio: l’atto non ha reso più difficile la soddisfazione del credito , semmai ha migliorato la liquidità di Y.” Se l’attore non è ancora insoddisfatto (credito non scaduto o pendenza giudizio sul credito), sottolineare l’assenza di danno concreto e forse chiedere rigetto per carenza attuale di interesse (questo di solito non blocca la revocatoria, ma può convincere se appare prematura).
b) Insussistenza della scientia damni in capo al debitore: “La società Y, al momento dell’atto, non aveva consapevolezza di pregiudicare alcun creditore. Il credito dell’attore era contestato/ non ancora scaduto / di modesta entità rispetto al patrimonio. Y ha agito nella convinzione di migliorare la propria efficienza (cfr. delibera assembleare doc… ove nemmeno si menzionano i creditori). In ogni caso, per la giurisprudenza è richiesto il dolo generico, ossia la mera previsione del pregiudizio : qui tale elemento è assente, in buona fede Y ha ceduto il ramo per ottenere liquidità e concentrarsi su core business, senza alcuna finalità di sottrarre garanzie.” Se utile, citare comportamenti post atto coerenti con buona fede (es. Y ha continuato a pagare i debiti per quanto possibile, non ha occultato l’atto – anzi l’ha pubblicato; male invece se l’ha occultato, ma allora difesa è ardua).
c) Insussistenza (o inconfigurabilità) del consilium fraudis del terzo Z: “La società Z, cessionaria, non era a conoscenza di eventuali intenti fraudolenti di Y. Z ha agito come controparte economica, pagando integralmente il prezzo. Il fatto che Y e Z fossero collegate non implica automaticamente la malafede di Z . Occorre prova concreta che Z fosse consapevole del danno ai creditori (Cass. SU 27466/2013). Nel caso di specie, Z non poteva supporre che Y fosse insolvente, atteso che… (es. Y era sempre stata solvibile, i rapporti infragruppo erano trasparenti, etc.). Inoltre gli amministratori di Z diversi da quelli di Y non avevano visibilità sui debiti verso l’attore.” Se Z è la controllante che ha diretto l’operazione, è dura negare consilium – allora puntare su assenza di danno e su utilità per tutti. Ma se Z è solo un’altra controllata, e magari con amministratori formalmente distinti, si può provare a separare le teste.
- Ulteriori argomenti equitativi (se opportuno): Ad esempio: “L’attore ha abusato dello strumento revocatorio, non avendo nemmeno tentato le vie ordinarie di recupero sul patrimonio residuo di Y, che sarebbe sufficiente. L’azione appare finalizzata ad avvantaggiarlo indebitamente (ottenendo garanzie su beni ceduti) rispetto ad altri creditori parimenti esposti.” – Questo per far vedere al giudice che il creditore sta cercando di ottenere più di quel che gli spetta, magari generando empatia verso la difesa.
- Conclusione: “Si chiede, per tutto quanto esposto, il rigetto integrale della domanda attorea per difetto dei presupposti di legge dell’azione revocatoria. In subordine, qualora fosse ravvisato un pregiudizio, si chiede di limitare l’inefficacia ai soli limiti di tale pregiudizio ex art. 2901 c.c. e 2902 c.c., accertando in ogni caso che eventuali terzi acquirenti in buona fede (se nel frattempo Z avesse rivenduto a terzi) restino salvi (art. 2901, ult. comma). Con vittoria di spese.”
- Documenti allegati: Bilanci prima/dopo, perizie di stima, estratti conto che mostrano pagamento a valore, comunicazioni a creditori (se fatte) magari per opposizione scissione – dimostrano trasparenza, ecc.
Questo schema va adattato caso per caso. Se il contesto è fallimentare e l’azione la fa un curatore, l’approccio è simile ma con in più eventualmente questioni di concorso di azioni (ma SU 2025 risolve: fallimentare vs ordinaria competenza). Si può contestare ad es. che curatore doveva fare revocatoria fall. e non ordinaria – anche se art. 66 l.fall gli permette di scegliere l’una o l’altra, qui complessità oltre scopo.
3. Memoria difensiva in procedimento penale per reati tributari/fallimentari (linee generali)
La difesa penale è un’attività specialistica, qui possiamo solo delineare i punti da evidenziare in una memoria al PM o al GIP/GIU:
- Fatti concreti con cronologia: mostrare contesto: es. “è vero che Tizio (amministratore) trasferì €… alla società collegata, ma ciò avvenne nel …, prima che vi fossero cartelle esattoriali/notifiche di pignoramento; all’epoca l’azienda era ancora operativa. Nessun occultamento: l’operazione è registrata in contabilità e nota ai sindaci.” – serve a contrastare l’idea di fraudolenza nascosta.
- Assenza di artifici o falsità: sottolineare che tutti i documenti erano regolari, non falsificati, l’operazione infragruppo era reale (beni consegnati, servizio svolto). Quindi se reato contestato è frode fiscale (art. 4, dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti), dimostrare che le operazioni esistevano (difesa simile a Cass. 16442/2024: società operativa, non cartiera ). Se reato è bancarotta distrattiva, insistere che il valore di cessione era equo e che la crisi non era evidente al momento (mancanza di dolo).
- Buona fede e consulenze: se l’imputato ha agito su parere di professionisti, allegare quel parere (dimostra che non aveva coscienza di illiceità). La mancanza di dolo specifico può scagionare per reati come sottrazione fraudolenta: se Tizio credeva seriamente di poter pagare le tasse dilazionate e spostò beni per efficienza, non per frodare, manca elemento soggettivo.
- Risoluzione del danno: segnalare se il debito tributario è stato pagato o se i beni distratti sono stati comunque recuperati dal curatore (non scusa il reato già consumato, ma può influire su trattamento sanzionatorio o su qualificazione – es. bancarotta semplice vs fraudolenta).
- Richiami giurisprudenziali: citare Cassazioni come la n. 16442/2024 che impongono di provare inequivocabilmente la natura fittizia di società e operazioni per condannare per frode . Citare eventualmente pronunce su art. 11 DLgs 74/2000: es. Cass. 14428/2017 che richiede comportamenti “fraudolenti” concreti (atti simulati, costitutivi di garanzie fittizie, etc.) per configurare reato – un mero trasferimento reale e trasparente di beni a terzi, pur rendendo più arduo il recupero, potrebbe non integrare la fattispecie se non c’è malizia (questo è borderline, dipende da giudice).
- Conclusione: chiedere archiviazione o proscioglimento, enfatizzando che “il fatto non sussiste” (manca elemento materiale fraudolento) o “manca l’elemento soggettivo del dolo specifico di evadere/distrarre”.
Questa memoria può essere rivolta al PM (in fase indagini) per persuaderlo a chiedere archiviazione, o al GIP in sede di udienza preliminare per sostenere non luogo a procedere, o al giudice dibattimentale per l’assoluzione.
Ovviamente, molto dipende dalle prove raccolte dall’accusa: la difesa qui è soprattutto fattuale.
I modelli sopra delineati vanno personalizzati, ma riflettono un filo conduttore: controbattere punto per punto gli elementi costitutivi della violazione contestata (che sia abuso, atti in frode o reato), supportando le affermazioni con documenti e richiami di legge/sentenze autorevoli. Una struttura logica e una ricostruzione alternativa credibile dei fatti possono cambiare l’esito.
Domande e risposte frequenti (FAQ)
D: Che cos’è l’abuso del diritto in ambito tributario?
R: L’abuso del diritto tributario è una condotta elusiva in cui il contribuente utilizza strumenti giuridici leciti in modo artificioso al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale indebito, in contrasto con la finalità delle norme fiscali . In altre parole, pur rispettando formalmente le leggi, realizza operazioni prive di sostanza economica reale che gli fanno pagare meno imposte del dovuto. Se l’Amministrazione prova che un’operazione è priva di sostanza e mira essenzialmente a un risparmio d’imposta, può disconoscerne i benefici fiscali invocando la clausola antiabuso (art. 10-bis L.212/2000) . Ad esempio, creare società fittizie per spostare utili all’estero o frammentare artificiosamente attività per godere di esenzioni sono possibili abusi. Va distinto dall’evasione: nell’abuso non c’è violazione immediata di legge (nessuna falsa fattura o omessa dichiarazione), ma un uso distorto di norme per fini contrari al loro scopo.
D: Qual è la differenza tra elusione fiscale (abuso del diritto) ed evasione fiscale?
R: L’evasione fiscale consiste nella violazione diretta di norme tributarie – ad esempio, occultare redditi, emettere false fatture, non presentare le dichiarazioni – al fine di non pagare imposte dovute. È un illecito violento contro la legge, spesso di rilevanza penale (frode fiscale, ecc.). L’elusione fiscale (sinonimo di abuso del diritto tributario) invece avviene quando il contribuente rispetta formalmente le regole, ma le combina in modo artificioso per ottenere un vantaggio fiscale che il legislatore non aveva previsto di concedere . In pratica l’elusione “si infila nelle pieghe” della legge, sfruttando scappatoie senza infrangere un divieto esplicito. Le conseguenze differiscono: l’evasione comporta sanzioni amministrative e penali (in certi casi, es. dichiarazione fraudolenta), mentre l’elusione comporta il recupero delle imposte e sanzioni amministrative, ma non costituisce reato . Ad esempio: non dichiarare affitti percepiti è evasione; invece intestare l’immobile a una società per usufruire di un regime fiscale più favorevole, pur continuando a goderne personalmente, può essere elusione (se fatto senza valide ragioni economiche).
D: Le operazioni infragruppo sono di per sé sospette di abuso?
R: No, non automaticamente. Non esiste alcuna presunzione legale che i rapporti infragruppo siano abusivi. La Cassazione ha espressamente affermato che la mera appartenenza a un gruppo societario non è di per sé indice di abuso . Occorre valutare caso per caso. Certo, le operazioni infragruppo vengono monitorate con attenzione dal Fisco e dai creditori perché in un gruppo è più facile spostare basi imponibili o patrimoni. Ma se un’operazione infragruppo risponde a logiche di mercato e ha sostanza economica – ad esempio, un reale finanziamento con tasso di mercato, una vendita a prezzo equo, una fusione per vere sinergie – non c’è abuso solo perché avviene “in famiglia”. L’abuso scatta quando l’operazione non avrebbe senso economico al di fuori dei benefici fiscali e sembra fatta solo per quelli. In sintesi: operare infragruppo richiede trasparenza e valori normali, ma non è vietato né presunto illecito a priori.
D: Quali sono esempi tipici di operazioni infragruppo contestate come abuso del diritto?
R: Alcuni esempi ricorrenti: – Conferimento + cessione: conferire asset (azienda, immobile) in una newco del gruppo in neutralità d’imposta e poi venderne le quote usufruendo di un’esenzione (participation exemption), evitando di tassare la plusvalenza sugli asset. Questo schema è stato spesso contestato come abuso , perché senza valide ragioni è un aggiramento dell’imposizione sulla cessione diretta. – Scissione societaria prima di cedere partecipazioni: analogo al precedente. Scindere una società separando beni in una beneficiaria e poi cedere quest’ultima, riducendo il carico fiscale. Se fatto solo per risparmio fiscale, la Cassazione lo vede come abuso (e i creditori come frode, se li pregiudica). – Uso di società estere del gruppo (esterovestizione): allocare fittiziamente la residenza o i profitti in una controllata estera (spesso società di comodo) con fiscalità inferiore. Esempio: una società italiana crea una LTD in un paradiso fiscale e le fattura servizi inesistenti per spostare utili. Questo è abuso (oltre che potenzialmente evasione se occultano profitti). Cass. 10305/2024 ha definito tali società schermo e indicato indici per smascherarle . – Finanziamenti infragruppo anomali: ad esempio trasformare un apporto di capitale in un prestito per dedurre interessi, o far pagare interessi eccessivi a una consociata per spostare reddito imponibile. Se non giustificato da condizioni di mercato, è contestato (anche via norme su prezzi di trasferimento). – Triangolazioni IVA infragruppo: schemi per generare crediti IVA o applicare regimi di favore (magazzini fittizi ecc.). La Corte UE li bolla come abuso se fatti senza reale scopo commerciale. – Gestione centralizzata costi: far addebitare la maggior parte dei costi di gruppo a una società con utili per erodere la base imponibile (soprattutto in consolidato fiscale). Cass. 17433/2024 ha di fatto sancito l’inammissibilità di spostare costi tra consolidate senza base economica .
Ogni volta il filo conduttore è: l’operazione era formalmente lecita ma sostanzialmente insensata se non per risparmiare tasse.
D: Come valuta l’Agenzia delle Entrate se un’operazione infragruppo è abusiva?
R: Applica il test dell’art. 10-bis: verifica la sostanza economica e le ragioni extrafiscali. In pratica, esamina: – Se l’operazione ha prodotto effetti economici significativi al di là del vantaggio fiscale. Sono cercati indizi di artificiosità: ad esempio, uso di società prive di struttura, operazioni circolari (denaro che torna al mittente), atti giuridici complessi ma inutili nella pratica se non per risparmiare imposte, incongruenze rispetto alle logiche di mercato . – Se c’erano motivazioni non fiscali credibili e non marginali: espansione commerciale, riorganizzazione per efficienza, necessità regolamentari, esigenze finanziarie reali, ecc. . Se sì, e il risparmio fiscale appare conseguenza secondaria di scelte di business, di regola non c’è abuso (co.3 art. 10-bis). – Inoltre, l’Agenzia deve seguire la procedura: prima invia una comunicazione al contribuente spiegando perché sospetta l’abuso e chiedendo chiarimenti . Valuta la risposta del contribuente (che dovrebbe dettagliare le ragioni economiche). Solo dopo, eventualmente, emette l’accertamento, che deve motivare in modo articolato le ragioni dell’abuso (norme eluse, vantaggi indebiti) confutando le giustificazioni fornite . L’onere della prova iniziale è suo , deve mostrare gli elementi di anomalia; se ci riesce, spetta al contribuente dimostrare i motivi extrafiscali . In sintesi, l’AdE adotta un approccio “substance over form”: guarda oltre la forma giuridica, all’essenza economica. Si aiuta anche con banche dati e analisi del rischio (dal 2024 anche sistemi di IA anti-evasione, come previsto dal d.lgs. 12/2024 citato in fonti ). Ad esempio, rileva se una società dichiara molte operazioni infragruppo anomale (costi elevati verso consociate, utili bassi incoerenti col fatturato, etc.) e può avviare controlli mirati.
D: In caso di contestazione fiscale per abuso, quali sanzioni e conseguenze rischia il contribuente?
R: Principalmente, il recupero delle imposte che si sarebbero dovute pagare se non si fosse messa in atto l’operazione abusiva. L’Agenzia ridetermina le basi imponibili “come se” l’operazione elusiva non fosse mai esistita . Ad esempio, se grazie a uno schema elusivo l’azienda ha risparmiato 100 di tasse, verranno richiesti quei 100, oltre agli interessi maturati. Inoltre si applicano le sanzioni amministrative tributarie per dichiarazione infedele. La norma (art. 10-bis co.13) stabilisce che l’abuso non è reato , ma non esonera dalle sanzioni amministrative. Queste in genere sono dal 90% al 180% dell’imposta evasa, salvo definizioni agevolate. Non essendoci violazione “formale”, l’illecito è considerato colposo (il contribuente poteva interpretare diversamente la norma): spesso le sanzioni vengono irrogate comunque, ma in certe circostanze si può chiedere l’esclusione se si prova buona fede e incertezza normativa (non facile). Dunque, in soldoni, l’esito più comune è: pagamento imposte evitate + sanzioni + interessi. Non ci sono pene detentive né casellario giudiziale, perché non è reato . Però un abuso accertato può comportare altri effetti: – Reputazionali e di vigilanza: per società quotate o vigilate, contestazioni di abuso possono far scattare obblighi di comunicazione o incidere su rating, rapporti con stakeholder. – Costo del contenzioso: se non si definisce e si fa ricorso, c’è il rischio di lunghe cause fino in Cassazione (costi legali, incertezza). – In casi molto gravi, l’Agenzia può trasmettere atti alla Procura, ma solo se ravvisa profili penali reali (es. scopre che l’abuso celava in realtà una frode con falsi documenti). In conclusione: il contribuente accusato di abuso rischia sul piano patrimoniale (pagare quanto “risparmiato” con sovrappiù di sanzioni), ma non sul piano penale in quanto tale contestazione rimane nell’alveo amministrativo.
D: Un creditore sociale può agire se una società sposta beni a un’altra del gruppo non lasciando abbastanza garanzie?
R: Sì, il creditore ha strumenti per reagire. Il principale è l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), grazie alla quale può far dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto di disposizione compiuto dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni . Ad esempio, se la società debitrice mi deve €100 e trasferisce il suo unico immobile a una società collegata, io – creditore – posso chiedere al tribunale di revocare quella vendita, così da poter pignorare l’immobile come se fosse ancora del debitore. Devo però provare: – che l’atto ha leso la mia garanzia (il debitore è diventato meno solvibile: eventus damni), – che il debitore lo sapeva (scientia damni) e, se l’atto è a titolo oneroso, che il terzo acquirente era consapevole della frode (consilium fraudis) . Se l’operazione infragruppo è gratuita o palesemente squilibrata, è più facile revocarla; se era a valore di mercato e il debitore era ancora solvibile, è più difficile. Un altro strumento, se la società debitrice fallisce, è la revocatoria fallimentare esercitata dal curatore, con termini e presunzioni proprie (atti entro 1-2 anni prima del fallimento). Inoltre, in caso di gruppi, esiste l’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c.: i creditori di una società eterodiretta possono chiedere danni alla capogruppo se questa ha abusato dell’attività di direzione causando danno al patrimonio della controllata . Esempio: la holding impone alla controllata di trasferirle beni o di pagare debiti del gruppo, e la controllata resta insolvente – i creditori di quest’ultima possono citare la holding per farsi risarcire il danno (fino ai crediti non soddisfatti). Questa è una responsabilità “da abuso di direzione e coordinamento”. In sintesi, il creditore non è inerme: se vede spostamenti infragruppo sospetti può ricorrere al giudice per tutelarsi. Va fatto tempestivamente (la revocatoria ordinaria va iniziata entro 5 anni dall’atto) . Da notare che se l’atto è una fusione/scissione, c’è stato dibattito sulla revocabilità; ma la Cassazione a Sezioni Unite 2025 ha confermato che anche gli atti di scissione possono essere revocati se in frode ai creditori .
D: Dopo quanti anni un’operazione infragruppo “a rischio” non è più contestabile?
R: Dipende dal tipo di contestazione: – Dal Fisco (abuso): l’accertamento per abuso del diritto segue i termini ordinari di accertamento fiscale. In genere 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (se la dichiarazione del periodo è stata presentata) oppure del settimo anno se omessa dichiarazione. Quindi se un abuso incide sul reddito 2019 (dichiarazione presentata nel 2020), l’Agenzia ha tempo fino al 31/12/2025 per contestarlo. Dopo, scatta la decadenza. Dunque, un’operazione di fine 2019 che ha effetto sulla dichiarazione 2020 sarà “al sicuro” dal Fisco (salvo casi di omessa dichiarazione) dopo fine 2025. L’abuso è un motivo di rettifica dei tributi, non un atto autonomo, quindi conta il periodo d’imposta che ha influenzato.
– Dai creditori (revocatoria): l’azione revocatoria ordinaria si prescrive in 5 anni dal compimento dell’atto . Ad esempio, se una cessione infragruppo è del marzo 2020, entro marzo 2025 i creditori devono citarla in giudizio, altrimenti perdono il diritto. In caso di fallimento, la revocatoria fallimentare ha termini più brevi (atti a titolo oneroso 1 anno, gratuiti 2 anni prima, pagamenti preferenziali 6 mesi-1anno) ma se il curatore non agisce, i creditori individuali possono ancora fare la loro ordinaria entro i 5 anni. – Penale tributario: i reati come la sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (art. 11) hanno prescrizione penale (6 anni base, 7.5 con atti interruttivi, spesso aumentata se soglia alta). Ma l’importante è: se passano i termini di accertamento fiscale e l’Agenzia non ha contestato nulla, è difficile che parta un penale oltre, perché di solito l’iniziativa penale scaturisce da verifiche fiscali. Similmente per bancarotta, se sono trascorsi molti anni dall’atto infragruppo e non c’è fallimento, viene meno anche il presupposto di procedibilità (senza fallimento non c’è bancarotta). Riassumendo: 5 anni è un numero chiave per molte possibili azioni civili e per l’accertamento fiscale usuale. Trascorsi 5 anni, l’operazione è di regola prescritta rispetto a revocatorie e decaduta rispetto a nuovi accertamenti tributari (salvo che emergano elementi di reato – ma quelli di solito sarebbero emersi prima). Attenzione però: se un atto abusivo ha effetti protratti (es. si deducono ammortamenti per 20 anni su un bene conferito sotto valore), ogni anno c’è un potenziale abuso che si rinnova. Dopo 5 anni dall’ultimo effetto, si prescrive. Insomma, il decorso del tempo gioca a favore del contribuente/debitore, ma va valutato caso per caso.
D: Se ho agito in buona fede, rileva qualcosa nelle contestazioni di abuso?
R: In ambito tributario, l’abuso è oggettivo: non importa l’intento soggettivo del contribuente, conta la natura dell’operazione (salvo eventualmente per attenuare sanzioni). Quindi anche se in buona fede pensavi che una struttura fosse legittima, l’Agenzia può comunque contestarla come abuso se soddisfa i criteri (assenza di sostanza, vantaggio indebito) . Non è una violazione penale che richiede dolo; è più un risultato che viene disconosciuto. Tuttavia, la tua buona fede può riflettersi in certi aspetti: – L’art. 10-bis è formulato in modo da non punire il contribuente che sfrutta opzioni di legge lecite: se c’era una ragionevole scelta tra due regimi, non dovrebbe considerarsi abuso punibile la scelta più conveniente . Quindi se eri in buona fede seguendo una interpretazione plausibile, potresti farlo valere. – In sede sanzioni amministrative, se dimostri incertezza normativa oggettiva (norme poco chiare) e di aver agito con la diligenza di un buon padre di famiglia (magari con pareri professionali), puoi chiedere la non applicazione delle sanzioni (principio sancito dallo Statuto del Contribuente art. 10, comma 3). Non sempre l’Agenzia lo riconosce, ma in giudizio può essere considerato (specie se l’abuso era ante 2015, quando la disciplina non era codificata). – In ambito penale, la buona fede è invece cruciale: se ti contestano reati tributari o bancarotta, poter dimostrare che non avevi consapevolezza di violare la legge o intento di frode può scagionarti, perché lì serve il dolo. Ad esempio, in un caso di presunta sottrazione fraudolenta di beni, se provi che credevi di poter comunque pagare i creditori e di non volerli danneggiare, potresti far mancare l’elemento soggettivo. Quindi, in sede fiscale amministrativa la buona fede non evita il recupero dell’imposta se la struttura è considerata abusiva, ma può aiutare a evitare sanzioni o a spiegare meglio le ragioni. È sempre bene operare consulendosi con esperti e magari cercando interpello se incerti: se ottieni un interpello favorevole, sei protetto; se neanche gli esperti erano concordi, dimostri che c’era incertezza. In sostanza: la buona fede non “assolve” dall’abuso in senso stretto, ma male non fa e ti tutela da conseguenze peggiori (sanzioni al minimo, niente accusa di frode).
D: Come posso prevenire accuse di abuso del diritto nelle operazioni infragruppo?
R: Ecco alcune best practice: – Pianificazione trasparente: Progettare operazioni infragruppo sempre con un occhio agli aspetti di sostanza. Chiedersi “farei questa operazione se non ci fosse il vantaggio fiscale?” Se la risposta è no, occorre ripensarla o dotarla di sostanza (trova anche altri benefici). – Valide ragioni extrafiscali: Assicurarsi di avere motivazioni economiche reali e documentarle per iscritto (delibere consiliari, relazioni). Ad esempio, motivare un trasferimento di beni con ragioni industriali (riorganizzazione di divisioni, aggregazione per filiere, ecc.). – Arm’s length e perizie: Scambiare beni e servizi infragruppo a valori di mercato. Far fare perizie per beni rilevanti, stabilire contratti per i servizi con logiche adottate anche verso terzi. Questo riduce sospetti di artificio. – Consultare l’Amministrazione con interpello: In caso di operazioni complesse, usare l’interpello antiabuso (art. 11, c.1, lett. c) L.212/2000). Si sottopone il caso all’Agenzia prima di farlo e si chiede se sarebbe considerato abuso. La risposta (entro 90 gg) vincola l’Amministrazione: se dice “sì, è abuso”, almeno lo sai prima e puoi cambiare piano; se dice “no, non è abuso”, hai una protezione totale – quell’operazione non potrà più essere contestata come abuso. – Mantere documentazione accurata: Conservare tutti i documenti di supporto – contabili, corrispondenza, studi di consulenti – che dimostrino la genuinità delle operazioni. Se anni dopo arriva un controllo, poter esibire un fascicolo con contratti, report, analisi di convenienza economica dell’operazione avrà un forte impatto nel dimostrare la buona fede e la sostanza. – Non esagerare con le strutture “creative”: Se un’operazione può essere fatta in modo più lineare, fallo così, anche se paghi un po’ più di imposte. L’abuso nasce spesso quando si complicano inutilmente i passaggi per ottenere vantaggi. Ad esempio, invece di fare tre passaggi infragruppo per spostare un immobile e risparmiare il registro, valuta se ne vale la pena: potrebbe essere più sicuro accollarsi l’imposta, piuttosto che rischiare anni di contenzioso (specialmente ora che il MEF ha chiarito che differimenti lunghi possono essere considerati vantaggi abusivi ). – Formazione interna e compliance: Se sei un’impresa grande, crea policy interne sulle transazioni infragruppo, magari con un comitato che le valuta indipendentemente. Mantieni anche un registro delle operazioni infragruppo significative e del razionale dietro ognuna, per memoria storica. In pratica, si tratta di adottare la mentalità della sostanza: fai in modo che ogni operazione intragruppo abbia vero senso e potresti spiegarla a un giudice con serenità, senza dover dire “l’ho fatto per risparmiare tasse” come unica motivazione. Così ti metti al riparo.
D: Cosa devo fare se l’Agenzia delle Entrate contesta un abuso del diritto?
R: Non farsi prendere dal panico e: 1. Leggere attentamente la contestazione (sia essa una lettera di chiarimenti o direttamente un avviso di accertamento). Capire quali operazioni sono nel mirino e quali norme avrebbero eluso secondo l’Ufficio. 2. Se è una richiesta di chiarimenti (fase preventiva): hai 60 giorni per rispondere. Usa questo tempo saggiamente: raccogli documenti, fatti aiutare da un fiscalista esperto e prepara una memoria difensiva dettagliata (come quella descritta prima). Argomenta tutte le ragioni economiche e spiega l’operazione. Questa è spesso l’ultima occasione per convincere l’Agenzia a desistere o ridimensionare. 3. Se è già un avviso di accertamento: valuta se ci sono errori procedurali (mancata richiesta di chiarimenti, motivazione carente). Entro 60 giorni dalla notifica non pagare subito: hai tempo per il ricorso. Puoi eventualmente presentare istanza di accertamento con adesione (sospende i termini per 90 giorni) per trattare un’eventuale conciliazione. Se la somma non è enorme e la posizione non è difendibilissima, l’adesione può portare a un compromesso con sanzioni ridotte. 4. Prepara il ricorso in Commissione Tributaria se ritieni di aver buone ragioni o se la pretesa è elevata. Il ricorso va presentato entro 60 giorni (o 150 se fai prima adesione) dalla notifica. Nel ricorso ribadisci in diritto e in fatto perché non c’è abuso, allega la documentazione e magari cita precedenti a te favorevoli. È importante essere assistiti da un avvocato tributarista o commercialista esperto di contenzioso fiscale. 5. Valuta soluzioni deflattive: a seconda dei casi, potresti optare per la mediazione (obbligatoria se importo < €50k) o una conciliazione in udienza. Oggi esistono anche definizioni agevolate (pace fiscale) se il governo le prevede: verifica se rientri in qualcuna (ad es. definizione in acquiescenza con sanzioni ridotte ad 1/3 se rinunci al ricorso). 6. Pagamenti e garanzie: ricorda che dopo l’accertamento, per evitare misure cautelari, potresti chiedere la sospensione in Commissione se il ricorso è fondato e c’è rischio grave per l’azienda dal pagamento immediato. Altrimenti potresti dover versare 1/3 delle imposte a seguito della notifica dell’intimazione dopo 60gg (ma attento: con la riforma 2023 la riscossione potrebbe essere posticipata a dopo la sentenza di primo grado per gli atti dal 2023 in poi – verifica la normativa vigente). In sintesi: rispondi punto su punto alle tesi dell’Agenzia, esercita i tuoi diritti nel procedimento (contraddittorio) , e se non si risolve, impugna l’atto motivando bene. Molti giudici tributari sono sensibili al principio che il contribuente può scegliere la via fiscale meno onerosa se ha ragioni valide – citarlo e dimostrare le tue ragioni può portare all’annullamento dell’atto.
D: Come difendersi da un’azione revocatoria sui trasferimenti infragruppo?
R: Se un creditore (o un curatore) agisce in revocatoria sostenendo che un’operazione infragruppo ha leso i suoi diritti, devi: – Analizzare i requisiti di legge (eventus damni, scientia, consilium). Individua il punto debole della sua domanda. Ad esempio, puoi puntare sul fatto che non c’è stato vero danno perché il debitore aveva altri beni o il corrispettivo è rimasto nel patrimonio. Oppure che mancava la consapevolezza: il debitore magari era in bonis all’epoca. – Raccogliere prove contrarie: Bilanci, inventari patrimoniali, estratti bancari per dimostrare la situazione patrimoniale prima e dopo l’atto. Testimonianze o documenti che mostrano che il debitore pagava regolarmente i debiti (non segnale di insolvenza). Se il terzo convenuto (es. società acquirente) può testimoniare di non sapere di eventuali trucchi, predisponi dichiarazioni. – Contestare formalmente nella comparsa di risposta: come nello schema sopra: no pregiudizio, no malafede. Ad esempio, far notare se il creditore era chirografario e dopo l’atto è comunque garantito da patrimonio residuo o da garanzie. – Se possibile, transare: a volte la via più pragmatica è un accordo. Il creditore magari vuole solo assicurarsi che verrà pagato. Si può trovare un’intesa per cui l’atto resta valido ma la società del gruppo (terzo convenuto) si impegna a pagare quel creditore (ad es. accollandosi il debito). Questo può portare a rinuncia alla revocatoria. – Aspetti procedurali: verifica la competenza (come detto, se è atto societario, tribunale imprese) ; e la legittimazione (il creditore deve avere un credito certo – se sta ancora litigando col debitore sull’esistenza del credito, la revocatoria di solito si può iniziare ma potrebbe essere sospesa finché il credito non è accertato). – Difesa penale parallela: se dall’azione revocatoria nasce anche un’inchiesta per bancarotta o frode, coordina la difesa civile con quella penale (attenzione a dichiarazioni che in civile potresti fare ma che in penale potrebbero nuocere). In breve, per vincere devi convincere il giudice che non c’era una “frode” ai creditori: l’operazione aveva senso legittimo e non ha tolto la garanzia dovuta al creditore o comunque tu debitore non l’hai fatta con quell’intento. Spesso se il creditore è rimasto poi soddisfatto (anche parzialmente) o se appare che sta esagerando, il giudice può guardare con occhio critico la sua domanda. Al contrario, se è evidente che il debitore ha impoverito il patrimonio e è insolvente, la difesa sarà difficile.
Nota finale: In caso di dubbi specifici su situazioni concrete, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista (avvocato tributarista o civilista) data la complessità della materia e le continue evoluzioni normative e giurisprudenziali. La presente guida riflette lo stato dell’arte ad agosto 2025 basandosi su fonti autorevoli e pronunce aggiornate, ma ogni caso reale va calibrato sulle sue peculiarità.
Fonti (principali normative e sentenze citate):
- Statuto del Contribuente, L. 212/2000, art. 10-bis (Disciplina dell’abuso del diritto fiscale).
- Codice Civile, art. 2901 (Azione revocatoria ordinaria) ; art. 2497 (Responsabilità da direzione e coordinamento di società).
- D.Lgs. 74/2000, art. 11 (Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).
- Cass., Sez. Unite civ., 26-02-2025 n.5089 – Revocatoria di scissione e competenza.
- Cass., Sez. V trib., 16-04-2024 n.10305 – Abuso del diritto e società schermo.
- Cass., Sez. V trib., 27-10-2023 n.29936 – Leasing infragruppo e onere della prova dell’elusione.
- Cass., Sez. V trib., 10-05-2024 n.12823 – Doppio onere probatorio nell’abuso (oneri di Fisco e contribuente) .
- Cass., Sez. III pen., 19-04-2024 n.16442 – Frode IVA infragruppo, necessità di provare società cartiera (operatività reale).
- Cass., Sez. V trib., 25-06-2024 n.17433 – Inammissibilità spostamento costi tra società consolidate (principio di inerenza per ciascuna).
- Atto di indirizzo MEF 27-02-2025 n. 7 – Linee guida applicative sull’abuso del diritto.
- Art. 2901 codice civile – Condizioni.
- Sentenze di ottobre 2024 – giugno 2025.
- Corte di Cassazione (5458/2023) – Differenza tra supersocietà di fatto, fallibile in estensione a seguito del fallimento di un suo socio e holding di fatto eventualmente fallibile autonomamente a richiesta dei soggetti a ciò legittimati.
- Art. 11 legge sui reati tributari – Sottrazione fraudolenta.
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 17433 depositata il 25 giugno 2024 – Non può ammettersi la “compensazione” di voci del conto economico di rilievo fiscale che, in violazione del disposto dell’art. 109 TUIR, determini lo spostamento di oneri o compensi da una società all’altra, pur appartenenti al medesimo consolidato fiscale, e ciò attesa la tassatività è inderogabilità delle regole che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa di ciascuna società.
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate considera alcune operazioni infragruppo come abuso di diritto? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate considera alcune operazioni infragruppo come abuso di diritto?
Vuoi sapere cosa rischi e come puoi difenderti da queste contestazioni?
Le operazioni tra società appartenenti a uno stesso gruppo (finanziamenti, cessioni di beni, prestazioni di servizi, riorganizzazioni) sono legittime se motivate da ragioni economiche reali. Tuttavia, il Fisco può riqualificarle come elusive se ritiene che siano state fatte con l’unico scopo di ottenere un risparmio fiscale.
👉 Prima regola: documenta sempre le operazioni infragruppo con contratti, perizie e giustificazioni economiche.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Finanziamenti infragruppo con tassi non congrui rispetto al mercato;
- Cessioni di beni o servizi a prezzi anomali, inferiori o superiori ai valori di mercato;
- Riorganizzazioni societarie (fusioni, scissioni, conferimenti) considerate prive di motivazioni economiche;
- Operazioni circolari che producono solo effetti fiscali senza reale sostanza;
- Utilizzo di società veicolo o localizzate in Paesi a fiscalità agevolata.
📌 Conseguenze della contestazione
- Disconoscimento dei vantaggi fiscali ottenuti;
- Recupero delle imposte ritenute evase (IRES, IRAP, IVA);
- Applicazione di sanzioni per abuso del diritto;
- Interessi di mora;
- Rischio di accertamenti su altre operazioni del gruppo.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Ragioni economiche: l’operazione aveva obiettivi gestionali, organizzativi o patrimoniali concreti?
- Documentazione contrattuale: esistono contratti e delibere regolarmente registrati?
- Valori di mercato: i prezzi applicati sono congrui secondo le regole di transfer pricing?
- Motivazione dell’accertamento: l’Agenzia deve dimostrare l’assenza di sostanza economica;
- Regolarità della notifica e rispetto dei termini di decadenza.
🧾 Documenti utili alla difesa
- Contratti infragruppo e delibere societarie;
- Bilanci e relazioni illustrative delle operazioni;
- Perizie di stima e analisi economiche;
- Documenti di transfer pricing e comparazioni di mercato;
- Estratti conto e prove delle movimentazioni finanziarie;
- Report interni che spieghino le finalità gestionali.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare le ragioni extrafiscali delle operazioni infragruppo;
- Contestare l’applicazione dell’abuso di diritto quando il risparmio fiscale non era l’unico scopo;
- Eccepire vizi formali dell’accertamento: motivazione insufficiente, decadenza, notifica irregolare;
- Richiedere autotutela in caso di contestazioni prive di fondamento documentale;
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni, con possibilità di sospendere il recupero;
- Mediazione tributaria per ridurre sanzioni e definire la controversia.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’operazione infragruppo contestata e la ricostruzione del Fisco;
📌 Verifica la congruità economica e fiscale delle operazioni;
✍️ Redige memorie difensive e ricorsi per tutelare la legittimità delle scelte aziendali;
⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nei giudizi tributari;
🔁 Suggerisce strategie preventive per pianificare operazioni infragruppo in sicurezza.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in abuso del diritto e operazioni straordinarie societarie;
✔️ Specializzato in difesa di gruppi societari contro contestazioni fiscali;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle operazioni infragruppo come abuso di diritto non sempre hanno basi solide: spesso derivano da interpretazioni restrittive o da presunzioni.
Con una difesa mirata puoi dimostrare le reali ragioni economiche delle operazioni, evitare la riqualificazione come elusive e proteggere il tuo gruppo da pretese fiscali indebite.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti sulle operazioni infragruppo inizia qui.