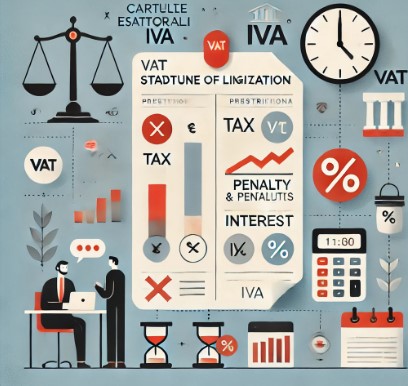Hai ricevuto una cartella esattoriale per debiti IVA e vuoi sapere se è ormai prescritta? La prescrizione non è uguale per tutti i componenti della cartella: imposta, sanzioni e interessi seguono regole diverse. Conoscerle è fondamentale per difendersi da pretese illegittime dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Prescrizione dell’imposta IVA
– L’IVA è un tributo armonizzato a livello europeo.
– Per la riscossione coattiva, la giurisprudenza prevalente riconosce un termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).
– Questo significa che l’imposta può essere richiesta per dieci anni dalla notifica della cartella, salvo atti interruttivi della prescrizione (es. intimazioni di pagamento, pignoramenti).
Prescrizione delle sanzioni IVA
– Le sanzioni amministrative tributarie seguono una disciplina diversa.
– Si prescrivono in cinque anni, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997.
– Trascorso questo termine senza validi atti interruttivi, le sanzioni non possono più essere richieste.
Prescrizione degli interessi IVA
– Gli interessi hanno natura accessoria rispetto al debito principale.
– In base all’art. 2948 c.c., si prescrivono in cinque anni.
– Anche in questo caso, eventuali atti interruttivi fanno decorrere nuovamente il termine.
Cosa significa in pratica
– Può accadere che l’imposta sia ancora esigibile perché soggetta al termine decennale, ma che sanzioni e interessi siano prescritti dopo cinque anni.
– È quindi fondamentale distinguere le voci della cartella per eccepire correttamente la prescrizione.
Come difendersi da una cartella IVA prescritta
– Verificare la data di notifica della cartella e degli eventuali atti successivi di interruzione
– Contestare la prescrizione parziale per le sanzioni e gli interessi, anche se l’imposta resta dovuta
– Eccepire la prescrizione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria con ricorso tempestivo
– Richiedere la sospensione delle procedure esecutive se la cartella si basa su crediti ormai prescritti
– Dimostrare la nullità degli atti interruttivi se notificati in modo irregolare
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la cartella e gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione
– Verificare la decorrenza dei termini di prescrizione per imposta, sanzioni e interessi
– Predisporre ricorso mirato per ottenere l’annullamento parziale della cartella
– Contestare le pretese indebite e chiedere la sospensione immediata delle azioni esecutive
– Tutelare il contribuente da pignoramenti, fermi e ipoteche illegittime
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della cartella esattoriale
– L’eliminazione di sanzioni e interessi prescritti, riducendo notevolmente il debito
– La sospensione di procedure esecutive già avviate
– La protezione del patrimonio personale e aziendale
– La certezza di pagare solo quanto realmente dovuto e non crediti ormai prescritti
⚠️ Attenzione: la prescrizione non opera automaticamente, deve essere eccepita dal contribuente. Se non viene contestata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può continuare a richiedere somme non più dovute.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria – ti spiega come funziona la prescrizione delle cartelle esattoriali IVA e quali differenze ci sono tra imposta, sanzioni e interessi.
👉 Hai ricevuto una cartella esattoriale IVA e sospetti che sia prescritta? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua cartella, verificheremo i termini di prescrizione e costruiremo la strategia difensiva più efficace per proteggerti.
Introduzione
La cartella esattoriale – oggi più propriamente chiamata cartella di pagamento – è l’atto con cui l’agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) intima al contribuente il pagamento di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Nel caso dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), la cartella esattoriale può scaturire da omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione annuale IVA, oppure da un avviso di accertamento divenuto definitivo. Una volta notificata la cartella, il debitore ha generalmente 60 giorni di tempo per pagare; trascorso tale termine senza pagamento, la cartella costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva.
Un aspetto cruciale per i debitori è capire fino a quando la cartella esattoriale può essere legalmente riscossa. In altre parole, occorre determinare i termini di prescrizione del credito iscritto a ruolo. La particolarità, nel caso delle cartelle IVA, è che il termine di prescrizione non è unico per tutte le componenti del debito, ma varia a seconda che si tratti dell’imposta principale (IVA non versata), delle sanzioni amministrative tributarie applicate (multe/penalità per violazioni fiscali) o degli interessi di mora maturati sul debito stesso. Questa guida avanzata, aggiornata ad agosto 2025, esamina in dettaglio i diversi termini di prescrizione applicabili alle cartelle esattoriali riferite a debiti IVA, evidenziando le differenze tra imposta, sanzioni e interessi dal punto di vista del debitore. Verranno citate le norme rilevanti della legislazione italiana vigente e le più recenti pronunce giurisprudenziali (Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite) che hanno definito la materia .
Adotteremo un linguaggio giuridico rigoroso ma con finalità divulgative, adatto sia a professionisti legali (avvocati, dottori commercialisti) sia a privati cittadini e imprenditori che vogliono comprendere i propri diritti. Dopo aver delineato il quadro normativo e i principi generali (inclusa la distinzione tra decadenza e prescrizione nei procedimenti di riscossione tributaria), analizzeremo separatamente i termini di prescrizione per l’IVA dovuta, per le relative sanzioni e per gli interessi moratori. Si forniranno esempi pratici e simulazioni per contestualizzare l’applicazione di queste regole a casi concreti (ad es. professionista con cartella IVA non pagata, piccola impresa che riceve una cartella dopo vari anni, ecc.), sempre dal punto di vista del debitore che intenda eccepire l’estinzione del debito per prescrizione.
Nel prosieguo, troverete anche tabelle riepilogative che sintetizzano i diversi termini e condizioni di prescrizione per ciascuna componente del debito, nonché una sezione di Domande e Risposte frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni: ad esempio, “Dopo quanti anni si prescrive la cartella IVA?”, “Come differisce la prescrizione delle sanzioni rispetto a quella dell’imposta?”, “Cosa succede se richiedo la rateizzazione?”, “Come far valere la prescrizione maturata?”, ecc. Tutto il contenuto è aggiornato alle norme e sentenze vigenti al 2025, con riferimento alle fonti ufficiali e più autorevoli (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, leggi e decreti in vigore) per garantire accuratezza e attendibilità delle informazioni fornite.
Quadro normativo e definizioni generali
Prima di entrare nel merito dei termini di prescrizione, è fondamentale inquadrare il contesto normativo italiano in materia di riscossione dei tributi e chiarire alcuni concetti chiave:
- Prescrizione: in diritto civile, la prescrizione estingue il diritto del creditore di pretendere una prestazione trascorso un certo periodo di tempo dall’esigibilità del diritto, salvo atti interruttivi nel frattempo. Nel contesto tributario, la prescrizione è il periodo oltre il quale il debitore non può più essere legalmente costretto a pagare un debito tributario perché il diritto di riscossione si è estinto per il decorso del tempo (art. 2934 c.c.). Per i crediti iscritti a ruolo (come quelli della cartella esattoriale), il termine di prescrizione può essere quinquennale o decennale a seconda della natura del credito . Approfondiremo a breve quali termini si applicano alle diverse componenti (imposta/sanzioni/interessi) nel caso dell’IVA.
- Decadenza: diversamente dalla prescrizione, la decadenza attiene ai termini entro cui l’ente creditore deve compiere determinati atti, pena la perdita del potere di far valere il credito. In ambito fiscale, tipici termini di decadenza sono quelli per notificare un avviso di accertamento o per notificare la cartella a partire da un atto precedente. Ad esempio, l’art. 25 del D.P.R. 602/1973 prevede specifici termini decadenziali (di regola, il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica dell’avviso di accertamento definitivo) entro cui l’agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento. Se la cartella viene notificata oltre il termine di decadenza previsto, l’ente impositore perde il potere di riscuotere quelle somme tramite ruolo . In altre parole, il credito diventa inesigibile non perché prescritto, ma perché l’atto è tardivo (viziato da decadenza). La decadenza dunque incide sul potere di accertamento/riscossione dell’ente nei tempi previsti dalla legge, mentre la prescrizione incide sul diritto di credito in sé, una volta che questo si è formato.
- Differenze tra prescrizione e decadenza: È importante non confondere i due istituti. La prescrizione estingue il diritto di credito se, una volta sorto, non viene esercitato (o non ne viene sollecitato il pagamento) entro il termine stabilito; la decadenza invece fa perdere all’ente il potere di compiere un atto se questo non viene esercitato entro un certo termine iniziale. Un’altra differenza pratica fondamentale è che solo la prescrizione può essere interrotta o sospesa, mentre la decadenza no . Ciò significa che, se un termine di prescrizione viene “spezzato” da un atto interruttivo valido, il conteggio del tempo riparte da zero da quel momento (salvo eventuale sospensione durante procedimenti giudiziari in corso). La decadenza invece non può essere interrotta: l’unico modo di evitarla è il compimento tempestivo dell’atto previsto entro il termine di legge (es: notifica della cartella entro la scadenza). Se l’ente non notifica in tempo, il diritto di procedere tramite quell’atto decade irreparabilmente. Come sintesi: la decadenza riguarda il termine entro cui l’ente deve notificare l’atto impositivo o di riscossione, la prescrizione riguarda il termine entro cui il credito – una volta validamente notificato – può essere riscosso .
Nel prosieguo ci concentreremo sulla prescrizione (non sulla decadenza) delle cartelle esattoriali IVA, ossia sul periodo successivo alla notifica della cartella entro il quale il Fisco può legittimamente agire per riscuotere il credito, distinguendo tra la componente del tributo IVA, le sanzioni e gli interessi.
Termini di prescrizione dell’imposta IVA (debito d’imposta principale)
Per quanto concerne il debito principale di IVA non versata, ovvero l’imposta dovuta, la regola generale – in assenza di termini specifici più brevi stabiliti da norme tributarie – è che si applichi la prescrizione ordinaria decennale prevista dal codice civile (art. 2946 c.c.) . Ciò significa che l’Amministrazione finanziaria ha 10 anni di tempo per riscuotere coattivamente l’imposta indicata nella cartella, decorrenti, in linea di massima, dalla data in cui il credito tributario è divenuto definitivo ed esigibile.
Nel caso dell’IVA, il credito diviene esigibile quando l’accertamento o l’iscrizione a ruolo diventa definitivo. Ad esempio, se la cartella IVA deriva da somme dichiarate dallo stesso contribuente ma non versate (ruolo derivante da dichiarazione), il credito è definitivo ab origine e la prescrizione decennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella cartella (60 giorni dalla notifica) . Se invece la cartella deriva da un avviso di accertamento non impugnato, la definitività del credito coincide con il decorso dei termini per ricorrere (60 giorni dall’atto impositivo) e la successiva iscrizione a ruolo: da quel momento decorre il termine di prescrizione decennale per riscuotere l’imposta accertata . In ogni caso, il dies a quo (giorno iniziale) del termine di prescrizione è il giorno successivo a quello in cui l’obbligazione tributaria diviene esigibile, tipicamente il giorno dopo la scadenza del termine ultimo per pagare indicato nella cartella o nell’atto .
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’IVA (così come le altre principali imposte erariali come IRPEF, IRES, IRAP) non rientra tra le obbligazioni “periodiche” soggette a prescrizione breve quinquennale ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. . Questo perché, sebbene l’IVA sia dovuta periodicamente (mensilmente o trimestralmente in acconto, con liquidazione annuale), la sua struttura impositiva non la rende una prestazione periodica in senso civilistico: ogni periodo d’imposta è autonomo, genera un’obbligazione tributaria distinta, derivante da fatti economici specifici di quell’anno o frazione d’anno, e non da un’unica causa debendi continuativa . In altre parole, il debito IVA “nasce” ogni anno (o ogni periodo di liquidazione) su basi autonome, e non si tratta della medesima obbligazione che si rinnova periodicamente a scadenze fisse. Proprio in virtù di tale autonomia per periodo di imposta, la giurisprudenza prevalente esclude la natura periodica dell’IVA, applicando quindi la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) al relativo credito erariale .
Questo principio è stato consacrato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con una importante sentenza del 2016 (n. 23397/2016). Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, il termine di prescrizione di un credito erariale iscritto a ruolo deve essere individuato in base alla natura del tributo e alla relativa disciplina normativa . Se per quel tributo non esiste una norma specifica che preveda un termine di prescrizione “breve” (come esiste invece, ad esempio, per i contributi previdenziali, fissato in 5 anni dalla L. 335/1995), si applica in via residuale il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. . Le SS.UU. del 2016, decidendo un caso in materia di contributi INPS, hanno sancito un principio generale poi esteso anche ai tributi: “in assenza di giudicato, la prescrizione della cartella segue la normativa propria del tributo in essa contenuto e, in assenza di tale previsione, deve applicarsi in via residuale il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.” .
Nel solco di questo principio, pronunce successive della Cassazione hanno ribadito che per i tributi “erariali” (ossia statali come IVA, imposte sui redditi, IRAP), mancando una norma speciale che disponga un termine più breve, vale il termine decennale . Ad esempio, la Cass. Sez. V n. 2941/2007 (spesso richiamata anche in decisioni più recenti) testualmente afferma: “in tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica…” . Tale orientamento è consolidato: di recente le Sezioni Unite 11676/2024 hanno confermato che i crediti IVA (così come IRPEF, IRAP ecc.) “sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente” . E poiché per l’IVA la legge non dispone un termine di prescrizione ad hoc, si applica appunto il termine decennale civilistico.
In sintesi, dal punto di vista del debitore ciò significa che il debito IVA contenuto in una cartella esattoriale si estingue per prescrizione se trascorrono 10 anni senza che intervenga un atto interruttivo valido. Ad esempio, se ricevo una cartella per IVA il 1° marzo 2015 e da quella data (successiva alla scadenza di pagamento) decorrono 10 anni senza alcuna intimazione o atto esecutivo, dal 2 marzo 2025 il debito d’imposta IVA non è più esigibile perché prescritto. Naturalmente, come vedremo, atti come intimazioni di pagamento, pignoramenti, solleciti formali, richieste di rateazione, ecc. possono interrompere questo decorso decennale, facendo ripartire il termine da capo (su questo v. infra, sezione sull’interruzione).
Nota sulle eccezioni: l’unico caso in cui anche per un tributo erariale potrebbe applicarsi un termine diverso dai 10 anni è se si dimostra la riconducibilità del credito a una categoria per cui la legge prevede espressamente un termine più breve (5 anni). Per l’IVA, però, non esiste una norma specifica di legge che fissi un termine di prescrizione diverso; il dibattito sulla sua natura periodica (5 anni) vs. unitaria (10 anni) è stato risolto dai giudici a favore della tesi del termine decennale . Diverso è il caso dei tributi locali (IMU, TARI, bollo auto etc.), per i quali la Cassazione ha riconosciuto la prescrizione quinquennale in quanto ritenuti tributi periodici o comunque assistiti da norme specifiche . Ad esempio, per la tassa automobilistica (bollo auto) la legge dispone 3 anni; per IMU/TARI la giurisprudenza applica 5 anni per analogia alle entrate periodiche degli enti locali . Ma questi casi non riguardano l’IVA, che – ribadiamo – segue la regola generale dei 10 anni.
Va aggiunto che se il contribuente ha impugnato in giudizio la cartella (o l’atto presupposto) e la controversia si è conclusa con una sentenza definitiva, allora il credito tributario accertato dal giudice si consolida in un “titolo” giudiziale. Tuttavia, nel caso di IVA ciò non incide sul termine, perché era già decennale; l’art. 2953 c.c. (che “trasforma” in decennale le prescrizioni brevi a seguito di giudicato) non trova applicazione pratica se il credito IVA era sin dall’origine soggetto a prescrizione ordinaria . In altri termini, la regola dell’actio iudicati (art. 2953 c.c.) diventa determinante soprattutto per le sanzioni – come vedremo tra poco – o per quei tributi il cui termine originario era breve (es. tributi locali quinquennali, che se confermati da sentenza passano a dieci anni). Per l’IVA, essendo già dieci anni il termine “di partenza”, una sentenza definitiva di condanna non modifica la durata, restando dieci anni (decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, in base all’art. 2953 c.c.).
Ricapitolando sull’IVA (imposta): il debitore ha facoltà di eccepire l’intervenuta prescrizione decennale del debito IVA in tutti i casi in cui, dalla data di esigibilità (notifica della cartella non impugnata o definitività dell’accertamento) siano trascorsi oltre 10 anni senza atti interruttivi validi. La presenza di sanzioni e interessi nella cartella non modifica questo aspetto per l’imposta principale: le altre componenti potrebbero prescriversi prima (come vedremo subito), ma l’imposta resta esigibile finché non decorre il decennio. Passiamo ora proprio a esaminare le altre componenti, iniziando dalle sanzioni tributarie.
Termini di prescrizione delle sanzioni tributarie (IVA)
Le sanzioni amministrative tributarie irrogate in relazione all’IVA (ad esempio per omesso versamento, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione IVA, ecc.) seguono una disciplina propria dettata dal D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (la normativa generale sulle sanzioni tributarie). In particolare, l’art. 20, comma 3, D.lgs. 472/1997 stabilisce espressamente che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. Questa norma costituisce la base legale per affermare che le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni . Si tratta di un termine di prescrizione speciale, che prevale sul termine ordinario decennale proprio in virtù della disposizione normativa ad hoc. Il legislatore ha confermato così l’impostazione tradizionale, già presente in passato (fin dal R.D. 1931 e dalla L. 7/1929), secondo cui le “pene pecuniarie” per violazioni fiscali si estinguono in 5 anni .
Di conseguenza, la cartella esattoriale che contiene solo sanzioni tributarie (ad esempio una cartella per sole sanzioni da ritardato versamento IVA, o una sovrattassa) sarà soggetta al termine di 5 anni ex art. 20 D.lgs. 472/97. Nel caso più comune in cui la cartella rechi sia l’imposta IVA che le relative sanzioni, occorre considerare che la sorte delle sanzioni è autonoma: le sanzioni si prescrivono separatamente in 5 anni, anche se l’imposta sottostante si prescrive in 10 anni. Ciò può determinare che, trascorso un quinquennio senza atti interruttivi, le sanzioni non siano più dovute per prescrizione, mentre il debito d’imposta resti ancora esigibile fino al compimento del decennio.
È importante notare che l’art. 20 citato prevede anche che “l’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non decorre fino alla definizione del procedimento” . Questo significa che se il contribuente impugna (fa ricorso) contro l’atto che irroga la sanzione, la prescrizione viene sospesa durante il periodo del contenzioso: il tempo necessario a giungere a una decisione definitiva non viene conteggiato ai fini dei 5 anni. Solo al passaggio in giudicato della sentenza (o altro provvedimento definitorio) il termine riprende a decorrere. In assenza di impugnazione, invece, decorre normalmente.
Un’altra caratteristica peculiare delle sanzioni tributarie è il rapporto con il già menzionato art. 2953 c.c. (actio iudicati). Come anticipato, l’art. 2953 c.c. dispone che i diritti per cui la legge prevede una prescrizione più breve di 10 anni – come è appunto il caso delle sanzioni tributarie (5 anni) – “quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. In pratica, se una sanzione tributaria viene confermata da una sentenza definitiva, il credito da sanzione non sarà più soggetto al termine breve di 5 anni, ma a quello decennale (decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza). Questo principio è stato chiarito già dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 25790/2009, e ribadito in molte pronunce successive: “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., … mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dal D.Lgs. 472/1997, art. 20” .
In parole più semplici: – Se la sanzione non è mai stata confermata da un giudice (perché il contribuente non ha fatto ricorso e l’ha lasciata decadere, oppure ha rinunciato al ricorso, o altro), rimane applicabile il termine di 5 anni dalla data in cui la sanzione è divenuta definitiva (tipicamente l’iscrizione a ruolo in cartella, se non vi erano atti precedenti) . – Se invece la sanzione è stata oggetto di giudizio e il giudice tributario (fino eventualmente in Cassazione) l’ha confermata con sentenza definitiva, allora dal momento del giudicato il diritto a riscuotere quella sanzione dura 10 anni (come per i diritti accertati con sentenza).
Esempio: un contribuente riceve nel 2018 un avviso di irrogazione di sanzioni per omessa fatturazione IVA, per il quale è prevista sanzione amministrativa. Egli propone ricorso in Commissione Tributaria; dopo vari gradi di giudizio, nel 2023 la sanzione viene confermata da una sentenza della Cassazione che respinge il ricorso. A questo punto, la riscossione di quella sanzione (che magari era nel frattempo iscritta in cartella) sarà soggetta a prescrizione decennale dalla data della sentenza definitiva (2023), ex art. 2953 c.c. Se invece il contribuente non avesse impugnato l’atto del 2018, lasciando decorrere i termini, la sanzione sarebbe divenuta definitiva per mancata impugnazione, ma senza effetti di giudicato formale: in tal caso la Cassazione ritiene che il termine resti quello quinquennale di art. 20 D.lgs. 472/97, non essendoci una “sentenza” ma solo un provvedimento amministrativo divenuto incontrovertibile . Infatti la cartella di pagamento, pur se non opposta, non ha natura di sentenza o titolo giudiziale ma di atto amministrativo “paragiudiziale” (formato unilateralmente dall’amministrazione) che non può acquistare efficacia di giudicato sostanziale . Questo aspetto è stato definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite 23397/2016, superando precedenti orientamenti contrastanti: la mancata impugnazione della cartella dà luogo all’irretrattabilità del credito (cioè non si può più contestare nel merito), ma non converte la prescrizione breve in decennale . Solo un titolo giudiziario può far scattare l’art. 2953 c.c.
Pertanto, dal punto di vista pratico per il debitore, se nella cartella IVA vi sono sanzioni, conviene sempre verificare se sono trascorsi 5 anni dall’ultima intimazione o atto interruttivo riguardante quelle sanzioni. Spesso accade che, a distanza di molti anni, l’imposta possa ancora essere richiesta (perché sono passati meno di 10 anni) ma le sanzioni siano già prescritte perché il termine di 5 anni è decorso. In una situazione del genere, il contribuente può eccepire la prescrizione parziale: ovvero chiedere che venga dichiarato non dovuto il pagamento delle sanzioni (e relativi interessi sulle sanzioni, se presenti), restando dovuta solo l’imposta se il suo termine decennale non è ancora spirato. La giurisprudenza conferma tale possibilità: ad esempio Cass. n. 27055/2022 ha ribadito che, in assenza di giudicato, “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni … è quello quinquennale, così come previsto … dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3” . Similmente, Cass. n. 2095/2023 e numerose altre conformi hanno applicato il termine quinquennale alle sanzioni da cartella .
Per completezza, ricordiamo che l’art. 20 D.Lgs 472/97 prevede al comma 1 anche un termine di decadenza quinquennale per la notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni (diverso dalla prescrizione di cui al comma 3) , ma ciò esula dal nostro focus: qui ci occupiamo della prescrizione della fase di riscossione.
Riassumendo sulla prescrizione delle sanzioni IVA: – Termine base: 5 anni (art. 20, co.3 D.Lgs. 472/1997) . – Decorrenza: dalla definitività della sanzione (iscrizione a ruolo/cartella se non impugnata, oppure dall’atto di irrogazione se non c’è stata preventiva iscrizione). Se c’è contenzioso, il termine decorre solo dopo la conclusione definitiva del giudizio (periodo del giudizio non conteggiato). – Interruzioni: valgono gli atti interruttivi civilistici (intimazioni, atti di esecuzione, solleciti formali, ecc., v. oltre) nonché qualunque atto di riscossione specifico sulla sanzione. – Eccezione per giudicato: Se interviene sentenza definitiva di condanna sulle sanzioni, il nuovo termine diventa 10 anni dal giudicato (art. 2953 c.c.) . – Conseguenza: trascorsi 5 anni senza atti, la sanzione si estingue. In un’eventuale azione esecutiva, il debitore può opporsi limitatamente alle sanzioni eccependo la prescrizione quinquennale (anche se l’imposta e interessi fossero ancora azionabili).
Termini di prescrizione degli interessi di mora
La terza componente delle somme iscritte in cartella sono gli interessi (tipicamente interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento del tributo). Anche gli interessi seguono un regime peculiare: pur derivando dal debito principale, gli interessi costituiscono un’obbligazione autonoma e accessoria, con una propria causa (la mora nel pagamento) e una propria disciplina. In generale, la natura giuridica degli interessi (di qualsiasi tipo, salvo eccezioni) li configura come prestazioni periodiche o obbligazioni da corrispondersi periodicamente. Di conseguenza, il codice civile – all’art. 2948, comma 1, n. 4 – prevede che “si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” . Questo disposto codicistico si applica anche agli interessi da ritardata riscossione di tributi, inclusi quelli calcolati sulle somme dovute a titolo di IVA.
Pertanto, il termine di prescrizione degli interessi contenuti in una cartella esattoriale è generalmente di 5 anni . La Cassazione lo afferma in modo netto, considerandolo principio pacifico: ad esempio, la recente Cass. n. 5220/2024 (depositata il 27/02/2024) ha ribadito che gli interessi su crediti tributari sono regolati “da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione” . In altre parole, benché legati al tributo, gli interessi sono un credito separato che si prescrive in cinque anni, a prescindere dal termine applicabile all’imposta su cui maturano.
Decorrenza degli interessi: Gli interessi di mora decorrono, per legge (art. 30 D.P.R. 602/1973), dalla scadenza del termine di pagamento della cartella (il 61º giorno dopo la notifica, se non pagata nei 60 giorni) e si accumulano giorno per giorno sul capitale non pagato. In teoria, ogni giorno di ritardo genera un piccolo credito da interessi. Ai fini pratici, l’agente della riscossione calcola e richiede gli interessi dovuti fino alla data di effettivo pagamento. Tuttavia, in caso di lungo silenzio da parte della riscossione, una porzione degli interessi può divenire non esigibile per prescrizione. Occorre distinguere: – Gli interessi già indicati in cartella (quelli maturati fino alla formazione del ruolo): questi formano un importo fisso parte del ruolo e sono soggetti a prescrizione quinquennale calcolata dalla notifica della cartella (in quanto da tale momento l’Agente li può riscuotere). – Gli interessi di mora successivi (che maturano dopo la notifica e fino al pagamento): tecnicamente, ciascuna rata annuale di interessi moratori potrebbe considerarsi soggetta a prescrizione quinquennale dal momento in cui matura. In pratica, però, se trascorrono più di 5 anni senza alcun sollecito o atto interruttivo, il contribuente potrà eccepire che non sono dovuti gli interessi relativi a periodi anteriori al quinquennio. Ad esempio, se l’Agente notifica un’intimazione di pagamento dopo 6 anni di silenzio, egli potrà domandare interessi solo per gli ultimi 5 anni, mentre quelli maturati nel primo anno di silenzio saranno prescritti.
Va segnalato che anche per gli interessi, analogamente alle sanzioni, la giurisprudenza ha applicato coerentemente la regola del quinquennio in assenza di giudicato, e l’eventuale estensione a dieci anni in presenza di un titolo giudiziale. Tuttavia, qui l’effetto del giudicato è indiretto: se un tributo viene accertato in giudizio, la sentenza definitiva liquida spesso anche gli interessi maturati sino a un certo momento; quegli interessi consolidati nel giudizio diventano parte del titolo e godono di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. (come ogni credito da sentenza). Ma gli interessi moratori che continuano a maturare dopo la sentenza rimangono soggetti a prescrizione quinquennale, perché continuano ad essere obbligazioni periodiche nuove. In sostanza, il giudicato riguarda il capitale e gli interessi fino alla data della sentenza; per il periodo successivo, gli interessi (ad esempio quelli legali sul capitale da sentenza, o moratori ulteriori) maturano periodicamente e restano quinquennali.
Dal punto di vista del debitore, in una cartella mista IVA con interessi: – Si potrà contestare la pretesa di interessi se sono trascorsi più di 5 anni dall’ultimo atto di messa in mora. Ad esempio, se l’ultimo sollecito di pagamento risale a oltre 5 anni prima, tutti gli interessi maturati fino a quella data sono caduti in prescrizione. – Anche se l’imposta non è ancora prescritta (perché sono passati ad es. 8 anni su 10), il debitore può rifiutare di pagare gli interessi relativi agli anni più remoti eccedenti il quinquennio. – La Cassazione, con molte pronunce, conferma che gli interessi di mora sui crediti tributari si prescrivono in cinque anni ex art. 2948 c.c. , e tale termine decorre autonomamente rispetto alla prescrizione dell’imposta.
Da ricordare che un eventuale pagamento parziale può essere imputato a capitale o interessi secondo regole civilistiche (il codice prevede di solito prima interessi poi capitale, salvo diverso accordo). Ma se gli interessi più vecchi sono prescritti, il contribuente dovrebbe contestare l’imputazione a interessi prescritti e pretendere che l’eventuale pagamento vada a capitale.
Ricapitolazione sugli interessi: – Termine di prescrizione: 5 anni (art. 2948, co.1 n.4 c.c.) . – Decorrenza: gli interessi contenuti in cartella decorrono da quando sono dovuti (per quelli pre-cartella, la notifica della cartella; per i moratori post-cartella, via via dalla maturazione). Spesso, per semplicità, si considera la decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di pagamento della cartella, in quanto da lì iniziano a maturare i moratori. – Interruzioni: qualsiasi atto dell’ente impositore o del concessionario che intimi il pagamento del debito (anche limitatamente agli interessi) interrompe il termine di 5 anni e lo fa ripartire. – Giudicato: eventuale giudicato vale come sopra detto (interessi già decisi dal giudice – p.es. interessi legali su imposta riconosciuta fino a sentenza – rientrano nel titolo decennale; interessi successivi restano quinquennali). – Conseguenza: trascorsi 5 anni senza intimazioni, gli interessi non sono più dovuti per la parte rimasta inerte oltre il quinquennio. Il contribuente può eccepire di pagare solo gli interessi maturati negli ultimi 5 anni (o nessun interesse se per 5 anni non v’è stato alcun sollecito, perché sarebbero tutti prescritti fino a quel momento).
Interruzione e sospensione della prescrizione
Abbiamo più volte accennato agli atti interruttivi della prescrizione. È essenziale, specialmente dal punto di vista del debitore, comprendere quali eventi “bloccano” il decorso della prescrizione di cartelle esattoriali e con quali effetti, perché il calcolo dei termini di prescrizione (5 o 10 anni) va sempre riferito all’ultimo atto interruttivo noto.
Atti interruttivi della prescrizione
Il codice civile all’art. 2943 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta da una serie di atti del titolare del diritto o del debitore, tra cui in particolare: – La notifica di un atto con cui il creditore esercita il diritto verso il debitore, ad esempio un atto di citazione, un ricorso, un atto di precetto, ecc. – Qualsiasi atto che costituisca in mora il debitore, ossia che contenga una chiara intimazione o richiesta di adempimento da parte del creditore rivolta al debitore.
Nel contesto delle cartelle esattoriali, rientrano tra gli atti interruttivi (emessi dal creditore fiscale o dall’agente della riscossione) tipicamente: – L’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973: è un sollecito formale che precede l’esecuzione forzata, intimando al debitore di pagare entro 5 giorni. La notifica di un’intimazione costituisce senz’altro atto di costituzione in mora che interrompe la prescrizione . – Il preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca: anche la comunicazione preventiva di misure cautelari sul patrimonio (fermo auto, ipoteca su immobili) è un atto con cui si manifesta la volontà di riscossione e costituisce in mora il debitore, interrompendo la prescrizione (come riconosciuto da giurisprudenza). – L’atto di pignoramento (es. pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, ecc.): trattandosi di atto esecutivo notificato al debitore (e/o al terzo), interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. come atto di esecuzione. – La cartella di pagamento stessa: naturalmente, se dopo un accertamento l’ente notifica una cartella, questa interrompe qualsiasi precedente termine di prescrizione del credito e dà inizio al conteggio secondo i termini propri del credito in cartella. Ma parliamo qui di atti successivi alla cartella. – Qualunque altro sollecito scritto o comunicazione esattiva che contenga la chiara pretesa del credito. Ad esempio, una lettera di sollecito inviata con raccomandata A/R (in passato Equitalia mandava dei solleciti bonari, che però spesso non avevano tutti i crismi formali; oggi Agenzia Riscossione può inviare “comunicazioni di sollecito” anche via PEC). Se l’atto contiene l’indicazione del debitore, dell’importo e l’intimazione a pagare, secondo la Cassazione può valere come atto interruttivo .
Un atto interruttivo fa sì che il termine di prescrizione ricominci da zero dal giorno dell’atto (art. 2945 c.c.). Ad esempio, se mancano 2 mesi alla prescrizione ma arriva un’intimazione, da quella notifica si deve ricalcolare l’intero quinquennio o decennio daccapo.
È importante sottolineare che l’atto interruttivo deve essere portato a conoscenza del debitore (generalmente con notifica nelle forme di legge) per produrre effetto. Un atto non notificato o notificato invalidamente non interrompe la prescrizione. Inoltre, come ribadito dalla Cassazione, per avere efficacia interruttiva, l’atto deve contenere l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione di adempimento, in modo inequivoco . Un atto ambiguo o privo di richiesta chiara potrebbe non essere considerato idoneo.
Riconoscimento del debito da parte del contribuente
Oltre agli atti del creditore, la prescrizione può essere interrotta anche da un comportamento del debitore che implichi riconoscimento del diritto altrui (art. 2944 c.c.). Nel contesto che trattiamo, questo significa che se il contribuente compie atti che riconoscono l’esistenza del debito tributario, questi atti interrompono la prescrizione. Un caso tipico è la richiesta di rateizzazione (o dilazione) delle somme iscritte a ruolo.
- Istanza di rateizzazione: Quando il debitore, dopo aver ricevuto la cartella, chiede all’Agente della riscossione di poter pagare a rate, sta implicitamente riconoscendo il debito (sia pure chiedendo più tempo per pagare). La giurisprudenza più recente è concorde nel ritenere che l’istanza di rateazione interrompe la prescrizione dei crediti in cartella, facendo decorrere un nuovo termine da quando eventualmente la rateazione si conclude o viene revocata. In particolare, la Cassazione, ord. n. 27504 del 23/10/2024 ha ribadito che la presentazione da parte del debitore della richiesta di dilazione, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, “rileva ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione delle cartelle di pagamento” . Inoltre, chiedere la rateazione preclude al contribuente di eccepire di non aver mai saputo della cartella o di altri atti (talvolta i debitori contestano di non aver ricevuto notifica regolare: ma se poi hanno chiesto la rateazione, evidentemente ne erano a conoscenza, e la Cassazione considera ciò un elemento di prova di conoscenza) .
Dal punto di vista pratico: se un contribuente ottiene una dilazione in 10 rate semestrali, durante il piano di rateazione la prescrizione resta interrotta (o quanto meno sospesa fino all’ultima rata, secondo alcuni). Dopo l’ultima rata (oppure dopo l’ultima rata pagata prima di decadere dal piano), inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione integrale. Ad esempio, se ho rateizzato nel 2023 e finisco di pagare (o decado) nel 2025, da quel momento il Fisco ha di nuovo 5 o 10 anni interi per riscuotere il residuo.
- Pagamenti parziali o spontanei: Analogamente al riconoscimento, qualsiasi pagamento, anche parziale, effettuato dal debitore su quella cartella implica accettazione del debito e interrompe la prescrizione (art. 2944 c.c.). Ad esempio, versare una piccola quota, o compensare parte del debito con crediti d’imposta, ecc., fa ripartire il termine da zero dal momento del pagamento.
- Richieste di sgravio o altri scritti: se il contribuente invia una richiesta all’ente creditore riferendosi al debito (ad esempio chiedendo l’annullamento in autotutela della cartella, oppure presentando un’istanza di adesione, ecc.), a seconda del contenuto potrebbe costituire riconoscimento (se ammette il dovuto in parte) oppure no. Occorre valutare caso per caso. In genere, solo l’ammissione dell’obbligo interrompe; una contestazione del debito no.
Sospensione della prescrizione
La sospensione è diversa dall’interruzione: sospendere significa che per un certo periodo il “contatore” del tempo si ferma, per poi riprendere da dove era rimasto (non da capo, a differenza dell’interruzione). Nel campo tributario, rilevano poche ipotesi di sospensione: – Sospensione legale della riscossione: ad esempio quando la riscossione è sospesa per legge in caso di domanda di definizione agevolata (rottamazione) in corso, oppure per provvedimenti emergenziali (moratorie Covid, ecc.). Durante tali periodi, è ragionevole ritenere che la prescrizione non decorra, perché il Fisco è impossibilitato (o comunque inibito) dal riscuotere. – Contenzioso in corso: Come già detto, il periodo in cui pende un ricorso del contribuente contro il debito non viene conteggiato ai fini della prescrizione (art. 2945 c.c., comma 2). Più precisamente, l’atto di impugnazione interrompe la prescrizione e la mantiene ferma fino al passaggio in giudicato della sentenza . Dopo il giudicato, inizia un nuovo termine (decennale se c’è stata condanna, quinquennale se la condanna riguarda sanzioni/interessi, etc., come visto). – Sovraindebitamento o procedure concorsuali: In caso l’impresa debitrice sia soggetta a fallimento o procedure concorsuali, spesso i termini per i creditori subiscono sospensioni o adattamenti. Senza entrare nel dettaglio, basti sapere che durante, ad esempio, un fallimento dichiarato, i crediti fiscali devono essere insinuati al passivo e la prescrizione potrebbe essere sospesa fino alla chiusura della procedura (c’è dibattito, ma in genere si considera che finché il credito è cristallizzato nella procedura concorsuale la prescrizione non corre normalmente, o comunque gli atti della procedura tengono “vivo” il credito).
Per un privato o imprenditore debitore, conoscere gli atti interruttivi è essenziale per calcolare correttamente se la prescrizione è maturata. Ad esempio, può capitare di aver ricevuto una cartella 8 anni fa: verrebbe da pensare che tra 2 anni (10 anni totali) l’IVA sia prescritta. Ma se nel frattempo (diciamo 4 anni fa) è arrivata una comunicazione di intimazione che ci si è magari dimenticati, allora il termine si è interrotto e i 10 anni decorrono nuovamente da quella intimazione, spostando in avanti la scadenza della prescrizione. Verificare la cronologia delle notifiche degli atti è quindi fondamentale. Dal 2018, Agenzia Entrate-Riscossione invia ai contribuenti (su richiesta) un estratto conto chiamato “prospetto dei carichi” dove risultano date di notifica di cartelle e altri atti; questo può aiutare a identificare eventuali atti interruttivi.
In caso di lite, è onere del concessionario della riscossione provare l’esistenza e la notifica degli atti interruttivi, ove il contribuente eccepisca l’intervenuta prescrizione . Ciò significa che se il contribuente sostiene che sono passati oltre 5/10 anni, spetta all’Agente esibire le relate di notifica di eventuali atti entro quel periodo. Se non riesce a provarli, il giudice dichiarerà il credito estinto per prescrizione.
Riepilogo dei termini di prescrizione – imposta IVA, sanzioni, interessi
Per meglio visualizzare quanto esposto, la seguente tabella riepiloga i diversi termini di prescrizione applicabili alle cartelle esattoriali contenenti debiti IVA, distinguendo per tipologia di importo:
| Voce in cartella | Termine di prescrizione | Riferimenti normativi | Note |
|---|---|---|---|
| IVA – Imposta principale | 10 anni (ordinario) | Art. 2946 c.c. | Decorrenza dal momento in cui il tributo diviene definitivo ed esigibile (notifica cartella/accertamento definitivo). Termine decennale salvo diversa previsione di legge (che per IVA non c’è). Non considerata “prestazione periodica” . |
| Sanzioni tributarie (non da giudicato) | 5 anni | Art. 20, co. 3, D.Lgs. 472/1997 | Decorrenza dalla definitività della sanzione (iscrizione a ruolo). Se la cartella non è fondata su sentenza passata in giudicato: prescrizione quinquennale . Impugnazione sospende il decorso. |
| Sanzioni tributarie confermate da sentenza passata in giudicato | 10 anni | Art. 2953 c.c. | Se la sanzione è divenuta definitiva per giudicato, si applica l’actio iudicati: termine decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza. |
| Interessi di mora | 5 anni | Art. 2948, co.1 n.4 c.c. | Considerati obbligazioni periodiche autonome. Decorrenza dall’esigibilità degli interessi (maturazione/accredito). Anche interessi su sanzioni seguono 5 anni. Eventuale giudicato sui soli interessi (raro) li consolida a 10 anni, ma gli interessi futuri restano 5 anni. |
Fonti: Codice Civile e normativa fiscale vigente; giurisprudenza Cassazione (es. Cass. 2941/2007, SS.UU. 23397/2016, SS.UU. 11676/2024, Cass. 2095/2023, Cass. 27055/2022, Cass. 5220/2024) .
Come si evince dalla tabella, il debitore che si trova di fronte a una cartella IVA deve tenere presente che: – Il “capitale” (IVA) ha vita più lunga (10 anni), mentre sanzioni e interessi cadono prima (5 anni) se l’ente della riscossione rimane inerte. – È possibile che, a distanza di anni, la cartella non sia integralmente prescritta, ma lo siano in parte alcune voci. Ad esempio, dopo 6-7 anni di silenzio, è probabile che le sanzioni e tutti gli interessi maturati sino a quel momento siano prescritti, mentre l’imposta sia ancora recuperabile. – L’eventuale presenza di una sentenza (giudicato) incide solo sul termine delle sanzioni (passandolo da 5 a 10 anni). Nel caso di IVA, come detto, la presenza di giudicato non modifica il termine dell’imposta (che era già decennale). – Per tributi diversi dall’IVA, potrebbero esserci termini differenti (non oggetto specifico di questa trattazione, ma ad es. tributi locali 5 anni, contributi previdenziali 5 anni, ecc., secondo normative proprie). Nel contesto IVA, le regole sono quelle indicate sopra.
Importante: La prescrizione non opera automaticamente, ma deve essere eccepita dal debitore nelle sedi opportune. Se il contribuente non solleva la questione della prescrizione, il giudice (o l’Agente della riscossione) potrebbe non rilevarla d’ufficio. È quindi onere del debitore far valere i termini a sua difesa.
Nei prossimi paragrafi vedremo alcune simulazioni pratiche e risponderemo a domande comuni per applicare queste regole a casi concreti.
Simulazioni pratiche (casi concreti)
Di seguito vengono illustrati alcuni scenari pratici riguardanti la prescrizione di cartelle IVA, per comprendere meglio come applicare le norme ai fatti reali.
Caso 1: Cartella IVA non pagata e nessun atto per anni
Scenario: Il sig. Rossi, un lavoratore autonomo (professionista), riceve il 10 gennaio 2015 una cartella esattoriale dall’Agenzia Entrate-Riscossione per IVA non versata relativa all’anno d’imposta 2011. Nella cartella sono indicati: imposta IVA €10.000, sanzioni €2.000, interessi di mora €500 (calcolati fino alla data della cartella). Rossi, in difficoltà economiche, non paga e non propone alcun ricorso. Dopo la notifica della cartella nel 2015, per molti anni l’Agente della riscossione non compie alcun atto nei suoi confronti: nessuna intimazione, nessun sollecito, nulla. Arriviamo al 2025: sono trascorsi 10 anni e Rossi non ha più notizie.
Analisi: In questa situazione, il diritto di riscossione delle varie componenti si è estinto per prescrizione? – Sanzioni: Il termine di 5 anni (art. 20 D.Lgs. 472/97) decorreva dal 2015 (data in cui la sanzione è divenuta esigibile con la cartella). Già a gennaio 2020 le sanzioni erano prescritte, perché sono passati 5 anni senza interruzioni. Dunque i €2.000 di sanzioni non sono più esigibili . – Interessi: Gli interessi indicati in cartella (500 €) seguono anch’essi la prescrizione quinquennale. Quindi anch’essi, a gennaio 2020, risultavano prescritti . Inoltre, eventuali interessi di mora maturati dopo il 2015 (sul capitale di 10.000 €) non possono essere pretesi per il periodo oltre 5 anni: in pratica, dal 2020 in poi l’agente avrebbe potuto chiedere solo gli interessi degli ultimi 5 anni, ma poiché non ha agito affatto, al 2025 anche gli interessi successivi sono comunque caduti in prescrizione man mano che maturavano. – Imposta IVA: Il termine è 10 anni dal 2015 . A gennaio 2025 è scaduto il decennio. Dunque, a gennaio 2025 anche l’imposta di €10.000 è prescritta. Significa che il Fisco non può più legalmente pretendere il pagamento di quella somma.
Soluzione dal punto di vista del debitore: Il sig. Rossi, se dovesse ricevere nel 2025 un qualsiasi atto di riscossione (es. un’intimazione tardiva, o un pignoramento), potrà far valere l’eccezione di prescrizione per l’intero importo. L’eccezione andrà sollevata davanti al giudice competente (Commissione Tributaria/Corte di Giustizia Tributaria se impugna una cartella o un atto della riscossione, oppure giudice dell’esecuzione se si oppone a un pignoramento, a seconda delle circostanze). In ogni caso dovrà documentare la data di notifica della cartella (2015) e l’assenza di atti interruttivi successivi. Spetterà eventualmente all’Agente della riscossione provare il contrario, ma nell’esempio non essendoci atti, il creditore non ha mezzi per contrastare l’eccezione. La cartella sarà quindi dichiarata inesigibile perché prescritta in tutte le sue parti.
Variazioni sul caso: Se invece l’Agente avesse notificato un sollecito nel 2018, allora al 2025 la situazione cambierebbe. Un sollecito nel 2018 interrompe tutto: da lì i 5 anni per sanzioni/interessi ripartono, così come i 10 anni per l’IVA. Quindi, dopo l’atto del 2018, la prescrizione delle sanzioni si sarebbe spostata al 2023 e quella dell’IVA al 2028. Il sig. Rossi nel 2025, vedendo trascorsi solo 7 anni dall’ultimo atto (2018), potrebbe far valere la prescrizione solo di sanzioni e interessi (5 anni dal 2018 -> 2023) ma non ancora dell’IVA (10 anni dal 2018 -> 2028). Questo esempio evidenzia l’importanza di identificare l’ultimo atto interruttivo per capire cosa è prescritto e cosa no.
Caso 2: Cartella IVA rateizzata e poi non pagata interamente
Scenario: La società Alfa S.r.l. riceve nel luglio 2019 una cartella per IVA anno 2014 non versata, importo: €50.000 imposta + €5.000 sanzioni + interessi. Decide di presentare istanza di rateizzazione e ottiene dall’Agente della riscossione un piano di dilazione in 72 rate mensili (6 anni). La società paga regolarmente alcune rate, poi a metà del 2021 entra in crisi e smette di pagare le rate restanti, decadendo dal beneficio della dilazione. Dopo la decadenza (diciamo avvenuta a fine 2021), la riscossione non riprende subito iniziativa. Passano altri anni senza comunicazioni. Nel 2025, avendo superato la crisi, Alfa S.r.l. valuta se il debito sia ancora esigibile o se possa considerarsi prescritto.
Analisi: Qui occorre considerare gli effetti della rateazione: – La presentazione dell’istanza nel 2019 ha interrotto la prescrizione riconoscendo il debito . Quindi il termine quinquennale per sanzioni/interessi e quello decennale per l’IVA sono ripartiti da capo nel 2019. – Durante il periodo di rateazione (2019-2021) la prescrizione era comunque sospesa/interrotta, perché i pagamenti rateali implicavano riconoscimento continuo del debito. Nel momento in cui la società è decaduta (fine 2021), il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere nuovamente da zero da quella data (fine 2021). – Dal 2022 in avanti, se l’Agente non ha compiuto atti: – Sanzioni: 5 anni da fine 2021 -> fine 2026 sarebbe il termine. Quindi nel 2025 non sono ancora prescritti 5 anni completi; le sanzioni risultano non ancora prescritte (lo saranno solo nel 2026). – Interessi: stesso discorso, 5 anni da 2021 -> 2026. – IVA: 10 anni da fine 2021 -> 2031, quindi ovviamente non prescritta nel 2025.
Quindi, paradossalmente, la rateizzazione (che è stata breve in questo caso) ha allungato la vita al credito. Senza rateazione, se nulla fosse stato fatto, nel 2025 sarebbero trascorsi 6 anni dalla cartella – sanzioni e interessi sarebbero già prescritti nel 2024, qui invece sono ancora vivi perché il conteggio è ripartito nel 2021.
Soluzione: Alfa S.r.l. nel 2025 non può fondatamente eccepire prescrizione, perché solo ~4 anni sono passati dall’ultimo evento (decadenza del piano nel 2021). L’Agente Riscossione può legittimamente riprendere la riscossione (pignoramenti ecc.). Una difesa per Alfa potrebbe semmai basarsi su altri motivi (vizi di notifica della cartella originaria, ecc.), ma non sulla prescrizione (ancora prematura). Questo caso insegna che la richiesta di rateazione interrompe e rinnova i termini di prescrizione, per cui prima di chiedere una dilazione il contribuente farebbe bene a valutare la tempistica: se il credito è prossimo alla prescrizione, l’istanza di rateizzazione lo rianimerà.
Caso 3: Cartella IVA impugnata in parte e sentenza passata in giudicato
Scenario: La ditta individuale Bianchi riceve nel 2016 una cartella IVA per maggior imponibile accertato sul 2012: €30.000 di IVA, €6.000 di sanzioni. Bianchi ritiene infondato l’accertamento e propone ricorso. Durante il contenzioso, paga intanto €5.000 a titolo di acconto (magari per evitare misure cautelari). Nel 2019 la Commissione Tributaria emette sentenza riducendo il tributo a €15.000 e le sanzioni proporzionalmente a €3.000. La sentenza diviene definitiva nel 2020 (nessun appello). A questo punto, l’Agenzia Riscossione deve ricalcolare la cartella secondo la sentenza: importi dovuti €15.000 + €3.000, meno i €5.000 già versati = residuo €13.000 (presumendo imputati prima a interessi e sanzioni, ma semplifichiamo). Nel 2021 notifica a Bianchi una comunicazione di “presa d’atto del giudicato” con richiesta di pagamento del residuo. Bianchi però ancora non paga. Cosa succede al 2025?
Analisi: Qui abbiamo: – Una sentenza definitiva (giudicato) nel 2020 che riconosce un credito tributario (imposta + sanzione, ricalcolate). – Per la parte di imposta (€15.000), come detto, il fatto che ora ci sia un giudicato non cambia la durata della prescrizione: era decennale prima e resta decennale dopo. Se vogliamo essere precisi, potremmo dire che dal 2020 il credito risulta da sentenza e quindi comunque soggetto all’actio iudicati (10 anni) – ma erano 10 anni anche come credito erariale originario. Dunque, la prescrizione dell’IVA residua scadrà nel 2030 (10 anni dal giudicato 2020). – Per le sanzioni (€3.000), il giudicato le ha confermate (anche se ridotte). Quindi ora le sanzioni si basano su sentenza passata in giudicato. Questo fa scattare l’art. 2953 c.c.: la prescrizione delle sanzioni diventa decennale dalla data del giudicato . Quindi non più 5 anni dal 2020, ma 10 anni dal 2020, ovvero fino al 2030. – Gli interessi legali sul capitale riconosciuto in sentenza (se dovuti) sarebbero anch’essi consolidati e parte del titolo di condanna (in genere la sentenza li menziona). Dalla definitività, la riscossione di quegli interessi segue 10 anni. Ma i nuovi interessi moratori sul residuo (dal 2020 in poi) rimangono soggetti al solito termine quinquennale, che però, attenzione, decorre di fatto dall’ultima richiesta formale (la comunicazione del 2021 in cui AR ha richiesto il pagamento del residuo). Dal 2021 cinque anni portano al 2026.
Nel 2025, quindi: – L’imposta residua €15.000: non prescritta (termine 2030). – Sanzioni €3.000: non prescritte (termine 2030). – Interessi di mora maturati dal 2020 al 2025 sul residuo: in parte potrebbero essere prescritti se l’ultimo atto è del 2021. Da 2021 a 2025 sono 4 anni, quindi gli interessi ultimi 4 anni non prescritti (servirebbe arrivare a 2026 per dire che 5 anni di mora post-giudicato sono passati).
Bianchi nel 2025 non avrebbe chance di far dichiarare prescritto il debito residuo. In prospettiva, solo se l’Agenzia Riscossione rimanesse inattiva fino al 2030, allora tutto cadrebbe; ma è improbabile perché conoscendo la pronuncia, l’Agente agirà prima (già lo ha fatto con l’atto del 2021, e magari con intimazioni successive).
Nota: Questo caso mostra che quando c’è una pronuncia giudiziaria, i tempi si allungano per il contribuente debitore, specie sulle sanzioni che da 5 passano a 10 anni .
Caso 4: Debitore fallito o società estinta
Scenario: La società Gamma S.r.l. aveva diverse cartelle IVA non pagate (2010-2013). Nel 2018 è stata dichiarata fallita e nel 2020 è stata chiusa la procedura fallimentare senza attivo sufficiente a pagare i debiti fiscali. La società quindi è stata cancellata dal registro imprese nel 2021. Nel 2025, l’Agenzia Entrate-Riscossione invia ai soci (o agli ex amministratori) una comunicazione per il recupero dei debiti IVA non pagati, sostenendo che la società non li ha estinti. Può farlo? E i termini di prescrizione come operano in questi casi?
Analisi: Quando una società viene meno (liquidazione/fallimento), ci sono regole speciali: i debiti fiscali di società di capitali di norma non si trasferiscono ai soci (che hanno responsabilità limitata), salvo alcuni casi di responsabilità sanzionatoria o per utili distribuiti nei 2 anni precedenti ecc., oppure se c’è stato un accertamento di responsabilità per obbligazioni tributarie (tipo amministratori che hanno sottratto beni al Fisco). Ma in generale, se la società fallisce e non paga, il credito fiscale rimane insoluto. L’Agenzia può solo insinuarsi al passivo fallimentare e, se non riceve nulla, il credito è di fatto irrecuperabile a meno di azioni verso responsabili solidali.
Dal punto di vista prescrizionale: – Durante il fallimento (2018-2020), i termini erano sospesi o comunque l’insinuazione al passivo ha interrotto la prescrizione. – Dopo la chiusura del fallimento nel 2020 e la cancellazione nel 2021, l’eventuale credito residuo verso la società resta tecnicamente esistente fino a prescrizione (10 anni per IVA dall’ultimo atto utile, es. dal decreto di chiusura?). Però essendo la società estinta, non c’è più un soggetto giuridico da perseguire. – L’Agenzia potrebbe tentare di far valere responsabilità individuali: ad esempio l’art. 36 del DPR 602/1973 prevede che se la società si estingue con debiti tributari, l’Amministrazione può notificare ai soci un atto per riscuotere nei limiti delle somme ricevute in liquidazione. Oppure se c’è frode fiscale, procedere contro amministratori.
In tali casi, ogni nuovo atto nei confronti di soci/terzi nel 2025 costituirebbe un atto interruttivo nei loro confronti, ma si potrebbe eccepire che il credito originario è prescritto se sono passati oltre 10 anni dalla definitività per l’IVA (o 5 per sanzioni) senza atti nemmeno verso la società. Occorre quindi analizzare la situazione concreta: – Se Gamma S.r.l. aveva cartelle notificate nel 2013, e l’ultima azione è stata l’insinuazione nel fallimento nel 2018, al 2025 sono passati 7 anni dall’ultimo atto, quindi l’IVA non è prescritta (termine 2028), sanzioni sì (termine 2023). Tuttavia la società è estinta, quindi l’atto ai soci nel 2025 è forse tardivo anche per decadenza di notifica ex art. 36 (c’è giurisprudenza complessa su ciò). – Il socio potrà contestare che l’atto è nullo se tardivo, e in subordine eccepire prescrizione per eventuali sanzioni (5 anni già passati dal 2018) e magari per tributi se ne fosse passato abbastanza.
Questo scenario è complicato e va oltre la trattazione standard, ma serve a evidenziare che in caso di procedure concorsuali le dinamiche temporali mutano e la difesa del debitore (o ex debitore) può basarsi sia su eccezioni di decadenza (notifica ai soci tardiva) sia di prescrizione (termini maturati durante l’inerzia post-fallimento).
Caso 5: Avviso di addebito INPS vs cartella IVA (confronto)
(Confronto per comprendere ambiti diversi): Un professionista Tizio ha due debiti: uno con INPS per contributi 2015, l’altro con Agenzia Entrate per IVA 2015. Entrambi diventano ruoli e cartelle nel 2018. I contributi INPS per legge prescrivono in 5 anni (L.335/1995), mentre l’IVA in 10 come visto. Se nessun atto interviene, già nel 2023 il debito INPS sarebbe prescritto, mentre il debito IVA no. Questo esempio fa capire perché è importante conoscere la natura del credito: non tutte le cartelle si prescrivono in 5 anni, dipende dalla legge che disciplina quel credito . Molti contribuenti fanno erroneamente affidamento sulla “regola generale dei 5 anni” pensando valga per ogni cartella, ma come abbiamo visto ciò non è vero per IVA (o IRPEF, ecc.) in mancanza di specifiche previsioni di legge. Occorre sempre fare riferimento al quadro normativo specifico del tributo in questione.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande e risposte comuni sulla prescrizione delle cartelle esattoriali IVA, dal punto di vista del debitore, con risposte basate sulla normativa e le più recenti interpretazioni giurisprudenziali:
1. Domanda: In quanti anni si prescrive una cartella esattoriale relativa all’IVA?
Risposta: Non esiste un unico termine valido per tutte le componenti della cartella, ma bisogna distinguere: – Per l’IVA (imposta) il termine è 10 anni dalla data in cui il debito diventa definitivo ed esigibile , salvo atti interruttivi nel frattempo. Ciò perché l’IVA è un tributo erariale non soggetto a prescrizione breve . – Per le sanzioni tributarie collegate all’IVA, il termine è 5 anni (art. 20 D.Lgs. 472/97) , a meno che la sanzione sia stata confermata da una sentenza passata in giudicato: in tal caso passa a 10 anni (art. 2953 c.c.) . – Per gli interessi di mora il termine è 5 anni (art. 2948 c.c.) , poiché gli interessi sono prestazioni periodiche.
Quindi, ad esempio, una cartella IVA non impugnata si estinguerà completamente dopo 10 anni di totale inattività; tuttavia già dopo 5 anni non saranno più dovute le sanzioni e gli interessi maturati fino a quel momento .
2. Domanda: Da quando inizia a decorrere la prescrizione?
Risposta: In generale, dalla data in cui il credito diviene esigibile. Per una cartella di pagamento, la prescrizione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per pagare indicato nella cartella stessa (60 giorni dalla notifica) . Dunque, se una cartella è notificata il 1° febbraio 2025, la scadenza per pagare è il 2 aprile 2025, e la prescrizione inizia il 3 aprile 2025. Se però la cartella deriva da un atto precedente (es. avviso di accertamento) non pagato né impugnato, taluni fanno decorrere la prescrizione dall’ultima data utile di pagamento di quell’atto (che coincide poi col ruolo). In pratica cambia poco: il concetto è che la prescrizione parte quando l’Amministrazione può legalmente iniziare la riscossione coattiva. Da notare che, per le sanzioni, se c’è stato ricorso, la prescrizione inizia solo dal passaggio in giudicato della sentenza che le conferma (il tempo del giudizio non conta). Per gli interessi, decorre man mano che maturano, ma la prassi è considerarli insieme al capitale da quando il capitale è esigibile.
3. Domanda: Quali atti interrompono la prescrizione delle cartelle esattoriali?
Risposta: Qualsiasi atto con cui il creditore (Agenzia Entrate-Riscossione o ente impositore) manifesta la volontà di riscuotere il credito verso il debitore. Esempi tipici: – Intimazione di pagamento (ex art. 50 DPR 602/73) – atto formale che ingiunge il pagamento entro 5 giorni . – Preavviso di fermo amministrativo (bloccare auto) o preavviso di ipoteca su beni – sono atti notificati che contengono la richiesta di pagamento per evitarli, dunque interrompono. – Atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso terzi) – sicuramente interruttivo in quanto atto esecutivo. – Comunicazioni di sollecito scritte, se sufficientemente dettagliate e inviate con mezzi tracciabili, possono valere come costituzione in mora. – Iscrizione a ruolo di ulteriori somme e relativa cartella – se il ruolo successivo è per accessori sul medesimo debito, la nuova cartella interrompe anche per il pregresso (ma questa è situazione particolare). Inoltre, anche atti del debitore possono interrompere: la richiesta di rateizzazione è un riconoscimento del debito che interrompe i termini ; un pagamento parziale idem (art. 2944 c.c.). Dopo ogni interruzione, il “timer” della prescrizione riparte da zero (per intero 5 o 10 anni) .
4. Domanda: Cosa significa che la prescrizione può essere sospesa? In quali casi avviene?
Risposta: La sospensione significa congelare il decorso per un certo periodo, che quindi non viene conteggiato. Nel contesto delle cartelle IVA, le cause di sospensione sono meno comuni rispetto all’interruzione. Alcuni esempi: – Contenzioso pendente: dal momento in cui si propone ricorso in Commissione Tributaria, la prescrizione si interrompe e rimane sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza . È un misto di interruzione immediata e sospensione durante il processo, ex art. 2945 c.c. – Rateizzazione in corso: durante il periodo di rateazione concordata, l’Agente di riscossione normalmente non procede con atti esecutivi, quindi di fatto il termine potrebbe considerarsi sospeso; ma più corretto dire che è già interrotto dal riconoscimento iniziale e ripartirà solo a rateazione conclusa. – Moratorie di legge: es. provvedimenti emergenziali (come sospensioni Covid dei termini di riscossione nel 2020) hanno fermato i termini per un certo periodo. Quelli di quel periodo vanno aggiunti alla scadenza. – Procedure concorsuali: in caso di fallimento, concordato preventivo, ecc., l’esigibilità dei crediti resta vincolata alla procedura, quindi i termini possono essere sospesi fino alla chiusura. In generale, comunque, la maggior parte delle situazioni si inquadrano come interruzioni. La sospensione ha applicazione relativamente limitata e spesso è espressamente prevista da norme.
5. Domanda: Se il Fisco non mi ha più inviato nulla per anni, devo pagare la cartella o posso evitarlo?
Risposta: Se sono trascorsi oltre 5 anni senza alcun atto, con buona probabilità sanzioni e interessi sono prescritti e quindi non dovuti. Se sono trascorsi oltre 10 anni (per debiti IVA, IRPEF ecc.) senza atti, allora anche l’imposta è prescritta e l’intero debito si è estinto . Attenzione: la prescrizione non cancella automaticamente il debito, ma lo rende inopponibile; occorre cioè sollevare l’eccezione. Quindi il contribuente, trovandosi in tale situazione (nessun contatto da >5 o >10 anni), può: – Evitare il pagamento spontaneo e, se dovesse ricevere una nuova intimazione o pignoramento, opporsi sostenendo l’intervenuta prescrizione. – In alcuni casi, si può presentare un’istanza in autotutela all’ente creditore allegando la prova delle date e chiedendo lo sgravio per intervenuta prescrizione. L’ente non è obbligato ad accogliere, ma talvolta per somme piccole o casi evidenti può farlo. – Non è consigliabile pagare somme prescritte. Se si paga, non sono ripetibili (cioè non si può chiedere rimborso per indebito se al momento del pagamento il debito era prescritto ma volontariamente pagato, perché la prescrizione è rinunciabile). In sostanza: se il Fisco “si dimentica” per troppo tempo, la legge tutela il contribuente diligente che eccepisce il decorso del tempo. È però prudente farsi assistere da un professionista per calcolare bene i termini e verificare l’effettiva assenza di atti interruttivi.
6. Domanda: Come faccio a sapere se ci sono stati atti interruttivi che io magari non ho visto?
Risposta: È fondamentale controllare le notifiche. Spesso gli enti notificano atti presso la residenza/sede risultante all’epoca, e può capitare di non accorgersene (soprattutto se ci si trasferisce e non si aggiorna l’indirizzo fiscale, o per disguidi). Per sicurezza, si possono fare alcune cose: – Chiedere un estratto di ruolo all’Agenzia Entrate-Riscossione: recandosi agli sportelli o tramite PEC, si può richiedere lo storico delle cartelle e degli atti. Viene fornito un prospetto con l’elenco delle cartelle a carico e lo stato (se pagata, se sospesa, se in contenzioso). Talvolta sono indicati anche i successivi atti (intimazioni, fermi). – Accesso ai dati online: chi ha SPID/CIE può accedere al sito dell’Agenzia Riscossione e verificare nella propria area riservata le cartelle e i piani di dilazione, nonché scaricare i dettagli. – Verificare presso l’Albo dei concessionari: alcune volte gli atti di difficile notificazione vengono pubblicati online (Albo Ministero Finanze), se notifica via posta fallisce. Controllare con codice fiscale su quei siti può rivelare se c’è stata una notifica per compiuta giacenza o via deposito. – Controllare la PEC: dal 2019/2020 in poi, molte notifiche a imprese e professionisti avvengono via PEC. Quindi controllare la casella di Posta Elettronica Certificata (inclusa spam) per eventuali messaggi dall’Agente Riscossione. In sintesi, fare una due diligence delle proprie pendenze fiscali aiuta a non incorrere in sorprese. In giudizio, comunque, se il contribuente afferma di non aver mai ricevuto atti, spetta all’Agente provarne la notifica regolare. Se l’Agente esibisce relate di notifica valide, quei atti contano ai fini della prescrizione anche se il contribuente sostiene di “non saperlo” (ad es. notifica per compiuta giacenza è valida anche se il destinatario non ritira la raccomandata). Quindi è importante informarsi attivamente.
7. Domanda: La prescrizione può essere eccepita in qualsiasi modo?
Risposta: No, va eccepita nelle sedi opportune: – Se si riceve una nuova cartella (es. di aggiornamento) e si ritiene che il debito in essa contenuto sia già prescritto, bisogna impugnarla davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) entro 60 giorni, sollevando la prescrizione. – Se si riceve un atto esecutivo (intimazione, preavviso di fermo, pignoramento), si può fare opposizione: a seconda dei casi, le controversie su atti della riscossione andranno davanti al giudice tributario (se riguardano la debenza del tributo) o davanti al giudice ordinario (se riguardano vizi dell’esecuzione). La giurisprudenza ha affermato che l’eccezione di prescrizione del credito tributario, se il ruolo è già definitivo, va proposta con l’opposizione all’esecuzione innanzi al giudice ordinario in certi casi, ma non entriamo nel tecnicismo: in dubbio, un avvocato valuterà il rito. L’importante è non restare inerti: se arriva un atto e si dorme sui termini, non si potrà poi far valere la prescrizione. – In nessun caso l’Agente della riscossione riconoscerà d’ufficio che un credito è prescritto e smetterà di riscuoterlo (salvo piccole partite interessate da provvedimenti di legge di annullamento automatico – ad es. lo stralcio 2023 dei debiti fino a €1.000 per ruoli antecedenti al 2015, misura straordinaria). Dunque la prescrizione è uno scudo che il contribuente deve alzare attivamente.
8. Domanda: La prescrizione è uguale per tutti i contribuenti (privati, ditte individuali, società)?
Risposta: Sì, la legge fissa i termini in base alla natura del credito, non alla tipologia del debitore. Quindi un debito IVA di €10.000 si prescrive in 10 anni sia che l’obbligato sia una persona fisica, sia una ditta individuale, sia una società di capitali. Allo stesso modo, sanzioni e interessi fiscali hanno i medesimi termini indipendentemente dal soggetto. Ciò che può cambiare sono le procedure di riscossione: ad esempio, se il debitore è una società che fallisce, come visto, i tempi e i modi di far valere il credito cambiano (il credito va insinuato al passivo, ecc.). Ma il conteggio del termine prescrizionale resta lo stesso. Un professionista e una SRL hanno parità di trattamento sul piano dei termini di prescrizione IVA. Semmai, alcuni soggetti possono essere interessati da normative speciali: es. i contributi previdenziali dei professionisti hanno un termine di 5 anni per legge; ma quello è un altro tipo di credito (non IVA). Per l’IVA tutti i soggetti passivi (imprese, professionisti, enti, privati per acquisti intracomunitari ecc.) seguono la regola del decennio per l’imposta e quinquennio per sanzioni/interessi.
9. Domanda: Cosa succede agli interessi maturati dopo 5 anni di inerzia? Devo pagarli comunque in parte?
Risposta: Gli interessi sono un flusso continuo. In teoria, se l’inerzia supera i 5 anni, gli interessi più vecchi cadono in prescrizione man mano. Poniamo che per 6 anni l’Agente non faccia nulla: gli interessi maturati dal 1º al 6º anno, quelli del primo anno sono persi (prescritti) perché sono trascorsi più di 5 anni senza richiesta; quelli del secondo anno cadranno dopo il 7º anno, e così via. Quindi se dopo 6 anni arriva un’intimazione: – Il Fisco potrà legalmente pretendere gli interessi maturati negli ultimi 5 anni (anni 2-6, se contiamo da fine del 1°), ma non quelli maturati nel primo anno di silenzio. – In pratica, spesso l’Agente ricalcola tutti gli interessi dalla data della cartella come se nulla fosse, ma il contribuente può contestare che la quota relativa al periodo oltre i 5 anni è prescritta. È un calcolo non semplice, ma si può fare assistendosi di un tecnico (bisogna vedere i tassi anno per anno e spezzare il conteggio). – D’altra parte, se la completa inattività supera i 5 anni, di solito conviene eccepire la prescrizione totale almeno di interessi e sanzioni, come fanno molti. Il Fisco a volte su questo cede (riconosce di non poter riscuotere interessi datati). Quindi, no, non devi pagare gli interessi oltre il quinquennio di inerzia, ma realisticamente potresti doverli contestare attivamente. Spesso, infatti, l’ufficio applica tutto e sta al contribuente eccepire.
10. Domanda: Quali sono le sentenze più importanti da conoscere su questa materia?
Risposta: Elenchiamo alcune pronunce chiave: – Cass. Sezioni Unite n. 23397/2016 – Ha risolto il contrasto stabilendo che la cartella non impugnata non si trasforma in un giudicato per la prescrizione (niente automatismo 2953 c.c.), e che il termine di prescrizione dipende dalla natura del tributo (5 anni se previsto da legge o se obbligazione periodica, altrimenti 10 anni) . – Cass. Sezioni Unite n. 25790/2009 – Già prima, in ambito sanzioni, chiarì che sanzioni tributarie: 5 anni senza giudicato, 10 anni con giudicato . – Cass. n. 2941/2007 – Riferimento spesso citato per ribadire che IVA/Irpef non sono prestazioni periodiche, quindi prescrizione 10 anni . – Cass. n. 20600/2011 – Notò che per sanzioni da cartella senza giudicato vale 5 anni dalla data di iscrizione a ruolo . – Cass. n. 27055/2022 – Conferma orientamento: cartella non fondata su sentenza, prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi . – Cass. n. 2095/2023 – (Ordinanza 24/01/2023) ribadisce prescrizione quinquennale sanzioni ex art. 20 D.lgs 472/97 e interessi ex art. 2948 c.c., cita vari precedenti . – Cass. n. 5220/2024 – (Ordinanza 27/02/2024) ennesima conferma: interessi su tributi = 5 anni, sanzioni 5 anni, salvo sentenza . – Cass. SU n. 11676/2024 – (30/04/2024) ha riaffermato che i tributi erariali (IVA, IRPEF, IRAP) soggiacciono a prescrizione decennale, consolidando definitivamente il quadro . – Cass. n. 27504/2024 – (23/10/2024) sull’effetto interruttivo della rateizzazione: la richiesta di dilazione riconosce il debito e impedisce di eccepire disconoscimento delle cartelle, interrompendo la prescrizione . Queste sono solo alcune; la materia è stata oggetto di molte pronunce, ma quelle citate costituiscono i pilastri. Conoscerle è utile soprattutto per gli addetti ai lavori (avvocati, commercialisti) che difendono i contribuenti, così da poterle citare nelle memorie e negli atti.
Conclusioni
Dal punto di vista del debitore di somme iscritte a ruolo per IVA, la prescrizione rappresenta un elemento di tutela fondamentale contro pretese tardive del Fisco. Tuttavia, come abbiamo visto, la disciplina è articolata e richiede attenzione: il termine decennale si applica all’imposta, ma termini più brevi (quinquennali) tutelano per le sanzioni e gli interessi . Questa differenza può consentire al contribuente di ridurre significativamente l’importo dovuto qualora vi sia stata inerzia della riscossione per almeno 5 anni, pur dovendo magari ancora corrispondere il tributo principale se non sono passati 10 anni. Per massimizzare le proprie tutele, il debitore deve: – Conoscere il dies a quo e monitorare il decorso del tempo dalla notifica o dall’ultimo atto; – Conservare documentazione delle notifiche (cartelle, intimazioni, ecc.); – All’occorrenza, sollevare tempestivamente l’eccezione di prescrizione nelle sedi competenti, aiutandosi con il supporto di professionisti che sappiano inquadrare correttamente la questione in fatto e in diritto; – Valutare con cautela azioni come la rateizzazione, sapendo che interrompono i termini (a volte riattivando debiti prossimi alla prescrizione).
In un’ottica più ampia, l’ordinamento italiano bilancia l’esigenza dello Stato di riscuotere i tributi dovuti con quella del cittadino di non restare per troppo tempo esposto a richieste di pagamento. Il quadro normativo attuale – alla luce delle pronunce più autorevoli della Corte di Cassazione aggiornate al 2025 – delinea un sistema in cui: – Dopo 5 anni, il contribuente persona fisica, professionista o imprenditore, ha una prima “ancora di salvezza” per liberarsi di multe e interessi non sollecitati . – Dopo 10 anni, anche il tributo IVA in sé non può più essere preteso , chiudendo la partita definitivamente (fatti salvi eventi interruttivi nel frattempo). – Le regole sono ormai ben definite e consolidate, il che permette agli operatori di agire con un certo grado di certezza. Le recenti pronunce, soprattutto delle Sezioni Unite, hanno eliminato vecchie incertezze (come la querelle sul giudicato implicito della cartella) .
In conclusione, la prescrizione delle cartelle esattoriali IVA è un tema tecnico ma di estrema importanza pratica. Questa guida ha fornito un’analisi avanzata ma dal taglio comprensibile, con riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati, per aiutare avvocati, consulenti, imprenditori e privati a orientarsi e a difendere efficacemente i propri diritti di fronte al Fisco. Conoscere i termini di prescrizione – e la differenza tra imposta, sanzioni e interessi – significa avere consapevolezza del fattore tempo come alleato nella gestione del proprio debito tributario, purché lo si gestisca attivamente e con cognizione di causa.
Fonti e Riferimenti normativi/giurisprudenziali principali:
- Codice Civile: art. 2934 c.c. (estinzione per prescrizione), 2946 c.c. (prescrizione ordinaria 10 anni), 2948 n.4 c.c. (prescrizione quinquennale interessi e obbligazioni periodiche) , 2953 c.c. (conversione in prescrizione decennale a seguito di giudicato) .
- D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, art. 20 (termine di decadenza e prescrizione di 5 anni per sanzioni tributarie) .
- D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 25 (termini di notifica cartella), art. 19 (dilazione pagamento), art. 30 (interessi di mora), art. 50 (intimazione ad adempiere).
- Cassazione Civile Sez. Unite n. 23397/2016 – in materia di prescrizione cartella non impugnata (principi generali su art. 2953 c.c. e termini propri dei tributi) .
- Cassazione Sez. Unite n. 11676/2024 – conferma prescrizione decennale tributi erariali, quinquennale accessori .
- Cassazione Sez. V n. 2941/2007 – IVA non prestazione periodica, prescrizione 10 anni .
- Cassazione Sez. V n. 20600/2011 – prescrizione quinquennale sanzioni da cartella non impugnata .
- Cassazione Sez. V n. 27055/2022 – cartella non su sentenza: prescrizione 5 anni sanzioni/interessi .
- Cassazione Sez. V n. 2095/2023 – applicazione di art. 20 D.Lgs 472/97 e art. 2948 c.c. per sanzioni/interessi .
- Cassazione Sez. V n. 5220/2024 – ribadisce autonomia interessi (5 anni) e sanzioni (5 anni) .
- Cassazione Sez. V n. 27504/2024 – istanza di rateazione come riconoscimento del debito e atto interruttivo .
- Cassazione SS.UU. n. 25790/2009 – sanzioni tributarie: 5 anni ordinario, 10 anni se giudicato .
- Cassazione SS.UU. n. 29538/2019 – (non citata sopra, ma rilevante in altre fattispecie di notifica) e altre minori per completezza.
Ciascuna di queste fonti contribuisce al quadro complessivo delineato. È consigliabile, per approfondimenti ulteriori, consultare le sentenze integrali (ad es. tramite database giuridici o siti istituzionali della Corte di Cassazione) e le circolari esplicative eventualmente emanate dall’Agenzia delle Entrate o dalla stessa Agenzia Riscossione su aspetti particolari.
In definitiva, il punto di vista del debitore informato sulle regole della prescrizione può fare la differenza tra subire passivamente una pretesa fiscale e opporsi con successo esercitando i propri diritti entro i confini della legge. Conoscere e far valere la prescrizione, quando spettante, è pienamente legittimo e confermato dalle fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli aggiornate al 2025 qui esposte.
Fonti:
Cass., sez. unite civ., 17 novembre 2016, n. 23397.
Cass., n. 4969/2024.
Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 7711 del 23 marzo 2025.
Hai ricevuto una cartella esattoriale per IVA e ti stai chiedendo se il debito sia ormai prescritto? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto una cartella esattoriale per IVA e ti stai chiedendo se il debito sia ormai prescritto?
Vuoi sapere come funziona la prescrizione per imposta, sanzioni e interessi, e come puoi difenderti da una richiesta tardiva?
Il tema della prescrizione delle cartelle IVA è molto delicato, perché le regole non sono uguali per tutte le voci: occorre distinguere tra imposta principale, sanzioni amministrative e interessi di mora.
👉 Conoscere i termini precisi di prescrizione è fondamentale per valutare la legittimità della cartella e, se del caso, contestarla.
⚖️ Prescrizione dell’imposta IVA
- L’IVA è un tributo armonizzato di natura periodica.
- La prescrizione ordinaria è di 10 anni, salvo eventuali atti interruttivi notificati nei termini (es. solleciti, intimazioni di pagamento, pignoramenti).
- Ogni atto interruttivo fa ripartire il termine da capo.
📌 Prescrizione delle sanzioni IVA
- Le sanzioni amministrative tributarie si prescrivono in 5 anni.
- Il termine decorre dalla data di notifica della cartella o dell’atto impositivo.
- Anche qui valgono gli atti interruttivi, che sospendono o fanno ripartire i termini.
📌 Prescrizione degli interessi di mora
- Gli interessi seguono la prescrizione propria dei crediti accessori: 5 anni.
- Decorrono dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- Anch’essi si interrompono con le notifiche o gli atti di riscossione.
🔍 Come difendersi
- Analizza la cartella e gli atti successivi: individua se e quando sono stati notificati atti interruttivi.
- Verifica i termini di prescrizione: 10 anni per l’imposta, 5 anni per sanzioni e interessi.
- Raccogli la documentazione: notifiche ricevute, estratti di ruolo, atti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
- Eccepisci la prescrizione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria o al giudice dell’esecuzione.
- Predisponi un ricorso o un’opposizione per far dichiarare estinto il debito prescritto.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Controlla la regolarità delle notifiche e il rispetto dei termini di prescrizione;
- 📌 Individua la differenza tra imposta, sanzioni e interessi, eccependo la prescrizione parziale;
- ✍️ Predispone ricorsi e opposizioni per far dichiarare estinti i debiti prescritti;
- ⚖️ Ti rappresenta nei giudizi tributari e nelle opposizioni esecutive;
- 🔁 Valuta soluzioni alternative, come rottamazioni o definizioni agevolate, quando più convenienti.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in prescrizione di cartelle esattoriali e contenzioso tributario;
- ✔️ Specializzato in IVA e riscossione tributaria;
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
La prescrizione delle cartelle esattoriali IVA non è uguale per tutte le voci:
- 10 anni per l’imposta;
- 5 anni per sanzioni;
- 5 anni per interessi.
Con una difesa legale mirata puoi eccepire la prescrizione totale o parziale del debito, ridurre drasticamente l’importo richiesto e proteggere il tuo patrimonio.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro cartelle IVA prescritte inizia qui.