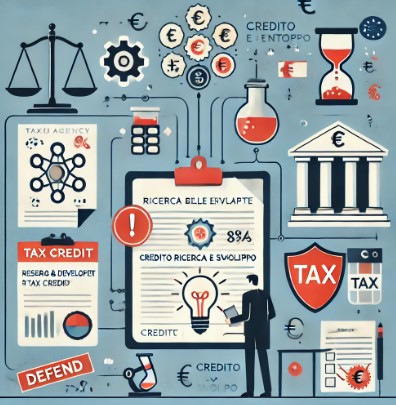Hai usufruito del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate? Negli ultimi anni i controlli su questo bonus si sono intensificati, con particolare attenzione alla corretta qualificazione delle attività come R&S e alla documentazione presentata. Una contestazione può comportare il recupero del credito con sanzioni e interessi, ma esistono strumenti per difendersi.
Quando scattano le contestazioni sul credito R&S
– Se le attività svolte non vengono considerate effettiva ricerca e sviluppo ma semplici attività ordinarie o di routine
– Se manca la documentazione tecnica che giustifichi i progetti dichiarati
– Se le spese indicate non sono state ritenute ammissibili (es. costi di personale, consulenze, materiali)
– Se la rendicontazione dei costi è incompleta o non conforme alla normativa
– Se il credito è stato compensato in F24 senza adeguata esposizione nel quadro RU della dichiarazione
Cosa rischi in caso di contestazione
– Recupero del credito d’imposta già utilizzato
– Applicazione di sanzioni dal 30% al 200% dell’importo contestato
– Addebito di interessi di mora
– Possibile contestazione di indebita compensazione in caso di importi elevati
– Avvio di azioni esecutive se non viene versato quanto richiesto
Come difendersi da una contestazione sul credito R&S
– Dimostrare la natura innovativa e sperimentale dei progetti presentando relazioni tecniche, studi e report di laboratorio
– Fornire documentazione contabile e fiscale completa che giustifichi i costi sostenuti
– Contestare la valutazione dell’Agenzia se basata su interpretazioni troppo restrittive della normativa
– Evidenziare la buona fede del contribuente, soprattutto in presenza di incertezze interpretative della disciplina
– Impugnare l’avviso di recupero davanti alla Corte di Giustizia Tributaria per chiedere l’annullamento o la riduzione della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la contestazione e verificare i presupposti di legge per il recupero del credito
– Raccogliere e organizzare la documentazione tecnica e contabile utile alla difesa
– Contestare la sproporzione delle sanzioni applicate
– Difendere il contribuente nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e in sede giudiziale
– Valutare soluzioni conciliative o adesioni che permettano di ridurre l’impatto economico
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– Il riconoscimento della legittima spettanza, totale o parziale, del credito
– L’annullamento o la riduzione della contestazione e delle sanzioni
– La sospensione delle procedure esecutive collegate all’avviso di recupero
– La tutela del patrimonio aziendale da pretese fiscali indebite
– La certezza di pagare solo quanto realmente dovuto
⚠️ Attenzione: il credito ricerca e sviluppo è uno degli incentivi più complessi e soggetti a interpretazioni. Molte contestazioni del Fisco nascono da valutazioni arbitrarie o da documentazione incompleta: con una difesa ben strutturata è possibile ribaltare l’accertamento.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e agevolazioni fiscali – ti spiega come affrontare una contestazione dell’Agenzia delle Entrate sul credito ricerca e sviluppo e come difenderti in modo efficace.
👉 Hai ricevuto una contestazione sul credito R&S? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo progetto, verificheremo la documentazione e predisporremo la strategia difensiva più efficace per proteggere la tua impresa.
Introduzione
Introduzione: Quando l’Agenzia delle Entrate contesta a un’impresa o contribuente un credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S), l’impatto può essere gravoso. Si richiede la restituzione del credito utilizzato in compensazione, con l’aggiunta di sanzioni pecuniarie significative e interessi, e nei casi più seri può scattare anche una denuncia penale per indebita compensazione. Negli ultimi anni si è assistito a un’intensificazione dei controlli su questo incentivo fiscale – introdotto per le annualità 2015-2019 e rifinanziato con formule diverse dal 2020 – a causa di abusi diffusi e utilizzi disinvolti del bonus in ambiti non consentiti. Di fronte a un atto di recupero del credito R&S, è fondamentale conoscere i propri diritti di difesa e le strategie per opporsi efficacemente, soprattutto alla luce delle novità normative e giurisprudenziali aggiornate ad agosto 2025.
Questa guida, di livello avanzato ma con linguaggio il più possibile chiaro, esamina dettagliatamente la materia dal punto di vista del contribuente (debitore), offrendo riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati, tabelle riepilogative e una sezione Domande & Risposte. Verranno illustrati:
- Il quadro normativo del credito R&S e le caratteristiche dell’agevolazione.
- I motivi tipici di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio, la mancanza del carattere di “novità” dei progetti finanziati o altre cause di decadenza).
- La distinzione chiave tra crediti “non spettanti” e “inesistenti”, chiarita di recente da norme e sentenze, con i relativi riflessi su termini di accertamento, sanzioni amministrative e conseguenze penali.
- L’iter di controllo e accertamento: dalle verifiche iniziali all’eventuale emissione dell’atto di recupero, esaminando i diritti del contribuente (contraddittorio, difesa tecnica, ecc.) e le opzioni difensive (ravvedimento operoso, procedure di riversamento spontaneo, ricorso alle Corti di giustizia tributaria, ecc.).
- I profili penali tributari correlati: quando scatta il reato di indebita compensazione (art. 10‐quater D.Lgs. 74/2000) e come incide l’adesione a procedure di sanatoria sulla punibilità, considerando sia le persone fisiche coinvolte sia le possibili responsabilità degli enti.
In appendice, una serie di FAQ (domande frequenti) chiarirà in forma dialogica i dubbi pratici più comuni, mentre tabelle riepilogative aiuteranno a sintetizzare i punti chiave – ad esempio, il confronto tra credito non spettante e credito inesistente in termini di definizione, sanzioni e termini di accertamento. L’obiettivo è fornire a professionisti (avvocati tributaristi, dottori commercialisti), imprenditori e contribuenti evoluti uno strumento esaustivo per difendersi efficacemente da contestazioni sul credito R&S, preservando i propri diritti e minimizzando i rischi. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono riportate per esteso, così da consentire ulteriori approfondimenti.
Il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo: quadro normativo e caratteristiche
Il credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (art. 3), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. L’agevolazione mirava a incentivare gli investimenti delle imprese in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, riconoscendo un credito d’imposta fino al 50% delle spese incrementali in R&S sostenute nel periodo 2015-2019 rispetto a una media storica (di norma il triennio 2012-2014). Dal 2020 il credito R&S è stato sostituito da nuovi crediti d’imposta distinti per ricerca, innovazione tecnologica e design, con aliquote e massimali rivisti, ma resta emblematico per via del consistente contenzioso che ha generato.
Modalità di fruizione: Il credito R&S era utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Come per molti crediti d’imposta “automatici”, l’impresa calcolava autonomamente l’ammontare spettante e lo indicava nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, utilizzandolo poi in compensazione dei debiti tributari. Questo meccanismo snello, se da un lato ha permesso un utilizzo immediato del beneficio, dall’altro ha fatto sì che eventuali errori o abusi emergessero solo ex post, in sede di controllo successivo. Va ricordato che per usufruire legittimamente del credito R&S erano posti alcuni adempimenti formali a pena di decadenza, in particolare: l’obbligo di certificazione delle spese da parte di un revisore legale (per aziende non già soggette a revisione), da allegare al bilancio, e la predisposizione di una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca svolti e della loro riferibilità alle attività agevolabili (come richiesto dal D.M. 27 maggio 2015 attuativo della misura). La mancata osservanza di tali oneri (es. assenza dell’attestazione di certificazione delle spese) può rendere il credito inutilizzabile e costituire violazione formale determinante, come si vedrà in seguito (classificabile secondo la normativa attuale come credito “non spettante” per difetto di un adempimento obbligatorio).
Attività e costi ammissibili: in estrema sintesi, erano ammissibili al credito R&S le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale come definite a livello europeo e richiamate dal decreto attuativo. I costi agevolabili includevano principalmente: spese per personale (ricercatori e tecnici impiegati nei progetti), quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, contratti di ricerca extra-muros con università o enti, competenze tecniche e privative industriali. Non erano invece agevolabili le attività di innovazione routinaria o di semplice adattamento/introduzione di prodotti esistenti, né i costi di produzione corrente non direttamente afferenti alla ricerca. Il confine tra ciò che costituisce “attività di R&S” in senso stretto e ciò che ne rimane fuori (ad esempio miglioramenti ordinari di processo, personalizzazioni per clienti, o progetti privi di un carattere di originalità) si è rivelato, nella pratica, molto sottile e di non immediata definizione. L’Agenzia delle Entrate, nelle sue verifiche, ha spesso fatto riferimento ai criteri internazionali del Manuale di Frascati (per la ricerca scientifica) e del Manuale di Oslo (per l’innovazione) per valutare l’ammissibilità dei progetti. Tuttavia, tali manuali non erano esplicitamente richiamati nella normativa primaria all’epoca e – come chiarito dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico – costituiscono semmai guide tecniche non vincolanti se non espressamente menzionate dalla legge. Su questo punto si innesta una parte rilevante del contenzioso.
Diffusione e utilizzo del credito: Il credito R&S è stato ampiamente utilizzato da migliaia di imprese italiane di ogni dimensione tra il 2015 e il 2019. In molti casi, soprattutto PMI prive di competenze fiscali interne, l’accesso all’agevolazione è avvenuto con l’ausilio di consulenti esterni specializzati in finanza agevolata. Purtroppo sono emerse anche pratiche opportunistiche: progetti “gonfiati” o privi di reale contenuto innovativo, imputazione di costi non pertinenti (spese commerciali o amministrative spacciate per R&S), errori nel calcolo dell’incremento o nella determinazione della media storica, nonché casi di documentazione insufficiente o predisposta ex post. Inoltre, un’area grigia normativa ha riguardato le attività di ricerca commissionate da imprese estere: solo a fine 2018 una norma di interpretazione autentica (L. 145/2018, art. 1 c. 72) ha chiarito che dal 2017 non erano agevolabili i progetti su commessa da clienti esteri, lasciando però scoperte le annualità precedenti e generando incertezze. Tutti questi fattori hanno contribuito a far sì che l’Agenzia delle Entrate individuasse il credito R&S come ambito ad alto rischio di abuso, intensificando i controlli a tappeto negli anni successivi.
Controlli e contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sul credito R&S
L’attività di controllo: A partire dal 2020 circa, l’Agenzia delle Entrate (spesso in collaborazione con la Guardia di Finanza) ha avviato numerose verifiche mirate sulla fruizione del credito R&S. Le verifiche possono svolgersi in due modalità: in loco presso la sede dell’azienda (accessi, ispezioni e acquisizione di documentazione) oppure mediante questionari e inviti a comparire presso gli uffici (controlli “a tavolino”). In entrambi i casi, all’impresa viene tipicamente richiesto di fornire copia della documentazione a supporto del credito: la relazione tecnica descrittiva dei progetti svolti, l’elenco dettagliato dei costi sostenuti con relative fatture, i registri contabili, le attestazioni del revisore sui costi, eventuali brevetti o pubblicazioni derivanti dalla ricerca, ecc.
Una criticità segnalata dai contribuenti è che, nonostante l’ingente mole di documenti forniti e spiegazioni tecniche fornite, l’Amministrazione finanziaria spesso mantiene inalterata la linea di contestazione iniziale, senza avvalersi di competenze tecnico-scientifiche esterne adeguate. In pratica, i funzionari verificatori (di formazione economico-contabile) valutano l’“innovatività” dei progetti senza coinvolgere organi tecnici super partes: emblematicamente, l’Agenzia delle Entrate stessa ha dichiarato di non avere competenza a giudicare se specifiche attività rientrino fra quelle agevolabili, rinviando tali valutazioni al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in sede di interpello. Nonostante ciò, nei controlli ex post l’Ufficio spesso procede autonomamente ad escludere progetti dal beneficio per asserita mancanza dei requisiti richiesti.
Motivi tipici di contestazione: Dall’analisi dei casi pratici emerge che l’Agenzia delle Entrate contesta più frequentemente i crediti R&S per:
- Carente carattere di novità/originalità dei progetti dichiarati di R&S. È spesso il primo rilievo: si sostiene che l’attività svolta dall’azienda non abbia apportato un avanzamento scientifico o tecnologico significativo, ma si limiti a modifiche minori o personalizzazioni. In altri termini, il progetto viene considerato fuori dall’ambito oggettivo della definizione di R&S agevolabile. Ad esempio, se un’azienda software ha richiesto il credito per sviluppare una nuova funzionalità di un programma esistente, l’Ufficio potrebbe obiettare che si tratta di sviluppo routine e non di vera ricerca. Su questo fronte, la “novità assoluta” non è un requisito esplicito di legge (basta la novità relativa all’impresa e un contenuto di incertezza tecnico-scientifica), e infatti né il decreto ministeriale attuativo né il Manuale di Frascati richiedono l’ottenimento di un brevetto o di un’invenzione radicale per soddisfare il requisito dell’innovatività . Diverse sentenze di merito hanno dato ragione ai contribuenti su tale aspetto, ritenendo ammissibili anche progetti di miglioramento significativo (vedasi ad es. CTP Bologna n.549/2022).
- Spese non ammissibili: l’altro filone di contestazione riguarda la natura dei costi portati a credito. Si verificano casi di costi eterogenei (non strettamente legati alla ricerca) indebitamente inclusi nel calcolo, come ad esempio costi commerciali, di produzione o amministrativi. Oppure spese di ricerca sostenute da società del gruppo non residenti (problema delle commesse estere post-2017). Ancora, l’Agenzia spesso non riconosce compensi a amministratori o titolari d’azienda come spese di personale R&S (specie nelle PMI) se non adeguatamente documentati, oppure pone limiti all’inclusione di consulenze esterne generiche. Tali esclusioni riducono il totale delle spese eleggibili e conseguentemente il credito spettante.
- Errori di calcolo e violazioni formali: molti atti di recupero segnalano errori nella determinazione del credito, ad esempio: errata media storica di riferimento (magari perché l’impresa ha escluso costi di un anno di base in realtà da includere, gonfiando così l’incremento), errata applicazione delle aliquote (il credito era al 50% per ricerca e 25% per sviluppo, ma alcune spese andavano al 25%), utilizzo del credito oltre i limiti annuali consentiti (il credito R&S non aveva un tetto generale se non €5 milioni/anno, ma se cumulato con altri crediti poteva sforare i limiti di compensazione orizzontale di €700k, poi €2M, etc.). Inoltre, la mancata osservanza di adempimenti obbligatori è motivo di contestazione: come accennato, l’assenza della relazione tecnica o della certificazione dei costi da parte del revisore portano l’Ufficio a sostenere che il credito non poteva essere fruito (violazione dell’art. 3, c.11 DL 145/2013). Queste situazioni sono spesso configurate più come crediti “non spettanti” per violazione di requisiti formali o quantitativi, piuttosto che come inesistenti (vedremo la differenza).
- Abuso/frode: nei casi più gravi (per fortuna rari nel R&S rispetto ad altri bonus), l’Agenzia riscontra vere e proprie condotte fraudolente, quali: creazione di fatti contabili inesistenti (progetti mai realizzati ma documentati fittiziamente), uso di fatture false per costi di R&S mai sostenuti realmente, interposizione di società allo scopo di gonfiare le spese, simulazioni contrattuali (es. contratti di ricerca con parti correlate privi di sostanza). In tali ipotesi estreme, il credito d’imposta è completamente privo di base reale, e l’Ufficio lo qualifica senz’altro come credito “inesistente” frutto di frode. Si tratta di situazioni borderline che spesso sconfinano nel penale (frode fiscale).
Atto di recupero e qualificazione del credito come “inesistente”: Al termine della verifica, se le giustificazioni fornite dal contribuente non sono ritenute sufficienti, l’Agenzia delle Entrate procede a emettere un Provvedimento di recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato (talvolta strutturato come avviso di accertamento se il recupero coinvolge anche imposte dirette correlate). In tale atto l’Ufficio contesta formalmente l’indebita fruizione del credito R&S, indicando l’importo da restituire, gli interessi maturati e le sanzioni amministrative applicate.
Un punto cruciale è come l’Amministrazione qualifica il credito contestato nell’atto: negli anni scorsi la prassi (conforme alle istruzioni interne, ad es. Circolare Ag. Entrate n. 31/E del 23.12.2020) è stata quella di classificare praticamente tutte le ipotesi di credito R&S non spettante come “crediti inesistenti” ai sensi dell’art. 13, co. 5, D.Lgs. 471/1997, sostenendo che l’agevolazione fosse priva dei presupposti sostanziali. Ciò aveva (ed ha) conseguenze gravose per il contribuente: se il credito è “inesistente”, l’Ufficio applica una sanzione pari al 100% fino al 200% dell’importo compensato e beneficia di un termine di accertamento più lungo (8 anni) rispetto al normale. Inoltre, considera dovuta la segnalazione penale per utilizzo di credito inesistente oltre soglia, trattando il contribuente alla stregua di chi ha precostituito un credito fittizio in maniera fraudolenta. In molti casi concreti, però, le violazioni riscontrate erano di natura ben diversa (errori o interpretazioni discutibili), sicché tale impostazione “punitiva” è apparsa eccessiva e ha dato luogo a numerosi ricorsi. Come evidenziato da varie sentenze pro-contribuente, non è affatto scontato che un credito R&S contestato sia da considerarsi “inesistente” invece che semplicemente “non spettante”. Anzi, la distinzione tra queste due categorie è stata oggetto di un acceso dibattito giuridico fino al recente intervento chiarificatore della Cassazione a Sezioni Unite e della riforma 2024. Approfondiamo dunque questa distinzione, essenziale per modulare la difesa.
Credito “non spettante” vs “credito inesistente”: differenze, sanzioni e termini
Quando si parla di utilizzo indebito di crediti d’imposta, la legge e la prassi distinguono due fattispecie: i crediti non spettanti e i crediti inesistenti. La differenza terminologica può sembrare sfumata, ma comporta conseguenze drasticamente diverse in termini di sanzioni applicabili, termini entro cui il Fisco può intervenire e perfino profili penali. Vediamo innanzitutto le definizioni normative, aggiornate alle ultime modifiche del 2024, e successivamente riassunte in una tabella comparativa:
- Credito d’imposta “non spettante”: è il credito utilizzato in compensazione in violazione delle condizioni di legge, pur esistendo di fatto una base creditizia reale. In altre parole, il credito era originariamente previsto dall’ordinamento ma il contribuente non ne aveva diritto, o non più diritto, per motivi come: utilizzo oltre i limiti o in periodi non consentiti, mancanza di qualche elemento ulteriore richiesto per l’agevolazione, omesso espletamento di formalità necessarie. Ad esempio, rientra nel “non spettante” il caso di un credito R&S utilizzato in misura eccedente il massimale annuo consentito, oppure fruito non rispettando la ripartizione in quote annuali previste (tempistica errata). Ancora, se un progetto presentava tutti i requisiti di R&S tranne uno specifico elemento richiesto dalla norma (p.es. mancava la certificazione formale delle spese, o l’attività era di R&S ma svolta su commessa estera non agevolabile), il credito maturato su quel progetto sarà “non spettante” – cioè teoricamente esistente come calcolo, ma al di fuori dell’ambito della legge agevolativa. In sintesi, nel credito non spettante il presupposto base c’è, ma il suo utilizzo è risultato indebito per violazione di requisiti o condizioni.
- Credito d’imposta “inesistente”: è il credito che difetta di un presupposto costitutivo sostanziale, risultando in tutto o in parte privo di una base reale secondo la disciplina di riferimento. Si tratta dei crediti fiscali che potremmo definire “non reali” o “fantasma”: ad esempio un credito calcolato su spese che in realtà non rientrano affatto tra quelle agevolabili (difettando quindi del requisito oggettivo principale), oppure un credito ottenuto mediante false rappresentazioni (documenti falsi, fatture per operazioni inesistenti, simulazione di attività mai svolte). La nuova normativa (D.Lgs. 87/2024) precisa infatti che sono inesistenti: (1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati dalla legge nell’agevolazione; (2) i crediti in cui tali requisiti, sebbene dichiarati, sono frutto di rappresentazioni fraudolente con documenti falsi o altri artifici. Dunque rientra nell’inesistente il credito totalmente privo di fondamento (es: credito R&S calcolato su attività che non sono affatto R&S secondo la legge, o su costi che non esistono nei conti dell’azienda). Anche un credito “artificialmente creato” inserendo un codice tributo in F24 senza che vi sia a monte alcuna spesa eleggibile rientra in questa categoria, come chiarito dal MEF. In sintesi, nel credito inesistente manca il substrato sostanziale che giustifica l’agevolazione, spesso a causa di condotte dolose o di errori clamorosi.
In passato la distinzione non era esplicitata chiaramente dalle norme, e l’Agenzia tendeva ad assimilare molti casi al concetto di “inesistente” in senso lato. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenze nn. 34419 e 34445 dell’11 dicembre 2023) è intervenuta per dirimere i contrasti, stabilendo i criteri distintivi: un credito può dirsi inesistente solo quando manca il presupposto costitutivo e la mancanza è tale da non emergere dai controlli automatizzati o formali sui dati dichiarati. In altre parole, secondo la Cassazione 2023, il credito inesistente è una fattispecie più grave e ristretta: manca la base reale (credito “non vero”) e tipicamente il contribuente non lo ha nemmeno indicato in dichiarazione rendendolo rilevabile dai controlli incrociati. Se invece il credito, pur non spettando, deriva da operazioni effettive e risulta dalle dichiarazioni (quindi l’anagrafe tributaria poteva intercettarlo), si tratterà di un credito non spettante, meno offensivo. Ad esempio, un’azienda che abbia erroneamente indicato nel quadro RU un credito R&S su spese non nuove ma comunque sostenute davvero, ha opposto indebitamente un credito reale e dichiarato: questo scenario – come riconosciuto anche da giurisprudenza di merito – esclude la natura fraudolenta e va ricondotto al non spettante con sanzione ridotta. Viceversa, chi fabbrica un credito fittizio per costi mai avvenuti, oppure non dichiara affatto il credito nelle forme dovute emergendo solo a seguito di indagine, ricade nell’inesistenza pura.
Le recenti novità legislative del 2024 hanno recepito tali principi, fornendo per la prima volta definizioni positive di entrambe le categorie. Il D.Lgs. 12 gennaio 2024, n. 13 e soprattutto il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (attuativi della delega fiscale 2023) hanno riscritto la disciplina: oggi l’art. 38-bis del DPR 600/1973 distingue nettamente i termini di accertamento (5 anni per crediti non spettanti, 8 anni per inesistenti) e l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni differenziate (ridotte rispetto al passato). Inoltre, il MEF con atto di indirizzo del 1° luglio 2025 ha chiarito con esempi le tipologie di credito non spettante (include, ad es., utilizzi oltre soglia o oltre termine, casi di difetto di requisiti ulteriori, omissione di adempimenti formali a pena di decadenza) e di credito inesistente (mancanza requisiti di base; condotte fraudolente). Importante: è stato confermato che manuali tecnici come il “Manuale di Frascati” non possono costituire fonte di requisiti aggiuntivi se non espressamente richiamati dalla legge; quindi la loro violazione, di per sé, non rende ipso facto inesistente un credito, a meno che la norma primaria o secondaria li integri specificamente.
Di seguito una tabella di sintesi che confronta i due concetti in base ai principali aspetti:
<table> <thead> <tr><th> </th><th>Credito <u>non spettante</u></th><th>Credito <u>inesistente</u></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td><strong>Definizione</strong></td><td>Credito utilizzato indebitamente pur se basato su spese/operazioni reali. Mancano in tutto o in parte i requisiti per goderne, oppure violate condizioni/modalità di utilizzo. Esempi: credito spettante ma usato oltre il limite o in periodo non consentito; progetto con spese vere ma fuori ambito agevolazione (manca requisito ulteriore); credito fruito senza aver rispettato un adempimento formale obbligatorio.</td><td>Credito privo di presupposto reale secondo la disciplina agevolativa, oppure ottenuto con mezzi fraudolenti. In sostanza credito “fittizio” o creato artificiosamente. Esempi: spese dichiarate come R&S ma che non sono attività di R&S secondo la legge; costi totalmente inventati o documenti falsi; crediti non indicati in dichiarazione e non rilevabili da controlli automatici (occultamento).</td></tr> <tr><td><strong>Dichiarazione in UNICO</strong></td><td>Generalmente indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (o in altri prospetti), quindi conoscibile dall’Amministrazione finanziaria nei controlli formali. La sua esistenza contabile è riconosciuta, ma viene contestato l’errore di spettanza.</td><td>Spesso non indicato o indicato in modo tale da non emergere dai controlli automatizzati. In molti casi l’impresa non ha esposto il credito nelle dichiarazioni, oppure lo ha “creato” direttamente in F24 senza un codice identificativo corretto.</td></tr> <tr><td><strong>Termine di accertamento</strong></td><td>Ordinario: 5 anni dalla dichiarazione/uso (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo del credito). Questo termine si applica ora a tutti i casi che non soddisfano i criteri dell’inesistenza. Esempio: credito usato nel 2019, contestabile fino al 31/12/2024 salvo sospensioni.</td><td>Prorogato: 8 anni successivi all’anno di utilizzo in compensazione. Introdotto da DL 185/2008 e confermato ora nell’art. 38-bis DPR 600/73. Esempio: credito fittizio usato nel 2019, contestabile fino al 31/12/2027. (Se il credito è anche occultato alla dichiarazione, di fatto il termine lungo decorre dall’utilizzo in F24.)</td></tr> <tr><td><strong>Sanzione amministrativa</strong></td><td>25% dell’importo del credito utilizzato indebitamente (aliquota ridotta in vigore dal 2024, prima era 30%) . Se il credito è già stato recuperato prima dell’atto (ad es. con ravvedimento operoso), la sanzione si applica su quanto non versato nei termini. – Nota: In caso di definizione agevolata (accertamento con adesione, acquiescenza) la sanzione è ulteriormente riducibile di 1/3.</td><td>70% dell’importo, aumentabile dalla metà fino al doppio (cioè fino al 140% – 210%) se il credito è frutto di comportamenti fraudolenti con falsi documenti o artifici. (In passato la sanzione edittale era 100%–200%, rivista al ribasso nel 2024). – Nota: In presenza di frode conclamata spesso l’Ufficio irroga il massimo edittale. La definizione agevolata della sanzione non è ammessa nei casi fraudolenti più gravi.</td></tr> <tr><td><strong>Rilievo penale (art. 10-quater D.Lgs.74/2000)</strong></td><td>Utilizzo di crediti non spettanti per oltre €50.000 annui configura il reato di indebita compensazione <u>semplice</u> (comma 1). Pena attuale: reclusione da 6 mesi a 2 anni. – Note: (i) Prevista non punibilità se le valutazioni tecniche erano oggettivamente incerte (clausola introdotta nel 2024 per tutelare i casi dubbi di buona fede); (ii) reato estinguibile se il contribuente paga integralmente il dovuto prima del dibattimento (art. 13 D.Lgs.74/2000, in quanto applicabile).</td><td>Utilizzo di crediti inesistenti per oltre €50.000 annui integra il reato di indebita compensazione <u>aggravata</u> (comma 2). Pena: reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni. – Note: Nessuna causa di non punibilità per incertezza normativa è prevista in questo caso (dato il carattere fraudolento). È però possibile l’esclusione della punibilità attraverso la procedura di riversamento spontaneo varata nel 2021 (vedi oltre), se perfezionata in tempo: ciò estingue l’eventuale reato ex art. 10-quater anche per crediti inesistenti.</td></tr> </tbody> </table>
Come si evince, la qualificazione corretta del credito contestato (non spettante vs inesistente) è un nodo fondamentale. Nella prassi, molti crediti R&S oggetto di recupero ricadono in realtà nella fascia non spettante – perché le spese sono state effettivamente sostenute, il credito era indicato nella dichiarazione, e la controversia verte sull’interpretazione di requisiti tecnico-normativi. Ciò apre spazi importanti di difesa: in sede contenziosa i contribuenti hanno spesso successo nel far riconoscere la natura “non fraudolenta” della violazione, ottenendo la riqualificazione a credito non spettante con conseguente riduzione di sanzioni al 30% (o 25% oggi) e contestazione tardiva oltre i 5 anni dichiarata decaduta. Ad esempio, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina con sent. n.610/2022 ha escluso l’inesistenza per un credito R&S, applicando la sanzione del 30% e ritenendo invalido l’atto emesso oltre il termine quinquennale. Oggi, con la norma del 2024 che attribuisce valenza retroattiva interpretativa alle nuove definizioni, anche nei giudizi in corso relativi ad annualità passate è possibile invocare la definizione più ristretta di “inesistente” per ricondurre il proprio caso nella categoria del non spettante (più favorevole). Va però notato che la riduzione delle sanzioni introdotta nel 2024 (70% e 25%) non è automaticamente retroattiva per il principio del tempus regit actum amministrativo (fatto salvo il principio del favor rei in casi non definitivi, che tuttavia andrebbe argomentato); quindi, ad esempio, per un credito 2018 contestato oggi come non spettante, l’infrazione è avvenuta sotto la vecchia disciplina sanzionatoria (30%). Questo significa che in un eventuale ricorso si potrebbe puntare alla riqualificazione come non spettante (per evitare l’extrema ratio di 8 anni e sanzione 100%), ma la sanzione applicabile resterebbe quella vigente nell’anno d’imposta (30%), salvo che il giudice ritenga applicabile la sanzione nuova più mite per qualche profilo di retroattività in bonam partem.
In sintesi, difendersi su questo punto tecnico-giuridico è spesso decisivo: provare che il credito contestato aveva una base reale (anche se la tesi del Fisco è che non fosse dovuto) permette di invertire l’onere di dimostrare un intento fraudolento, ridimensionando la vicenda a mera divergenza interpretativa o errore. La stessa Cassazione ha sottolineato la differenza di offensività delle due condotte: nel credito inesistente c’è un quid pluris di insidiosità (assenza totale di base reale e spesso volontà fraudolenta), mentre nel non spettante c’è una violazione meno grave, un credito con base reale opposto indebitamente. Ciò si riflette coerentemente nelle nuove cornici sanzionatorie sia amministrative che penali. Nel prossimo paragrafo vedremo come questa distinzione impatti sul termine entro cui l’Agenzia può emettere l’atto di recupero e come verificare se una contestazione è arrivata oltre i termini di decadenza.
Termini di decadenza per l’accertamento e eccezioni
Uno dei primi aspetti da valutare quando si riceve una contestazione sul credito R&S è se sono ancora aperti i termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria poteva legittimamente agire. Come accennato, la legge prevede termini diversi a seconda che si tratti di credito non spettante o credito inesistente.
- Termine per crediti non spettanti: in base all’art. 43 del DPR 600/1973 (nel testo vigente fino al 2022) e all’attuale art. 38-bis DPR 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. 13/2024), il Fisco può recuperare un credito non spettante entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione nella quale il credito è stato indicato, o a quello di utilizzo in compensazione. In pratica, si applica lo stesso termine degli accertamenti tributari ordinari. Ad esempio, un credito R&S maturato nel 2017 e utilizzato nel modello F24 nel 2018 doveva essere contestato, se considerato non spettante, entro il 31 dicembre 2023 (quinto anno dopo il 2018). Decorso tale termine, scatta la decadenza e l’atto è impugnabile per tardività. Da notare che se il credito era indicato nella dichiarazione dei redditi 2018 (presentata nel 2019), secondo alcuni potrebbe farsi decorrere il termine dal 2019; ma la norma chiarisce “successivo a quello di utilizzo”, dunque fa fede l’anno di compensazione effettiva.
- Termine per crediti inesistenti: per i crediti qualificati come “inesistenti”, una norma speciale (originariamente art. 27, c.16, DL 185/2008 conv. L.2/2009, ora rifusa nell’art. 38-bis DPR 600) concede all’Agenzia un periodo più ampio: otto anni dal relativo utilizzo. Così, in caso di credito R&S inesistente utilizzato ad es. nel 2015, il termine scadrebbe al 31 dicembre 2023. Questo termine lungo era stato pensato per contrastare frodi complesse, dove il Fisco potrebbe impiegare più tempo a scoprire il raggiro. Tuttavia, è stato spesso applicato anche a situazioni di incertezza non fraudolenta, suscitando le critiche di dottrina e giudici. Si è osservato infatti che far leva sull’ottavo anno per contestare crediti relativi a molti anni addietro può violare il principio dell’affidamento legittimo del contribuente, specie se l’azienda – confidando nel silenzio protratto del Fisco – ha pianificato negli anni le proprie risorse contando su quel beneficio.
Interruzioni e sospensioni: I termini di decadenza sopra indicati possono essere sospesi in caso di eventi particolari (p.es. se il contribuente aderisce a una procedura di accertamento con adesione, i termini si prolungano di 90 giorni; alcune sospensioni Covid hanno esteso i termini 2020). Inoltre, la presentazione della domanda di riversamento spontaneo (si veda oltre) comportava, per espressa previsione normativa, una sospensione dei termini di decadenza fino al 30 giugno 2023 per i casi in cui l’istanza è stata poi rigettata o il riversamento non perfezionato, nonché l’allungamento di due anni del termine per gli atti 2016 e 2017 nel caso di riapertura della sanatoria al 2025. Bisogna dunque verificare caso per caso se il termine utile fosse stato prorogato da disposizioni emergenziali o di sanatoria.
Strategia sulla decadenza: Se dall’analisi risulta che l’atto di recupero è stato notificato oltre il termine consentito, la decadenza va eccepita subito nel ricorso come motivo di nullità. Tuttavia, come visto, ciò dipende dalla qualificazione: spesso l’Ufficio – nel dubbio – qualifica come “inesistente” proprio per beneficiare del termine più lungo. La difesa del contribuente consisterà allora nel dimostrare che, secondo i criteri sopra esposti, il credito era al più “non spettante” e che dunque il termine era scaduto. Di nuovo, risulta centrale la differenziazione qualitativa del credito: contestare la qualificazione giuridica può mandare fuori gioco l’accertamento se tardivo. Ad esempio, in un caso seguito dalla Commissione di La Spezia (sent. n.276/2022) la mancata richiesta di parere al MISE e la natura dichiarativa del credito hanno indotto i giudici ad annullare l’atto per decadenza quinquennale, rigettando l’argomento dell’inesistenza.
In conclusione su questo punto: appena ricevuto l’atto, calcolare gli anni trascorsi e valutare la tardività è un passo obbligato. Nel far ciò bisogna considerare lo scenario peggiore (termine 8 anni) ma anche argomentare perché eventualmente non sia applicabile. Se il termine di 8 anni è rispettato ma quello di 5 no, la contestazione ruoterà attorno alla qualificazione del credito: una questione squisitamente giuridica che dovrà essere posta all’attenzione del giudice tributario, supportata dalle recenti pronunce di legittimità e dalla nuova definizione normativa.
Iter del procedimento di accertamento e diritto di difesa del contribuente
Passiamo ora a delineare come si sviluppa il procedimento che va dal controllo iniziale all’eventuale contenzioso, evidenziando i diritti e le facoltà di difesa del contribuente in ogni fase.
1. Verifica e contraddittorio endoprocedimentale: Durante la fase di verifica (sia essa un accesso in azienda o un controllo da remoto), il contribuente ha diritto di essere informato delle irregolarità riscontrate e di fornire chiarimenti e prove a suo favore. In genere, al termine delle operazioni, i verificatori redigono un Processo Verbale di Constatazione (PVC) in cui elencano i rilievi: nel nostro caso, ad esempio, “credito R&S anno X non spettante perché le attività non sono qualificabili come ricerca innovativa”, oppure “credito indebito per mancanza di documentazione probatoria delle spese”, e così via. Il PVC viene consegnato all’azienda, che entro 60 giorni può presentare osservazioni e memorie difensive scritte (ai sensi dello Statuto del Contribuente, L.212/2000). Questo è un momento fondamentale: è opportuno predisporre una risposta tecnica dettagliata, magari allegando pareri di esperti, documentazione aggiuntiva non esibita prima, riferimenti normativi a supporto. Ad esempio, se l’ufficio contesta la mancanza di novità, si potrà allegare un parere tecnico-scientifico di un professore universitario che attesti l’originalità del progetto; oppure si potrà richiamare la Circolare MISE n.59990/2018 che ha chiarito l’interpretazione di “ricerca e sviluppo ammissibile” in termini più ampi. In questa fase, l’obiettivo è convincere l’ufficio a non emettere l’atto o quantomeno a ridimensionare la contestazione (ad esempio riconoscendo parte del credito come spettante).
Il diritto al contraddittorio preventivo è sancito per gli accertamenti fiscali di natura tributaria (specie per i tributi “armonizzati” come l’IVA, ma qui trattasi di credito d’imposta): anche se la normativa sul credito R&S non prevedeva espressamente un contraddittorio obbligatorio, la prassi e i principi generali spingono l’amministrazione a sentire il contribuente prima di iscrivere a ruolo somme rilevanti. In alcuni casi, all’esito delle controdeduzioni il Fisco può decidere di archiviare (parzialmente o totalmente) la posizione o di continuare insistendo sui rilievi.
2. Emissione dell’atto di recupero o accertamento: Se le controdeduzioni non vengono accolte, l’ufficio emette il provvedimento impositivo. Per i crediti d’imposta, tecnicamente viene emesso un “Atto di recupero di credito indebito” ai sensi della L. 311/2004 (Finanziaria 2005) art. 1 c.421, spesso assimilato a un avviso di accertamento. L’atto viene notificato (a mezzo PEC o raccomandata) al contribuente. Da quel momento decorrono 60 giorni per effettuare un’eventuale impugnazione dinanzi alla Commissione (ora Corte) di Giustizia Tributaria di primo grado. È importante verificare che l’atto contenga la motivazione dettagliata e l’indicazione delle norme applicate, nonché la quantificazione di imposta, interessi e sanzioni; in caso di vizi (es. motivazione generica) ciò potrà costituire motivo di ricorso.
Entro 30 giorni dalla notifica, è inoltre facoltà del contribuente presentare istanza di accertamento con adesione all’Ufficio (D.Lgs. 218/1997). Questo istituto sospende per 90 giorni i termini del ricorso e consente di avviare un dialogo diretto con l’ufficio per trovare un accordo transattivo sull’importo dovuto. Nell’ambito di un credito R&S contestato, l’adesione potrebbe comportare, ad esempio, il riconoscimento di una parte del credito inizialmente negato, o la riclassificazione della violazione da inesistente a non spettante con riduzione delle sanzioni. In sede di adesione, infatti, l’ufficio può rimodulare la pretesa e le sanzioni sono ridotte ad 1/3 del minimo (quindi se mantenessero inesistente 70%, scenderebbe a ~46%, se non spettante 25% scenderebbe a ~16.7%). Va detto però che, per esperienza, l’Agenzia difficilmente rivede radicalmente le proprie posizioni in adesione su questioni di principio (es. non ammetterà progetti che ha valutato come non R&S, temendo un precedente). Potrà al più riconoscere errori di calcolo o applicare la sanzione minima. L’utilità dell’accertamento con adesione in questi casi è spesso legata alla volontà del contribuente di chiudere presto la vicenda, evitando l’incertezza e i costi del contenzioso, soprattutto se l’importo contestato non è enorme o se si temono strascichi penali. Se si raggiunge un accordo, si formalizza un atto di adesione e si paga quanto concordato (o prima rata) entro 20 giorni, estinguendo la disputa tributaria.
3. Pagamento e riscossione in pendenza di giudizio: Ricevuto l’atto, l’importo contestato (credito utilizzato + interessi + sanzione) viene iscritto a ruolo solo dopo la scadenza dei 60 giorni senza impugnazione o, se impugnato, dopo la sentenza di primo grado. Questo perché gli atti di recupero di crediti d’imposta, al pari degli accertamenti, rientrano nella sospensione legale della riscossione fino alla decisione di primo grado (D.Lgs. 546/1992, art. 15). Ciò significa che, se il contribuente presenta ricorso tempestivamente, non deve pagare nell’immediato (fatto salvo eventualmente un terzo della somma se perde in primo grado, e così via). Tuttavia, gli interessi continuano a maturare. In alternativa, se vuole evitare aggravi futuri, il contribuente può anche versare provvisoriamente le somme dovute (ad esempio solo il tributo e non le sanzioni in attesa di esito) per fermare gli interessi – ma questa è una scelta strategica. Qualora invece non si proponga ricorso né adesione entro 60 giorni, l’accertamento diventa definitivo e l’importo viene iscritto a ruolo coattivo (con aggiunta degli oneri di riscossione).
4. Ricorso al giudice tributario: Se non si è definito in adesione, il contribuente può proporre ricorso alla Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria) provinciale competente. Il ricorso va notificato entro 60 giorni e depositato entro 30 dalla notifica. Nel ricorso vanno articolati tutti i motivi di doglianza: ad es. motivi di merito (il progetto contestato rientra in R&S secondo legge, l’Agenzia ha mal interpretato i requisiti, le spese erano documentate, etc.), motivi procedurali (mancanza di contraddittorio se dovuto, difetto di motivazione dell’atto) e motivi di diritto (credito non inesistente ma al più non spettante – e dunque sanzioni e termini errati, eccependo decadenza se applicabile, come discusso sopra). Il contribuente può chiedere anche la sospensione cautelare dell’atto se dalla riscossione deriverebbe un danno grave (in genere non necessario se c’è sospensione ex lege fino a primo grado, ma opportuno se per qualche ragione l’AdE procede lo stesso a iscrivere a ruolo la sanzione). Nel giudizio tributario, soprattutto trattandosi di questioni tecnico-scientifiche, gioca un ruolo fondamentale la prova documentale e peritale: è consigliabile allegare perizie di parte, documenti tecnici sui progetti, e chiedere eventualmente al giudice di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) se vi è necessità di un parere indipendente sulla natura R&S delle attività. Alcune corti hanno disposto consulenze tecniche proprio per valutare i progetti contestati, con esiti talora favorevoli ai contribuenti.
5. Giudizi di appello e legittimità: La sentenza di primo grado può essere appellata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex CTR) entro 60 giorni. L’appello sospende solo in parte la riscossione: in caso di soccombenza del contribuente in primo grado, egli deve versare provvisoriamente 1/3 di imposta + interessi (e intera sanzione eventualmente ridotta) per ottenere la sospensione della restante parte fino all’esito dell’appello. In appello si possono far valere errori in primo grado e nuovi elementi sopravvenuti (ad esempio, se la Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata dopo la sentenza di primo grado, come avvenuto nel 2023, lo si evidenzierà). Dopo il grado di appello, è possibile il ricorso in Cassazione per soli motivi di diritto. Nel frattempo, se la causa è ancora pendente e intervengono modifiche normative favorevoli (come la definizione autentica del 2024), il difensore deve prontamente segnalarle perché potrebbero influire sull’esito.
Giurisprudenza recente favorevole: Vale la pena notare che vari organi giudicanti, negli ultimi anni, hanno mostrato sensibilità verso le ragioni dei contribuenti R&S. Si registrano numerose sentenze di merito che hanno annullato gli atti di recupero per motivi sostanziali o formali: ad esempio, Commissione Prov. Bologna n. 549/2022 e n. 500/2021 hanno accolto ricorsi di aziende ritenendo che l’Amministrazione non avesse competenza tecnica per negare l’innovatività e che i manuali OCSE non potessero avere valore cogente se non recepiti. La Commissione Reg. Emilia-Romagna n. 2342/2019 (confermata poi in Cassazione) ha sancito che l’indicazione del credito in dichiarazione RU esclude la condotta fraudolenta, declassando la violazione a non spettante con sanzione 30%. Ancora, la CTP La Spezia n. 276/2022 ha annullato un recupero per mancato parere MISE e decadenza 5 anni. Queste pronunce, pur di merito, delineano un filone giurisprudenziale solido.
Dal canto suo, la Corte di Cassazione ha fissato punti fermi: oltre alle Sezioni Unite 2023 già esaminate, va menzionata la Ordinanza Cass. Sez. Trib. n. 25018/17.09.2024, la quale ha affermato che le nuove definizioni normative di credito non spettante/inesistente introdotte nel 2024 hanno carattere di interpretazione autentica e dunque si applicano retroattivamente. Nel caso concreto (credito per investimenti nel Mezzogiorno utilizzato oltre termine), la Suprema Corte ha qualificato il caso come non spettante, poiché il bene era realmente acquistato e l’istanza presentata ma tardiva – quindi un requisito temporale venuto meno, elemento accessorio e non costitutivo. Questa interpretazione può giovare anche nei casi R&S in cui, ad esempio, un’impresa abbia presentato la documentazione richiesta ma in ritardo: si tratterebbe di vizio formale (non spettanza), non di inesistenza.
In sintesi, affrontare il contenzioso sul credito R&S richiede una doppia strategia: tecnica, sul merito scientifico (dimostrare che il progetto era R&S, supportandosi su ogni evidenza disponibile e magari su testimonianze di esperti); giuridica, sulle qualificazioni legali (incertezza normativa, non spettanza vs inesistenza, ecc.) e sulle eventuali violazioni procedurali dell’ufficio. Con gli argomenti giusti, vi sono buone probabilità di successo o comunque di ottenere una significativa riduzione delle sanzioni e la non applicazione di aggravanti fraudolente.
Strumenti di tutela e strategie difensive per il contribuente
Dopo aver delineato il quadro normativo e procedurale, ci concentriamo ora sugli strumenti concreti che il contribuente ha a disposizione per tutelarsi quando l’Agenzia contesta un credito R&S. Queste strategie difensive vanno calibrate in base alla fase in cui ci si trova (prima o dopo l’emissione dell’atto) e alla situazione specifica (ad esempio, se l’errore è riconosciuto e si vuole spontaneamente correggere, oppure se si intende sostenere la piena spettanza del credito).
Ravvedimento operoso e riversamento spontaneo del credito
Ravvedimento operoso “ordinario” – Se il contribuente si accorge di aver fruito di un credito R&S non spettante (in tutto o in parte) prima che l’irregolarità sia contestata o scoperta dal Fisco, può valutare il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997. Questo istituto consente di regolarizzare spontaneamente la violazione versando il tributo dovuto (cioè restituendo il credito indebitamente compensato) con interessi e una sanzione ridotta proporzionata al tempo del ravvedimento. Nel caso di crediti non spettanti, la sanzione base è 30% (25% se riferito a utilizzi dal 2023 in poi), quindi ad esempio ravvedendosi entro un anno la sanzione è ridotta a 1/8 = 3,75% dell’importo. Il ravvedimento va formalizzato correggendo la dichiarazione (se il credito era indicato) e versando quanto dovuto con appositi codici tributo (es. codice tributo 8120 per restituzione volontaria crediti R&S) e codice sanzione. Vantaggi: si evitano le sanzioni piene e soprattutto si mostra buona fede, potenzialmente evitando anche conseguenze penali (in quanto si sana il debito prima di qualunque contestazione). Limiti: il ravvedimento non è più ammesso se l’Agenzia ha già notificato un atto di recupero o avviso di accertamento oppure se sono iniziati accessi/verifiche sul punto. Inoltre, se la violazione è caratterizzata da frode, il semplice ravvedimento post factum non esclude il reato (ma può incidere sulla punibilità ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000, come cause di non punibilità per pagamento integrale prima del dibattimento, applicabili anche all’indebita compensazione).
Procedura di “riversamento spontaneo” speciale (credito R&S 2015-2019) – Data la diffusione del fenomeno, il legislatore ha introdotto una sanatoria ad hoc per i crediti R&S del periodo 2015-19. L’art. 5, commi 7-12, del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha istituito la procedura di riversamento spontaneo: in pratica, una finestra temporale entro cui le imprese potevano restituire i crediti R&S indebitamente utilizzati senza sanzioni né interessi. Questa procedura – aperta inizialmente fino al 30 settembre 2022 – è stata prorogata più volte (DL “Aiuti-ter” l’ha prorogata al 31/10/2023; successivamente la riapertura del 2025 l’ha estesa fino al 3 giugno 2025). Possono aderirvi i soggetti che hanno fruito di crediti R&S in modo non conforme alla legge, ad esempio per: a) attività non configurabili come R&S rilevante; b) progetti svolti su commissione estera (dopo 2017) poi esclusi per interpretazione autentica; c) spese ammissibili ma calcolate violando criteri di pertinenza e congruità; d) errori nella media storica di riferimento. Sono esclusi i casi in cui il credito indebito derivi da condotte fraudolente (fatture false, operazioni simulate) o manca del tutto la documentazione probatoria, e i crediti già contestati con atto definitivo alla data di entrata in vigore (22/10/2021).
Come funziona il riversamento? Il contribuente doveva presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (secondo modello approvato) entro il termine stabilito (da ultimo 3/6/2025) indicando gli importi di credito che intende restituire e rinunciando ai corrispondenti contenziosi eventualmente pendenti. Il versamento dell’importo da riversare poteva essere fatto in un’unica soluzione o in 3 rate (la prima entro il 3/6/2025, la seconda al 16/12/2025 con interessi legali, la terza al 16/12/2026 con interessi). Nessuna sanzione né interesse è dovuto se si perfeziona il pagamento. Per chi aveva aderito alla finestra precedente (scad. 31/10/2024) senza poi riuscire a pagare, la norma del 2025 ha consentito di ripresentare l’istanza e sfruttare la nuova dilazione .
Effetti principali del riversamento:
– Regolarizzazione tributaria totale: il credito restituito non sarà più contestabile dall’Agenzia per quel periodo, essendosi il contribuente autodenunciato e avendo pagato il dovuto. L’istanza di riversamento comporta la rinuncia ai ricorsi pendenti sul credito e all’impugnazione di eventuali atti non definitivi.
– Nessuna sanzione amministrativa né interessi: lo Stato rinuncia a punire l’errore, ottenendo in cambio la rapida emersione dei casi dubbi.
– Esclusione della punibilità penale: fondamentale, la legge ha previsto che l’adesione e il perfezionamento del riversamento estingue il reato di indebita compensazione art. 10-quater D.Lgs.74/2000 eventualmente configurabile. Ciò significa che, anche se l’importo era sopra soglia e formalmente il reato si era consumato al momento dell’utilizzo, la successiva sanatoria spontanea toglie rilevanza penale al fatto. In pratica è stata introdotta una causa speciale di non punibilità legata al pagamento, ancora più favorevole di quella generale prevista dall’art. 13 D.Lgs.74 (che richiede il pagamento integrale di imposte, interessi e sanzioni entro l’apertura del dibattimento, mentre qui bastano imposte senza sanzioni e non vi è limite temporale fino alla sentenza definitiva).
– Contributo a fondo perduto: per incoraggiare le adesioni, il Governo ha anche stanziato un indennizzo parziale. La Legge di Bilancio 2024 (L.197/2022) prima e successivamente la L. 207/2024 hanno previsto un contributo in conto capitale per chi riversa il credito R&S indebito: si tratta di un ristoro calcolato in percentuale sul credito restituito, con limite complessivo di 250 milioni stanziati sul periodo 2025-2028. In sostanza, un’impresa che aderisce potrebbe vedersi restituire in futuro – come contributo – una quota (non ancora definita, ipoteticamente intorno al 30-40%) di quanto riversato. Questo conferma la volontà pubblica di chiudere il contenzioso su R&S evitando il collasso di molte PMI che si troverebbero a dover restituire cifre elevate.
In definitiva, il riversamento spontaneo si è rivelato uno strumento di emersione: migliaia di imprese lo hanno utilizzato per “fare pace” col Fisco su R&S (secondo dati MEF, erano pervenute 3.200 istanze entro nov. 2022, poi aumentate con le proroghe). Per chi ha dubbi fondati sulla legittimità del proprio credito e vuole evitare rischi di sanzioni pesanti e di processo penale, aderire alla sanatoria – nei termini previsti – è stata senz’altro la via più prudente. Al contrario, imprese convinte della correttezza del proprio operato (o comunque disposte a far valere le proprie ragioni) hanno preferito non aderire e attendere l’eventuale accertamento, confidando di vincere in giudizio. La scelta non è stata facile e va sempre ponderata con consulenti: come osservato da un analista, vanno considerati “tutti questi elementi per valutare se valga la pena intraprendere il contenzioso” rispetto alla sanatoria. A fine giugno 2025 la finestra di riversamento si è chiusa; chi non vi ha aderito ora dovrà passare attraverso i canali ordinari (ravvedimento se ancora possibile, oppure contenzioso).
Difesa tecnica nel merito: documentazione e perizie
Una linea difensiva imprescindibile è quella di dimostrare nel merito la spettanza (anche parziale) del credito R&S contestato. Ciò significa ribattere punto per punto alle contestazioni tecniche dell’Ufficio con evidenze documentali e argomentazioni scientifiche. Ecco alcune mosse tipiche:
- Produrre documentazione integrativa: spesso durante il controllo iniziale non era stato esibito tutto, o non era disponibile. In sede di difesa (sia in risposta al PVC che in giudizio) è possibile esibire nuovi documenti a sostegno. Ad esempio: report di progetto più approfonditi, documenti interni (es. verbali, email, schede di laboratorio) che attestino le difficoltà tecniche incontrate e quindi la natura di R&S; eventuali brevetti o domande di brevetto depositate relativi ai risultati ottenuti, oppure pubblicazioni scientifiche o presentazioni a convegni – questi elementi sono ottimi indizi di attività innovativa; contratti di ricerca o preventivi che mostrino come l’attività fosse indirizzata a creare nuovi prototipi; registri presenze e buste paga per provare l’effettivo impiego del personale su quei progetti (contrastando l’accusa che magari quelle persone facessero altro). In altre parole, colmare qualsiasi lacuna probatoria evidenziata dall’ufficio.
- Chiarire gli aspetti tecnici con perizie: poiché né i giudici né i funzionari fiscali sono esperti in chimica, software, ingegneria, ecc., è utile incaricare un consulente tecnico di parte (un ingegnere, un ricercatore, ecc. a seconda del settore) che rediga una perizia giurata sul progetto controverso. La perizia dovrebbe spiegare in termini semplici ma rigorosi in cosa consisteva l’innovazione, quali obiettivi di ricerca c’erano, quali incertezze si affrontavano e quali risultati nuovi si sono ottenuti. Dovrebbe anche confutare eventuali affermazioni dell’Agenzia (es. se l’AdE sostiene che il progetto era solo customizzazione, il perito spiegherà perché invece era sviluppo sperimentale). Alcune sentenze citano in positivo l’apporto di perizie di parte che hanno convinto i giudicanti del carattere innovativo. Va ricordato che, come emerso in una sentenza di Bologna del 2024, l’Agenzia delle Entrate nei propri PVC spesso non ha figure tecniche e muove rilievi standardizzati: evidenziarlo e contrapporre un’analisi specialistica dà forza alla difesa.
- Invocare i pareri ministeriali (MISE/MIMIT): Il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT) è l’organo che meglio conosce le norme agevolative dal lato tecnico. Ci sono stati documenti importanti come la Circolare MISE n. 59990 del 9/2/2018 che ha fornito esempi concreti di attività qualificabili come R&S e ha chiarito l’interpretazione di aspetti dubbi (ad esempio distinguendo ricerca contrattuale vs commessa estera). Anche la Circolare Agenzia Entrate 13/E/2017 affermava che per dubbi sull’ambito di R&S l’Agenzia stessa avrebbe girato la questione al MISE. Nella difesa, citare questi riferimenti istituzionali è utile per mostrare che la propria interpretazione era in linea con indicazioni ufficiali. Ad esempio, se contestano l’assenza di “novità assoluta”, si può citare che né la norma né le circolari MISE richiedono novità “mondiale”, ma basta un avanzamento per l’impresa stessa. Oppure, se l’ufficio ha disconosciuto spese per ricerca su commessa di azienda estera nel 2016, si potrà far valere che la norma interpretativa che le ha escluse vale dal 2017 in poi e che su 2016 vigeva incertezza, e a supporto citare una FAQ MISE 2019 o circolari di Confindustria. L’obiettivo è far emergere l’obiettiva incertezza normativa su cui il contribuente poteva ragionevolmente cadere, aspetto cruciale anche per evitare le sanzioni (vedi oltre).
- Dimostrare la buona fede e la diligenza: In un contesto dove spesso l’Agenzia insinua che l’impresa abbia “abusato” del credito, è importante far emergere l’atteggiamento diligente: ad esempio, se l’azienda si è affidata a consulenti qualificati, ha ottenuto pareri legali o interpretativi, ha seguito le guide ufficiali disponibili, ciò va sottolineato. Molte difese portano a conoscenza del giudice che il contribuente ha agito in conformità a prassi diffuse o a interpretazioni ragionevoli date da professionisti. Questo può supportare la richiesta di esenzione da sanzioni per obiettiva incertezza normativa (art. 6, co.2, D.Lgs. 472/97) o per buona fede. In effetti la Cassazione ha riconosciuto che la buona fede del contribuente, specie su norme di non immediata chiarezza, è causa di non sanzionabilità amministrativa (anche se è oscillante nel richiederne la prova rigorosa). Nel caso di crediti R&S, vista la complessità tecnica, l’incertezza è quasi fisiologica – e questa può diventare un punto di difesa non solo in sede tributaria ma anche in sede penale, come vedremo.
In definitiva, sul merito tecnico-scientifico la difesa deve “parlare la lingua” dell’innovazione meglio di come ha fatto l’Ufficio, educando il giudice sugli aspetti caratterizzanti il progetto. Se questo viene fatto con credibilità (documenti, perizie), si hanno buone chance che almeno una parte del credito venga riconosciuta legittima dal giudice, o quantomeno che non si ravveda quell’assenza totale di base reale che giustifica le sanzioni massime.
Profili sanzionatori e difesa in sede penale tributaria
Oltre alla dimensione tributaria, le contestazioni su crediti R&S di importo elevato possono sfociare in procedimenti penali a carico dei responsabili aziendali. Occorre quindi considerare anche questo fronte, distinguendo tra sanzioni amministrative (già trattate in parte) e il vero e proprio reato di indebita compensazione.
Sanzioni amministrative e cause di esonero: Come visto, la qualificazione dell’illecito influisce sull’ammontare della sanzione (25% vs 70% base). È fondamentale invocare, quando ne ricorrono i presupposti, le circostanze di non punibilità amministrativa previste dall’ordinamento: la principale è la già citata obiettiva incertezza normativa (art. 6, co.2, D.Lgs.472/97), che impone di non sanzionare il contribuente quando la norma violata era così incerta da indurlo in errore scusabile. Nel caso R&S, si può argomentare che fino al 2020 c’erano interpretazioni discordanti su cosa fosse agevolabile (come dimostrano i tanti documenti di prassi tardivi e i contrasti giurisprudenziali). Ad esempio, la definizione di “ricerca industriale” vs “innovazione” non era chiarissima, oppure la questione delle commesse estere è stata definita solo a fine 2018, lasciando un vuoto interpretativo prima. Se l’azienda ha applicato una certa interpretazione plausibile (magari suggerita da guide o esperti) poi rivelatasi errata, non dovrebbe essere punita con sanzioni. Diverse sentenze di merito hanno annullato le sanzioni per incertezza su R&S, e la stessa Cassazione ha riconosciuto che in presenza di norme oscure e contribuente diligente, l’esimente è applicabile . Nel ricorso occorre dunque enfatizzare la volatilità del quadro normativo e il comportamento accorto tenuto (richiesta di pareri, conformità a circolari, ecc.). Un’altra causa di non punibilità è l’errore contabile formale senza imposta evasa (art. 6, co.5-bis D.Lgs.472/97) se mai fosse invocabile (ma qui c’è imposta evasa, quindi non si applica).
Reato di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): Scatta quando un soggetto non versa tributi dovuti utilizzando in compensazione crediti fittizi o non spettanti per importi rilevanti. Nella formulazione attuale (post riforma 2024), come già indicato in tabella, il reato ha due gradazioni: comma 1 per crediti non spettanti > €50.000 per anno, punito con reclusione 6 mesi – 2 anni; comma 2 per crediti inesistenti > €50.000, punito con reclusione 1 anno e 6 mesi – 6 anni. Fino al 2023 la norma non distingueva espressamente, punendo genericamente >50k con 1-6 anni se inesistenti e 6 mesi-2 anni se non spettanti (tale distinzione di fatto è ora formalizzata). Soggetti attivi: trattandosi di reato proprio tributario, ne risponde chi ha commesso il fatto – tipicamente il legale rappresentante o l’amministratore che ha materialmente firmato i modelli F24 o comunque deciso la compensazione indebita nell’interesse dell’azienda. La società in quanto tale non è penalmente responsabile, ma potrebbe scattare a suo carico la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 (dal 2020 i reati fiscali, incluso il 10-quater, sono presupposto della responsabilità degli enti con sanzioni pecuniarie fino a 400 quote), qualora si provi che il reato è stato commesso a vantaggio dell’ente per carenze organizzative.
Momento di consumazione e decorso: il reato si perfeziona al momento in cui si effettua la compensazione indebita (presentazione dell’F24 in banca/Agenzia). Non rileva che l’Agenzia accerti il fatto dopo anni – ai fini penali il fatto storico si colloca nell’anno d’imposta di utilizzo. Questo incide su prescrizione: attualmente il 10-quater (comma 2) avendo pena max 6 anni, ha una prescrizione base di 6 anni + eventuali aumenti per atti interruttivi (fino a 7 anni e mezzo). Ciò implica che, se l’uso illecito fu ad es. nel 2015, il reato potrebbe essere già prescritto entro il 2023, a meno che nel frattempo sia intervenuto un atto interruttivo (es. richiesta rinvio a giudizio) che ne sospenda il termine.
Avvio dell’azione penale: Tipicamente, quando l’Agenzia delle Entrate contesta un credito come “inesistente” oltre soglia, trasmette una notitia criminis alla Procura della Repubblica competente. Anche la Guardia di Finanza, se coinvolta nelle verifiche, può redigere un processo verbale di constatazione penale e inoltrarlo. In alcuni casi, le Procure hanno avviato indagini coordinate con l’Agenzia già durante le verifiche sui crediti d’imposta (specie se c’erano sospetti di frode). Comunque, la formale denuncia penale per indebito utilizzo di crediti scatta obbligatoriamente quando la somma supera la soglia di €50.000 annui. È bene sottolineare che la soglia va calcolata per anno d’imposta: se un’azienda ha compensato 30k nel 2018 e 30k nel 2019 in modo non spettante, nessun anno singolo eccede 50k, dunque tecnicamente non c’è reato (non sono cumulabili su più anni). Viceversa, se in un solo F24 ha compensato 60k di crediti R&S, scatta il penale.
Difesa penale e interazioni col tributario: In presenza di un procedimento penale (notifica di informazioni di garanzia, perquisizioni, ecc.), la difesa dovrà da un lato tutelare la posizione nell’ambito penale, dall’altro coordinarsi con la strategia tributaria. Molto spesso, l’esito del processo tributario (se il giudice annulla l’atto riconoscendo il credito spettante) ha riflessi positivi sul penale, potendo far venir meno l’elemento oggettivo del reato (se il credito è spettante, non c’è indebita compensazione). Tuttavia, attenzione: giudice penale e tributario operano con indipendenza di giudizio, quindi teoricamente il penale potrebbe proseguire anche se in primo grado tributario il contribuente ha vinto – soprattutto se ritiene che il fatto integri comunque un reato (ad esempio potrebbero contestare altri profili, come truffa aggravata ai danni dello Stato in ipotesi di frodi con crediti). In generale però, se il contenzioso tributario pende, spesso il procedimento penale viene sospeso in attesa di chiarimenti in quella sede, oppure quantomeno rallenta.
Le linee difensive penali principali sono:
– Negare l’elemento soggettivo del dolo: sostenere che l’imputato ha agito in buona fede, convinto della spettanza del credito, magari appoggiandosi a consulenti e alla prassi esistente. Ciò può essere rafforzato dalla dimostrazione di obiettiva incertezza tecnica o normativa, che nel nuovo art. 10-quater comma 3 è addirittura codificata come causa di non punibilità per i casi di non spettanza. Bisogna provare che la situazione rientrava in un “cono d’ombra” interpretativo. Ad esempio: l’azienda aveva ottenuto un parere scritto da un consulente che attestava la validità del credito; oppure la definizione di R&S era talmente tecnica da giustificare un errore non doloso. Se il giudice penale crede all’assenza di dolo, può assolvere perché il fatto non costituisce reato (mancando l’intento di evasione). Nel caso di crediti inesistenti “puri” (frode conclamata) questa strada è impervia, ma per i non spettanti borderline è concretamente percorribile. La norma nuova rinforza proprio questa idea: non punibile chi ha sbagliato per valutazioni tecniche complesse in condizioni di incertezza.
- Dimostrare la sussistenza effettiva (anche parziale) del credito: Similmente a quanto fatto nel tributario, se in penale si convince che il credito non era del tutto fittizio (ad esempio c’erano spese vere di R&S, magari solo non sufficienti), si potrebbe ottenere una derubricazione. Va detto che il reato parla di “crediti non spettanti o inesistenti”: quindi anche l’uso di un credito realmente maturato ma non dovuto formalmente integra l’elemento oggettivo. Tuttavia, far emergere che la base fattuale c’era può influire sulla valutazione del dolo (era un abuso, non un’invenzione ex novo) e sulla gravità della condotta, con possibili effetti su pena e concessione di attenuanti.
- Riversamento operoso come esimente: Come illustrato, se il contribuente riesce ad aderire alla procedura di riversamento spontaneo e a estinguere il debito tributario prima della sentenza, ha diritto all’esclusione della punibilità ex lege. Questa è un’arma potentissima: significa che anche se vi fossero prove di un reato consumato, lo Stato rinuncia a punire perché l’interessato ha fatto ammenda restituendo il maltolto. Nel concreto, un imputato che abbia in corso il penale potrebbe decidere di presentare istanza di riversamento (se i termini lo permettono) o comunque di pagare integralmente il dovuto – magari anche con sanzioni – prima dell’apertura del dibattimento, per poi chiedere di essere prosciolto per intervenuta causa di non punibilità (ex art. 13 D.Lgs.74 o in virtù della norma speciale del DL 146/2021). È importante il timing: l’art. 13 richiede pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; nel caso del riversamento speciale, la causa di non punibilità opera senza limiti di fase, anche se il dibattimento è iniziato, purché la procedura si perfezioni (il che poteva avvenire entro il 3/6/2025). Questa particolarità è stata sottolineata come più favorevole rispetto alla disciplina generale. Ad ogni modo, chiude definitivamente il capitolo penale.
- Utilizzo di riti alternativi e attenuanti: Se vi è evidenza di responsabilità ma si vuole contenere il danno, si può optare nel penale per riti come il patteggiamento, ottenendo la riduzione di pena e magari evitando sanzioni interdittive. Oppure puntare sull’attenuante della speciale tenuità del danno risarcito o del ravvedimento operoso (che il giudice può valutare in sentenza per diminuire la pena). Da notare che, per importi di poco superiori a 50k, non è infrequente che si arrivi a condanne miti spesso coperte dalla sospensione condizionale, specie se è la prima violazione.
Sequestro e confisca: Un aspetto pratico: in caso di indagine penale, la Procura può chiedere il sequestro preventivo per equivalente sulle somme corrispondenti al credito indebitamente compensato, in vista di una futura confisca. Ciò può portare al congelamento di conti correnti aziendali o personali dei responsabili, per importi rilevanti. La Cassazione penale ha chiarito che il sequestro può essere mantenuto anche se chi ha usato i crediti era in buona fede, perché la buona fede non legittima la circolazione di crediti inesistenti e tali crediti vanno comunque espunti dal circuito economico. Nel caso R&S per fortuna non c’è “circolazione” (i crediti R&S non erano cedibili a terzi, a differenza dei bonus edilizi), quindi il problema riguarda solo il soggetto che ha compensato. In ogni caso, se l’azienda versa volontariamente il dovuto o aderisce alla sanatoria, in sede penale potrà chiedere il dissequestro per cessazione delle esigenze (avendo pagato il credito contestato).
Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 dell’impresa: Come anticipato, le società potrebbero subire un procedimento parallelo se il reato di indebita compensazione è contestato come commesso a vantaggio aziendale. In tal caso, la società rischia una sanzione pecuniaria (fino a 400 quote, entità variabile in base a gravità e dimensioni) e misure interdittive (come il divieto di contrarre con la PA). Per difendersi, la società dovrebbe dimostrare di avere adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati fiscali, oppure che l’evento è dovuto a iniziativa fraudolenta dei singoli eludendo i controlli. All’atto pratico, data la novità (i reati tributari sono stati inseriti tra i presupposti solo dal 2020), molte aziende non avevano adeguato i modelli 231: questo potrebbe esporle. Anche qui, tuttavia, il pagamento integrale del debito prima del giudizio costituisce un potente argomento per mitigare la sanzione o chiedere l’esclusione di responsabilità per condotta riparatoria.
Conclusione sulla parte penale: Il contribuente/imprenditore deve essere consapevole che una contestazione di credito R&S sopra soglia non è solo una questione fiscale, ma può farlo incorrere in un reato. Pertanto, appena ricevuta la notifica di un PVC o atto di recupero per importi elevati, conviene coinvolgere anche un avvocato penalista, oltre al tributarista. Spesso le due strategie andranno di pari passo: ad esempio, scegliere di aderire al riversamento o di pagare subito può essere motivato più dalla volontà di evitare guai penali (che da quella di risparmiare sanzioni, visto che in sanatoria le sanzioni erano zero ma il debito va onorato per intero comunque). Fortunatamente, l’ordinamento offre oggi vie di uscita: il combinato disposto dell’art. 13 D.Lgs.74 e della sanatoria speciale consente a chi ha commesso violazioni senza intento fraudolento di rimediare evitando condanne. Inoltre, la nuova clausola di non punibilità per incertezza tecnica (comma 3 art.10-quater) rappresenta un riconoscimento importante: i casi R&S, per loro natura complessi, rientrano spesso in quell’alveo, purché si dimostri la genuina difficoltà interpretativa e la mancanza di volontà di evasione.
Con questo si conclude l’analisi dei profili sostanziali e procedurali. A seguire, presentiamo una sezione di Domande frequenti (FAQ) in cui riepiloghiamo sotto forma di domanda-risposta i dubbi più comuni di imprenditori e consulenti alle prese con contestazioni sul credito Ricerca & Sviluppo, fornendo risposte puntuali basate su quanto esposto nella guida.
Domande frequenti (FAQ)
D: In base a quali norme era riconosciuto il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 2015-2019?
R: La misura è stata introdotta dall’art. 3 del D.L. 145/2013 (decreto “Destinazione Italia”) e regolamentata dal D.M. 27 maggio 2015. Prevedeva un credito d’imposta pari al 25% o 50% delle spese incrementali in R&S sostenute dalle imprese negli anni 2015-2019, rispetto alla media 2012-2014. Il credito maturato andava indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e poteva essere utilizzato in compensazione tramite F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Sono seguite proroghe della misura fino al 2019, poi dal 2020 l’agevolazione è stata rimodulata in nuovi crediti (R&S “nuovo”, Innovazione tecnologica, Design) con aliquote decrescenti. Riferimenti: art. 3 DL 145/2013 conv. L.9/2014; DM 27.05.2015 attuativo.
D: Quali attività e spese erano considerate ammissibili come “Ricerca e Sviluppo”?
R: Erano ammissibili i progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale mirati ad accrescere le conoscenze e a sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi. Ad esempio: studi per nuovi prototipi o nuovi processi produttivi, sviluppo di software innovativi, sperimentazione di materiali o soluzioni tecniche mai applicate prima in azienda. Le spese agevolabili includevano: personale (ricercatori, tecnici e personale ausiliario impiegato nei progetti R&S) sia subordinato sia autonomo; quote di ammortamento di laboratori, impianti e attrezzature utilizzate nella ricerca; contratti di ricerca extra muros con università, enti di ricerca o altre imprese; competenze tecniche e privative industriali (acquisto o licenza di brevetti, know-how). Non erano invece agevolabili le normali spese di produzione, commerciali o amministrative, né attività di semplice innovazione organizzativa o di mercato. Il confine non era sempre netto: l’interpretazione ufficiale (Circolare Mise 2018) chiariva che per essere R&S l’attività deve comportare un elemento di novità e incertezza tecnico-scientifica, non bastando la customizzazione di routine. Riferimenti: art. 2 DM 27.5.2015 (definizioni di R&S); Manuale di Frascati OCSE (principi guida, non fonte di legge ma richiamato in prassi).
D: Perché l’Agenzia delle Entrate contesta il credito R&S a tante imprese?
R: Perché dai controlli sono emersi numerosi casi di utilizzo improprio o erroneo del bonus R&S. In particolare, l’Agenzia ha riscontrato che molte imprese hanno considerato come R&S attività che in realtà sarebbero fuori dal perimetro agevolabile (ad esempio progetti senza reale innovazione, oppure commesse di ricerca fatte per aziende estere dopo il 2017, che una norma interpretativa ha escluso dal beneficio). Altre ragioni comuni di contestazione: errori di calcolo del credito (sbaglio nella media di riferimento, duplicazione di costi), spese non pertinenti incluse indebitamente (es. costi ordinari, o costi di personale non direttamente impiegato nei progetti), carenze documentali (assenza di relazione tecnica o certificazione del revisore), oppure casi più gravi di crediti fittizi creati ad arte. Dato che il credito veniva auto-determinato dalle imprese, l’Amministrazione ha intensificato i controlli ex post e in molti casi ha ritenuto che il credito fosse stato utilizzato senza averne diritto, da qui le contestazioni con recupero dell’imposta e relative sanzioni.
D: Come faccio a capire se il mio credito R&S potrebbe essere contestato? Ci sono “campanelli d’allarme”?
R: Alcuni indicatori di rischio: – Progetti a basso contenuto innovativo: se il progetto finanziato consisteva in normali aggiornamenti di prodotto o semplici modifiche, è più facile che l’Agenzia lo contesti per mancanza di “novità” significativa. – Documentazione carente: se non si dispone di una relazione tecnica dettagliata, di registri delle ore del personale, di evidenze delle fasi di ricerca, sarà più arduo difendere il credito. L’assenza dell’attestazione di un revisore sui costi, quando obbligatoria, è un grave vulnus. – Spese anomale: se gran parte del credito deriva da fatture di consulenza generiche, o da costi infragruppo, o se i costi di R&S risultano sproporzionati rispetto all’organico dell’azienda, l’AdE andrà a fondo. Anche un utilizzo integrale del credito fino al massimale (€5 milioni annui) attira attenzione. – Interpello o prassi contraria: se sul vostro caso specifico esiste un interpello o una circolare che esclude la spettanza (es. credito su commessa estera post-2017), è praticamente certo che contesteranno. In generale, se avete dubbi sulla correttezza del credito (per esempio avete saputo di altre aziende simili a cui è stato contestato lo stesso tipo di progetto), conviene fare un check-up documentale e magari farsi assistere da un esperto prima di subire controlli.
D: L’Agenzia può contestare il credito dopo tanti anni dalla fruizione? Quali sono i termini di prescrizione/decadenza?
R: Sì, può contestarlo anche a distanza di anni, ma entro certi limiti temporali fissati dalla legge. In generale: – Se il credito è considerato “non spettante”, vale il termine ordinario di accertamento, cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo del credito in compensazione. Ad esempio, per un credito utilizzato nel 2017, l’atto doveva arrivare entro il 31/12/2022. – Se l’Agenzia lo qualifica come “inesistente”, ha a disposizione un termine più lungo, otto anni dal suo utilizzo. Quindi, credito utilizzato nel 2017 contestabile fino al 31/12/2025. In passato l’Agenzia definiva quasi tutti i crediti R&S indebiti come inesistenti, per applicare l’otto anni. Oggi però la norma (D.Lgs. 87/2024) e la Cassazione circoscrivono l’inesistenza ai casi più gravi; negli altri vale il termine breve. Pertanto, se ricevete un atto oltre il quinto anno, occorre verificare se l’Ufficio aveva veramente titolo per invocare l’ottavo (ossia se il credito era effettivamente inesistente secondo i nuovi criteri). In vari casi i giudici hanno ritenuto tardive le contestazioni oltre 5 anni perché il credito in realtà era solo non spettante.
D: Che differenza c’è tra “credito non spettante” e “credito inesistente”? Perché è così importante?
R: In breve: – Un credito non spettante è un credito di cui formalmente non avevi diritto (perché hai violato qualche requisito), ma che deriva comunque da operazioni reali e normalmente era indicato in dichiarazione. È un utilizzo indebito “meno grave”.
– Un credito inesistente è un credito che proprio non ha base, creato dal nulla o con frode, di regola non desumibile dalla documentazione veritiera. È la fattispecie più grave, equiparabile a un falso.
La distinzione è cruciale perché determina sanzioni e termini: per il non spettante la sanzione amministrativa ora è 25% (30% in passato) e l’accertamento va fatto in 5 anni; per l’inesistente sanzione 70% (prima 100-200%) e termini 8 anni. Anche penalmente, usare >50k di credito inesistente comporta fino a 6 anni di carcere, mentre se era non spettante max 2 anni. Insomma, essere in un caso o nell’altro cambia drasticamente le conseguenze. Negli ultimi mesi (sentenze Cassazione Sez. Unite 2023 e riforma 2024) si sono fissati paletti chiari: inesistente solo se manca il presupposto e non è riscontrabile da controlli automatici; tutto il resto è non spettante. Quindi, ad esempio, aver compensato un credito R&S su spese effettivamente sostenute ma non innovative = credito non spettante (sanz. 25%, termine 5 anni). Aver compensato un credito su costi totalmente fittizi = credito inesistente (sanz. 70%, termine 8 anni). Capire dove si colloca il vostro caso aiuta a modulare la difesa e spesso a limitare i danni.
D: Se ricevo un avviso di accertamento per il credito R&S, devo pagare subito? Posso evitarlo in attesa della sentenza?
R: Non dovete pagare immediatamente l’intero importo, a patto che presentiate ricorso entro 60 giorni. Infatti, per legge la riscossione è sospesa fino alla decisione di primo grado (Commissione Tributaria provinciale) se fate ricorso tempestivo. Quindi nulla è dovuto subito (e potete anche chiedere al giudice di sospendere oltre, ma di solito non serve perché c’è la sospensione ex lege). Se invece lasciate decorrere i 60 giorni senza ricorrere né aderire, l’atto diventa definitivo e verrà iscritto a ruolo, portando a cartella di pagamento: a quel punto dovreste pagare (salvo tentare una tardiva – e difficile – impugnazione per motivi formali). Ricapitolando: presentando ricorso ottenete una protezione automatica. Dopo la sentenza di primo grado, se fosse sfavorevole, dovreste versare intanto un terzo delle imposte accertate e gli interessi maturati, per avere la sospensione del resto in appello. In caso di esito favorevole, ovviamente non pagherete nulla (e se avevate versato qualcosa in pendenza, vi sarà restituito). È comunque possibile, se uno preferisce eliminare il debito subito, pagare anche se in ricorso – magari giusto il tributo senza sanzioni – ma è una scelta volontaria. Molti preferiscono attendere l’esito almeno del primo grado, data la sospensione prevista d’ufficio.
D: Cos’è e conviene aderire all’“accertamento con adesione” in questi casi?
R: L’accertamento con adesione è una procedura che vi permette di negoziare con l’ufficio un accordo sull’accertamento, evitando il contenzioso. Presentando istanza di adesione (entro 30 gg dalla notifica dell’atto), si sospende il termine di ricorso e si viene convocati per un incontro all’Agenzia. Lì si discute e, se si trova un accordo, si firma un atto di adesione con nuovi importi ridotti. In generale, con l’adesione le sanzioni sono ridotte a 1/3 di quelle minime, il che è un bel vantaggio. Nel caso di crediti R&S, l’adesione potrebbe essere utile se ritenete di aver effettivamente sbagliato qualcosa e volete chiudere la faccenda limitando i danni. Ad esempio, poniamo che l’ufficio vi contesta €100k di credito inesistente con sanzione 100% (€100k). In adesione potreste ottenere, ad esempio, di qualificare tutto come non spettante e magari riconoscere un 20% del credito come lecito. Paghereste quindi €80k di imposta, e sanzione 1/3 del 30% = 10% su €80k, quindi €8k, più interessi. In giudizio forse potreste fare di meglio o forse no, ma con l’adesione avete certezza e chiudete subito. Conviene? Dipende: se pensate di avere buone possibilità di vittoria in contenzioso, forse è meglio lottare. Se invece riconoscete almeno in parte la pretesa e volete ridurre sanzioni e stress, l’adesione è una strada da considerare. Attenti però: una volta firmata, non potete più impugnare nulla (è definitiva). E l’adesione non incide sull’eventuale penale: ma il fatto che pagate e chiudete potrebbe comunque pesare positivamente se ci fosse un’indagine penale (dimostrate ravvedimento).
D: Ho appreso dell’esistenza della “sanatoria” sul credito R&S. Posso ancora aderire e quali vantaggi mi darebbe?
R: La finestra straordinaria di riversamento spontaneo purtroppo si è chiusa definitivamente il 3 giugno 2025 (dopo varie proroghe). Fino a quella data, chi aveva crediti indebitamente fruiti negli anni 2015-19 poteva presentare l’istanza e restituire l’importo senza sanzioni né interessi, con pagamento in max 3 rate. I vantaggi erano notevoli: niente sanzioni, niente interessi e non punibilità penale per l’indebita compensazione. Se siete oltre tale scadenza, al momento non ci sono nuove proroghe in legge – e pare che quella fosse l’ultima chiamata (era stata riaperta più volte, definita “settima proroga” in alcuni commenti). Dunque, oggi (agosto 2025) non è più possibile aderire alla sanatoria R&S. Rimangono però gli strumenti ordinari: se non avete ancora un atto formale a carico, potete fare il ravvedimento operoso (pagando volontariamente con sanzione ridotta). Oppure, se l’atto c’è già, potete tentare un accordo con l’ufficio (adesione) o difendervi in giudizio. La sanatoria è stata un’occasione irripetibile per uscire puliti, e in tanti l’hanno colta (per dire, il Governo ha dovuto stanziare 250 milioni per riconoscere un contributo a chi ha riversato, segno che parecchi hanno pagato). Se ve la siete lasciata sfuggire, ora dovrete necessariamente percorrere la via del contenzioso o del ravvedimento ordinario.
D: Se pago spontaneamente il credito contestato (fuori procedura sanatoria), mi eviterei il penale?
R: Pagare spontaneamente tutto il dovuto (credito, interessi e sanzioni) prima dell’apertura del dibattimento penale costituisce condotta idonea a ottenere la non punibilità ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000, ma solo per i crediti non spettanti (comma 1 art. 10-quater) e per le soglie di punibilità di omesso versamento (art. 10-bis, 10-ter). Cioè se il vostro caso rientra nel non spettante >50k, pagando prima del processo potete essere dichiarati non punibili (o ottenere l’archiviazione). Se invece il credito è considerato “inesistente” – quindi reato più grave – l’art. 13 non lo menziona espressamente. In tal caso il pagamento integrale costituisce comunque un attenuante molto importante e spesso porta a patteggiamenti con pene minime, ma teoricamente la punibilità non è esclusa de jure. Tuttavia, la procedura di riversamento speciale (che appunto implicava pagare il credito senza sanzioni) escludeva anche la punibilità per gli inesistenti. Quindi se avete crediti inesistenti e volete assolutamente evitare il penale, l’unica strada era entrare nella sanatoria. Ormai chiusa quella, resta il fatto che collaborare e saldare il debito aiuta enormemente in sede penale, ma non garantisce al 100% di evitare il processo se la Procura è molto convinta di dolo grave. Diciamo che nella peggiore delle ipotesi, pagando, anche se doveste subire una condanna, avreste accesso a tutte le attenuanti del caso e probabilmente a una pena sospesa (in casi di frodi spudorate invece senza ravvedimento si rischiano condanne più pesanti e interdittive).
D: L’Agenzia delle Entrate può decidere autonomamente cosa è R&S e cosa no? Non dovrebbe consultare il Ministero competente (MIMIT)?
R: In teoria, la legge non obbliga l’Agenzia a consultare il MIMIT (ex MISE) prima di emettere l’atto. In pratica però, come ricordavi, la stessa Agenzia in una circolare (13/E del 2017) ammise di non avere competenze tecniche e invitava a rivolgere quesiti di interpretazione al MISE. Alcune Commissioni Tributarie hanno criticato il Fisco proprio per non aver coinvolto il Ministero: c’è una sentenza (CTP La Spezia 2022) che ha annullato un recupero anche per questo motivo, ritenendo che su una materia così tecnica l’ufficio avrebbe dovuto acquisire il parere del MISE e la sua mancanza ha inficiato la determinazione dell’atto. Altre sentenze (CTP Bologna 2022) hanno evidenziato che l’Agenzia ha usato come “parametro” il Manuale di Frascati, la cui traduzione ufficiale in italiano è arrivata solo a fine 2021, e che comunque il MISE aveva chiarito certe definizioni solo nel 2018. Tutto ciò per dire: sì, l’Agenzia si è mossa in autonomia, ma questo approccio viene spesso contestato in giudizio. In difesa, potete eccepire che l’Ufficio non aveva le competenze per valutare il merito tecnico e avrebbe dovuto ottenere la valutazione dell’organo tecnico (MIMIT) prima di negare il credito – omissione che può configurare difetto di istruttoria. Non c’è però una norma che imponga quel parere, quindi non sempre i giudici accolgono tale tesi. È più un elemento che rafforza la percezione di incertezza e complessità tecnica (utile per le sanzioni e il penale). In definitiva, sebbene non formalmente vincolata, la consultazione del Ministero sarebbe auspicabile; la sua assenza è un punto a favore del contribuente ma difficilmente da sola basta per annullare un atto (a meno che i giudici sposino una linea garantista come nei casi detti).
D: Che rischi concreti corro a livello penale se mi contestano un credito R&S indebito? Vengo denunciato per evasione?
R: Il reato specifico è indebita compensazione di crediti tributari (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000). Non è esattamente “evasione fiscale” generica, ma una fattispecie ad hoc introdotta per punire chi utilizza crediti falsi o indebiti per non pagare tasse. I rischi concreti sono: – Procedimento penale a carico dell’amministratore (o chi ha firmato la delega F24): se l’importo > €50.000 per anno, la notizia di reato verrà trasmessa in Procura e potete ricevere un avviso di garanzia. Le pene massime variano: fino a 2 anni di reclusione se si tratta di crediti non spettanti; fino a 6 anni se crediti inesistenti (fraudolenti). Non sono previste pene pecuniarie, solo detentive, ma nei fatti per reati tributari di entità non enorme è plausibile una condanna a <= 2 anni, spesso con sospensione condizionale (se incensurati). – Sequestri patrimoniali: la Procura può congelare beni o conti fino a concorrenza dell’importo del credito indebito. Ciò può impattare sulla liquidità aziendale o personale nel breve periodo. Se poi veniste condannati, quei beni sarebbero confiscati a titolo definitivo equivalente al “profitto” del reato (cioè le imposte non pagate). – Fedina penale/macchia reputazionale: una condanna, ancorché con pena sospesa, comporta pur sempre precedenti penali. Inoltre, in caso di condanna >2 anni scatta l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, e altre pene accessorie come l’incapacità a contrattare con la PA possono essere applicate (anche per meno di 2 anni in alcuni casi). Va però detto che: – Se non c’è frode palese e dimostrate di aver agito in buona fede su una norma dubbia, potete evitare la condanna (non punibilità per particolare tenuità o per obiettiva incertezza, vedi sopra). – Avete strumenti per estinguere il reato: ad esempio, pagando tutto prima del processo potete beneficiare della non punibilità ex art.13 D.Lgs.74 (applicabile perlomeno ai non spettanti). Oppure, se eravate nei termini, l’adesione alla sanatoria entro giugno 2025 estingue il reato automaticamente. – Nella prassi, le Procure perseguono con severità soprattutto i crediti fittizi deliberatamente fraudolenti (es. chi ha creato crediti con fatture false). Se il vostro caso è più un’interpretazione sbagliata, c’è spazio per argomentare l’assenza di dolo e ottenere magari un’archiviazione o assoluzione. Quindi i rischi ci sono ma sono gestibili con un’adeguata difesa legale. L’importante è non ignorare l’aspetto penale: se ricevete l’avviso di garanzia, attivatevi immediatamente tramite un avvocato penalista esperto in reati tributari per valutare le mosse (pagamento, patteggiamento, ecc.) più opportune.
D: Il mio credito contestato era sotto €50.000 per ciascun anno, significa che non ho problemi penali?
R: Corretto, se in nessun periodo d’imposta avete superato la soglia di €50.000 di utilizzi indebiti, non si configura il reato di indebita compensazione. Ad esempio, €40k nel 2018 e €40k nel 2019 anche se sommati fanno 80k, non integrano reato perché la legge parla di “per ciascun periodo d’imposta”. In tal caso subirete solo le conseguenze amministrative (restituzione credito, sanzioni, interessi). Ovviamente dovrete comunque difendervi sul piano tributario, ma almeno non avrete a che fare con Procura e tribunale penale. Attenzione però: la soglia di 50k vale per 10-quater, ma se – ipotesi estrema – la contestazione celasse condotte più gravi (tipo falso in bilancio, truffa ai danni dello Stato se avete preso contributi in base a crediti finti, ecc.), potrebbero esserci altri reati non legati a soglie. Comunque ciò è molto raro nelle dispute R&S. Nella stragrande maggioranza dei casi, sotto i 50k annui il penale non parte.
D: Se l’azienda chiude o fallisce, la contestazione del credito R&S su chi ricade?
R: Il credito d’imposta era un beneficio dell’azienda, quindi l’atto di recupero viene emesso verso il soggetto giuridico che l’ha utilizzato. Se l’azienda viene liquidata o fallisce, l’Agenzia si insinuerà al passivo per il credito indebito e difficilmente otterrà qualcosa se non ci sono attivi. A meno che non venga dimostrata frode, i soci o amministratori non rispondono in solido delle sanzioni tributarie dell’ente (salvo casi di società di persone, etc.). Tuttavia, sul piano penale, la responsabilità è personale: se un amministratore ha commesso il reato di indebita compensazione, quell’azione non si estingue perché l’azienda fallisce. Potrà comunque essere perseguito penalmente e condannato. In sede civile, lo Stato potrebbe poi chiedergli i danni (tributi evasi), ma normalmente lo fa tramite l’azione amministrativa verso la curatela. Dunque, non pensate di eludere il problema chiudendo la società: l’AdE potrà rivalersi sugli eventuali liquidatori per le sanzioni se riscontrasse irregolarità nella chiusura, e soprattutto il penale vi seguirebbe personalmente se pertinente.
D: Esistono precedenti giurisprudenziali a favore dei contribuenti in questa materia?
R: Sì, ce ne sono diversi: – Cassazione Sez. Unite nn. 34419 e 34445/2023: hanno risolto un contrasto dando un’interpretazione restrittiva di credito inesistente (come visto, mancanza presupposto e non riscontrabilità). Queste sentenze, pur non specifiche sul R&S, hanno effetti generali su tutti i crediti d’imposta. – Cassazione n. 25018/2024: caso di credito Investimenti Mezzogiorno utilizzato tardivamente, la Corte ha detto che è credito non spettante (difetto di un requisito temporale) e che le definizioni nuove hanno valore interpretativo retroattivo. È un precedente utile perché rafforza la retroattività favorevole. – Cass. Penale Sez. III n. 3108/2024: in tema di Superbonus (crediti edilizi) ha affermato che il cessionario in buona fede di un credito inesistente comunque subisce il sequestro e deve restituirlo – quindi ribadisce che la buona fede soggettiva non “convalida” un credito inesistente. Anche se è un contesto diverso, sottolinea come il credito inesistente vada sempre recuperato. – Comm. Trib. Prov. Bologna n. 549/2022: ha annullato un recupero R&S rilevando che l’Agenzia aveva preteso un “brevetto” per provare l’innovazione mentre né norme né Frascati lo richiedono. Ha riconosciuto l’approccio scrupoloso dell’impresa sulla novità e dato ragione al contribuente . – CTP La Spezia n. 276/2022: ha accolto il ricorso dell’azienda per difetto di parere tecnico MISE e perché l’Agenzia aveva contestato nel 2021 crediti del 2015-16 come inesistenti sfruttando gli 8 anni, il che è stato giudicato contrario all’affidamento legittimo. – CTR Emilia Romagna n. 2342/2019: caso R&S, ha ritenuto che l’indicazione del credito in dichiarazione RU, rendendolo trasparente, escludeva la condotta fraudolenta. Ha quindi considerato il credito non spettante e applicato solo la sanzione del 30%. Questo principio, benché precedente alla Cassazione SU, è coerente con essa. – Vari casi in primo grado (CTP Milano, CTP Roma) hanno ridotto sanzioni o annullato atti quando l’azienda ha dimostrato buona fede o piccoli errori di calcolo.
Quindi, sì, esiste una giurisprudenza favorevole crescente. Ovviamente ci sono anche pronunce sfavorevoli (alcune CTP hanno avallato la linea AdE qualificando inesistenti crediti R&S per mancanza di novità, specie prima delle SU 2023). Ma oggi avete nel vostro arsenale alcune sentenze di legittimità di peso e tanti precedenti di merito da citare a sostegno.
D: Alla luce di tutto ciò, cosa mi consigliate di fare se l’Agenzia mi contesta il credito R&S?
R: Ogni situazione ha le sue specificità, ma in generale: 1. Valutare onestamente il merito: il progetto era realmente R&S? Le spese erano corrette? Se riconoscete internamente che c’è stato un errore (magari vi siete fidati di consulenti troppo ottimisti), potreste optare per chiudere la faccenda il prima possibile (adesione, pagamento). Se invece siete convinti di aver ragione, preparatevi a combattere in giudizio con tutti gli elementi.
2. Consultare esperti: fatevi assistere da un fiscalista e, se necessario, da un tecnico del settore del progetto per preparare la difesa. E se l’importo >50k, anche da un penalista.
3. Non perdere i termini: presentate ricorso nei 60 giorni (o adesione entro 30) per non far passare la riscossione in automatico.
4. Raccogliere la documentazione: tutto ciò che può provare l’attività di R&S e la buona fede va messo sul tavolo.
5. Distinguere i ruoli: l’aspetto tributario e quello penale vanno coordinati ma distinti. In tributario puntate a far riconoscere il credito o almeno a ridurre la sanzione (non spettante vs inesistente). In penale, puntate a evitare la condanna (incertezza normativa, pagamento).
6. Valutare accordi: se l’ufficio mostra apertura (ogni tanto succede, specie se vedono che avete argomenti solidi), considerare una definizione in adesione può risparmiarvi anni di processo. 7. Tenere d’occhio le novità: le norme fiscali sono in evoluzione; ad esempio la riforma fiscale 2024 ha cambiato le regole del gioco a vostro vantaggio su sanzioni e definizioni. Rimanere aggiornati vi permette di sfruttare eventuali nuove opportunità (come fu la sanatoria).
In sintesi, calma e sangue freddo. Un accertamento per il credito R&S non è la fine del mondo: molti contribuenti si sono difesi con successo, specie se hanno agito in buona fede. Con la giusta strategia potete proteggere i vostri diritti fiscali e magari conservare parte del beneficio, o quantomeno evitare penalità sproporzionate. Sempre meglio, ovviamente, prevenire tali situazioni: per il futuro, su questi incentivi conviene muoversi con maggior prudenza, perché come abbiamo visto anche un piccolo errore può costare caro.
D: Questa guida è valida anche per altri crediti d’imposta (es. Bonus investimenti, Formazione 4.0, ecc.)?
R: I principi generali sulla distinzione non spettante/inesistente e sulle strategie difensive valgono trasversalmente per tutti i crediti d’imposta. Ovviamente ogni credito ha le sue peculiarità (norme differenti, requisiti diversi) e non tutti hanno avuto una sanatoria come R&S. Però ad esempio la questione di interpretare restrittivamente l’inesistenza e applicare termini minori è comune anche ai Bonus Sud, Bonus Formazione, Bonus 4.0 ecc. Le Sezioni Unite 2023 riguardavano proprio un credito investimenti (caso Grafiche Mazzucchelli) e fanno giurisprudenza per tutti. Quindi, sebbene questa guida sia focalizzata sul R&S, molte difese e riferimenti sono estensibili ad analoghe contestazioni su altri crediti. C’è da dire che il R&S è stato uno dei più “abusati” e perciò ha generato più casi e anche misure di sanatoria uniche. Ad esempio, per i crediti da Bonus 4.0 o Ecobonus le contestazioni sono state altrettanto numerose e valgono considerazioni simili su buona fede, eccedenze non spettanti vs crediti fittizi (nel Superbonus addirittura si parla di frode massiva, ma c’è una legislazione a parte). In sostanza, i concetti chiave qui esposti possono orientarvi anche in altri ambiti di crediti d’imposta, adattandoli al contesto specifico.
Fonti Normative e di Prassi principali citate:
- DL 145/2013 art.3 (conv. L.9/2014): Istituzione credito R&S 2015-2019.
- DM 27.05.2015: Criteri attuativi credito R&S (definizioni di R&S, spese ammissibili, adempimenti).
- Circolare Agenzia Entrate 13/E del 27.04.2017: Primi chiarimenti su credito R&S (rinvio al MISE per valutazioni tecniche).
- Legge 30.12.2018 n.145 art.1 c.72: Norma interpretativa su esclusione attività commissionata estera dal 2017.
- Circolare MISE n. 59990 del 09.02.2018: Chiarimenti ministeriali su definizioni di R&S agevolabile.
- Legge 27.12.2019 n.160 (L. Bilancio 2020): Introduzione nuovi crediti R&S, Innovazione, Design (post 2019).
- Legge 21.06.2022 n.51 art. 20: Proroga termini sanatoria R&S al 31.10.2022.
- DL 144/2022 (Aiuti-ter) art. 5: Ulteriore proroga sanatoria al 31.10.2023.
- DL 14.03.2025 n.25 art.19 (conv. L.69/2025): Riapertura termini sanatoria al 3.06.2025 e disciplina contributo incentivo.
- D.Lgs. 146/2021 art.5 commi 7-12 (conv. L.215/2021): Istituzione procedura riversamento spontaneo R&S e non punibilità penale.
- L. 9.08.2023 n.111 art.20 c.1 lett.a n.5: Delega fiscale 2023, principi per distinzione non spettante/inesistente.
- D.Lgs. 12.01.2024 n.13: Riforma sanzioni tributarie – introdotto art.38-bis DPR 600/73 e modif. art.13 D.Lgs.471/97 (sanzioni 25% e 70%).
- D.Lgs. 14.06.2024 n.87: Definizioni normative di crediti non spettanti/inesistenti (modifiche D.Lgs.74/2000, art.1 e art.10-quater; art. 25-quinquiesdecies D.Lgs.231).
- D.Lgs. 29.10.2020 n.75: Estensione reati tributari nel catalogo D.Lgs.231/2001 (art.25-quinquiesdecies).
- Art. 10-quater D.Lgs.74/2000 (come modificato da D.Lgs. 24/2024, allegato art.84): Indebita compensazione – comma 1 non spettanti >50k (6 mesi-2 anni), comma 2 inesistenti >50k (1½-6 anni), comma 2-bis non punibilità obiettiva incertezza (solo per comma1).
- Art. 13 D.Lgs.74/2000: Causa di non punibilità per pagamento integrale debito prima del dibattimento (applicabile a 10-quater comma1).
- Art. 6 D.Lgs.472/97: Criteri di irrogazione sanzioni – co.2 (non punibilità per obiettiva incertezza), co.5-bis (violazioni formali senza imposta).
Principali pronunce giurisprudenziali citate:
- Cassazione SS.UU. civili nn. 34419 e 34445 dell’11.12.2023 – principi su crediti inesistenti vs non spettanti, requisiti distintivi e termini (caso Grafiche Mazzucchelli).
- Cassazione sez. tributaria ord. n. 25018 del 17.09.2024 – nuove definizioni 2024 sono interpretazione autentica, applicabili retroattivamente; es. credito investimenti Mezzogiorno usato oltre termine è non spettante.
- Cassazione sez. III penale sent. n. 3108 del 26.01.2024 – caso Superbonus: buona fede del cessionario non impedisce sequestro di crediti inesistenti; buona fede non “sanatoria” di inesistenza.
- CTR Emilia-Romagna sent. 28.11.2019 n.2342/2019 – credito R&S indicato in dichiarazione = non fraudolento, dunque violazione da ricondurre a credito non spettante (sanz. 30%); contestazione oltre 5 anni non valida.
- CGT 2° grado Lombardia (ex CTR) sent. 10.06.2024 n.287/2024 – (segnalata) decisione su differenza sanzioni 100% vs 30% per credito contestato (indicazioni su applicazione retroattiva definizioni 2024).
- CTP Bologna sent. 549/2022 – annullato atto: AdE aveva richiesto “privativa industriale” per provare innovatività, ma né DM né Manuale Frascati lo prevedono; riconosciuta scrupolosità dell’impresa sul concetto di novità .
- CTP Latina sent. 610/2022 – credito R&S qualificato come non spettante, sanzione 30%, termine 5 anni (AdE non può invocare 8 anni automaticamente).
- CTP La Spezia sent. 276/2022 – annullato recupero per mancato coinvolgimento MISE su valutazione tecnica e per applicazione 8 anni su annualità lontane violando affidamento.
- CTP Milano sent. 944/2021 – (es.) riconosciuta obiettiva incertezza normativa su definizione R&S, sanzioni annullate.
- Cass. civ. sez. trib. nn. 34443-34445/2021 – precedenti su nozione di credito inesistente come credito “non reale… privo di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili” (anticipano principi poi fatti propri dalle SU 2023).
(Le sentenze di merito sono citate a titolo esemplificativo; la giurisprudenza di legittimità costituisce orientamento vincolante sulle questioni di diritto.)
Conclusione: Affrontare una contestazione sul credito R&S richiede un approccio multidisciplinare, combinando conoscenze tributarie, tecniche e legali. La posizione del contribuente può sembrare inizialmente di debolezza di fronte a un’Amministrazione finanziaria che contesta e sanziona, ma come abbiamo visto esistono solide tutele giuridiche da far valere. Dal contraddittorio procedimentale al ricorso in commissione, fino agli eventuali risvolti penali, il contribuente ha modo di far emergere la realtà dei fatti (i progetti effettivamente condotti, l’assenza di intenti fraudolenti) e di ricondurre la vicenda nell’alveo di una violazione sì da correggere ma non dolosa né gravemente colposa. Con l’ausilio di consulenti esperti e un’analisi accurata del caso concreto, è possibile spesso ottenere un annullamento totale o parziale dell’atto di recupero, la riduzione delle sanzioni e la neutralizzazione di eventuali accuse penali. In un sistema normativo in continua evoluzione, aggiornato ora alle ultime riforme del 2024-2025, la chiave è conoscere e sfruttare i propri diritti: il diritto alla difesa nel merito scientifico, il diritto a non essere sanzionati oltremisura in situazioni dubbie e il diritto, in definitiva, a un trattamento equo da parte del Fisco. Questa guida ha cercato di fornire gli strumenti conoscitivi per esercitare tali diritti in modo consapevole. In caso di avviso di accertamento per credito R&S, il messaggio è dunque: non farsi prendere dal panico, esaminare lucidamente le contestazioni, e mettere in campo – magari con l’aiuto di professionisti qualificati – tutte le strategie difensive illustrate. Spesso “il diavolo non è brutto come lo si dipinge”: molte contestazioni R&S si sono risolte a favore dei contribuenti o con soluzioni di compromesso ragionevoli. L’importante è agire tempestivamente, evitare errori procedurali e far valere con determinazione le proprie ragioni. In tal modo, chi ha realmente investito in Ricerca e Sviluppo potrà vedere riconosciuti i propri diritti o quantomeno limitare le conseguenze di eventuali leggerezze commesse, continuando a innovare e crescere senza il peso di debiti fiscali insostenibili.
Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione?
Vuoi sapere quali sono i rischi e come puoi difenderti?
Il credito d’imposta per R&S è una delle agevolazioni più utilizzate dalle imprese, ma anche una delle più contestate dal Fisco. Le verifiche spesso riguardano la corretta qualificazione delle attività come ricerca e sviluppo, la documentazione prodotta e la compilazione del quadro RU in dichiarazione.
👉 Non sempre, però, la contestazione è fondata: molte volte le spese sono reali e inerenti, ma l’Agenzia le esclude per interpretazioni restrittive o per meri errori formali.
⚖️ Perché scatta la contestazione
- Attività considerate ordinarie e non riconducibili a ricerca e sviluppo;
- Spese non documentate o giudicate non congrue;
- Mancata o incompleta compilazione del quadro RU;
- Contestazioni sulla natura dei costi del personale o sull’ammissibilità di contratti e consulenze;
- Recupero del credito compensato tramite F24 per presunto utilizzo indebito.
📌 Conseguenze possibili
- Recupero del credito d’imposta già utilizzato;
- Sanzioni dal 100% al 200% del credito compensato ritenuto indebito;
- Interessi di mora;
- Nei casi più gravi, rischio di segnalazioni penali per indebita compensazione.
🔍 Come difendersi
- Analizza l’avviso di recupero: individua le spese o le attività contestate.
- Raccogli la documentazione tecnica e contabile: progetti, contratti, relazioni, bilanci, schede di costo del personale.
- Dimostra la natura innovativa delle attività: non solo ricerca pura, ma anche sviluppo sperimentale e processi innovativi sono ammissibili.
- Contesta gli errori dell’Agenzia: la mancata compilazione del quadro RU o difformità formali non cancellano automaticamente il diritto al credito.
- Predisponi memorie difensive o ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ridurre o annullare la pretesa.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Esamina la contestazione dell’Agenzia delle Entrate e individua i punti deboli;
- 📌 Ricostruisce la spettanza del credito con documentazione tecnica e giuridica;
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi fondati su prove concrete e giurisprudenza favorevole;
- ⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio e nei giudizi tributari;
- 🔁 Valuta anche soluzioni agevolate, come adesione o definizione, per ridurre sanzioni e interessi.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in crediti d’imposta e agevolazioni per le imprese;
- ✔️ Specializzato in contenzioso tributario e difesa su ricerca e sviluppo;
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo possono avere impatti molto gravi sull’impresa, ma non sempre sono fondate.
Con una difesa legale mirata puoi dimostrare la spettanza del credito, evitare che meri errori formali diventino motivo di recupero e ridurre le sanzioni.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro le contestazioni sul credito R&S inizia qui.