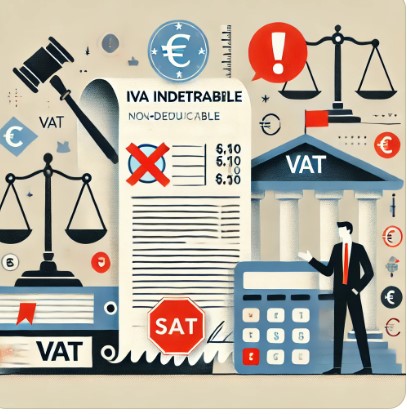Hai ricevuto un accertamento dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestata l’indetraibilità dell’IVA su alcune spese considerate non inerenti all’attività? L’inerenza è il principio in base al quale un costo può essere portato in detrazione solo se strettamente collegato all’attività d’impresa o professionale. Si tratta però di un concetto spesso interpretato in modo rigido dal Fisco e che può essere oggetto di contestazione.
Quando l’IVA diventa indetraibile
– Se le spese riguardano beni o servizi utilizzati per finalità personali e non aziendali
– Se i costi non sono documentati da fatture chiare e dettagliate
– Se le spese appaiono sproporzionate rispetto all’attività esercitata
– Se si tratta di beni ad uso promiscuo (auto, cellulari, immobili) senza corretta ripartizione tra uso personale e aziendale
– Se vengono considerate prive di utilità economica per l’impresa
Cosa rischi in caso di contestazione
– Recupero dell’IVA detratta ritenuta indebita
– Sanzioni fiscali dal 90% al 180% dell’imposta contestata
– Addebito di interessi di mora
– Estensione dei controlli ad altri anni di imposta e ad altre voci di spesa
– Possibili contestazioni penali se collegate a operazioni simulate o a fatture false
Come difendersi da una contestazione per IVA indetraibile
– Dimostrare la reale inerenza delle spese all’attività con contratti, ordini, relazioni e documentazione contabile
– Contestare valutazioni arbitrarie dell’Agenzia delle Entrate quando non supportate da elementi concreti
– Dimostrare che spese apparentemente personali erano in realtà funzionali all’attività d’impresa
– Evidenziare la corretta gestione fiscale di beni ad uso promiscuo con detrazione parziale riconosciuta dalla legge
– Impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria se l’atto è illegittimo o sproporzionato
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la contestazione e verificare la legittimità delle motivazioni addotte dal Fisco
– Raccogliere prove concrete a sostegno dell’inerenza delle spese contestate
– Contestare la sproporzione delle sanzioni applicate
– Difendere l’impresa nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e in sede giudiziale
– Negoziare soluzioni conciliative che permettano di ridurre l’importo dovuto
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– Il riconoscimento della detraibilità di spese effettivamente inerenti
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi richiesti
– La sospensione delle procedure esecutive già avviate
– La tutela del patrimonio aziendale e personale degli amministratori
⚠️ Attenzione: il concetto di “inerenza” è spesso oggetto di interpretazioni soggettive. Non tutte le spese contestate sono davvero indetraibili: con prove documentali e una difesa tecnica ben impostata è possibile ribaltare l’accertamento.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e fiscale d’impresa – ti spiega cosa fare se l’Agenzia delle Entrate ti contesta l’IVA per spese ritenute non inerenti all’attività e come difenderti.
👉 Hai ricevuto una contestazione per IVA indetraibile? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo le spese contestate, raccoglieremo la documentazione utile e costruiremo la strategia difensiva più efficace per proteggere la tua impresa.
Introduzione
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è strutturalmente un tributo neutrale per le imprese: grazie al meccanismo della detrazione, il soggetto passivo può recuperare l’IVA pagata sugli acquisti deducendola dall’IVA incassata sulle vendite . Tuttavia, il diritto alla detrazione IVA è condizionato al rispetto di specifici requisiti di legge. Tra questi requisiti vi è la necessità che i beni e servizi acquistati siano effettivamente afferenti all’attività economica tassata svolta dal contribuente. In altre parole, l’operazione a monte (l’acquisto) deve avere un nesso con le operazioni a valle imponibili esercitate dall’impresa o dal professionista . Se tale nesso manca – perché la spesa è estranea all’attività, di natura personale o comunque “non inerente” – l’IVA assolta su di essa non è detraibile.
Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sulla detraibilità dell’IVA per spese ritenute non inerenti sono frequenti. L’Agenzia delle Entrate può negare la detrazione IVA su una fattura qualora ritenga che:
- L’acquisto non sia inerente o strumentale all’attività d’impresa o professionale (es. bene ad uso personale, spesa voluttuaria non legata all’oggetto sociale) .
- Oppure che l’operazione sia esente o fuori campo IVA, dunque l’acquisto non dà diritto a detrazione in base alle regole sull’afferenza e sul prorata (come vedremo oltre) .
Altre cause di contestazione della detrazione IVA – che esulano però dal profilo dell’“inerenza” in senso stretto – includono vizi formali della fattura (dati mancanti, errore di intestazione), il mancato rispetto di termini e condizioni per esercitare la detrazione (ad esempio detrazione tardiva oltre i termini di legge), oppure ipotesi più gravi come operazioni inesistenti o frodi IVA (es. frodi “carosello” con fornitori fittizi) . In questa guida ci concentreremo sul caso specifico di spese reali ma considerate non inerenti all’attività: una situazione in cui l’operazione è effettivamente avvenuta, ma il Fisco nega la detrazione sostenendo che quel costo non ha a che fare con l’esercizio dell’impresa.
Affronteremo dapprima i principi generali: cosa si intende per inerenza in ambito fiscale e in particolare ai fini IVA, quale normativa italiana disciplina la detraibilità e quali limitazioni oggettive esistono (es. per alcune categorie di beni e servizi). Vedremo che la giurisprudenza ha delineato in modo sempre più chiaro il concetto di inerenza, distinguendo tra imposte dirette e IVA, con la Corte di Cassazione che – in linea con la Corte di Giustizia UE – richiede un nesso diretto e immediato tra acquisto e attività imponibile affinché l’IVA sia detraibile .
Successivamente, analizzeremo le principali tipologie di spese “a rischio” di indetraibilità per difetto di inerenza: dalle auto aziendali ad uso promiscuo, alle spese di vitto e alloggio per dipendenti e amministratori, dalle spese di rappresentanza e promozionali (es. omaggi, eventi) ai beni di lusso o voluttuari intestati all’azienda (yacht, aerei da turismo, immobili abitativi), fino a casi peculiari come le spese legali sostenute per amministratori/dipendenti (difese penali e simili). Per ciascuna categoria illustreremo il trattamento fiscale ordinario e i limiti alla detrazione IVA previsti dalla normativa, gli orientamenti della Cassazione più recenti e i possibili rischi in caso di accertamento.
Dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta), la guida fornirà indicazioni su come difendersi qualora l’Agenzia delle Entrate contesti la detraibilità dell’IVA per spese asseritamente non inerenti. Esamineremo:
- Gli strumenti deflativi e le azioni immediate da intraprendere non appena si riceve un avviso di accertamento (es. presentare memorie difensive, valutare un accertamento con adesione, l’eventuale acquiescenza o la definizione agevolata delle sanzioni, l’istanza di autotutela).
- Le strategie difensive in sede contenziosa davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie), inclusa la raccolta delle prove documentali per dimostrare l’inerenza (contratti, documenti societari, registri di utilizzo, ecc. ), l’impostazione del ricorso e delle eccezioni (ad esempio vizi di motivazione dell’atto, violazioni procedurali) e l’uso dei precedenti giurisprudenziali favorevoli.
A corredo, troverete tabelle riepilogative che sintetizzano i punti chiave (come i limiti di detraibilità per tipologia di bene e i riferimenti normativi) e una sezione di Domande frequenti (FAQ) che risponde ai dubbi più comuni: Cosa significa bene non inerente? Quali sanzioni si rischiano? L’Agenzia può contestare un costo solo perché “troppo alto”? Cosa fare se un bene aziendale viene usato occasionalmente per scopi personali? Come documentare al meglio l’inerenza di una spesa? ecc. Infine, verranno presentati alcuni casi pratici e simulazioni (ispirati a vicende reali) per comprendere in concreto come vengono affrontate le contestazioni di IVA indetraibile e quale potrebbe essere l’esito, alla luce delle ultime pronunce dei giudici tributari.
Nota bene: Questa guida è aggiornata ad agosto 2025. Si tengono in considerazione le novità normative più recenti (ad es. la riforma della giustizia tributaria 2022-2023, l’evoluzione delle norme sanzionatorie con D.Lgs. 87/2024, ecc.) e le ultime sentenze rilevanti fino all’estate 2025, come l’ordinanza Cass. 15638/2025 sull’IVA in attività esenti e la sentenza Cass. 17113/2025 sull’IVA relativa a spese legali per amministratori . Si richiamano inoltre i principi affermati in importanti decisioni pregresse (Cassazione e Corte di Giustizia UE) per fornire un quadro completo. Le fonti citate – normative e giurisprudenziali – sono riportate in nota per consentire al lettore ulteriori approfondimenti e verifica.
Entriamo ora nel vivo dell’argomento, partendo dal definire il concetto di “inerenza” e dal quadro normativo di riferimento ai fini IVA.
Principio di inerenza e detraibilità dell’IVA: quadro normativo
Che cos’è l’“inerenza” di una spesa? In ambito fiscale italiano, il principio di inerenza esprime la necessaria correlazione qualitativa tra un costo e l’attività svolta dal contribuente . Un costo è inerente se sostenuto nell’esercizio dell’impresa o per fini ad essa economico-funzionali; viceversa, è non inerente se attiene a una sfera estranea all’impresa (esigenze personali dell’imprenditore, dei soci o altre finalità non aziendali) . In termini di imposte sui redditi, ciò si traduce nella deducibilità dal reddito imponibile solo dei costi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di ricavi (o altri proventi imponibili) . La normativa cardine è l’art. 109, comma 5 del TUIR (D.P.R. 917/1986) che stabilisce: “le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito…” . Su tale base la Cassazione ha definito l’inerenza come criterio qualitativo, non quantitativo: conta la natura e destinazione del costo rispetto all’attività, non la sua utilità economica immediata né la proporzione con uno specifico ricavo .
Ai fini dell’IVA, il principio di inerenza assume connotati in parte analoghi ma con requisiti più stringenti. Occorre richiamare innanzitutto l’art. 19 del D.P.R. 633/1972 (“Decreto IVA”), che disciplina in generale il diritto alla detrazione: il soggetto passivo può detrarre l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi nella misura in cui questi sono impiegati per effettuare operazioni soggette ad IVA (operazioni imponibili o assimilate) . Tale principio è conforme a quanto previsto a livello europeo dall’art. 168 della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), secondo cui un soggetto passivo può detrarre l’IVA a monte se i beni/servizi acquistati sono utilizzati “per le esigenze delle sue operazioni soggette ad imposta”. In altri termini, non basta che la spesa riguardi l’attività in senso generico (oggetto sociale), è anche necessario che essa sia correlata ad operazioni che rientrano nel campo IVA imponibile .
Questa precisazione è cruciale: se un’impresa svolge attività escluse da IVA o esenti, i costi relativi non danno diritto a detrazione. L’art. 19, co.2 del DPR 633/72 è esplicito: “Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad IVA” . La Cassazione ha recentemente ribadito che il fattore determinante è la destinazione dell’acquisto: se i beni/servizi sono destinati ad un’attività per legge esente, l’IVA sugli acquisti è totalmente indetraibile, anche per la fase preparatoria . Ad esempio, se un imprenditore compie investimenti iniziali per avviare un’attività che genererà solo operazioni esenti, non potrà recuperare l’IVA pagata su tali investimenti (principio affermato da Cass. ord. 15638/2025 in linea con la giurisprudenza UE) .
Dal punto di vista concettuale, dunque, l’inerenza ai fini IVA richiede che vi sia un nesso economico-funzionale diretto tra l’acquisto e l’attività tassata. La Corte di Giustizia UE parla di “nesso diretto e immediato” tra un’operazione a monte (acquisto) e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione (cessioni/prestazioni imponibili) . Se tale nesso manca, l’IVA a monte non può essere recuperata. La Corte di Cassazione ha fatto propria questa impostazione sottolineando che ai fini IVA l’inerenza è più rigorosa: non basta un generico collegamento all’attività d’impresa, occorre una relazione immediata e diretta con le attività produttive di ricavi . In una recente sentenza (Cass. 17113/2025), essa ha chiarito che le spese sostenute da una società per finalità indirette o riflesse (es. tutelare l’immagine aziendale, prevenire danni potenziali) non soddisfano il requisito della inerenza immediata richiesta per la detrazione IVA . In quel caso, le spese legali per difendere penalmente l’amministratore, pur riguardando in senso lato la sfera aziendale, non erano considerate costi direttamente afferenti all’attività imponibile dell’impresa e la relativa IVA è stata giudicata indetraibile .
Va poi evidenziato l’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che una data spesa è inerente e strumentale alla propria attività economica . Questo principio, valido per le imposte dirette, si riflette anche in ambito IVA: se l’Ufficio contesta la detrazione per difetto di inerenza, il contribuente dovrà provare la natura e destinazione imprenditoriale di quel costo, fornendo documentazione e spiegazioni plausibili . La Cassazione ha affermato che il contribuente deve documentare la concreta destinazione del bene o servizio alla sua attività produttiva e i relativi motivi economici, al fine di giustificarne la detrazione . Di converso, l’Amministrazione finanziaria, quando nega l’inerenza, deve motivare chiaramente le ragioni per cui ritiene quel costo estraneo all’impresa, non potendo limitarsi a mere affermazioni generiche . Un avviso di accertamento che non esplicita i motivi del disconoscimento potrebbe risultare viziato per difetto di motivazione, offrendo al contribuente un ulteriore spunto di difesa.
Limiti oggettivi alla detraibilità IVA (Art. 19-bis1 DPR 633/1972). Oltre al principio generale sopra descritto, la normativa IVA italiana individua alcune categorie di beni e servizi per cui la detrazione è esclusa o limitata a priori, indipendentemente dall’uso che se ne fa. Tali restrizioni, ammesse in deroga alle regole UE (c.d. limitazioni oggettive alla detrazione), sono elencate all’art. 19-bis1 del DPR 633/72. Ecco le principali:
- Automezzi aziendali ad uso promiscuo: l’IVA relativa all’acquisto (o importazione) di autovetture, autoveicoli e motocicli non utilizzati esclusivamente per l’esercizio d’impresa è detraibile solo al 40% . Questa limitazione si applica tipicamente alle auto aziendali a disposizione di amministratori, dipendenti o professionisti per uso sia lavorativo che personale. Eccezioni: se il veicolo è strumentale per natura all’attività (es. autoscuole, taxi, noleggio auto) o se è utilizzato da agenti e rappresentanti di commercio, la detrazione spetta integralmente (100%) . La percentuale ridotta del 40% è un forfettario e prescinde dall’effettivo chilometraggio privato/aziendale; è stata adottata dall’Italia in base alle opzioni concesse dall’UE.
- Spese per carburanti, manutenzioni e accessori dei veicoli: l’IVA su carburanti, lubrificanti, riparazioni e altri costi relativi a detti veicoli segue la stessa proporzione di detraibilità applicabile al veicolo medesimo . Dunque, ad esempio, per un’auto soggetta a detrazione 40%, anche l’IVA sul carburante sarà detraibile al 40%.
- Trasporto di persone: l’IVA su servizi di trasporto persone (biglietti aerei, ferroviari, taxi per spostamenti non fatturati come rivalsa) non è detraibile, salvo che tali servizi costituiscano oggetto dell’attività propria dell’impresa . Ciò significa che se un’azienda acquista servizi di trasporto passeggeri per finalità proprie (es. trasferte dipendenti), in linea generale non recupera l’IVA. Rientrano qui i viaggi di lavoro, biglietti di mezzi pubblici, ecc., che scontano IVA (quando applicata) indetraibile.
- Alberghi e ristoranti (vitto e alloggio): fino al 2007 l’IVA su prestazioni alberghiere e di ristorazione era oggettivamente indetraibile, a meno che fossero acquistate per rivenderle (agenzie di viaggi) o per mense aziendali. Dal 2008 questa limitazione è stata abrogata (ex lett. g, ora abrogata) , allineando il regime italiano ai principi generali. Oggi quindi l’IVA su vitto e alloggio è detraibile secondo i principi generali, ovvero se la spesa è inerente all’attività. Ad esempio, se un dipendente va in trasferta e l’hotel fattura alla sua azienda, l’IVA è detraibile (la trasferta è funzionale all’attività). Resta tuttavia il fatto che molte spese di vitto/alloggio rientrano tra le spese di rappresentanza (es. cene offerte a clienti, eventi promozionali con ospitalità) e come tali soffrono delle limitazioni apposite (vedi punto successivo).
- Spese di rappresentanza: l’IVA relativa a spese di rappresentanza è in linea di principio indetraibile al 100% . Lo prevede la lettera h) del citato art. 19-bis1: nessuna detrazione per l’IVA sulle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte dirette, tranne l’IVA sulle spese per beni di costo unitario non superiore a 50 euro . Dunque, gli omaggi di modico valore (fino a €50) godono dell’eccezione: l’IVA su di essi è detraibile, coerentemente col fatto che ai fini redditi tali omaggi sono deducibili integralmente. Per tutte le altre spese di rappresentanza (cene, viaggi premio, eventi senza corrispettivo, regali costosi, sponsorizzazioni senza adeguato ritorno commerciale diretto, ecc.), l’IVA è indetraibile per legge, anche qualora l’evento abbia attinenza generica con l’attività. L’idea sottesa è che queste spese non generano direttamente operazioni imponibili, ma mirano a un beneficio d’immagine di difficile misurazione; il legislatore ha dunque scelto una via prudenziale, negando a monte il diritto a detrazione (fatti salvi gli omaggi minori).
- Beni immobili a destinazione abitativa: l’IVA sull’acquisto, locazione, manutenzione o gestione di fabbricati abitativi è indetraibile, salvo per le imprese la cui attività consiste nella costruzione o rivendita di tali immobili . La lettera i) stabilisce infatti il divieto di detrazione per immobili abitativi, ad eccezione delle imprese edili/immobiliari che costruiscono o commerciano case (in tal caso l’IVA sugli acquisti è detraibile perché quei beni rientrano nell’attività propria). Un’ulteriore eccezione: la norma non si applica per i soggetti che effettuano locazioni esenti di abitazioni (art. 10 n.8) che già comportano prorata di detrazione – tecnicismo che qui citiamo per completezza, ma in sostanza, per un’azienda non immobiliare l’IVA su una casa presa per uso aziendale resta indetraibile.
- Altri beni “di lusso” o voluttuari: l’art. 19-bis1 include restrizioni anche per aeromobili da turismo, imbarcazioni da diporto, e alcuni beni elencati nell’allegata Tabella B (ad es. pellicce, beni di lusso, etc.). In sintesi: per aeromobili privati e navi da diporto l’IVA è detraibile solo se tali mezzi formano oggetto dell’attività d’impresa (es. società di noleggio aerei o barche) e comunque è esclusa per i professionisti . Quindi una società non operante nel settore aeronautico che acquisti un aereo privato non può detrarre l’IVA, né può farlo un professionista che compri un aereo o yacht per uso proprio. Per i beni elencati in Tabella B (di carattere personale/voluttuario, come ad esempio specifici motocicli >350cc non da lavoro), similmente l’IVA è detraibile solo se quei beni rientrano nell’attività propria dell’impresa, altrimenti no.
Le limitazioni oggettive sopra evidenziate riflettono, in fondo, la stessa logica dell’inerenza: il legislatore ha individuato beni e servizi che, per loro natura, prestano il fianco a utilizzi personali o estranei all’impresa, scegliendo quindi di precludere o ridurre ex lege la detrazione per evitare abusi. Oltre a queste, rimane sempre valido il principio generale: anche laddove non interviene una norma specifica, qualsiasi spesa che risulti di fatto estranea all’attività d’impresa comporta indetraibilità dell’IVA, perché manca il presupposto del nesso con operazioni imponibili .
Sintesi principi chiave: Ai fini IVA un costo è inerente se il bene/servizio è effettivamente utilizzato nell’attività economica imponibile del soggetto passivo . L’IVA sugli acquisti è detraibile solo in presenza di questo nesso funzionale. Sono non inerenti (quindi IVA indetraibile) le spese personali o voluttuarie, o comunque non legate all’esercizio dell’impresa, nonché quelle relative ad attività esenti o fuori campo . La legge (art.19-bis1) individua alcune aree critiche e impone limiti oggettivi (auto 40%, rappresentanza no detrazione oltre soglia, ecc.) . In caso di contestazione, il contribuente deve provare l’inerenza fornendo evidenze documentali ; l’assenza di un vantaggio economico immediato non implica di per sé non inerenza (la Cassazione riconosce che anche spese propedeutiche o futuristiche possono essere inerenti) , ma se la spesa appare manifestamente estranea o antieconomica, l’Ufficio può usarlo come indizio di non inerenza reale . In definitiva, l’IVA è un’imposta neutrale solo per gli acquisti effettuati nell’ambito e per le finalità dell’attività tassata; diversamente, diventa costo a carico del contribuente.
Nel prossimo capitolo, passeremo in rassegna alcune categorie tipiche di spese che sovente vengono considerate “non inerenti” in sede di verifica fiscale, esaminando per ciascuna di esse il trattamento fiscale e i rischi di indetraibilità IVA connessi.
Spese non inerenti all’attività: casi tipici e trattamento fiscale
Quali sono, nella pratica, le spese che più spesso danno luogo a contestazioni di IVA indetraibile per difetto di inerenza? In questa sezione analizziamo i casi più frequenti, raggruppando per tipologia di bene o spesa. Per ognuna forniremo: (a) come dovrebbe essere trattata la spesa se effettivamente inerente (limiti di detrazione previsti, percentuali ammesse, ecc.); (b) quando e perché l’Agenzia la contesta come non inerente; (c) i riferimenti normativi e giurisprudenziali rilevanti, inclusi i più recenti orientamenti.
Al termine della sezione troverete anche una tabella riepilogativa dei principali beni “a rischio” con il rispettivo regime fiscale e possibili contestazioni.
1. Autovetture aziendali ad uso non esclusivamente strumentale
Trattamento fiscale ordinario: Le autovetture aziendali rappresentano un classico caso di beni ad uso promiscuo. Ai fini IVA, come visto, la regola generale (art. 19-bis1 lettera c) prevede la detraibilità limitata al 40% dell’IVA sull’acquisto e sulle spese ad esse relative, se il veicolo non è ad uso esclusivo aziendale . In pratica, quasi tutte le auto assegnate ad amministratori, dipendenti o utilizzate anche per esigenze private rientrano in questo regime forfettario del 40%. Fanno eccezione i veicoli che l’azienda utilizza solo come beni strumentali (ad es. un furgone attrezzato per assistenza tecnica, un’auto dimostrativa in concessionaria) o quelli che formano oggetto dell’attività (es. concessionarie auto, società di noleggio, taxi) e per gli agenti di commercio: in tali casi l’IVA è detraibile al 100% . L’inclusione degli agenti e rappresentanti tra le eccezioni è dovuta al riconoscimento che per essi l’auto è tipicamente uno strumento essenziale e quasi esclusivo dell’attività di vendita.
Va notato che il 40% è una percentuale di indetraibilità oggettiva, fissata per legge indipendentemente dall’uso reale. Ciò significa che anche se l’auto venisse usata solo al 20% per fini personali, comunque la detrazione massima resta il 40% (non proporzionale all’uso). Viceversa, se l’uso personale fosse elevatissimo (80-90%), la legge consente comunque il 40% di detrazione, salvo che si dimostri che l’auto in realtà non rientra affatto nell’attività (caso estremo di totale estraneità che vedremo tra poco). Per le imposte dirette (reddito d’impresa) c’è un parallelo: i costi auto sono deducibili solo al 20% (con limiti assoluti di valore) se l’auto è a uso promiscuo, percentuale elevata al 70% se l’auto è assegnata a un dipendente come fringe benefit tassato e al 100% solo se auto strumentale o ad agenti (80% per agenti) . Queste percentuali diverse tra IVA (40%) e reddito (20%) sono frutto di normative differenti; ai fini delle contestazioni di inerenza però vanno spesso di pari passo: un’auto non ritenuta inerente verrà sanzionata sia sul versante IVA (IVA indetraibile oltre il dovuto) sia sul versante redditi (costi indeducibili oltre il 20%).
Quando scatta la contestazione di non inerenza: Nonostante la detrazione ridotta, l’auto aziendale è comunque un bene su cui il Fisco mantiene alta l’attenzione. Le contestazioni tipiche riguardano situazioni in cui l’auto, formalmente intestata alla società, risulta di fatto utilizzata quasi esclusivamente per fini personali di un soggetto (socio, amministratore) e non ha una giustificazione aziendale plausibile. In tali casi l’Ufficio può sostenere che l’auto è un bene estraneo all’impresa, e quindi:
- Negare totalmente la detrazione IVA anche oltre il 40%. In sostanza, se dimostra che l’uso è personale pressoché al 100%, l’Amministrazione potrebbe disconoscere il diritto stesso al 40%, trattando l’operazione come completamente fuori sfera IVA (è però un onere probatorio non banale, e in pratica spesso si limita a sanzionare usi impropri piuttosto che rifiutare il 40% forfettario previsto per legge). Un argomento difensivo per il contribuente, in questi frangenti, è che la norma del 40% prescinde dall’uso effettivo e già considera un uso non esclusivo; tuttavia, se l’uso personale è praticamente totale, l’Agenzia può replicare che non c’è mai stato un reale impiego aziendale e che quindi la fattura d’acquisto nemmeno avrebbe dovuto entrare nel calcolo della detrazione. Si entra qui in una zona grigia tra l’applicazione formale del 40% forfettario e il concetto sostanziale di inerenza: la Cassazione in passato ha affermato che l’onere di provare l’inerenza grava sul contribuente, e se l’auto non è mai usata per l’impresa, l’IVA è indetraibile in toto .
- Recuperare a tassazione i costi al 100% ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF), sostenendo che non spettava nemmeno la deduzione limitata del 20%. Ciò può avvenire quando emergono elementi che l’auto serviva solo a soddisfare esigenze private (ad es. nessuna traccia di utilizzo per trasferte di lavoro, auto di lusso usata come “auto personale” del socio, ecc.).
- Applicare la disciplina dei beni in godimento a soci: se l’auto aziendale è stata messa a disposizione di un socio o familiare per uso personale senza un adeguato corrispettivo pagato alla società, scatta la normativa anti-elusiva introdotta dal DL 138/2011. Tale norma prevede: (1) obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria del bene concesso; (2) tassazione in capo al socio di un reddito diverso pari alla differenza tra valore di mercato del godimento e quanto eventualmente pagato; (3) indeducibilità integrale per la società di tutti i costi relativi a quel bene . In pratica, se la società fa usare l’auto al socio gratis o sottocosto, perde per legge la deduzione dei costi (quindi vani sarebbero i tentativi di difendere l’inerenza: è una presunzione assoluta) e il socio viene tassato per il beneficio. Questa norma è un vero “muro” contro gli abusi: se applicabile, rende quasi impossibile vincere in giudizio, perché non si discute di inerenza in senso tradizionale ma di una indeducibilità automatica ex lege . L’unica via, in questi casi, è dimostrare che non c’è stata concessione ad uso personale, o che il socio ha pagato un corrispettivo di mercato (vedi oltre FAQ D7 sulle difese in tema beni ai soci).
Riferimenti normativi e giurisprudenziali: Oltre all’art. 19-bis1, c.1, lett. c) DPR 633/72 (IVA detraibile 40%), rileva per i costi auto l’art. 164 TUIR (limiti 20% per deducibilità reddito) . Sul fronte dei controlli anti-abuso: art. 2, c.36-quinquies, DL 138/2011 (conv. L.148/2011) sui beni concessi in godimento ai soci . La Cassazione ha prodotto vasta giurisprudenza: una sentenza recente è la n. 11791/2024, che conferma il limite forfettario del 20% per le auto ai fini IRAP (calcolo su base bilancio) . In tema di inerenza sostanziale, un principio utile è in Cass. 33854/2022: l’inerenza è qualitativa e anche spese elevate (come quelle auto di rappresentanza) possono essere inerenti se funzionali all’impresa; viceversa un’auto di lusso intestata alla società ma usata a scopi privati sarà considerata non inerente e i relativi costi/IVA disconosciuti . Cass. 4365/2023 (caso barca, ma applicabile per analogia) ha affermato che se un bene è estraneo all’impresa, i costi sono indeducibili e i ricavi correlati vanno esclusi dal reddito d’impresa – un principio che può soccorrere il contribuente almeno per non pagare tasse sui benefit: se l’auto non era davvero aziendale, anche l’eventuale compenso figurativo andrebbe eliminato. Ne riparleremo nelle strategie difensive.
In sintesi: Le auto aziendali sono normalmente ammesse a detrazione IVA ridotta (40%). Per evitare contestazioni maggiori, è fondamentale: limitare gli usi personali o regolarli formalmente (assegnazione come fringe benefit o noleggio al socio a valore di mercato), documentare l’uso aziendale (registro viaggi, calendario trasferte) e in caso di verifica dimostrare concretamente che l’auto serviva all’attività (es. provare visite a clienti, cantieri, ecc.). Se l’auto è di lusso e intestata a una piccola società senza logica economica (es. spider sportiva in una società di consulenza), è molto probabile una contestazione: il contribuente dovrà faticare per provare che aveva un’utilità di rappresentanza (in alcuni casi la Cassazione ha riconosciuto l’auto di lusso come strumento di rappresentanza per l’immagine aziendale, ma ricordiamo che l’IVA su spese di rappresentanza resta non detraibile oltre i limiti).
2. Immobili ad uso abitativo intestati alla società
Trattamento fiscale ordinario: Quando una società possiede un immobile abitativo (categoria catastale A, non ufficio) che non è strumentale all’attività (cioè non è utilizzato come sede, né è merce per un’impresa immobiliare), la normativa fiscale è particolarmente penalizzante. Ai fini IVA, come detto, l’IVA sull’acquisto, locazione e manutenzione di immobili abitativi non è detraibile (art. 19-bis1 lett. i) a meno che la società sia un’impresa di costruzione o trading immobiliare) . Questo significa che se, ad esempio, una S.r.l. non immobiliare acquista un appartamento, l’IVA in fattura (al 10% o 22% a seconda dei casi) non può detrarla affatto: diventa un costo. Se l’appartamento viene dato in affitto, l’attività di locazione abitativa è per legge esente IVA (art. 10 n.8), quindi comunque non ci sarebbe detrazione e l’azienda paga l’IVA sugli acquisti senza recuperarla.
Ai fini delle imposte sui redditi, esiste una norma analoga: l’art. 90 del TUIR stabilisce che i costi relativi a immobili patrimonio (abitativi non strumentali) non sono deducibili dal reddito d’impresa . La società proprietaria di un’abitazione può dichiarare come reddito al fisco solo la rendita catastale (o il canone di locazione ridotto del 5% se affittata), ma non può dedurre né ammortamenti, né spese di manutenzione, né altre spese (tranne, per espressa deroga, gli interessi passivi su eventuale mutuo per l’acquisto) . In sostanza il fisco considera questi immobili estranei al ciclo produttivo e nega i costi correlati. Dunque, già in condizioni “ordinarie” l’appartamento in pancia alla società è fiscalmente inefficiente: IVA indetraibile e costi indeducibili (salvo interessi mutuo). L’unico caso virtuoso è se l’immobile viene trasformato in strumentale (es. la società lo utilizza effettivamente come ufficio o showroom): allora l’IVA sull’acquisto potrebbe essere detraibile (se l’acquisto è imponibile) e i costi deducibili, ma in tal caso di solito si cambia destinazione d’uso o categoria catastale (abitazione usata come ufficio può creare altre complicazioni, come l’indeducibilità parziale di quote, ecc.).
Contestazioni tipiche: Visto che la legge già nega deduzioni e detrazioni, su questo fronte l’attenzione del Fisco si focalizza su possibili usi personali occultati. Il caso emblematico è l’immobile abitativo intestato alla società ma utilizzato come abitazione dal socio o dall’amministratore (o da loro familiari). Si tratta di uno scenario abbastanza comune in passato: immobili di pregio acquistati dalla società per godere magari di maggiore potere di acquisto o per convenienza, poi di fatto usati dal titolare. In tali situazioni, l’Agenzia delle Entrate può contestare:
- L’applicazione della già citata norma sui beni ai soci (DL 138/2011): un immobile dato in uso gratuito o a canone di favore a un socio configura bene in godimento, con conseguente tassazione di un benefit in capo all’utilizzatore e indeducibilità per legge di tutti i costi . Come per l’auto, questa norma chiude la porta a discussioni sull’inerenza: se l’uso personale senza corrispettivo è accertato, la società non può dedurre nulla per definizione.
- Utili in natura o distribuzione occulta di utilità: in aggiunta o alternativa al bene a soci, l’Ufficio potrebbe riqualificare l’operazione come assegnazione di un bene al socio (o utilizzo infruttifero) e quindi considerare i costi sostenuti come utili “in natura” erogati al socio. Questo però è più pertinente al profilo reddituale. Sul piano IVA, se l’immobile è usato privatamente, qualsiasi acquisto o servizio su di esso è fuori attività: quindi l’IVA è indetraibile già de jure e l’eventuale detrazione operata verrebbe recuperata. Ad esempio, se la società avesse detratto l’IVA su fatture di ristrutturazione o arredo dell’appartamento, tali detrazioni verrebbero contestate.
- Falsa strumentalità: a volte le società argomentano che l’immobile abitativo è in realtà utilizzato dall’impresa (ad esempio come foresteria per ospiti, o in vista di futura rivendita). L’Agenzia in genere valuta i fatti: se non c’è traccia di effettivo uso d’impresa (es. nessun ospite documentato nella foresteria, nessun tentativo di vendere l’immobile per anni), concluderà che l’immobile è patrimonio e l’uso d’impresa è solo cartolare. In Cassazione è consolidato il principio generale: i costi di immobili abitativi non strumentali sono indeducibili (Cass. n. 7369/2012 tra le tante) .
- Canoni figurativi: in giudizio, talvolta i contribuenti chiedono che, se i costi sono indeducibili, allora non dovrebbero neppure tassare eventuali ricavi da quell’immobile (e.g. fitti figurativi imputati). Sul punto, l’approccio logico è come per la barca: se il bene è estraneo, esclude costi e ricavi dal reddito d’impresa . Quindi, qualora l’Ufficio tentasse di tassare un affitto figurativo per l’uso personale dell’immobile, andrebbe parallelamente tolta la tassazione ai fini IRES (in base al citato orientamento Cass. 4365/2023). Questo può essere usato dal difensore come “minaccia” in caso di accertamento: o mi lasci dedurre i costi perché lo consideri attività d’impresa, oppure se dici che è personale allora non puoi tassarmi redditi su di esso – coerentemente col principio di simmetria che Cassazione ha evidenziato .
Difese possibili: Per prevenire problemi, se un immobile sociale viene di fatto usato da un socio/amministratore, la migliore strategia è stipulare un contratto (di locazione o comodato) a valore di mercato. Pagando un affitto congruo, il socio evita il regime beni in godimento (che si applica solo sotto il valore normale) e la società può almeno dichiarare un ricavo e giustificare la detenzione dell’immobile. I costi restano in gran parte indeducibili (ex art. 90 TUIR) ma l’operazione è resa trasparente. Nella sezione FAQ troverete un quesito (D7) proprio su questo: in breve, se il socio paga un corrispettivo pari al valore d’uso, la penalizzazione beni ai soci non scatta e la società può considerare quell’immobile come dato in locazione a terzi, tassando il canone ma non perdendo ulteriori costi oltre quelli già non deducibili di legge . In sede di verifica, esibire un regolare contratto di locazione registrato, bollettini di pagamento dei canoni, ecc., aiuta a sostenere che non c’è un’utilizzazione “occulta” e che la società sta seguendo il regime fiscale corretto (pagando le dovute imposte sui canoni e non deducendo quanto non consentito). Se invece nulla è formalizzato, il rischio di contestazione è molto alto e difficilmente difendibile nel merito, se non attaccando vizi formali dell’atto.
Riferimenti: Art. 19-bis1 lett. i) DPR 633/72 (IVA indetraibile per immobili abitativi) ; Art. 90 TUIR (indeducibilità costi immobili patrimonio, salvo interessi mutuo) ; Circolare AdE 47/E del 2008 (chiarimenti su regime art.90 TUIR e interessi passivi mutuo) . Cass. 7369/2012 ha confermato la non deducibilità generalizzata dei costi di immobili abitativi intestati a società . Cass. 34474/2019 (citata più avanti per le spese di lusso) tocca anche il tema dell’arredo di lusso in uffici privati, affermando che se tali beni non sono effettivamente destinati all’attività (ad es. quadri tenuti nell’ufficio personale non aperto al pubblico) sono anch’essi non inerenti . In pratica, l’onere di dimostrare che l’immobile serve davvero all’impresa è molto rigoroso.
3. Beni di lusso e asset “voluttuari” intestati all’azienda (yacht, aerei, opere d’arte, etc.)
Tra le spese più delicate in termini di inerenza vi sono quelle relative a beni di lusso acquistati o intestati alla società. Parliamo di oggetti come imbarcazioni da diporto (yacht), aeromobili da turismo (jet privati, elicotteri), auto di grossa cilindrata di rappresentanza, opere d’arte, gioielli, beni da collezione e simili. Questi beni, per loro natura, hanno un’elevata attrattiva personale e spesso risultano estranei all’attività economica tipica, a meno che l’impresa operi proprio in quei settori (noleggio yacht, servizi aerei, gallerie d’arte, ecc.).
Disciplina IVA e imposte dirette: Dal lato IVA, come abbiamo visto: – L’IVA su yacht e aeromobili privati è indetraibile, salvo il caso in cui tali mezzi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (es. società di locazione barche, scuola di volo). Inoltre, per i professionisti l’IVA su aeromobili e barche è sempre esclusa (dato che difficilmente un libero professionista può avere come attività propria il possesso di un jet). Quindi se una società non di settore compra uno yacht, non ha diritto ad alcuna detrazione IVA sulle spese d’acquisto e di gestione ad esso relative; di conseguenza, se invece detrae indebitamente l’IVA (magari presentando fatture di leasing nautico come costo aziendale), l’Erario contesterà l’indebita detrazione al 100%. – Per gli autoveicoli di lusso, rientrano pur sempre nella disciplina generale veicoli: l’IVA è al 40% se non esclusivamente strumentali. Un’auto di lusso (es. supercar) per un’azienda non del settore, di fatto, anche se formalmente può detrarre il 40%, attira l’attenzione come possibile bene non inerente se non c’è una spiegazione coerente (ad es. utilizzo per rappresentanza con clienti top, ecc.). Spesso in controlli su piccole società che acquistano auto sportive, si disconoscono i costi per difetto di inerenza (sostenendo che l’auto era per il godimento personale del titolare). – Opere d’arte, arredi di pregio, gioielli, ecc.: L’IVA su questi beni di norma segue le regole ordinarie (non c’è un divieto di detrazione in 19-bis1 tranne che rientrino in spese di rappresentanza). Se l’opera d’arte è acquistata da una galleria (attività propria) l’IVA è detraibile. Se la compra una società qualsiasi per abbellire l’ufficio, bisogna valutare: potrebbe configurare spesa di rappresentanza (se l’ufficio è frequentato da clienti, l’opera serve all’immagine) e in tal caso purtroppo l’IVA non sarebbe detraibile per la lettera h) (a meno che costi meno di €50, evento raro). Se invece si sostiene che è un investimento o arredo strumentale (ad esempio un quadro messo nella sala riunioni di una società di design per valorizzare l’ambiente di lavoro funzionale alle trattative), si può provare a difendere la detraibilità, ma la linea di confine è sottile. La Cassazione ha affermato che spese per arredi di lusso sono deducibili solo se funzionali a impressionare clienti (quindi spese di rappresentanza) e comunque nei limiti normativi , implicando che oltre tali limiti non c’è riconoscimento fiscale.
Contestazione e rischi: Se un’azienda acquista beni vistosamente non correlati alla propria attività (esempio classico: la società Alfa Srl, che produce software, compra un yacht di 15 metri intestato all’azienda), il Fisco presume fortemente la non inerenza. Gli sviluppi possibili:
- IVA indetraibile: verrà contestata ogni detrazione IVA operata su acquisto, leasing, carburante, ormeggio, manutenzione dello yacht, in quanto il bene è ritenuto estraneo all’impresa (a meno di situazioni peculiari come che l’azienda abbia effettivamente noleggiato a terzi lo yacht con IVA sulle prestazioni). Un esempio concreto lo fornisce Cass. 4365/2023: una società aveva una barca utilizzata dal socio; la Cassazione ha confermato l’indetraibilità dei relativi costi per difetto di inerenza . Addirittura, come accennato, la Corte ha sostenuto che anche gli eventuali ricavi da noleggio percepiti (forse marginali o fittizi) dovevano essere esclusi dal reddito d’impresa, coerentemente col fatto che quel bene in realtà non apparteneva alla sfera imprenditoriale . Questo mostra la linea dura: l’uso personale mascherato da attività di noleggio sporadico viene smascherato e colpisce sia i costi (non deducibili, IVA indetraibile) sia i ricavi (non considerati veramente d’impresa, con potenziali riflessi anche sull’IVA eventualmente addebitata).
- Sanzioni amministrative e penali: In casi eclatanti, l’uso di beni aziendali per fini personali può essere visto come abuso o addirittura frode fiscale. Pensiamo a società di comodo create solo per intestare beni ai soci e scaricarne i costi: se si usano fatture false o sovrafatturazioni, si può configurare reato di dichiarazione fraudolenta. Anche senza reato, le sanzioni tributarie sono pesanti: tipicamente 90% dell’IVA non versata (detratta indebitamente) come sanzione base per infedele dichiarazione , aumentabile se superate certe soglie. Per di più, i beni di lusso attirano controlli incrociati (es. verifica redditometrica sul socio utilizzatore, segnalazioni di spese incompatibili, ecc.). Nel caso dello yacht, inoltre, rientra la disciplina beni ai soci: se il socio lo usa gratis, costi indeducibili a priori per la società e tassazione in capo al socio (oltre atti dovuti per omessa comunicazione del bene a soci, sanzionabile). Il rischio penale concreto sorge se i costi sono molto elevati: per reato di dichiarazione infedele serve imposta evasa > €150.000 , soglia raggiungibile se ad esempio si è detratta IVA su un aereo da milioni di euro. In molti casi di inerenza, comunque, manca il dolo fraudolento (il contribuente magari pensava, pur erroneamente, di poter dedurre/detrarre): si resta nell’ambito amministrativo .
- Difesa quasi impossibile se fuori settore: Se il contribuente non riesce a dimostrare un impiego imprenditoriale concreto, la difesa nel merito è debole. Ad esempio, un’azienda non del settore nautico che possiede uno yacht per “immagine” ha pochi appigli: non è come un’auto di rappresentanza che almeno può essere utilizzata per incontri con clienti. Uno yacht tipicamente è assimilato a divertimento personale del titolare. La Cassazione (sent. n. 9560/2014) aveva già negato deducibilità dei costi di uno yacht usato privatamente, definendolo palesemente non inerente . Analogamente per aerei da turismo: ci sono stati casi di società con elicottero aziendale usato per spostamenti personali o hobby, tutti finiti con conferma della ripresa fiscale (spesso questi beni vengono considerati “di prestigio” e non giustificabili in aziende estranee al settore) .
Possibili giustificazioni e strategie preventive: L’unico scenario in cui beni del genere possono passare il vaglio fiscale è se l’azienda riesce a monetizzarli o impiegarli nell’attività. Ad esempio: – Lo yacht viene effettivamente noleggiato a terzi con contratti reali e con IVA sulle prestazioni (rendendo detraibile l’IVA sui costi proporzionalmente); oppure viene usato per eventi aziendali di marketing documentati (meeting con clienti top a bordo, sponsorizzazioni in regata). Attenzione: anche in tal caso, lo scopo di rappresentanza rende l’IVA sui costi di esercizio in linea di principio indetraibile (per la norma sulla rappresentanza), a meno di riuscire a qualificarli come spese pubblicitarie (difficile se non c’è un corrispettivo o un ritorno specifico). – L’aereo aziendale viene usato per spostare squadre di tecnici su cantieri lontani, o comunque per esigenze logistiche documentate dell’impresa: se si prova questo, l’acquisto potrebbe considerarsi strumentale (ma è raro, e comunque il costo va comparato: se un volo di linea sarebbe costato 1/10, l’antieconomicità estrema potrebbe suggerire che l’acquisto del jet aveva altre finalità). – Per opere d’arte: tenerle in spazi aperti al pubblico, inserirle in una strategia di marketing (es. mostra aziendale permanente), in modo da poter dire che servono a migliorare l’esperienza dei clienti e l’immagine, entro limiti ragionevoli. Anche qui però l’IVA rimane non detraibile se classificate come rappresentanza. Una via può essere sostenere che l’opera è un investimento: alcune società comprano arte sperando che si rivaluti. In tal caso, se l’opera non è esposta per finalità di business ma tenuta in cassaforte, è ancora peggio (non inerenza totale). Se invece viene esposta e poi venduta, la società di fatto fa commercio d’arte (anche se occasionale), quindi quell’IVA forse sarebbe detraibile come costo di un bene destinato alla rivendita imponibile. Tuttavia, l’Agenzia tende a guardare l’oggetto sociale: se non c’è il commercio d’arte, tratterà la vendita come operazione occasionale e potrebbe negare comunque la detrazione iniziale se la vendita non era pianificata dall’inizio.
Riferimenti: Art. 19-bis1 lett. a) e b) (aeromobili e imbarcazioni, Tabella B beni di lusso); Cass. 4365/2023 (costi barca non inerenti, principi correlati) ; Cass. 9560/2014 (precedente su yacht privato, no deducibilità) ; Cass. 34474/2019 (opere d’arte/arredi di lusso deducibili solo se effettivamente di rappresentanza e rispettati limiti) . Giurisprudenza di merito: varie sentenze CTR hanno negato deduzioni su elicotteri aziendali (non di linea) ritenuti estranei all’attività .
Nota: In tutti i casi di beni di lusso, se si tratta di soci o familiari ad utilizzarli per diletto, la prima linea di difesa del Fisco sarà applicare la normativa dei beni ai soci (2012). Come già detto, quella prevede l’indeducibilità automatica e la tassazione di un fringe in capo all’utilizzatore, senza molte scappatoie . Dunque per difendersi occorre innanzitutto evitare di incappare in tale fattispecie: formalizzare contratti di noleggio/noleggio occasionale del bene a terzi o agli stessi soci a prezzi di mercato potrebbe mitigare il problema (es: la società possiede la barca ma la noleggia al socio facendogli pagare quanto pagherebbe una charter esterna – scenario comunque particolare). Se invece il bene è tenuto nascosto e usato privatamente, in caso di verifica la sconfitta del contribuente è quasi inevitabile . In simili contenziosi l’obiettivo realistico spesso diventa limitare il danno (ridurre le sanzioni, evitare il penale) più che far riconoscere l’inerenza.
4. Spese di rappresentanza, spese promozionali e di ospitalità (vitto, alloggio, eventi)
Le spese di rappresentanza costituiscono un’altra macro-categoria in cui il confine dell’inerenza è sfumato. Per definizione, le spese di rappresentanza sono quelle sostenute gratuitamente dall’impresa per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, allo scopo di creare benefici di immagine o ritorni economici generali (non immediatamente quantificabili) . Rientrano qui: omaggi a clienti o fornitori, feste e ricevimenti, sponsorizzazioni senza corrispettivo diretto, viaggi premio, mostre, convegni e seminari gratuiti, ecc. Spesso queste spese includono prestazioni di vitto e alloggio (cene, catering, pernottamenti per ospiti) e altre forme di ospitalità.
Disciplina fiscale: Ai fini IVA, come evidenziato, l’IVA su spese di rappresentanza è indetraibile per espressa previsione (art. 19-bis1 lett. h) tranne che per beni di costo unitario fino a €50 . Ciò significa che, anche se tali spese hanno attinenza con l’attività (perché servono a mantenerne il prestigio o la clientela), il legislatore IVA le considera non detraibili a priori. Questa è una importante divergenza con le imposte dirette: per IRES/IRPEF, infatti, le spese di rappresentanza sono deducibili in misura limitata (1,5% dei ricavi o parametri simili, in base al volume di fatturato della società) se rispondono ai criteri di inerenza e congruità fissati dal DM 19/11/2008. Quindi, ad esempio, una cena natalizia con i clienti per €5.000 potrebbe essere dedotta nei limiti (se l’azienda ha adeguati ricavi), ma l’IVA su quei €5.000 non è in alcun caso detraibile.
Spese di vitto e alloggio: Occorre distinguere due casi: – Spese di vitto/alloggio per trasferte del personale o amministratori: se servono per consentire lo svolgimento dell’attività (trasferta di lavoro), tali costi sono considerati inerenti all’attività. L’IVA su di essi, dopo il 2008, è divenuta detraibile secondo le regole generali, in quanto la limitazione oggettiva è stata soppressa . Quindi, se un dipendente va in missione e l’hotel fattura all’azienda, l’IVA dell’hotel è detraibile (sempreché la prestazione non sia esente; in Italia gli hotel applicano IVA 10% quindi c’è l’imposta). Discorso simile per i pasti in ristorante durante trasferte: il ristorante applica IVA 10%, l’azienda può detrarla se il costo è inerente (cioè se paga direttamente con fattura intestata a sé per il dipendente in viaggio). Nota: Spesso però, operativamente, le spese di vitto/alloggio di trasferta vengono rimborsate al dipendente, e in quel caso c’è una procedura diversa (il dipendente portava ricevute intestate a sé, con IVA che rimaneva “persa” per l’azienda). Dal 2017 è stato chiarito che se il dipendente ottiene fattura elettronica intestata all’azienda, si può detrarre l’IVA. Resta comunque il limite di deducibilità al 75% del costo + obbligo di tracciabilità dal 2020 (ma questi riguardano i redditi, non l’IVA). – Spese di vitto/alloggio per clienti, fornitori, altri ospiti: queste sono generalmente classificate come spese di rappresentanza (es. cena offerta al cliente potenziale, soggiorno pagato a un fornitore invitato a evento). Di conseguenza, l’IVA su tali spese non è detraibile (tranne casi marginali come coffee-break sotto 50€ per persona, che però comunque sarebbero servizi non beni). L’unico modo per detrarre l’IVA di un pranzo offerto sarebbe qualificarlo come spesa di pubblicità o simili, il che è arduo perché manca il corrispettivo. Una eccezione potrebbe essere: se l’azienda organizza un evento promozionale aperto al pubblico con catering, a cui ingressi sono gratuiti, formalmente è rappresentanza e niente detrazione IVA. Se invece quell’evento fosse a pagamento (biglietti venduti, anche simbolici), allora le spese diventerebbero costi per servizi venduti e l’IVA sarebbe detraibile. Questo per far capire che la gratuità è la linea divisoria: la presenza di corrispettivo trasforma l’evento in un’operazione imponibile (o collegata a operazioni imponibili) e legittima la detrazione, la gratuità lo relega nel regime di indetraibilità (salvo modico valore).
Contestazioni tipiche: Dato che la norma IVA già vieta la detrazione per la maggior parte di queste spese, le contestazioni riguardano piuttosto il caso in cui il contribuente abbia indebitamente detratto l’IVA su spese che in realtà erano di rappresentanza. Ad esempio, l’azienda riceve fattura per “sponsorizzazione evento con cena di gala” e detrae l’IVA pensando sia spesa di pubblicità; l’Agenzia può obiettare che quella era in realtà spesa di rappresentanza (nessun ritorno commerciale diretto misurabile, evento per generici PR) e quindi l’IVA andava esclusa . Oppure il contribuente detrae integralmente l’IVA su un acquisto che è solo parzialmente inerente all’attività imponibile: ad esempio acquista materiale che utilizzerà in parte per attività esenti (o per omaggi gratuiti) e invece di fare prorata, porta tutta l’IVA in detrazione. In questi casi l’Ufficio contesta la quota di IVA eccedente come detrazione indebita .
Altro profilo: le spese di rappresentanza “mascherate” da altri costi. A volte i contribuenti contabilizzano spese di rappresentanza sotto altre voci sperando di detrarre IVA: es. spese di vitto per clienti classificate come “spese di trasferte personale” o regali costosi registrati come “campionario” o “pubblicità”. Se in sede di controllo si scopre la reale natura, l’IVA detratta viene recuperata con sanzioni. Anche qui l’inerenza entra in gioco: la Cassazione ha chiarito che spetta al contribuente provare che spese anomale (es. sponsor ingente a una piccola associazione sportiva locale) erano funzionali all’impresa, altrimenti l’IVA diventa indetraibile perché spesa voluttuaria . Casi molto noti riguardano sponsorizzazioni sportive: l’Agenzia tende a considerare (oltre un certo importo in rapporto al fatturato) come rappresentanza e non pubblicità, negando costi e IVA; la difesa deve provare il ritorno commerciale (es. contratti acquisiti grazie a quello sponsor). La giurisprudenza è altalenante, ma di recente la Cassazione ha adottato parametri oggettivi: se c’è un contratto di sponsorizzazione con prestazioni misurabili (logo esposto, visibilità), in linea di principio è pubblicità (IVA detraibile), salvo sproporzione macroscopica (es. paghi 100k € per sponsorizzare una squadra dilettante di paese: lì l’antieconomicità è così evidente da far dubitare che fosse vera sponsorizzazione e non elargizione privata) .
Difese e accorgimenti: Per le spese di rappresentanza, la difesa migliore è prevenire la contestazione gestendole correttamente a monte. Consigli: – Rispettare i limiti e regole delle spese di rappresentanza (ai fini redditi): così dimostri buona fede. Ad esempio, se fai omaggi, non eccedere valori folli per singolo cliente; se organizzi eventi, predisponi un elenco di invitati qualificandoli come potenziali clienti, etc. Questo non autorizza la detrazione IVA, ma evita che ti contestino pure l’indeducibilità extra-limite nei redditi (problema aggiuntivo). – Valutare se qualificare alcune spese come pubblicità invece che rappresentanza, se sostenibile: ad esempio, regalare prodotti aziendali in occasione di fiere può essere considerato campione o promozione (IVA detraibile) invece che omaggio (IVA indetraibile) purché ci sia attinenza e avvenga in un contesto commerciale. Serve cautela e coerenza documentale. – Documentare lo scopo promozionale con evidenze: se hai speso 10.000 € in un evento, conserva brochure, foto, elenco contatti presi, qualunque cosa possa provare che serviva a generare affari. Questo può aiutare a convincere un giudice che magari quella spesa aveva natura di pubblicità (diritto a detrazione) e non pura rappresentanza. – Non confondere vitto/alloggio trasferte con rappresentanza: Assicurati che le fatture di vitto e alloggio per dipendenti in missione riportino sempre i nominativi e il riferimento alla trasferta di lavoro. Così l’Agenzia non potrà insinuare che erano spese per clienti. Per i pasti con clienti, idealmente separa i documenti (un conto per i tuoi dipendenti – detraibile se trasferta – e uno per gli ospiti – indetraibile). Questo livello di scrupolo evita commistioni pericolose.
Riferimenti: Art. 19-bis1 lett. h) DPR 633/72 (IVA e spese di rappresentanza) ; DM 19/11/2008 (definizione spese rappresentanza ai fini reddito). Cass. 33854/2022 già citata sull’inerenza qualitativa (anche spese elevate possibili se funzionali) mette in guardia che spese apparentemente personali vanno giustificate dettagliatamente o l’IVA diventa indetraibile . Cass. 18904/2018 (richiamata in Cass.12588/2025) ribadiva che l’inerenza non si misura sull’utilità immediata, per cui una spesa di rappresentanza potrebbe teoricamente essere inerente anche se non produce ricavi diretti, ma rimane la barriera normativa IVA che nega la detrazione comunque . In sostanza, le spese di rappresentanza sono un caso in cui l’inerenza c’è in senso lato (migliorano il posizionamento dell’azienda) ma la legge IVA decide di non riconoscerle per scelta di politica fiscale. Dunque la difesa su IVA è spesso persa in partenza se la spesa ricade pacificamente nella definizione di rappresentanza: l’unica via è provare a contestare che quella specifica spesa non fosse rappresentanza ma un costo diverso (pubblicità, costo di esercizio, ecc.).
5. Spese legali e oneri vari non strettamente legati all’attività produttiva
Non di rado, in sede di verifica l’Agenzia contesta la detrazione IVA su spese di natura particolare che, pur essendo sostenute dall’azienda, appaiono solo indirettamente connesse alla sua attività. Un esempio emblematico (balzato alle cronache per recenti sentenze) è quello delle spese legali sostenute da una società per difendere i propri amministratori o dipendenti in procedimenti penali o civili. Ci si chiede: l’IVA sull’onorario dell’avvocato per difendere l’amministratore accusato di un reato è detraibile? L’azienda normalmente paga queste spese perché una clausola statutaria o contrattuale prevede di tenere manlevato l’amministratore dai costi legali oppure perché comunque la vicenda giudiziaria, pur riguardando la persona, può avere riflessi sull’impresa. Tuttavia, dal punto di vista IVA, tali spese non riguardano la produzione di beni o servizi dell’azienda, bensì vicende personali (anche se professionali) di suoi esponenti.
Orientamento della Cassazione: La Suprema Corte, con una serie di pronunce nel 2023-2025, ha assunto una posizione molto chiara: l’IVA sulle spese legali per la difesa di amministratori/dipendenti in procedimenti personali è indetraibile, perché manca il nesso diretto con l’attività d’impresa. In particolare, la sentenza Cass. 17113/2025 ha sancito che serve una “relazione immediata e diretta” tra costo e attività d’impresa per detrarre l’IVA; le spese di difesa penale di un amministratore non soddisfano tale requisito in quanto derivano dall’azione di un terzo (l’Autorità giudiziaria) e attengono a presunte condotte personali del manager . La Corte ha respinto l’argomento della società secondo cui quelle spese erano nell’interesse aziendale (evitare danni all’immagine, ecc.), affermando che quello è un collegamento solo indiretto e non sufficiente ai fini IVA . In pratica, la difesa penale del dipendente non è un “costo di produzione” dell’attività economica, ma un costo conseguente a un fatto esterno (il reato ipotizzato). La Cassazione ha anche sottolineato che la nozione di inerenza IVA è più ristretta di quella valida per le imposte dirette . Infatti, in passato la Cassazione stessa, sul fronte reddituale, aveva talvolta ammesso la deducibilità di spese legali per amministratori se c’era interesse dell’azienda (specie se l’oggetto del processo riguardava atti compiuti nell’esercizio della funzione). Ma ai fini IVA la musica è diversa: conta il nesso con operazioni imponibili, e un procedimento penale non genera ricavi né è parte del ciclo d’affari, per cui l’IVA è fuori gioco. Questo orientamento era stato anticipato da pronunce del 2023 (Cass. 33884/2022 e ordinanze gemelle 17111 e 17112/2025) e risulta coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C-104/12 Becker, 2013), la quale in un caso tedesco analogo concluse che l’IVA sulle spese legali per difendere amministratori accusati di illeciti personali non è detraibile, perché le prestazioni dell’avvocato vanno considerate rese “al di fuori del contesto delle attività imponibili dell’impresa” . La Corte UE sottolineò come nemmeno il fatto che l’illecito abbia prodotto un fatturato per l’impresa (nell’esempio, reati commessi per far ottenere appalti alla società) importa: se il procedimento penale riguarda la responsabilità personale, manca il nesso oggettivo con l’attività della società e l’IVA resta a carico di quest’ultima . Inoltre, non rileva che per diritto civile l’azienda sia tenuta a rimborsare quelle spese all’amministratore: l’obbligo contrattuale interno non trasforma la natura del costo, che rimane estraneo all’attività economica dell’impresa .
Altre spese potenzialmente contestabili: Su un piano simile si collocano: – Sanzioni, multe e relative spese legali: l’IVA su sanzioni non esiste (non c’è fattura), ma se un’azienda paga una multa o contravvenzione per conto di un dirigente e poi cerca di dedurre il costo o detrarre IVA su spese correlate (es. parcella per fare ricorso contro la multa), incontrerà dinieghi per non inerenza. Il costo derivante da una violazione non è inerente all’attività (anzi, per i redditi è indeducibile ex art. 14, c.4, L.537/93). – Spese per liti tra soci, cause personali dei soci: se la società paga avvocati per controversie tra soci, o per questioni successorie dei soci, ecc., è chiaramente fuori dallo scopo sociale e l’IVA non è detraibile (oltre a poter configurare distrazione di risorse). – Spese per cause non attinenti all’attività produttiva: ad esempio, spese legali per difendere la società in una causa non commerciale (es. una lite relativa a un immobile privato del socio, ma intestata impropriamente alla società). Se l’oggetto della causa non riguarda la produzione di reddito, la detrazione è a rischio. – Oneri finanziari anomali: se una società fa investimenti finanziari estranei alla sua attività e sostiene costi (consulenze finanziarie, parcelle notarili per patrimoni dei soci, ecc.), l’IVA su tali costi può essere negata perché quell’attività è fuori dallo scopo tipico. Ad esempio, azienda manifatturiera che paga un advisory per strutturare un trust a favore della famiglia del titolare: quell’IVA non è inerente all’impresa (serviva interessi personali), quindi indetraibile.
Come difendersi in questi casi? Non è facile, poiché la giurisprudenza è netta. Alcune possibili linee difensive: – Dimostrare che la vicenda riguardava direttamente l’impresa: nel caso spese legali, se l’amministratore è stato perseguito per un fatto compiuto nell’esercizio delle sue funzioni a favore dell’azienda (es. reato ambientale per sversamenti dell’impianto), si potrebbe argomentare che la difesa mira anche a evitare danni economici all’impresa (multe, sequestri). Ci sono state sentenze di merito che in passato hanno riconosciuto la deducibilità in simili circostanze, considerando la spesa necessaria alla protezione del reddito di impresa. Tuttavia, post Cass.17113/2025, tale tesi regge poco per l’IVA: i giudici di legittimità chiedono comunque il nesso immediato con operazioni imponibili, non con generici benefici. – Invocare l’affidamento o l’errore scusabile se c’è incertezza interpretativa: fino a qualche anno fa, non c’era una giurisprudenza uniforme su queste spese. Una società che ha detratto IVA su parcelle legali negli anni 2015-2020 potrebbe sostenere di essersi basata su prassi possibilista. L’Agenzia però non aveva mai emanato documenti di prassi a favore della detraibilità (anzi, in risposte ad interpello ha spesso negato). Quindi l’affidamento è difficile da dimostrare. – Chiedere almeno la non applicazione di sanzioni per obiettiva incertezza: può essere una strada: data la novità delle pronunce, il contribuente potrebbe richiamare l’art. 6, co.2 D.Lgs.472/97 (non sanzionabilità se la violazione dipende da condizioni di incertezza normativa). Ad esempio, se la contestazione riguarda anni precedenti il 2025, si può dire che solo con sentenze di quella data la questione è stata chiarita definitivamente. Questo potrebbe convincere il giudice a eliminare la sanzione del 90% e lasciare solo il recupero dell’imposta e interessi. – Valutare coperture assicurative: come nota fuori dal processo fiscale, le aziende talvolta stipulano polizze D&O (directors & officers) che rimborsano le spese legali degli amministratori. In tali casi, l’IVA sulle parcelle potrebbe essere recuperata via assicurazione (se la polizza rimborsa anche l’IVA non detratta). È un modo per mitigare il costo nel caso il fisco la neghi.
Riferimenti: Cass. 17113/2025 (difesa penale amministratore, IVA indetraibile) ; Cass. 17111 e 17112/2025 (ordinanze gemelle, stesso principio); Cass. 33884/2022 e 33885/2022 (spese legali dipendenti e amministratori, indetraibilità); Corte di Giustizia UE causa C-104/12 (Becker, 2013) ; Risoluzione AE 9/E/2016 (spese di patrocinio legale per amministratori, non detraibili).
Tabella riepilogativa – Principali casi di beni/spese non inerenti e trattamento fiscale
Di seguito una tabella riepilogativa che sintetizza i più comuni casi di beni aziendali potenzialmente contestati come non inerenti, indicando il trattamento fiscale ordinario (se effettivamente inerenti) e gli scenari di contestazione con i relativi riferimenti normativi e giurisprudenziali:
| Tipo di bene/spesa | Trattamento fiscale ordinario (se inerente) | Possibili contestazioni (bene non inerente) | Norme e sentenze rilevanti |
|---|---|---|---|
| Autovettura aziendale ad uso promiscuo <br>(veicolo non esclusivamente strumentale) | IVA: Detraibile al 40% su acquisto e spese (carburante, manutenzioni). <br> Redditi: costi deducibili al 20% (IRES/IRPEF) entro limiti di valore (max €18k circa per auto); se assegnata come fringe benefit a dipendente: deducibile 70%. Per agenti di commercio: deducibilità costi 80% (IRPEF) e IVA detraibile 100%. | Rischio contestazione: se l’auto è usata quasi esclusivamente per fini privati (es. dall’amministratore) senza adeguata giustificazione aziendale. L’Ufficio può ritenere il bene estraneo all’impresa e disconoscere tutti i costi/IVA (oltre il 40%). Inoltre, se l’auto è concessa a socio senza corrispettivo di mercato, scatta la disciplina beni a soci: costi indeducibili integralmente ex lege e tassazione del beneficiario. In caso di verifiche, attenzione anche alle auto di lusso in piccole imprese: l’antieconomicità marcata (es. grossa cilindrata usata dal socio) può essere indizio di non inerenza. | Art. 19-bis1 co.1 lett. c) DPR 633/72: IVA detraibile 40% per veicoli non esclusivi . <br> Art. 164 TUIR: limiti 20% deducibilità costi auto. <br> DL 138/2011 art.2 c.36-quinquies: beni a soci (costi indeducibili se uso personale senza prezzo di mercato) . <br> Cass. 33854/2022: onere contribuente provare inerenza concreta; spese personali mascherate indetraibili . <br> Cass. 4365/2023: barca (analogia con auto) usata dal socio – costi indeducibili, ricavi da escludere dal reddito d’impresa (principio di correlazione) . |
| Immobile abitativo intestato alla società (non strumentale) | IVA: indetraibile sull’acquisto e gestione (salvo società di costruzioni/immo. in casi particolari). <br> Redditi: se classificato “immobile patrimonio”, reddito imponibile calcolato su base catastale (rendita o canone ridotto forfetariamente del 15%) e tutti i costi non deducibili (ammortamenti, manutenzioni, spese varie) ex art. 90 TUIR . Unica eccezione: interessi passivi su mutuo acquisto deducibili (non considerati “costi relativi” ai sensi art.90). | Se l’immobile è di fatto utilizzato come abitazione personale di socio/amministratore: oltre al normale regime di indeducibilità costi (art.90), i controlli contestano l’uso extracontabile. Può scattare l’applicazione di “beni ad uso soci”: se l’utilizzo è personale senza canone di mercato, il socio andrà tassato su un beneficio in natura e la società perde qualsiasi deduzione (comunque già negata da art.90). <br> Difese possibili: provare che l’immobile è realmente strumentale (es. ufficio con tanto di destinazione d’uso commerciale) oppure che c’è un regolare canone di locazione pagato dall’utilizzatore a valore di mercato (evitando così la sanzione beni soci, pur rimanendo i costi indeducibili per legge). | Art. 90 TUIR: immobili patrimonio, indeducibilità costi (tranne interessi passivi) . <br> Art. 19-bis1 lett. i) DPR 633/72: IVA indetraibile per immobili abitativi (salvo imprese costruzione) . <br> Cass. 7369/2012: conferma indeducibilità costi immobili abitativi non strumentali (principio generale) . <br> Circolare 47/E 2008: chiarimenti art.90 TUIR (interessi mutuo deducibili, resto no) . <br> Norma beni ai soci (2011): applicabile se uso personale senza canone di mercato, con obbligo comunicazione al Fisco e indeducibilità automatica costi . |
| Imbarcazione da diporto (yacht, barca vela) intestata all’azienda | IVA: Detraibile solo se il bene è effettivamente utilizzato nell’attività commerciale dell’impresa (es. società di noleggio nautico, charter, scuola vela con operazioni imponibili). In caso di utilizzo promiscuo (anche per attività esenti o fuori campo), l’IVA non è detraibile per la quota non riferita ad operazioni imponibili (in pratica serve prorata). <br> Redditi: costi deducibili solo se inerenti l’attività (core business nautico); altrimenti indeducibili. | Alta probabilità di contestazione se l’utilizzo è personale (socio/amministratore) o comunque extra-attività. L’Agenzia considera il bene estraneo all’impresa e disconosce: l’IVA detratta (integralmente, perché non spettante ex art. 19-bis1 lett. b se non oggetto attività) e i costi ai fini redditi. Possibile accusa di evasione/elusione (uso privato mascherato da costi aziendali); sanzioni amministrative elevate e, se provata frode (es. fatture false o contratti fittizi di noleggio), anche rischi penali per dichiarazione fraudolenta. Inoltre, in caso di utilizzo privato gratuito, si applica la norma beni ai soci (comunicazione omessa, tassazione in capo all’utilizzatore e costi indeducibili ex lege). <br> Nota: Spesso si cerca di “coprire” l’uso personale con contratti di noleggio fittizi o con l’iscrizione del mezzo a noleggio occasionale: se tali accorgimenti non reggono alla verifica, la contestazione sarà severa. | Cass. 4365/2023: barca usata dal socio – costi indeducibili per difetto di inerenza; correlativamente, ricavi da noleggio da escludere dal reddito d’impresa (principio di simmetria) . <br> Art. 2 DL 138/2011: beni a soci (in uso personale senza corrispettivo => costi indeducibili per legge, tassazione beneficio). <br> Cass. 9560/2014: precedente – no deducibilità costi yacht ad uso privato (bene non inerente, conferma linea dura) . |
| Aeromobile da turismo (aereo privato, elicottero leggero) intestato a società | IVA: come per la barca: detraibile solo se l’aeromobile è strumentale all’attività (es. società di lavoro aereo, servizi di volo commerciali imponibili). Per altri soggetti, l’IVA su acquisto e gestione è in genere indetraibile (art. 19-bis1 lett. a preclude detrazione salvo oggetto attività; per professionisti sempre esclusa). <br> Redditi: costi deducibili solo se inerenti (es. società operante in ambito trasporto aereo privato); altrimenti non deducibili. | Contestazione tipica: utilizzo personale (voli privati di soci/amministratori). L’Agenzia può riqualificare i costi come extracontabili (benefici privati). Se l’aereo/elicottero è usato a scopo dilettantistico o per comodità del titolare, difesa difficilissima: beni di tale genere, in aziende non di settore, non trovano giustificazione economica. Anche qui si applica la disciplina beni a soci se l’uso non è remunerato. <br> Prevenzione: predisporre contratti di noleggio a terzi o dimostrare un impiego imprenditoriale (es. voli per clienti paganti, trasporto tecnico tra sedi) è l’unica via per tentare di rivendicare inerenza. In caso contrario, i costi verranno disconosciuti e l’IVA richiesta a rimborso. | Giurisprudenza di merito: numerosi casi di società con elicottero “di lusso” contestati come costi indeducibili (non inerenti) se l’attività aziendale non lo giustifica . <br> Normativa ENAC e Codice della Navigazione: un’impresa non del settore non può registrare un aeromobile per fini commerciali se poi lo usa per fini privati – eventuali discrepanze documentali possono aggravare la posizione (ma qui entriamo nel merito extrafiscale). In sostanza la linea è: aereo privato in azienda fuori dal settore = spesa non inerente. |
| Altri beni “di prestigio” (opere d’arte, gioielli, quote circoli esclusivi, arredi di lusso per ufficio privato, ecc.) | IVA: detraibile solo se il bene serve effettivamente all’attività e non è spesa di rappresentanza. Ad es., un’opera d’arte esposta nei locali sociali aperti al pubblico può essere considerata arredo funzionale all’immagine aziendale e potenzialmente configurare spesa di rappresentanza deducibile entro limiti (per i redditi) ma IVA non detraibile per definizione (se rappresentanza). Piccoli beni (quadretti, oggettistica <€50) – IVA detraibile perché rientrano nell’esenzione soglia dei regali. <br> Redditi: spese di rappresentanza deducibili entro limite (1.5% ricavi annui, art.108 TUIR). Se il bene invece è considerato investimento o bene strumentale (raro per arte), si potrebbe dedurre ammortamento (ma solo se dimostrabile utilità produttiva). | Contestazione tipica: l’opera o il bene è acquistato in realtà per soddisfazione/abbellimento personale dell’amministratore (es. quadro appeso nell’ufficio privato o a casa del socio) e non per scopi legati al business. In tal caso il Fisco considera la spesa non inerente. In sede di verifica, l’onere è sul contribuente: deve provare che il bene è usato nell’attività (es. quadro collocato nella sala riunioni frequentata da clienti, migliorando l’immagine aziendale in incontri d’affari). Se tale dimostrazione non è convincente, i costi saranno ripresi a tassazione e l’IVA detratta verrà recuperata. Anche quote di circoli sportivi o club vip intestate a società vengono contestate se usate da amministratori: di solito considerate utilità personali non inerenti. | Art. 108 TUIR: spese di rappresentanza deducibili entro limite (5‰ ricavi annui per imprese >50mln, 1.5% per PMI, etc.). <br> Principio generale inerenza: se il bene non è collegato all’attività, costi non deducibili (né IVA detraibile). <br> Cass. 34474/2019: spese per arredi di lusso deducibili solo se effettivamente funzionali a impressionare clienti (qualificabili rappresentanza) e comunque nei limiti normativi . Se l’utilizzo è personale (es. arredi per l’ufficio del presidente non accessibile a terzi), allora non c’è inerenza. <br> Cass. 450/2018: (richiamata da Cass.12588/2025) ha ribadito che l’inerenza è qualitativa e non richiede utilità immediata; ma ciò non salva spese prive di qualsiasi attinenza: un bene di lusso senza funzione aziendale resta non inerente . |
Legenda: IRES/IRPEF si riferisce alla deducibilità dalle imposte sul reddito d’impresa (società o ditta individuale), IVA alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto. “Bene a soci” indica la disciplina dei beni in godimento ai soci (uso personale di beni aziendali): scatta se un bene intestato alla società è goduto dal socio/familiare a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore al valore di mercato, con obbligo di comunicazione e penalizzazioni fiscali (introdotta dal 2012). Fringe benefit: concessione a dipendente con valorizzazione in busta paga (esente fino a una soglia), implica parziale deducibilità costi. Strumentale esclusivo: bene utilizzato solo nell’attività tipica (es. autocarro officina, immobile ufficio, computer per ufficio). Spesa di rappresentanza: vedi DM 19/11/2008 per definizione esatta, ma in sintesi, spesa gratuita volta a generare benefici di immagine o relazioni senza corrispettivo diretto.
Cosa fare in caso di accertamento: strategie difensive prima del contenzioso
Passiamo ora alla parte operativa: come difendersi se ci si trova di fronte a un avviso di accertamento che contesta IVA indetraibile (e presumibilmente anche costi indeducibili) per spese ritenute non inerenti. La difesa del contribuente si sviluppa tipicamente in due fasi: una fase pre-contenziosa (amministrativa) in cui è possibile interloquire con l’Ufficio o trovare soluzioni deflattive, e una eventuale fase contenziosa (giudiziale) davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria).
Appena ricevuto l’avviso di accertamento, è importante valutare tempestivamente le opzioni. In generale, dalla notifica dell’avviso decorrono 60 giorni per presentare ricorso al giudice tributario (art. 21, D.Lgs. 546/92) , a meno che intervengano sospensioni per strumenti deflattivi. Prima di andare in causa, dunque, ci sono alcuni strumenti da considerare:
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) – Consiste in una procedura di confronto con l’ufficio: il contribuente presenta un’istanza di adesione e ottiene la sospensione dei termini di ricorso per 90 giorni . In questo periodo, si instaura un contraddittorio con gli agenti accertatori per cercare un accordo transattivo. Vantaggi: se si raggiunge un accordo, si paga il dovuto con sanzioni ridotte a 1/3 del minimo ; si evita il contenzioso e si chiude la vicenda. L’adesione non implica ammissione di colpa, ma è un modo per negoziare la pretesa. Nel merito, durante l’adesione si può far valere la documentazione e le ragioni a favore della detrazione/deduzione, sperando di convincere l’Ufficio a rivedere (anche parzialmente) la sua posizione . Ad esempio, se l’accertamento disconosce €100k di costi e IVA correlata, si potrebbe ottenere che riconoscano almeno una parte (costo parzialmente inerente) o che riducano le sanzioni. Se l’ufficio percepisce che la questione è opinabile, talvolta propone un compromesso: mantenere l’imponibile contestato ma ridurre la sanzione . Quando usare l’adesione? Se la posizione del contribuente è debole (poche prove di inerenza) e c’è margine di trattativa per limitare i danni (ridurre sanzioni, frazionare il debito), l’adesione è utile. Viceversa, se si ritiene di avere solide ragioni per vincere in giudizio, l’adesione potrebbe portare a concedere terreno inutilmente. Importante: l’istanza va presentata prima della scadenza dei 60 giorni di ricorso, per ottenere la sospensione termini . Se non si trova accordo, si potrà comunque ricorrere successivamente (entro il termine prorogato).
- Acquiescenza parziale o definizione agevolata delle sanzioni – L’acquiescenza (art.15 D.Lgs. 218/97) è il pagamento spontaneo delle somme dovute entro 60 giorni, che dà diritto a sanzioni ridotte a 1/3 e chiusura della vicenda . È però totale: non si può fare acquiescenza parziale sull’imponibile, a meno che l’atto preveda più rilievi separati (allora si può aderire solo ad alcuni). Se il contribuente ritiene di non avere chance o non voler contestare, questa è una via per risparmiare sulle sanzioni. C’è anche la possibilità di definire solo le sanzioni (art.17, c.2 D.Lgs. 472/97) pagando 1/3 della sanzione entro 60 giorni, e comunque impugnare l’atto sul merito . Quest’ultima opzione è utile in casi dubbi: il contribuente, per cautela, versa un terzo della sanzione – così se poi perde in giudizio non dovrà pagare il resto – e intanto fa ricorso per farsi annullare l’imposta contestata . Se poi vince sul merito (gli tolgono l’imposta), non gli verrà restituito quel terzo di sanzione versata: è il prezzo della tranquillità. L’acquiescenza totale preclude qualsiasi ricorso successivo (chiude tutto) , mentre la definizione agevolata delle sole sanzioni lascia aperta la causa sul merito. Queste vie vanno ponderate attentamente con consulenti: in genere si usano se l’accertamento è fondato e si vuole solo limitare la penalità, oppure se l’interpretazione è incerta ma non si vuole rischiare sanzioni piene. Nel contesto “inerenza”, spesso i contribuenti convinti di avere ragione preferiscono ricorrere; quelli colti in fallo palese preferiscono definire per tagliare le sanzioni.
- Istanza di autotutela – È una richiesta all’ufficio di annullare o correggere d’ufficio l’accertamento, presentando le proprie ragioni (non c’è un termine fisso, può essere fatta anche oltre i 60 giorni, ma conviene farla subito). L’autotutela è discrezionale per l’Amministrazione, e non sospende né termini né pagamenti . In casi di inerenza – questione di merito e valutazione – è raro che l’Agenzia accolga l’autotutela, a meno di errori palesi nell’atto (scambio di contribuente, duplicazione, calcoli manifestamente errati) . Tuttavia, presentare un’istanza ben argomentata può avere un’utilità: se non altro, crea un documento che, in sede di giudizio, dimostra la buona fede e la collaborazione del contribuente (es. “ho già spiegato all’ufficio, ma non mi hanno ascoltato”) . Non bisogna però fare affidamento sull’autotutela come soluzione: è più che altro un colpo in extremis se emergono elementi nuovi clamorosi o se l’ufficio è disponibile a rivedere (evento raro su questioni interpretative come l’inerenza).
Un punto procedurale importante: fino al 2023, per le controversie di valore ≤ €50.000 era obbligatorio presentare il reclamo/mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92) prima di accedere al giudice. Questa procedura prevedeva l’invio del ricorso che valeva anche come reclamo all’ufficio, con possibilità di mediazione (sanzioni ridotte al 35% in caso di accordo). Dal 2024 tale obbligo è stato abrogato dalla riforma della giustizia tributaria (D.Lgs. 130/2022 attuato da D.Lgs. 209/2022 e D.Lgs. 220/2023) . Dunque, per avvisi notificati dal 1° gennaio 2024, il contribuente – anche per importi piccoli – può ricorrere direttamente al giudice senza dover presentare reclamo . Resta comunque possibile una mediazione successiva volontaria tra le parti, attraverso l’istituto della conciliazione giudiziale (che vedremo più avanti). In questa guida useremo il termine generale “ricorso” per indicare l’atto introduttivo del giudizio tributario, dato che ormai coincide col primo e unico passaggio (per le nuove liti) . Se però avete ricevuto un avviso entro il 2023, potreste dover fare i conti col vecchio reclamo obbligatorio (in tal caso, attenzione a rispettare quella procedura specifica).
Riassumendo, nel periodo pre-contenzioso le mosse consigliate per il contribuente sono: analizzare a fondo l’accertamento, con l’aiuto di un esperto, per valutare la solidità della contestazione e delle proprie controdeduzioni; raccogliere subito la documentazione utile (contratti, fatture, email, delibere, foto, registri interni che provano l’uso dei beni, ecc.); decidere se tentare un’adesione (sospendendo i termini) o andare direttamente in ricorso; se opportuno, versare il 1/3 sanzioni per sicurezza. In ogni caso, preparare già una bozza di memoria difensiva da inviare eventualmente all’ufficio (in adesione o allegata al reclamo/ricorso) in cui articolare le proprie ragioni con riferimenti normativi e giurisprudenziali. Questo mette pressione all’ufficio, mostrando che il contribuente è determinato e con argomenti. Importante: controllare sempre la motIVAzIone dell’atto – se è carente o contraddittoria, può essere un motivo di ricorso formale (vizio proprio dell’atto).
Nei paragrafi seguenti passeremo al contenzioso tributario, ossia cosa fare nel ricorso e in giudizio per difendere la detrazione IVA (e la deducibilità dei costi) relativi a spese contestate come non inerenti.
Difendersi in sede di contenzioso tributario
Se non si è trovato un accordo con l’Ufficio o se si ritiene l’accertamento infondato, occorre prepararsi ad affrontare il giudizio tributario davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione dal 2023 delle Commissioni Tributarie Provinciali). Vediamo le strategie difensive principali e come impostare il ricorso.
A) La redazione del ricorso e gli elementi da contestare
Nel ricorso introduttivo (che, ricordiamo, va notificato all’ente impositore entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, salvo sospensioni) bisogna articolare in modo chiaro sia i motivi di diritto sia i fatti a supporto della propria posizione. Nel caso di contestazione di inerenza/IVA indetraibile, i possibili motivi di ricorso includono:
- Errata applicazione della norma tributaria (motivo di merito): Si sostiene che l’Ufficio ha sbagliato nel ritenere la spesa non inerente. Ad esempio, si può argomentare che l’art. 19 DPR 633/72 in realtà consentiva la detrazione in quel caso perché il bene/servizio era destinato ad operazioni imponibili, quindi l’IVA era detraibile. Oppure che la spesa non rientrava tra quelle oggettivamente escluse (19-bis1) e presentava un nesso con l’attività. In pratica, si contrasta l’interpretazione data dal Fisco della nozione di inerenza, citando magari giurisprudenza a favore: es. Cassazione che riconosce inerenza qualitativa anche senza utilità immediata , o sentenze che in casi analoghi hanno dato ragione al contribuente. Se ci sono precedenti di merito (commissioni tributarie) sullo stesso tipo di spesa, vanno menzionati. Ad esempio, per spese di sponsorizzazione sportive, esistono pronunce che le considerano pubblicità (IVA detraibile) se proporzionate; citarle può convincere il giudice.
- Vizio di motivazione dell’accertamento (motivo formale): Se l’avviso di accertamento non spiega adeguatamente perché una spesa sarebbe non inerente, si può eccepire la violazione dell’art. 7 L.212/2000 e art. 3 L.241/90 (obbligo di motivazione). Ad esempio: l’atto si limita a dire “costi non inerenti per €XXX” senza indicare quali costi nello specifico e perché; oppure copia passaggi standard senza considerare la documentazione fornita. Una motivazione così generica può rendere l’atto annullabile . La Cassazione ha richiesto che l’Ufficio espliciti il suo ragionamento, altrimenti il contribuente è leso nel diritto di difesa . Questo motivo va sempre valutato: anche solo come pressione, inserire un vizio formale può indurre l’Ufficio a maggiore cautela.
- Errori di fatto o di calcolo: Controllare se l’ufficio ha commesso errori materiali (somme sbagliate, doppia inclusione di una spesa già ripresa altrove, ecc.). Può capitare, ad esempio, che l’Agenzia sommi costi già indeducibili per altra norma e li riprenda due volte (inerenza + altra ripresa). Far emergere tali errori può portare all’annullamento parziale.
- Prescrizione/decadenza: Se l’anno accertato è “vecchio” verificare che l’avviso sia stato notificato nei termini (31/12 del quinto anno successivo, o quarto se dichiarazione presentata, salvo proroghe Covid). Anche questo è un motivo formale da sollevare se c’è spazio.
- Violazione del principio di capacità contributiva / illogicità manifesta: argomento più teorico, ma in alcuni ricorsi si eccepisce che disconoscere un costo inerente (a parere del contribuente) viola l’art.53 Cost. perché tassa un reddito inesistente o simula un’IVA indebitamente. Onestamente raramente colgono, ma si può inserire come “colore”.
Nella parte fattuale del ricorso, bisogna raccontare la vicenda in modo convincente, allegando prove. Ad esempio: “Nel 2024 la società ha acquistato un’auto BMW serie 5, usata prevalentemente dal direttore vendite per recarsi presso clienti in tutto il territorio nazionale. Si allega estratto del registro di utilizzo del veicolo da cui risulta che su 12.000 km percorsi nel 2024, almeno 8.500 km erano per trasferte commerciali (destinazioni e date specificate). Nonostante ciò, l’Ufficio ha ritenuto non inerente l’auto in quanto utilizzata anche dal direttore per scopi personali. In realtà l’utilizzo privato è stato limitato a poche occasioni (fine settimana sporadici, peraltro già oggetto di fringe benefit tassato in busta paga).” E così via. Specificità e dettaglio aiutano a mostrare al giudice che l’azienda aveva un metodo e uno scopo lecito nell’uso del bene.
Importante è allegare documenti: se esiste un verbale CdA che autorizzava l’acquisto per specifiche ragioni aziendali, allegarlo; se c’è un contratto di assegnazione del bene, allegarlo; se ci sono foto (es. bene esposto in fiera), possono essere allegate (moderare la quantità).
Si può anche allegare, se disponibile, un parere pro veritate di un esperto (es. un consulente fiscale esterno che prima dell’accertamento aveva attestato la deducibilità di quella spesa): questo per dimostrare la buona fede e l’interpretazione ragionevole tenuta. Non ha valore di prova di per sé, ma può influire sull’aspetto sanzioni (prova che il contribuente si era informato).
Inoltre, conviene chiedere espressamente, in sede di ricorso, l’applicazione dell’art. 6, c.5-bis D.Lgs. 472/97 (discrezionalità del giudice nelle sanzioni) per ottenere una riduzione delle sanzioni se ci sono elementi di buona fede. Si può far presente che i costi contestati erano regolarmente registrati, la documentazione esibita, non c’è frode, ma solo diversa valutazione sull’inerenza. Spesso i giudici, se confermano la ripresa, riducono la sanzione al minimo edittale o la annullano per buona fede.
B) Difesa nel merito: provare concretamente l’inerenza
Quando la disputa verte sull’inerenza, la chiave della difesa è dimostrare in modo convincente che la spesa contestata era funzionale all’attività . Ciò significa portare prove concrete che colleghino il costo all’impresa. Ecco alcune linee guida:
- Documentazione contemporanea e dettagliata: come già accennato, presentare tutti i documenti raccolti: fatture con descrizioni chiare (se la fattura era generica, meglio accompagnarla da contratti o DDT o altre carte che ne svelino la natura). Se, ad esempio, viene contestata l’IVA su una fattura di “consulenza”, bisogna far vedere quale consulenza fosse e a che progetto aziendale serviva. La Cassazione ha posto l’accento sulla necessità di dimostrare i “motivi economici e la destinazione produttiva” dell’acquisto . Quindi spiegare: “Questa spesa è stata sostenuta per il progetto X, che mirava a… e infatti grazie a tale spesa l’azienda ha potuto… (includere risultati se ci sono)”.
- Prove testimoniali o peritali: Nel processo tributario le testimonianze orali sono vietate, però si possono produrre dichiarazioni scritte rese da terzi (ad esempio una dichiarazione firmata dal dipendente che attesta l’uso aziendale dell’auto, oppure dal cliente che conferma che quell’evento di rappresentanza ha portato trattative commerciali). Il loro valore è valutabile dal giudice liberamente. Anche perizie o pareri tecnici possono essere prodotti: ad esempio, se è in discussione se un bene fosse strumentale, una perizia che attesta che quel macchinario era idoneo solo a quell’attività e non ad altro. Nel caso di auto e immobili, contano poco, ma magari per opere d’arte un esperto può certificare che l’opera è stata effettivamente esposta in azienda con finalità culturale aperta al pubblico (se vero).
- Registro e logbook: Per veicoli e simili, se avete tenuto registri di utilizzo (come consigliato tra le buone pratiche), presentateli . Un logbook con date, tragitti e motivo (cliente X visitato) è molto persuasivo . Anche un calendario aziendale con annotate riunioni esterne può servire.
- Dimostrare la coerenza economica: Se vi accusano di antieconomicità (spesa troppo alta rispetto all’utilità), citate la giurisprudenza che vi tutela: “l’antieconomicità in sé non legittima il Fisco a negare la deduzione; solo una sproporzione macroscopica può essere sintomo di non inerenza se rivela finalità estranee” . Quindi argomentate perché la spesa non era così incongrua: ad esempio, “è vero che l’auto acquistata è di alta gamma, ma ciò era giustificato dall’esigenza di rappresentanza con clienti di livello internazionale, e comunque l’azienda aveva la capacità economica di sostenerla”. Insomma, contestualizzare la spesa nell’economia aziendale.
- Nesso con i ricavi o attività a valle: Molto efficace è se potete collegare la spesa a ricavi generati. Esempio: sponsor sportivo contestato? Mostrare che nel periodo successivo avete acquisito 5 clienti grazie a quell’evento (magari con testimonianze o con fatto che quei clienti provenivano dall’ambiente sponsorizzato). Questo rende tangibile l’inerenza. Se non c’è ricavo immediato, puntate sul nesso potenziale: es. spesa in formazione dipendenti (non dà ricavo subito, ma migliora competenze per futuri servizi – inerente in prospettiva). Cassazione ammette inerenza anche per spese “in proiezione potenziale o futura” .
- Burden of proof reciproco: Sottolineare che voi avete fornito prove dell’inerenza, ora spetterebbe all’Ufficio, eventualmente, dimostrare il contrario se vuole insistere. Ad esempio, se portate registro, testimonianze e quant’altro, l’Ufficio non può limitarsi a dire “non vero”: dovrebbe controbattere con evidenze (tipo che l’auto era vista spesso in luoghi vacanzieri, ecc.). Se non l’ha fatto, il giudice può ritenere assolto l’onere probatorio dal contribuente e annullare l’atto.
Un’altra strategia è invocare la giurisprudenza unionale: ad esempio, citare cause CGUE dove è stato riconosciuto il diritto a detrazione in situazioni borderline. Ce ne sono: ad esempio C-98/98 Midland (detrazione anche per costi connessi a operazioni esenti future poi abortite, caso diverso però), oppure C-334/16 Volkswagen (parziale uso privato di auto aziendale non toglie detrazione sulla quota business). Nel nostro contesto, il case law UE è più spesso restrittivo (vedi il caso Becker 2013 sulle spese legali, sfavorevole al contribuente ). Ma se trovate una sentenza UE che vi aiuta, citatela perché il giudice tributario la deve osservare. Ad esempio, una utile potrebbe essere C-33/11 A Oy: la Corte disse che l’IVA su spese di rappresentanza (yacht per clienti) non era detraibile; ok non aiuta… Forse meglio puntare su pronunce nazionali.
C) Strategie argomentative speciali
Ci sono alcuni trucchi del mestiere che i difensori adottano in questi casi:
- Richiesta subordinata di eliminare ricavi correlati: Come accennato prima, nel ricorso si può formulare una domanda in subordine: “qualora il giudice ritenesse non inerenti i costi in oggetto, si chiede che, in applicazione del principio di correlazione, vengano correlativamente eliminati dal reddito imponibile i proventi eventualmente imputati connessi a detti costi (es. l’eventuale fatturato o benefit contestuale)”. Questo discende da Cass. 4365/2023: “Il bene estraneo all’attività comporta indeducibilità dei costi e al contempo esclusione dal reddito d’impresa dei corrispondenti componenti positivi derivanti da quel bene” . Quindi, se ad esempio l’azienda aveva dichiarato ricavi da un bene poi ritenuto estraneo (magari affitto pagato dal socio per quell’immobile), quei ricavi andrebbero tolti. Questo mette il giudice di fronte a un bivio equo: o riconosce i costi inerenti (allora bene, vinciamo) oppure, se li nega, dovrebbe togliere i ricavi. Difficilmente un giudice vorrà creare una situazione in cui i costi sono negati ma i ricavi tassati, perché sarebbe ingiusto (tassazione su attività che si dichiara extra impresa). Questa tattica può portare l’ufficio a essere più conciliante in mediazione, perché ha timore che in giudizio gli tolgano pure i ricavi. Nella pratica, se l’accertamento non aveva toccato i ricavi, il giudice potrebbe non avere elementi per toglierli; ma la richiesta resta sul tavolo e se convincete su questo, ottenete almeno uno sgravio parziale.
- Conciliazione giudiziale: Durante il processo (fino all’udienza) è sempre possibile tentare una conciliazione con l’Ufficio, anche dopo aver presentato ricorso. La conciliazione può essere totale o parziale. Se la questione è rischiosa per entrambi, una conciliazione può ridurre sanzioni al 40% e definire la lite . Ad esempio, se emergono nuove prove a vostro favore dopo il ricorso, l’Agenzia potrebbe proporre di lasciare cadere una parte della pretesa. Valutate con l’avvocato: talora i giudici apprezzano le conciliazioni perché riducono il contenzioso. Da notare: con la riforma 2023, in appello sarà possibile una conciliazione anche con sanzioni ridotte al 50%, quindi c’è spazio negoziale in ogni grado.
- Aspetti penali: se c’è un procedimento penale parallelo (ad es. per dichiarazione fraudolenta in caso di costi fittizi), la difesa tributaria va coordinata con quella penale. In genere, se si tratta di inerenza, difficilmente c’è reato salvo ipotesi di frode (costi fittizi al 100% o operazioni simulate). Se voi siete certi che i costi sono reali, sottolineatelo nel ricorso: “trattasi di spese reali, supportate da fatture autentiche, non contestate come false”. Questo distingue il caso dalla frode e, come detto, rende meno probabile il penale. Se invece c’è odore di fatture false e l’Agenzia lo ha evidenziato, allora il focus è un altro e l’inerenza diventa secondaria (perché costi fittizi non deducibili a prescindere). Insomma, capire bene se l’Agenzia contesta anche la veridicità oltre che l’inerenza (nel PVC a volte scrivono “spesa non documentata o non veritiera”): in tal caso bisogna difendersi provando che la spesa c’è stata davvero (contratti, pagamento, ecc.), prima ancora che sull’inerenza.
- Buona fede e cooperazione: evidenziate sempre nel ricorso la vostra condotta: avete mostrato i documenti ai verificatori, avete risposto ai questionari, etc. Questo per allontanare l’idea di occultamento. Chiedete al giudice di valutare, in caso di soccombenza, la non applicazione di sanzioni per buona fede o quantomeno l’applicazione del minimo edittale (spesso già fatto dall’ufficio se è 90%, ma se avessero messo aggravanti si può chiedere riduzione). Il D.Lgs. 472/97 consente al giudice di modulare la sanzione secondo gravità e elemento soggettivo: per mere questioni valutative di inerenza, si può chiedere la minima prevista (che per dichiarazione infedele è il 90%, spesso già applicato; se hanno messo 135% perché superava soglia 3% del reddito, potete chiedere 90% se dimostrate che non c’era volontà elusiva). In casi particolari, il giudice potrebbe persino disapplicare la sanzione per errore inevitabile: ad esempio, se c’era un contrasto giurisprudenziale forte sull’inerenza di quella spesa.
D) Esempi di difesa tratti da casi reali
Per comprendere meglio come tutti questi concetti si traducano nei documenti difensivi, presentiamo di seguito alcuni estratti simulati ispirati a casi reali:
- Esempio 1 – Ricorso (estratto) su auto aziendale contestata:
“[…] L’avviso impugnato è illegittimo in quanto l’Ufficio nega la detrazione IVA e la deducibilità dei costi relativi all’autovettura BMW targata XX000YY, assumendo apoditticamente che ‘trattasi di bene ad uso personale del socio, estraneo all’attività’. Al contrario, l’autovettura in oggetto presenta un chiaro nesso di inerenza con l’attività d’impresa: essa è stata assegnata al direttore commerciale (non socio) Sig. Alfa per le sue trasferte lavorative presso i clienti nell’area Nord-Est. Si allega registro delle trasferte 2024 dal quale risulta che il Sig. Alfa ha compiuto, a bordo dell’auto aziendale, n. 25 viaggi per complessivi km 7.860 al fine di visitare clienti o partecipare a fiere di settore (cfr. dettaglio in Allegato 4). Il valore promozionale di tali trasferte è dimostrato dall’incremento del fatturato nell’area (+15% rispetto all’anno precedente). L’uso privato del veicolo è stato limitato a percorsi residuali (stima: 15% del totale), per i quali peraltro la società ha addebitato un fringe benefit conforme al D.P.R. 917/86 art. 51. Pertanto, è del tutto errato qualificare il bene come ‘estraneo all’attività’: semmai si tratta di bene ad uso promiscuo, la cui inerenza prevalente è fuori discussione. Ai fini IVA, la Società ha già applicato il regime di detraibilità limitata al 40% ex art. 19-bis1 co.1 lett. c) DPR 633/72, come ammesso dallo stesso Ufficio (v. PVC, pag. 3). Non vi è alcuna base legale per ridurre ulteriormente la detrazione: la norma forfettaria del 40% prescinde dall’uso effettivo, e la Corte di Giustizia ha riconosciuto validità a tali percentuali forfetarie (causa C-228/05, Stradasfalti). L’ulteriore disconoscimento operato dall’Ufficio, che pretende di azzerare la detrazione, configura una duplice penalizzazione non prevista da alcuna disposizione – oltre a violare il principio di neutralità dell’IVA. Anche volendo scrutinare l’inerenza in concreto, essa sussiste ampiamente: come detto, il veicolo ha supportato l’attività di vendita, risultando un mezzo strumentale sia pure non esclusivo. La Cassazione insegna che “l’inerenza esprime una correlazione qualitativa tra costo e attività, indipendentemente dalla sua utilità economica immediata” (Cass. 18904/2018, in motivazione) . Nel caso di specie, la correlazione è evidente e documentata, mentre l’Ufficio non ha fornito alcuna prova di un utilizzo extraziendale esclusivo. Ne deriva che il recupero dell’IVA è infondato. Si chiede, in via principale, l’integrale annullamento dell’atto impugnato. In via subordinata, qualora ad avviso di codesta Corte la vettura dovesse considerarsi effettivamente non inerente, si chiede – in ossequio al principio affermato da Cass. 4365/2023 – l’eliminazione dal reddito d’impresa dei componenti positivi correlati, ossia del fringe benefit addebitato al dipendente per l’uso dell’auto (€ 3.000, già assoggettato a tassazione separata). […]”
- Esempio 2 – Memoria difensiva in appello su spese legali amministratore:
“[…] L’Ufficio, e ahinoi il primo giudice, hanno trascurato un punto nodale: le spese legali di € 20.000 per cui è causa sono state sostenute dalla società appellante nell’interesse proprio dell’impresa, e non meramente a vantaggio personale dell’amministratore. Il procedimento penale a carico del legale rappresentante, infatti, concerneva presunti illeciti fiscali commessi nell’esercizio della carica (omesso versamento IVA); l’esito favorevole dello stesso – con piena assoluzione – ha evitato gravi ripercussioni economiche e reputazionali sulla società (che sarebbe stata coinvolta quale responsabile civile). Non si tratta dunque di vicenda estranea all’attività: è una vicenda dell’attività, sia pure patologica. La Corte di Giustizia UE, in circostanze analoghe, ha riconosciuto che “se le prestazioni dell’avvocato possono considerarsi fornite nell’interesse tanto dell’amministratore imputato quanto della società, il diritto a detrazione dell’IVA va accordato pro quota” (causa C-104/12) . Nel caso di specie, l’interesse sociale nella difesa era preminente: la società ha deliberato il rimborso delle spese legali in forza dell’art. x dello Statuto, proprio per tutelare l’ente da ingiuste accuse relative alla sua gestione fiscale (cfr. delibera assembleare 01/2021, doc. 5). Pertanto, la tesi dell’Ufficio secondo cui mancherebbe un nesso di inerenza appare riduttiva e contraria alla realtà economica. La Cassazione invocata dal fisco (sent. 17113/2025) va letta nel contesto specifico in cui è stata resa: ivi si trattava di spese legali per difendere dipendenti da accuse di frode extra moenia (corruzione in affari privati), ben diverse dalla presente fattispecie dove la difesa verte su questioni fiscali aziendali. In ogni caso, quella pronuncia non costituisce jus superveniens e non può ribaltare la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sulle imposte dirette che riconosce la deducibilità di tali oneri se inerenti all’attività (Cass. 4777/2017; Cass. 9720/2018). Sarebbe illogico avere un costo inerente ai fini IRES ma non ai fini IVA, atteso che il concetto di inerenza – pur declinato diversamente – non può condurre a esiti schizofrenici. Si confida dunque che codesta On.le Corte vorrà riformare la sentenza di prime cure, ritenendo sussistente il diritto alla detrazione dell’IVA in contestazione, attesa la connessione sostanziale delle spese al’attività d’impresa della società appellante. […]”
(Osservazione: qui si è forzato un po’ citando CGUE a favore, mentre sappiamo che in Becker 2013 la Corte fu sfavorevole. Ma è un esempio di come un difensore potrebbe provare comunque a piegare la giurisprudenza UE a suo favore distinguendo i fatti.)
E) Esito del contenzioso e considerazioni finali
L’esito di un ricorso su questioni di inerenza può variare molto a seconda della qualità delle prove presentate e della sensibilità del collegio giudicante. In generale:
- Se il contribuente fornisce un quadro documentale chiaro e la spesa contestata è ragionevolmente collegabile all’attività, i giudici tributari spesso danno ragione al contribuente, annullando (in tutto o in parte) l’accertamento. Soprattutto per importi modesti o casi borderline, c’è una certa indulgenza: il principio del favor rei nei dubbi interpretativi può portare all’annullamento delle sanzioni anche se rimane la ripresa d’imposta.
- Se invece la spesa appare platealmente estranea (es. bene di lusso senza alcuna giustificazione), le chance di vittoria in giudizio sono scarse. Si può ottenere al massimo la riduzione sanzioni, o la non tassazione di eventuali ricavi correlati, ma difficilmente il giudice potrà affermare l’inerenza contro ogni evidenza. Ad esempio, cause su yacht/elicotteri di solito si concludono a favore del Fisco, essendo difficoltoso provare il contrario.
- Esistono anche soluzioni intermedie: la Commissione potrebbe riconoscere la detrazione parziale dell’IVA (ad es. concedendo un prorata in base a un uso stimato). Non sarebbe ortodosso giuridicamente (o è inerente o no), ma per equità a volte si è visto: tipo “riconosciamo il 50% del costo come inerente, quindi togliamo metà delle imposte evase”. Ciò accade soprattutto in conciliazione. Formalmente la Cassazione non lo ammetterebbe (o è nero o è bianco), ma a livello locale ogni tanto succede.
Va ricordato che dal 2023 le liti di valore fino a €3.000 sono decise in camera di consiglio monocratica, senza contraddittorio orale, mentre oltre c’è udienza collegiale con possibilità di discussione orale. Per questioni complesse come l’inerenza, la discussione può aiutare: è l’occasione per il difensore di ribadire i concetti chiave e rispondere a eventuali dubbi del giudice. Dunque, se ritenete importante l’udienza, potete chiedere esplicitamente nella nota di trattazione scritta (per cause introdotte dopo settembre 2023) di essere ascoltati in pubblica udienza.
Infine, una volta ottenuta la sentenza di primo grado, se favorevole può darsi che l’Agenzia faccia appello (ha interesse, specie se sono somme alte o principio importante). Viceversa, se il contribuente perde, valuterà l’appello: oggi l’appello è più rischioso per il contribuente perché in caso di soccombenza c’è il concreto rischio di condanna alle spese (introdotta dalla riforma, mentre prima raramente le CTR condannavano). Quindi, se si perde in primo grado su inerenza con motivazioni solide e prove deboli, forse è meglio tentare una conciliazione in appello riducendo sanzioni e chiudendo lì. Se invece si hanno buoni argomenti non considerati, si può confidare nel giudice di seconde cure, che dal 2023 è professionale (magistrato) e magari più preparato sui principi di diritto.
Domande frequenti (FAQ) su IVA indetraibile per spese non inerenti
D1: Cosa significa esattamente “bene non inerente” ai fini fiscali?
R: Si parla di bene non inerente (o spesa non inerente) per indicare un bene di proprietà dell’azienda (o un costo sostenuto dall’azienda) che non è effettivamente utilizzato nell’attività imprenditoriale o professionale. In altre parole, è un bene estraneo all’esercizio dell’impresa, spesso impiegato per finalità personali dei soci o dell’amministratore, e non per produrre i ricavi dell’impresa. Esempi tipici: un’auto aziendale usata dal socio principalmente per le vacanze; un appartamento intestato alla società ma adibito ad abitazione privata del socio; una barca di lusso acquistata dalla società ma non collegata all’attività (magari ormeggiata e usata dal socio). In tutti questi casi, il Fisco considera i relativi costi non inerenti e li recupera a tassazione, negando la deducibilità e la detrazione IVA . Significa, in sintesi, dire che “quel bene non c’entra nulla con l’impresa” e dunque non può influire sul reddito d’impresa tassabile (né in negativo con costi, né in positivo con eventuali ricavi) . Da notare: gli orientamenti più recenti della Cassazione sottolineano proprio quest’ultimo punto – se un bene è dichiarato estraneo, anche gli eventuali ricavi ad esso associati andrebbero esclusi dal reddito (principio di simmetria).
D2: Quali sanzioni si rischiano se il Fisco contesta IVA indetraibile per difetto di inerenza?
R: La contestazione di costi indeducibili e IVA indebitamente detratta configura di solito una dichiarazione infedele. In pratica, l’Ufficio rettifica il reddito imponibile (IRES/IRPEF, e se del caso IRAP) aumentando l’utile di quell’importo di costi esclusi, e rettifica la liquidazione IVA eliminando il credito detratto indebitamente. Le sanzioni conseguenti sono: – Sanzione amministrativa per dichiarazione infedele, pari al 90% della maggior imposta dovuta . Nel nostro caso, la maggior imposta comprende sia l’IRES (o IRPEF) sull’aumento di reddito, sia l’IVA da versare perché non detratta. Esempio: se vengono disconosciuti €50.000 di costi, l’IRES (al 24%) evasa è €12.000; la sanzione base sarebbe €10.800 (90% di 12k) . Se c’è anche IVA, supponiamo €11.000 di IVA indebitamente detratta, anche su quella si calcola la sanzione 90% = €9.900. Queste sanzioni poi si sommano. Ci sono aggravanti? Sì, se l’imposta evasa supera il 10% di quanto dichiarato e €30.000, la sanzione può salire al 135% , ma nei casi di inerenza di solito non applicano questo (è pensato per casi più gravi). Ci sono anche cause di riduzione: ad esempio, se il contribuente collabora o se la violazione è di lieve entità, può essere diminuita. – Interessi moratori: su ogni imposta non versata scattano gli interessi dal giorno in cui era dovuta (per IRES dalla scadenza del saldo dichiarazione; per IVA dalla scadenza periodica relativa). Il tasso è quello legale (negli ultimi anni intorno all’1-2% annuo, ma variabile). Sono dovuti fino al pagamento. – Possibili sanzioni aggravate o altri reati tributari: se il Fisco ravvisa situazioni più gravi – ad esempio costi completamente fittizi usati per prelevare utilmente, o manovre fraudolente – può contestare sanzioni maggiori. Un esempio: se risultasse che le fatture sono false, la sanzione sale dal 90% al dal 100% al 200% (art. 2 c.3 D.Lgs. 471/97) . Oppure, in scenari estremi, può scattare il penale tributario: per esempio, se i costi fittizi portano a evadere più di €100.000 di imposta, si ipotizza il reato di dichiarazione fraudolenta (art.2 D.Lgs. 74/2000) o di dichiarazione infedele (art.4) se l’imposta evasa supera €150.000 . Tuttavia, è raro che semplici questioni di inerenza sfocino nel penale, a meno che – ripetiamo – non emergano fatture false o intenti di frode conclamata. Nei casi di “mera inerenza”, di solito si rimane nell’illecito amministrativo tributario . – Sanzioni per omessa comunicazione beni ai soci: se applicabile quella disciplina e non avete fatto la comunicazione obbligatoria, c’è anche una sanzione amministrativa da comunicazione tardiva. Mi pare intorno a €500. Non è enorme, ma va citata.
In definitiva, per un’azienda “media” che deduce costi poi ripresi, lo scenario tipico di esborso se perde è: pagamento della maggior imposta (IRES, IVA) + sanzione 90% + interessi . La sanzione può però essere ridotta con gli strumenti deflativi che abbiamo visto (adesione 1/3, conciliazione 40%, ecc.) , oppure dal giudice per buona fede. Non ci sono sanzioni penali se non in casi di importi enormi o frode (e comunque servono soglie di imposta evasa alte, come detto) .
D3: Il Fisco può sindacare l’importo di un costo dedotto, sostenendo che è troppo alto rispetto all’utilità ottenuta (cioè può dire “questa spesa è antieconomica, quindi te la nego”)?
R: In linea di massima no, non può. Le scelte imprenditoriali in termini di convenienza economica sono lasciate alla libertà dell’impresa; il Fisco non può sostituirsi al manager nel decidere se un costo “vale la pena” o è eccessivo . Finché la spesa è genuina e inerente all’attività, anche se è sproporzionata o poco produttiva di risultati, resta deducibile e l’IVA detraibile. La Cassazione lo ha chiarito espressamente: “l’inerenza esprime una correlazione qualitativa tra costo e impresa, prescinde da valutazioni di congruità” . Per esempio, se un’azienda spende €100.000 in pubblicità e ottiene pochi clienti, l’Agenzia non può negare la deduzione dicendo “avete speso troppo per quello che è venuto in cambio” . Questa è considerata una valutazione di merito economico che non spetta al Fisco.
Tuttavia, c’è un’importante eccezione: come discusso, se la spesa è talmente abnorme o priva di logica economica da far sospettare che in realtà nasconda altro (ad esempio un’utilità personale o un’operazione simulata), allora l’Amministrazione può usarla come indizio di non inerenza e approfondire . Ma non basta la semplice affermazione “hai speso troppo”: deve emergere che la sproporzione è così forte da suggerire che il costo in realtà non aveva alcun motivo aziendale ma un motivo estraneo . È una soglia probatoria alta: in pratica, l’Ufficio deve dimostrare che l’antieconomicità è sintomatica di non inerenza, non solo che c’è inefficienza.
In sintesi: la spesa eccessiva in sé non legittima la ripresa a tassazione. Può far scattare un campanello d’allarme in fase di controllo (e portare l’ufficio a chiedere spiegazioni), ma se il contribuente dimostra comunque l’inerenza (ovvero il perché aziendale di quella spesa), il costo rimane deducibile anche se “alto”. La giurisprudenza afferma proprio: “il giudizio quantitativo di incongruità rileva solo se evidenzia che l’operazione è estranea all’impresa” . Quindi va provato che dietro quell’importo anomalo si nascondeva in realtà un fine personale (o illecito). Se questa prova non c’è, il costo va accettato così com’è (magari moral suasion per il futuro, ma non contestazione tributaria).
D4: Se un bene aziendale ha ogni tanto un utilizzo personale (es. l’auto aziendale usata saltuariamente dal titolare per scopi privati), si perde del tutto la deducibilità/detraibilità?
R: Non necessariamente. Dipende dalla frequenza e dalla gestione di tale uso promiscuo. Se l’utilizzo personale è davvero occasionale e marginale, normalmente non si mette in discussione l’inerenza prevalente del bene. In pratica, se è un’eccezione di poco conto, difficilmente l’Agenzia verrà a contestarla – anche perché spesso non ne ha evidenza. Ad esempio, se il titolare usa l’auto aziendale per andare in vacanza un weekend all’anno, formalmente non sarebbe corretto (andrebbe eventualmente fatto un fringe benefit), ma è improbabile che venga scoperto o contestato . Uno sporadico uso personale di modesta entità di solito non innesca controlli.
Se invece l’uso personale diventa significativo, allora occorre regolarizzarlo opportunamente: – Nel caso delle auto: la normativa prevede l’assegnazione in uso promiscuo al dipendente/amministratore con tassazione di un fringe benefit (calcolato forfetariamente, di solito il 25% del costo convenzionale 15.000 km * costo km ACI). Facendo ciò, l’azienda può dedurre il 70% dei costi e mantiene il diritto alla detrazione IVA al 40%. Questo è il modo corretto se l’amministratore vuole usare l’auto anche per sé: farsela assegnare come benefit . Se invece l’auto la usa un socio non dipendente, allora bisognerebbe fargliela usare dietro corrispettivo (noleggio, vedi oltre D7). – Per altri beni: se un bene strumentale ogni tanto è usato privatamente (es. un telefono aziendale per chiamate personali, un computer aziendale per uso extra), in genere si tollera entro limiti ragionevoli. Per i telefoni, ad esempio, l’IVA è interamente detraibile se intestati all’azienda, non serve più ripartire (una volta era 50%). Però se venisse fuori un uso smodato privato (es. SIM usata dai figli del titolare), sarebbe contestabile come costo extracontabile. Anche qui la soluzione sarebbe addebitare in busta paga le telefonate personali, etc. Insomma, l’importante è che l’uso personale non prevalga su quello aziendale e che, se esiste, sia trattato fiscalmente in modo corretto (benefit o corrispettivo). – Caso immobili: se l’immobile è per lo più aziendale e una piccola parte/tempo lo usa l’amministratore (tipo una stanza dell’ufficio usata come foresteria privata un weekend), irrilevante di solito. Ma se succede, meglio formalizzare un contratto di comodato d’uso temporaneo e magari un rimborso spese.
Quindi, la parola chiave è proporzionalità: una modica commistione non fa perdere del tutto l’inerenza. Fiscalmente, spesso c’è già un correttivo normativo (come per auto = 40% IVA). Se la promiscuità è significativa ma gestita secondo legge (benefit tassato, corrispettivo pagato), la deducibilità/detraibilità resta nei limiti previsti (non integrale magari, ma neppure zero). Se invece è significativa e non gestita, allora l’Agenzia potrebbe contestare e, in assenza di regolarizzazione, trattare il bene come non inerente.
In sintesi: per usi personali sporadici e minimi non vale la pena neanche preoccuparsi troppo (restano in ombra). Per usi promiscui rilevanti, vanno formalizzati (es. auto a dipendente, casa al socio con affitto) per non perdere deduzioni e evitare sanzioni.
D5: Come posso documentare al meglio l’inerenza di un costo, per prevenire o contrastare un accertamento?
R: Ci sono diverse buone pratiche di documentazione che aiutano moltissimo in caso di verifiche:
- Dare una giustificazione “business” scritta ad ogni spesa significativa: Ad esempio, se acquistate un bene insolito per l’azienda (un’auto di lusso, un’opera d’arte, ecc.), redigete un verbale interno (delibera CDA, relazione) in cui dichiarate lo scopo aziendale di quell’acquisto . Esempio: “il CDA decide di acquistare un’auto modello X per finalità di rappresentanza aziendale verso clienti esteri di alto profilo” – oppure “si acquista un quadro da esporre nella sala riunioni per migliorare l’immagine aziendale”. Datate e firmate questo documento. In caso di verifica, un memo coevo che mostra la finalità imprenditoriale è un’ottima pezza d’appoggio.
- Formalizzare contratti e policy per l’uso dei beni aziendali: Se un bene aziendale viene utilizzato da persone interne per scopi eventualmente personali, meglio stipulare un contratto o delibera che regoli la cosa . Per es: l’auto data all’amministratore – fate una delibera che sancisce l’assegnazione come fringe benefit secondo le norme (indicando magari il valore); un immobile dato a un socio – fate un contratto di locazione a valore di mercato. Se un bene può essere usato fuori lavoro (telefono, PC portatile), predisponete una policy aziendale che ne permetta un uso personale limitato, così dimostrate di aver normato la faccenda. Questi atti ufficializzano l’uso e gli danno veste di regolarità, togliendo l’alone di uso “in nero”.
- Tenere registri di utilizzo dei beni strumentali: Questo è fondamentale per veicoli, ma utile anche per altri beni. Un logbook (registro) dei chilometri per ogni auto, con annotate data, destinazione, motivo del viaggio . Oggi con app GPS e gestionali è facile tracciare. Così, se l’Agenzia mai chiede “ma quest’auto perché ha fatto 10k km?”, voi potrete esibire il registro: “dal 5 al 7 marzo trasferta a Roma per cliente Tizio (400 km), il 20 marzo meeting a Milano (150 km)”, etc. . Analogamente, se avete un immobile foresteria, tenete un registro degli ospiti (chi è stato ospitato e perché). Se date apparecchi ai dipendenti (cellulari, laptop), tenete un modulo di assegnazione con regole d’uso. Tutto questo, di solito, l’Agenzia non ve lo chiede spontaneamente, ma se scoppia la questione, voi l’avete e la producete, chiudendo la bocca a molti dubbi.
- Collegare la spesa ai ricavi con documenti giustificativi, ove possibile: Ad esempio, se contestano una spesa di viaggio per un convegno, voi dovreste conservare il programma del convegno, l’attestato di partecipazione e magari i biglietti da visita raccolti lì (per provare che era per business e avete fatto networking). Se avete comprato una barca dicendo che farete eventi marketing a bordo, poi conservate foto degli eventi tenuti, brochure dell’evento, lista invitati, magari copia di contratti conclusi grazie a quell’evento . Più costruite un dossier su ogni asset/progetto, più facile difendersi se contestato.
- Interpelli o pareri preventivi: Se avete un caso borderline, potete presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate (ordinario o probatorio ex art.11 L.212/2000) per chiedere conferma del trattamento fiscale . Sull’inerenza raramente danno risposte nette perché dicono “è fattuale”, però tentare non nuoce – al limite rispondono che non è ammissibile. In alternativa, fatevi fare una consulenza scritta da un professionista prima di dedurre un costo dubbio: se poi viene contestato, esibirete quel parere a prova che eravate in buona fede e avevate motivi per ritenere lecito il vostro operato . Non vi salva dalla ripresa, ma può aiutare su sanzioni.
- Fatture dettagliate: Quando possibile, fate in modo che le fatture riportino descrizioni chiare . Una fattura che dice solo “consulenza” è una porta aperta a dubbi; meglio “consulenza di marketing per progetto XYZ (inerente all’attività di …)”. Oppure, per un bene, far indicare la destinazione (“autovettura uso agenti di commercio”). Non sempre fattibile, ma se il fornitore collabora, fatelo. E ovviamente, banalmente, evitare errori formali in fattura (es. se è un costo auto, fate mettere la targa sulla fattura di acquisto; molte contestazioni nascono perché la fattura carburante non aveva la targa – era obbligatorio un tempo). Insomma, non date appigli su aspetti formali: meglio avere qualche dettaglio in più che in meno.
Tutta questa documentazione sarà preziosa in caso di accertamento . Potrete dimostrare l’inerenza non a parole, ma con prove tangibili. Vi mette in una posizione di forza nelle trattative e in giudizio. In sostanza, dovete anticipare il pensiero del verificatore: “se un domani mi chiedono perché hai speso questi soldi?”, avere già la risposta pronta e documentata nel fascicolo.
D6: La mia società immobiliare possiede un appartamento che affitta: posso dedurre le spese di manutenzione e detrarre l’IVA sulle spese relative?
R: Dipende dal tipo di immobile e dall’uso. Se è un immobile abitativo (categoria catastale A, tipo A/2, A/3) detenuto come investimento (dato in affitto abitativo, o magari sfitto in attesa di vendita), ricadi nel regime particolare dell’art. 90 TUIR: i costi relativi all’immobile non sono deducibili dal reddito d’impresa . In pratica, tu dichiarerai come reddito il canone di affitto (ridotto forfetariamente del 5% per le spese di manutenzione ordinaria), e non potrai dedurre né ammortamento, né IMU, né spese di manutenzione ecc. (oltre quel 5%) . Quindi la risposta è: no, non puoi dedurle, se è un’abitazione a reddito (patrimoniale). L’unica cosa che puoi dedurre, come accennato, sono gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto: una norma interpretativa del 2007 li ha esclusi dal divieto dell’art.90, quindi quelli li deduci (anche se poi soggetti al limite generale 30% ROL sugli interessi passivi, ma questo è un altro discorso) . Tutte le altre spese no.
Per l’IVA, presumibilmente l’affitto è un affitto abitativo esente IVA (art. 10 n.8). Se così, tu sull’affitto non addebiti IVA, e quindi non hai diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti relativi a quell’immobile (perché afferenti operazioni esenti – vedi prorata). Dunque l’IVA ad esempio sui lavori di ristrutturazione, o sulle fatture del manutentore, non è detraibile. Se hai erroneamente detratto, l’Agenzia potrebbe contestare quell’IVA come indetraibile ex art. 19 co.2 DPR 633/72 . A meno che la tua società immobiliare non abbia esercitato l’opzione per l’IVA sull’affitto (è possibile optare per l’IVA su locazioni abitative solo se affittate da imprese costruttrici entro 5 anni dalla fine lavori; caso particolare). Ma supponiamo di no, locazione esente => IVA indetraibile.
Invece, se l’immobile fosse strumentale (es. categoria C/1 negozio, o A/10 ufficio, affittato con IVA o usato direttamente), allora le spese sarebbero deducibili come normali costi d’impresa e l’IVA detraibile (se affitti con IVA). Nel tuo caso hai detto società immobiliare con appartamenti: siamo proprio nell’ambito art.90. Non c’è scampo: quell’articolo fu messo per impedire di far dedurre alle società i costi delle case (che prima qualcuno comprava in società per scaricare spese). L’unica consolazione è sugli interessi passivi come detto.
Attenzione: l’IMU non è mai deducibile per gli immobili abitativi (mentre per quelli strumentali oggi è deducibile al 100% dall’IRES). Quindi su quell’appartamento l’IMU resta un costo fuori dal reddito (lo metti a bilancio ma poi lo deduci extracontabilmente in UNICO) .
Riassumendo: se la tua società affitta appartamenti (quindi funzionalmente fa gestione immobiliare passiva), il fisco ti tassa i redditi fondiari e ti nega i costi (è brutale ma è così da molti anni). L’IVA sulle spese è indetraibile perché affitti esenti. Diverso se l’immobile lo destinassi a un uso strumentale tuo o locato con IVA (tipo negozio): lì dedurresti tutto e detrarresti l’IVA, ma cambia la natura.
D7: La società mi ha concesso l’uso personale di un bene aziendale (auto, casa, ecc.) ma io verso un certo importo per questo utilizzo: in tal caso la società può dedurre i costi e detrarre l’IVA?
R: Se il corrispettivo che tu paghi è almeno pari al valore di mercato del diritto di godimento, allora sì, la società può dedurre i costi (e l’IVA rimane detraibile secondo le regole ordinarie) perché non si applica la penalizzazione dei “beni concessi in godimento” (che richiede appunto un corrispettivo inferiore al valore normale) . In pratica, se paghi a prezzo di mercato, è come se la società ti stesse vendendo/noleggiando il bene a condizioni normali: i ricavi che ottiene (il tuo canone) sono tassati per intero in capo alla società e i costi inerenti restano deducibili/detraibili come per qualunque bene strumentale.
Facciamo un esempio: la società ti fa usare un’auto aziendale chiedendoti €500 al mese, cifra che è circa il valore di mercato del noleggio di quell’auto. In tal caso, la società dichiarerà quei €500/mese come ricavo di noleggio (operazione imponibile IVA se formalizzata come noleggio) e potrà dedurre tutti i costi auto relativi (ammortamento, carburante, assicurazione, manutenzione) nei limiti ordinari (20% per auto promiscuo, perché quell’auto comunque è data in uso promiscuo, ma almeno non scatta l’indeducibilità totale) . Inoltre l’IVA sulle spese auto rimane detraibile al 40%. Se invece il corrispettivo che paghi è inferiore al valore normale (o zero), scatta la disciplina penalizzante: costi indeducibili al 100% per la società e tassazione di un benefit in capo a te (per la differenza).
Idem per un immobile: se la società ti affitta l’immobile a canone di mercato, quello è un ricavo per la società e i (pochi) costi deducibili lo restano. Non scatta la norma beni ai soci. Naturalmente, se l’immobile è abitativo, la società comunque non potrà dedurre certe spese (art.90 TUIR vale a prescindere), però evita ulteriori sanzioni.
Ricapitolando: pagare prezzo pieno mette la transazione su basi di mercato, e il Fisco lo vede come un rapporto tra società e “cliente” (anche se sei socio). Dunque non applica le misure punitive. La società dichiara un ricavo in più ma conserva la deducibilità dei costi inerenti. Tu socio non hai benefici nascosti (perché hai pagato il dovuto). Questo è il modo consigliato se proprio vuoi utilizzare beni sociali a titolo personale: pagare il giusto. Non solo evita sanzioni, ma elimina anche l’addebito morale di aver usato la società per spese personali.
Esempi pratici e casi reali: simulazioni di difesa del contribuente
In questa sezione presentiamo alcuni casi pratici, ispirati a situazioni realmente verificatesi, per mostrare come le contestazioni di IVA indetraibile per spese non inerenti possano svolgersi e quali strategie difensive siano state (o possano essere) adottate.
Caso 1: “L’auto sportiva della Alfa Srl”
Scenario: Alfa Srl è una piccola società di consulenza informatica (fatturato €500k). Nel 2023 acquista una Porsche Cayenne aziendale del valore di €80.000 + IVA €17.600, intestandola alla società e detraendo il 40% dell’IVA (€7.040). L’auto è formalmente assegnata all’amministratore unico (50% socio) senza contratto specifico, e viene usata sia per incontri con clienti VIP sia per esigenze personali dell’amministratore. A fine 2024, l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo fiscale: nota l’elevato costo auto in una società così piccola e scopre (tramite pedaggi Telepass e carburanti) che l’auto ha percorso molti km in agosto in località turistiche, quando l’azienda era chiusa. Contestazione: L’Ufficio emette avviso recuperando l’IVA detratta sul 40% (negando proprio il diritto al 40%) e i costi auto (ammortamento e spese) dedotti al 20%, sostenendo che l’auto è bene ad uso personale del socio e che trova applicazione la disciplina beni ai soci (dato che non risulta alcun corrispettivo pagato). Inoltre, l’Ufficio riqualifica l’uso personale come utilizzo in godimento non comunicato e calcola un reddito diverso in capo al socio per il benefit auto (valore normale €1.000/mese per 12 mesi = €12.000) da tassare separatamente. Sanzioni al 90% su IVA e IRES evasa, con aggravante beni ai soci (omessa comunicazione).
Difesa del contribuente: L’amministratore di Alfa Srl si rivolge a un avvocato tributarista. Dall’esame, emergono alcuni punti a favore: (a) l’auto è effettivamente utilizzata anche per fini aziendali (visite a 3 importanti clienti con cui ha contratti significativi – testimonianze disponibili); (b) la società, per ignoranza, non aveva formalizzato niente, ma sarebbe disposta a far emergere un corrispettivo d’uso. Nel rispondere all’avviso, il legale adotta una strategia mista: propone un accertamento con adesione all’Ufficio, presentando memorie in cui riconosce parzialmente l’uso personale ma sottolinea anche l’uso aziendale. In sede di contraddittorio, porta documenti: calendario incontri con clienti (15 meeting in un anno, alcuni fuori città raggiunti con l’auto), email di clienti che ringraziano per le visite, etc. Inoltre, evidenzia che la società è disposta a regolarizzare l’operazione come noleggio al socio con effetto retroattivo (per quanto possibile) pagando l’IVA sulle quote di uso personale. L’Ufficio inizialmente rigido (voleva tutto indetraibile) si ammorbidisce di fronte alle prove: propone una soluzione di compromesso in adesione. Esito adesione: Viene convenuto che il 50% dell’auto è inerente e il 50% no. Quindi: la società può mantenere il 40% di IVA su metà del valore (cioè 20% di IVA totale invece di 40%), restituendo l’altra metà; i costi deducibili al 20% si riducono della metà (effetto su IRES modesto). Le sanzioni vengono ridotte ad 1/3 del minimo. La società versa in totale circa €5.000 tra imposte e sanzioni e chiude la faccenda. Il socio evita la tassazione del benefit in cambio dell’assoggettamento ad IVA di un “nolo” figurativo (che la società versa come parte del concordato). Questo caso mostra che, con documentazione e apertura al compromesso, anche una situazione sfavorevole (auto di lusso usata privatamente) può chiudersi limitando i danni. Avrebbe potuto andare peggio in giudizio: se il giudice avesse sposato in toto la tesi del Fisco, Alfa Srl avrebbe pagato circa €15k tra imposte e sanzioni, più il socio tassato.
Caso 2: “La barca di Beta S.p.A.”
Scenario: Beta S.p.A. è una società di import-export (fatturato €10 milioni). Nel 2022 acquista un yacht di 20 metri intestato a una sua controllata estera, ma di fatto lo usa l’azionista di controllo di Beta (viaggi personali). Beta ha però giustificato l’operazione come necessaria per intrattenere rapporti con clienti esteri di alto livello, organizzando qualche evento in barca durante il Cannes Yachting Festival. In particolare, nel 2023 Beta ha fatturato a due clienti americani la vendita di macchinari per €500k ciascuno, dopo averli ospitati a bordo per trattative (così sostiene Beta). L’Agenzia però vede movimenti finanziari sospetti verso il cantiere navale e scopre che Beta ha di fatto pagato il leasing dello yacht tramite triangolazioni. Contestazione: Arriva un accertamento per il 2022-23 in cui si contesta che Beta S.p.A. ha sostenuto costi per uno yacht non inerente, sebbene non figurasse nelle sue immobilizzazioni (è all’estero). In dettaglio, si negano la deducibilità di €200k di costi vari (noleggio fittizio, carburanti) che Beta si era fatturata internamente come “marketing”, e si riprende l’IVA su queste fatture interne (perché considera operazioni inesistenti). Inoltre, il Fisco apre un fascicolo penale per dichiarazione fraudolenta (uso di fatture per operazioni inesistenti, supponendo che Beta abbia creato contratti fittizi di noleggio yacht).
Difesa: Il caso è grave. Beta S.p.A. impugna l’accertamento tributario contestando sia nel merito (dice che lo yacht aveva scopo di rappresentanza legato a operazioni imponibili, portando come prova i contratti firmati coi clienti americani che includono clausole di hospitality), sia nel metodo (eccepisce che l’IVA era detraibile per le attività di export – in realtà non convincente). La difesa punta anche sulla procedura: il verbale era magari carente, e giocano su quello. In giudizio, la CTP di Genova però ritiene non credibile Beta: i giudici richiamano Cass. 4365/2023 dicendo che se la barca è estranea, costi fuori e via anche eventuali proventi . Beta perde, e fa appello. Nel frattempo, la questione penale vede Beta patteggiare su reati minori (si scopre che gonfiavano i costi di gestione barca come fondi neri). L’appello tributario a questo punto viene conciliato: Beta accetta di pagare tutte le imposte (IVA e IRES su costi yacht) ma ottiene sanzioni ridotte al minimo e rinuncia a futuri contenziosi. Esito: Beta paga circa €100k di tasse e €30k di sanzioni, più interessi, e chiude la partita fiscale, mentre il patron di Beta patteggia una pena sospesa. Questo caso mostra che quando c’è di mezzo un bene di lusso chiaramente estraneo e addirittura manovre elusive, difendersi è quasi impossibile. L’unica mossa vincente sarebbe stata non fare l’operazione o almeno non portare i costi in deduzione. Beta avrebbe potuto evitare grane non scaricando i costi barca (il socio se lo pagava coi dividendi post-tasse). Appena li ha messi in bilancio, è scattato l’allarme. Quindi la lezione: con beni di lusso, se non siete certi di poter dimostrare un effettivo uso imprenditoriale, non caricateli sui conti aziendali.
Caso 3: “Spese legali per il CEO di Gamma Srl”
Scenario: Gamma Srl è un’azienda manifatturiera. Nel 2021 il suo CEO viene indagato per un infortunio sul lavoro occorso in stabilimento (ipotesi di lesioni colpose, violazione norme sicurezza). La società, ritenendo di agire nel proprio interesse (evitare responsabilità 231 ecc.), paga gli avvocati del CEO (€30.000 + IVA) e detrae l’IVA. Nel 2024 arriva accertamento: l’Agenzia, rifacendosi a Cass. 17113/2025 e ord. 17112/25, contesta l’IVA detratta su quelle parcelle, dicendo che è costo non inerente. Non tocca i costi ai fini redditi perché li ha lasciati indeducibili extracontabilmente (Gamma per prudenza non li aveva dedotti, trattandoli come oneri straordinari non deducibili).
Difesa: Gamma impugna sostenendo che invece quelle spese erano inerenti perché il fatto riguardava l’azienda (sicurezza sul lavoro) ed era doveroso difendere il CEO. Porta a sostegno che, se il CEO fosse stato condannato, l’azienda avrebbe avuto contraccolpi (sanzioni amministrative 231). La CTP, però, seguendo pedissequamente la Cassazione 2025, respinge: “manca nesso immediato, l’IVA è indetraibile”. Gamma valuta l’appello ma il suo consulente le sconsiglia perché la giurisprudenza è granitica. Sceglie allora di definire la lite in conciliazione con l’Agenzia in appello: versa l’IVA contestata (€6.600) e ottiene cancellazione totale delle sanzioni (prospettando di arrivare in Cassazione su favor rei sanzioni, l’ufficio cede sulle sanzioni per chiudere). Esito: Gamma paga l’IVA più interessi, niente sanzioni. Da allora, Gamma ha imparato: ha stipulato una polizza che copre queste spese legali e in futuro non detrae più l’IVA su parcelle relative a difese personali di dirigenti. Questo caso mostra come una spesa “di confine” viene trattata duramente in ambito IVA, e come spesso convenga trovare un accordo economico invece di incaponirsi in cause perse – sfruttando magari leve come la riduzione sanzioni.
Conclusione
Abbiamo visto come il tema dell’IVA indetraibile per spese non inerenti all’attività intrecci aspetti normativi complessi e valutazioni fattuali sulla concreta destinazione delle spese aziendali. Dal punto di vista del contribuente, affrontare con successo tali contestazioni richiede una duplice attenzione: preventiva, nel porre in essere una gestione accurata e documentata delle spese, e difensiva, nel far valere i propri diritti in sede di controllo o contenzioso.
In sintesi conclusiva:
- Conosci le regole e rispettale: imprese e professionisti devono essere consapevoli dei limiti normativi alla detrazione IVA (art.19-bis1) e delle definizioni di inerenza. Ci sono costi che, per quanto possano sembrare giustificati soggettivamente, il legislatore ha escluso (es. spese di rappresentanza, beni di lusso non strumentali). Pianificare la gestione fiscale di beni come auto, immobili, ecc., tenendo conto di queste restrizioni, può evitare brutte sorprese. Ad esempio, se un socio vuole un bene per sé, meglio valutare l’acquisto personale invece che in azienda, oppure prevedere forme contrattuali (noleggi) che mettano la società al riparo da contestazioni.
- Documenta tutto e sii trasparente: la miglior difesa contro l’accusa di non inerenza è una robusta documentazione. Un costo corredato da delibere, contratti, report e riscontri oggettivi del suo collegamento al business sarà molto più difendibile di una spesa annotata senza spiegazioni. La trasparenza paga: comunicare eventuali situazioni “sensibili” (beni a soci) secondo le procedure, e trattarle contabilmente in modo conforme (benefit, ricavi figurativi), può ridurre al minimo le contestazioni. Come abbiamo ribadito, qualche piccola formalità in più può risparmiare anni di lite.
- In sede di verifica, collabora ma fai valere le tue ragioni: se arriva un controllo, non assumere un atteggiamento passivo. Fornisci spontaneamente la documentazione che prova l’inerenza delle tue spese contestabili, così magari eviti che finiscano nel processo verbale. Allo stesso tempo, conosci i tuoi diritti: la verifica deve svolgersi secondo legge, l’accertamento va motivato; pretendi queste garanzie (Statuto del contribuente) e segnala eventuali carenze già in fase amministrativa. Mostrarsi preparati e risoluti può scoraggiare contestazioni deboli.
- Usa gli strumenti deflattivi con intelligenza: un accertamento per spese non inerenti può spesso risolversi con un buon accordo. Valuta con il tuo consulente se conviene aderire (specie se la posizione è rischiosa) e ricorda che c’è margine per trattare sanzioni e talvolta imponibili. Se vai in giudizio, mantieni aperta la porta della conciliazione: risparmiare tempo e denaro a volte è meglio di una vittoria incerta e lontana.
- Giurisprudenza aggiornata e strategie mirate: come in ogni materia tributaria, gli orientamenti giurisprudenziali evolvono. In questi ultimi anni, la Cassazione ha affinato la definizione di inerenza IVA, allineandola ai principi UE (nesso diretto e immediato) . Questo ha implicato un irrigidimento su alcune voci (ad es. spese legali, come visto). È fondamentale per i difensori citare le sentenze più recenti e saperle utilizzare a proprio vantaggio – o distinguerle se sfavorevoli. Ad esempio, conoscere Cass. 4365/2023 e il suo principio simmetrico può dare un’arma dialettica in più . All’opposto, se c’è una spiraglio aperto da qualche sentenza pro-contribuente (es. su sponsorizzazioni), costruire la difesa attorno a quello.
- Punto di vista del debitore: ricordiamoci sempre che dall’altra parte c’è il contribuente che rischia sanzioni e esborsi. Nell’impostare la difesa, specialmente in giudizio, umanizzare la vicenda – far capire che non c’era intento fraudolento, che magari l’errore è stato formale o dovuto a incertezza – può influenzare positivamente la decisione sulle sanzioni e sulla valutazione delle prove. Ad esempio, evidenziare la buona fede, il fatto di essersi affidati a un commercialista, etc., può spostare l’ago sul trattamento sanzionatorio (il giudice potrebbe annullarle per “colpa lieve”).
In conclusione, “difendersi” da un’accusa di IVA indebitamente detratta per spese non inerenti significa, da un lato, preparare il campo in anticipo (una gestione fiscale prudente e documentata), dall’altro, se la disputa nasce, combattere con gli strumenti giuridici a disposizione, senza timore di far valere i propri diritti ma con la necessaria flessibilità per cogliere eventuali soluzioni transattive favorevoli. In un sistema tributario in continuo divenire, l’approccio vincente è rimanere informati, organizzati e proattivi.
Bibliografia & Fonti:
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 (Detrazione), 19-bis1 (Esclusioni oggettive) .
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 90 (Immobili patrimonio), 108 (Spese di rappresentanza), 109 c.5 (Inerenza nelle imposte dirette) .
- Corte di Cassazione, sez. Trib., ordinanza 12 giugno 2025 n.15638 – Attività preparatorie ad operazioni esenti: IVA indetraibile in assenza di operazioni imponibili .
- Corte di Cassazione, sez. Trib., sentenza 25 giugno 2025 n.17113 – Spese legali difesa penale amministratori: IVA indetraibile per difetto di nesso immediato .
- Corte di Cassazione, sez. Trib., sentenza 17 febbraio 2025 n.12588 – Principi generali di inerenza: costo inerente se correlato all’attività, irrilevante congruità; onere della prova a carico contribuente; antieconomicità sintomo solo se macroscopica .
- Corte di Cassazione, sez. Trib., ordinanza 16 febbraio 2023 n.4365 – Bene di lusso (barca) usato dal socio: costi indeducibili e correlati ricavi fuori dal reddito d’impresa .
- Corte di Cassazione, sez. Trib., sentenza 2 dicembre 2019 n.34474 – Arredi/opere d’arte di lusso: deducibilità solo se rappresentanza funzionale a clienti e entro limiti .
- Corte di Giustizia UE, sentenza 21 febbraio 2013, causa C-104/12 (Becker) – IVA su spese legali difesa amministratore: non detraibile se prestazioni avvocato rese nell’interesse personale (mancanza nesso con attività imponibile) .
- Agenzia delle Entrate, Circolare 19/E/2012 – Disciplina beni concessi in godimento ai soci, adempimenti e indeducibilità costi.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9/E/2016 – IVA su spese legali sostenute dalla società per amministratori imputati: indetraibile per difetto di inerenza (richiamo a giurisprudenza).
Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché alcune spese sono state considerate non inerenti all’attività e quindi l’IVA detratta è stata ritenuta indetraibile? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché alcune spese sono state considerate non inerenti all’attività e quindi l’IVA detratta è stata ritenuta indetraibile?
Vuoi sapere quali sono i rischi e come puoi difenderti?
Il diritto alla detrazione IVA è riconosciuto solo per gli acquisti effettivamente collegati e funzionali all’attività d’impresa, professionale o artistica. Quando il Fisco ritiene che una spesa non abbia legame con l’attività svolta, può disconoscere la detrazione e recuperare l’imposta.
👉 Non sempre però l’accusa è fondata: l’inerenza non si misura solo sul ritorno economico immediato, ma anche sulla funzionalità generale della spesa rispetto all’attività.
⚖️ Perché scatta la contestazione
- Spese ritenute di natura personale o prive di collegamento con l’attività;
- Fatture relative a beni o servizi utilizzati promiscuamente (es. auto, telefoni, immobili);
- Costi considerati sproporzionati rispetto all’attività esercitata;
- Mancanza di documentazione idonea a provare l’uso professionale;
- Contestazioni su spese di rappresentanza, viaggi o consulenze.
📌 Conseguenze possibili
- Recupero dell’IVA detratta sulle spese ritenute non inerenti;
- Sanzioni fiscali dal 90% al 180% dell’imposta contestata;
- Interessi di mora;
- Nei casi più gravi, contestazioni anche sul piano delle imposte dirette (indeducibilità del costo).
🔍 Come difendersi
- Esamina le spese contestate: individua quali voci l’Agenzia ritiene non inerenti.
- Raccogli la documentazione giustificativa: contratti, ordini, report, relazioni, attestazioni che provino l’uso aziendale.
- Dimostra la funzionalità della spesa: anche se non genera immediato ricavo, può essere coerente con la strategia aziendale.
- Contesta le presunzioni del Fisco: l’inerenza non può essere valutata solo sulla base di criteri quantitativi o di convenienza.
- Predisponi memorie difensive o ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’accertamento IVA e le spese considerate non inerenti;
- 📌 Ricostruisce la reale destinazione dei beni e dei servizi acquistati;
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi fondati su normativa e giurisprudenza;
- ⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nei giudizi tributari;
- 🔁 Suggerisce soluzioni alternative, come definizioni agevolate, per ridurre sanzioni e interessi.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in contenzioso IVA e inerenza delle spese;
- ✔️ Specializzato in difesa da accertamenti su costi contestati;
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni sull’IVA indetraibile per spese non inerenti all’attività sono frequenti, ma non sempre corrette.
Con una difesa legale mirata puoi dimostrare la reale funzionalità delle spese, contestare le presunzioni del Fisco e ridurre le pretese tributarie.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro le contestazioni IVA inizia qui.