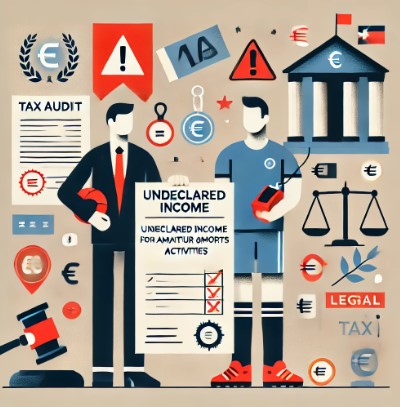Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per compensi da attività sportive dilettantistiche non dichiarati? Atleti, istruttori, allenatori e collaboratori di associazioni o società sportive possono percepire compensi soggetti a regole fiscali specifiche. Se non vengono dichiarati correttamente, il Fisco può considerarli redditi imponibili, con imposte, sanzioni e interessi a carico del contribuente.
Quando scattano le contestazioni
– Se i compensi ricevuti da associazioni o società sportive dilettantistiche non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi
– Se i pagamenti superano le soglie di esenzione previste e non sono stati tassati
– Se i rimborsi spese vengono considerati veri e propri compensi
– Se l’attività sportiva non è svolta realmente in forma dilettantistica, ma abituale e professionale
– Se i flussi bancari non risultano coerenti con i redditi dichiarati
Come funziona il regime fiscale dei compensi sportivi
– I compensi percepiti da attività sportiva dilettantistica possono beneficiare di esenzioni entro determinate soglie stabilite dalla legge
– Gli importi che superano tali limiti devono essere dichiarati e sono soggetti a tassazione ordinaria
– È necessario distinguere tra compensi, rimborsi spese documentati e indennità forfetarie
Cosa rischi in caso di omissione
– Recupero delle imposte sui compensi non dichiarati
– Sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta accertata
– Interessi di mora che aumentano l’importo complessivo
– Contestazione di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione se vengono superate le soglie penali
– Possibile perdita dello status di associazione sportiva dilettantistica per gli enti che non rispettano le regole fiscali
Come difendersi da una contestazione
– Dimostrare che i compensi rientrano nei limiti di esenzione previsti dalla legge
– Presentare documentazione che provi la natura di rimborsi spese e non di compensi imponibili
– Contestare gli errori di calcolo dell’Agenzia delle Entrate sui limiti di tassazione
– Dimostrare la buona fede e la corretta interpretazione della normativa, spesso soggetta a modifiche
– Impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria se la contestazione non è fondata
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare l’accertamento e verificare i presupposti della contestazione
– Raccogliere la documentazione sportiva e fiscale utile a dimostrare la spettanza delle esenzioni
– Contestare la qualificazione dei compensi come redditi imponibili
– Difendere l’atleta, il tecnico o l’associazione sportiva in fase di contraddittorio e in giudizio
– Negoziare con il Fisco soluzioni agevolate per ridurre imposte e sanzioni
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione di imposte, sanzioni e interessi richiesti
– Il riconoscimento della natura esente dei compensi entro i limiti previsti
– La sospensione delle procedure esecutive collegate
– La tutela del patrimonio personale e associativo
⚠️ Attenzione: le contestazioni sui compensi da attività sportive dilettantistiche derivano spesso da interpretazioni fiscali rigide o da errori di inquadramento. Con documenti e difesa tecnica è possibile dimostrare la legittimità delle esenzioni e ridurre drasticamente la pretesa fiscale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e diritto sportivo – ti spiega come affrontare un accertamento per omissione di compensi sportivi e come proteggerti dalle pretese indebite del Fisco.
👉 Hai ricevuto un accertamento per omissione di compensi da attività sportive dilettantistiche? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, raccoglieremo le prove utili e predisporremo la strategia difensiva più efficace per tutelarti.
Introduzione
Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) operano in un regime fiscale agevolato in virtù della loro natura senza scopo di lucro e del ruolo sociale nella promozione dello sport amatoriale. Una delle principali agevolazioni riguarda i compensi erogati a collaboratori sportivi dilettanti, come allenatori, istruttori, atleti non professionisti e personale amministrativo-gestionale non professionale. Tali somme, entro determinati limiti, godono di esenzioni d’imposta e semplificazioni contributive. Tuttavia, quando l’Agenzia delle Entrate o gli enti previdenziali riscontrano irregolarità – ad esempio compensi non dichiarati, eccedenze oltre le soglie esenti o rapporti di lavoro di fatto professionali – possono emettere avvisi di accertamento che contestano l’omissione di redditi e pretendono il pagamento di imposte, sanzioni e contributi arretrati . Dal punto di vista del debitore (sia esso l’associazione erogante o il collaboratore percettore del compenso), è fondamentale conoscere come difendersi efficacemente: ciò implica comprendere la normativa di riferimento, le più recenti pronunce giurisprudenziali, nonché gli strumenti “deflattivi” che consentono di evitare o ridurre il contenzioso (come l’istanza di autotutela, l’accertamento con adesione e – per gli atti antecedenti al 2024 – la mediazione tributaria).
Aggiornata ad agosto 2025, questa guida – di livello avanzato ma con un linguaggio chiaro e divulgativo – fornisce una panoramica completa sulla materia dal punto di vista di chi subisce l’accertamento (debitore/contribuente). Saranno esaminati i riferimenti normativi italiani più recenti, incluse le novità introdotte dalla riforma dello sport dilettantistico in vigore dal 1º luglio 2023, e commentate le sentenze più autorevoli degli ultimi anni (Corte di Cassazione e Giustizia Tributaria) inerenti i compensi sportivi. Troverete inoltre tabelle riepilogative delle regole fiscali e procedurali, esempi pratici di casi di accertamento e relative strategie difensive, oltre a una sezione di domande e risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni. L’obiettivo è offrire a professionisti (avvocati tributaristi, consulenti del lavoro), dirigenti di associazioni sportive ma anche privati cittadini coinvolti, uno strumento operativo avanzato per comprendere come reagire a un accertamento per omessa dichiarazione di compensi sportivi dilettantistici e quali tutele attivare per salvaguardare i propri diritti.
Quadro normativo: compensi sportivi dilettantistici e regime fiscale
La disciplina dei compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche ha subito importanti evoluzioni normative negli ultimi anni. Per contestualizzare le potenziali contestazioni fiscali, è essenziale partire dall’inquadramento giuridico-fiscale di tali compensi, distinguendo il regime previgente al 2023 e le novità introdotte dalla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023). Di seguito si esaminano i riferimenti normativi chiave, le soglie di esenzione e le condizioni perché i compensi erogati in ambito dilettantistico siano fiscalmente agevolati.
Definizione e natura dei compensi sportivi dilettantistici
I compensi percepiti nello svolgimento di attività sportive dilettantistiche si riferiscono a somme corrisposte da enti sportivi non professionistici – tipicamente associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o società sportive dilettantistiche (SSD) riconosciute dal CONI – a favore di soggetti che prestano la propria opera nello sport senza carattere di professionalità e senza vincolo di subordinazione. In questa categoria rientrano, ad esempio: atleti dilettanti, allenatori e istruttori, arbitri e giudici di gara, massaggiatori, nonché dirigenti o addetti a mansioni amministrativo-gestionali di supporto alle ASD/SSD, purché tali attività non costituiscano per loro una professione abituale . La normativa italiana da tempo riconosce una fiscalità di favore a tali emolumenti per incentivare il volontariato sportivo: in particolare, già prima del 2023, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986, detto TUIR) prevedeva che queste somme fossero inquadrate tra i “redditi diversi” (non come redditi di lavoro dipendente né autonomo) e fruissero di una sostanziale no tax area entro un certo importo annuo .
Sul piano normativo, il riferimento cardine era l’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, che elencava tra i redditi diversi «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» da parte di CONI, federazioni sportive ed enti sportivi riconosciuti, «nonché le indennità di trasferta e i compensi di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche» . In altre parole, la legge equiparava alle prestazioni sportive dilettantistiche anche le collaborazioni amministrative co.co.co. (coordinate e continuative) svolte presso ASD/SSD, a condizione che fossero attività non professionali (es. personale di segreteria, manutentori di impianti, dirigenti amministrativi volontari). Ciò che accomuna tutte queste figure è la natura dilettantistica del rapporto: assenza di professionalità (l’attività sportiva non è svolta come mestiere principale abituale) e assenza di subordinazione gerarchica tipica del lavoro dipendente .
Dal punto di vista previdenziale, la legislazione storicamente esentava questi compensi anche da obblighi contributivi, ritenendoli fuori dal campo del lavoro subordinato o autonomo. In particolare, un riferimento spesso richiamato era l’art. 35 comma 5 del D.L. 207/2008 (conv. L. 14/2009) che ha confermato l’esclusione dall’imponibile previdenziale di indennità e compensi sportivi dilettantistici entro i limiti di esenzione fiscale. Tale esenzione contributiva, tuttavia, si applica solo se le prestazioni sono genuinamente dilettantistiche. La Corte di Cassazione ha chiarito che grava sull’associazione che invoca l’esenzione l’onere di provare che il collaboratore svolgeva attività non professionale e non subordinata; in difetto, prevalgono le regole generali contributive . Ad esempio, in una recente ordinanza del 2025, la Cassazione ha ribadito che istruttori sportivi retribuiti in modo continuativo e abituale non possono essere considerati dilettanti esenti da contributi, ma vanno iscritti e assoggettati a previdenza, con obbligo per l’ASD di versare i contributi INPS dovuti .
Regime fiscale fino al 30 giugno 2023: soglia di €10.000 ed esenzione
Fino all’entrata in vigore della riforma nel 2023, i compensi sportivi dilettantistici godevano di un trattamento fiscale agevolato delineato principalmente dall’art. 69, comma 2 del TUIR (come modificato dalla L. 205/2017). Tale disposizione prevedeva che «Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi (di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67) non concorrono a formare il reddito per un importo complessivo non superiore nel periodo d’imposta a 10.000 euro», e che «non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale» . In sintesi, fino a €10.000 annui per percettore, i compensi sportivi dilettantistici erano interamente esenti da IRPEF (no tax area), e i percettori non erano tenuti neppure a dichiararli in quanto redditi esclusi dal tassazione . Contestualmente, per importi oltre la soglia di €10.000, scattava un meccanismo di tassazione alla fonte a titolo d’imposta: sulla parte eccedente i 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro complessivi, l’associazione (in qualità di sostituto d’imposta) doveva applicare una ritenuta fiscale del 23% (aliquota corrispondente al primo scaglione IRPEF) più eventuali addizionali locali, ritenuta considerata imposta definitiva su quella quota di reddito . In pratica, tra €10.000 e circa €30.600 di compensi, il collaboratore sportivo subiva un prelievo forfettario del 23% sulla parte eccedentaria, ma non era comunque obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per tali somme, poiché la ritenuta operata dall’ente sportivo estingueva la sua obbligazione tributaria . Solo per importi superiori a €30.658,28 annui (evento relativamente raro in ambito dilettantistico), la parte ulteriore veniva assoggettata a ritenuta a titolo di acconto del 23%, con conseguente obbligo per il percettore di dichiarare quella quota aggiuntiva e assoggettarla a tassazione ordinaria IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi .
La ratio di questo regime era di evitare oneri fiscali alle piccole collaborazioni sportive e semplificare la gestione per le associazioni. Si ricordi che, inizialmente, la soglia di esenzione era fissata a €7.500 annui, poi elevata a €10.000 dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) in considerazione dell’inflazione e per aumentare il sostegno allo sport dilettantistico . Inoltre, parallelamente all’esenzione IRPEF, la legislazione prevedeva ulteriori agevolazioni: ad esempio l’art. 25 comma 1 della L. 133/1999 stabiliva le modalità semplificate di applicazione delle ritenute alla fonte su tali compensi, e confermava che fino a €10.000 non vi era obbligo di operare ritenute (né di emettere certificazioni per quei redditi) . In sede previdenziale, come accennato, tali compensi venivano generalmente considerati esclusi da contributi se ricorrevano i requisiti di dilettantismo (norma che però, come vedremo, è stata oggetto di verifiche e interpretazioni restrittive da parte dei giudici).
È importante evidenziare che per usufruire di queste esenzioni, l’associazione/società sportiva deve essere in regola con i requisiti formali di legge (affiliazione al CONI, previsione statutaria di non lucro, ecc.) e le prestazioni devono effettivamente rientrare nell’ambito dilettantistico. In caso di abuso o di travalicamento di tali limiti, il Fisco può contestare la decadenza dalle agevolazioni. Ad esempio, la corresponsione di compensi troppo elevati ai collaboratori (specie se questi sono anche dirigenti o soci) può essere considerata come distribuzione indiretta di utili, facendo perdere all’ente i benefici fiscali dell’ASD. La Cassazione ha affermato un principio chiaro in proposito: pagare salari o stipendi ai dipendenti/collaboratori di un’ASD con importi superiori di oltre il 20% ai valori previsti dai contratti collettivi del settore costituisce presunzione legale assoluta di distribuzione di utili ai soci amministratori . In tal caso, per l’anno in cui ciò avviene, l’associazione è considerata a fini fiscali un ente commerciale, con tassazione ordinaria di tutti i proventi e perdita delle agevolazioni . Su questo tema si tornerà analizzando la giurisprudenza (vd. Cass. ord. pubblicata il 21/08/2025, in cui la Suprema Corte ha cassato con rinvio una decisione di merito proprio perché non aveva applicato la suddetta presunzione in presenza di compensi ai dirigenti maggiorati oltre il 20% del dovuto ).
La riforma del 2023: “lavoro sportivo” e nuova soglia di €15.000 esenti
La riforma dello sport dilettantistico, in vigore dal luglio 2023, ha introdotto la figura del “lavoratore sportivo” dilettante, modificando l’inquadramento fiscale e previdenziale dei collaboratori sportivi. I compensi erogati in ambito dilettantistico restano esenti da IRPEF entro una soglia più elevata (€15.000 annui), ma oltre tale importo diventano redditi da lavoro a tutti gli effetti.
Con il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (Correttivo della riforma dello sport, attuativo della delega “Spazzacorrotti” e riforma del lavoro sportivo) è stata operata una profonda revisione della disciplina dei lavoratori sportivi dilettanti. Dal 1º luglio 2023, infatti, i compensi sportivi dilettantistici non rientrano più tra i “redditi diversi” ai sensi del TUIR, bensì vengono qualificati come redditi di lavoro (subordinato o autonomo a seconda dei casi) . L’art. 36 del D.Lgs. 36/2021, dedicato al trattamento fiscale, al comma 6 stabilisce che «i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di €15.000. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di €15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo» . Si tratta dunque di una no tax area ampliata a 15.000 euro annui. La riforma ha innalzato la soglia di esenzione (da 10k a 15k) ma contestualmente ha “convertito” l’eccedenza in reddito imponibile ordinario: ciò significa che se un collaboratore dilettante percepisce più di €15.000 in un anno, tutto l’importo oltre tale soglia sarà trattato come reddito da lavoro, cumulabile con eventuali altri redditi e tassato secondo le aliquote IRPEF progressive . A differenza del previgente regime, non è più prevista un’imposta sostitutiva forfettaria del 23% sulla fascia intermedia: si applica direttamente la tassazione ordinaria per la parte oltre €15.000 .
In parallelo, il legislatore ha previsto l’obbligo per il lavoratore sportivo di rilasciare un’autocertificazione al momento del pagamento, attestando l’ammontare totale dei compensi sportivi dilettantistici già percepiti nell’anno solare . Ciò consente all’ente erogatore di verificare se, sommando la nuova erogazione, si supererà la soglia esente. Resta infatti onere del percettore monitorare il cumulo annuale tra eventuali compensi ricevuti da diverse associazioni. Sempre il D.Lgs. 36/2021 (art. 25, comma 2) ha chiarito che il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico può assumere la forma di un lavoro subordinato (es. istruttore assunto part-time) oppure di un lavoro autonomo anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), eliminando dunque la “zona grigia” del reddito diverso . Inoltre, all’art. 25 comma 3-bis è stata introdotta la possibilità, per ASD/SSD e federazioni, di avvalersi anche di prestatori di lavoro sportivo occasionale nei limiti e con le modalità di legge (una novità che consente micro-prestazioni occasionali con pagamento tramite voucher o similari, per esigenze sporadiche) .
Dal punto di vista previdenziale, la riforma ha compiuto un cambio di paradigma: i lavoratori sportivi dilettanti (salvo i puri volontari che percepiscono solo rimborsi spese) diventano soggetti assicurati ai fini pensionistici. È stato istituito un apposito Fondo Pensione Sport presso la gestione separata INPS. In base alle nuove regole (art. 35 D.Lgs. 36/2021), nessun contributo previdenziale è dovuto sui compensi annui fino a €5.000, mentre per la quota di compensi oltre €5.000 scatta l’obbligo contributivo (con aliquote ridotte rispetto al lavoro ordinario) . Ciò significa che, ad esempio, un istruttore dilettante che guadagna €10.000 l’anno non paga contributi sui primi 5.000, ma versa contributi (in parte a suo carico, in parte a carico dell’ente sportivo) sui restanti €5.000; se guadagna oltre €15.000, oltre a pagare i contributi sulla parte eccedente 5k, dovrà anche pagare IRPEF progressiva sulla parte eccedente 15k. Questa innovazione mira a garantire tutele previdenziali di base ai collaboratori sportivi, senza gravare eccessivamente sui piccoli compensi . Pertanto, dal 2023 la posizione dei collaboratori sportivi dilettanti è più regolarizzata: essi non sono più invisibili al fisco oltre certe soglie e anzi, se superano i limiti esenti, vengono trattati quasi come normali lavoratori per la parte eccedentaria di reddito.
Va sottolineato che il nuovo regime fiscale a 15.000€ esenti si applica in modo unitario all’intero anno d’imposta 2023, nonostante l’entrata in vigore a metà anno. Infatti il decreto prevede una specifica disciplina transitoria (art. 51, co. 1-bis D.Lgs. 36/2021) per il 2023, chiarendo che la soglia di esenzione di €15.000 vale per l’anno intero, indipendentemente dal fatto che i compensi del primo semestre fossero inquadrati come redditi diversi . L’Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio nella Risposta ad interpello n. 474/2023 (pubblicata l’11 dicembre 2023), caso in cui una SSD dilettantistica chiedeva come gestire un compenso di un atleta pagato €20.400 da gennaio a giugno e €15.400 da luglio a dicembre 2023. La soluzione è stata di considerare unitariamente le somme: il contribuente ha diritto a €15.000 complessivi esenti per il 2023 (non €10.000+15.000), per cui – dato che aveva già avuto €10.000 esenti nel primo semestre – solo ulteriori €5.000 del secondo semestre risultano esenti, mentre tutta la parte eccedente (€10.400 nel caso di specie) va assoggettata a imposizione . In pratica, sull’importo pagato a luglio-dicembre 2023 l’ASD dovrà tassare la parte oltre €5.000 rimasti nel plafond, andando a colpire esattamente i €10.400 residui con tassazione ordinaria (tenendo conto che sul primo semestre era già stata applicata la ritenuta del 23% sulla parte oltre 10k) . Questo chiarimento evita che qualcuno possa indebitamente beneficiare di due soglie separate (10k per la prima metà e 15k per la seconda), confermando che il tetto di esenzione di €15.000 è annuale unico anche nell’anno di transizione .
In sintesi, il quadro attuale (dal 2024 in poi) è il seguente: i primi €15.000 annui percepiti da un lavoratore sportivo dilettante non concorrono al reddito (esenti IRPEF); la parte eccedente è tassata con le regole ordinarie dei redditi di lavoro (soggetta a ritenuta d’acconto da parte dell’ente erogante e poi a conguaglio IRPEF in dichiarazione del percipiente). Dal lato contributivo, rimane l’esonero totale fino a €5.000 e contribuzione previdenziale dovuta sulla quota oltre €5.000, secondo aliquote agevolate stabilite per il settore sport (nel 2024 circa il 25%, destinata a salire negli anni successivi). Il passaggio da “redditi diversi” a “redditi di lavoro” comporta inoltre che i collaboratori sportivi che superano la soglia esente debbano presentare la dichiarazione dei redditi, cosa che in precedenza potevano evitare se i compensi erano interamente coperti da ritenuta a titolo d’imposta . D’altra parte, l’ampliamento della no tax area a 15k riduce il numero di soggetti che supereranno la soglia (tenuto conto che, secondo stime citate nelle relazioni, il reddito medio annuo dei dilettanti era attorno a €7.000 ).
Come vedremo, tuttavia, gli accertamenti per omissione di compensi possono riguardare anche periodi d’imposta precedenti al 2023 (ancora oggetto di controllo), e in tali casi si applicheranno le vecchie regole (10k esenti, ecc.). Inoltre, situazioni peculiari come la perdita dei requisiti sportivi dilettantistici da parte dell’ente erogante o la riqualificazione del rapporto di lavoro (da dilettantistico a professionale) possono comportare la disapplicazione delle agevolazioni, con recupero a tassazione anche di compensi che altrimenti sarebbero stati esenti. Pertanto, è cruciale per le ASD/SSD curare sia gli aspetti formali (registrazione CONI, clausole statutarie, tenuta registri) sia quelli sostanziali (effettivo svolgimento di attività non lucrative) per non incorrere in contestazioni. La Cassazione ha più volte affermato che non basta la forma giuridica o l’affiliazione formale a garantire il regime fiscale di favore: occorre provare che l’attività svolta è realmente dilettantistica e non orientata al profitto . In caso di verifica, l’onere probatorio ricade sull’associazione, che deve dimostrare concretamente la propria natura non lucrativa e la coerenza dei compensi corrisposti con i fini istituzionali .
Di seguito analizzeremo le figure soggettive coinvolte e le situazioni tipiche che possono portare a un accertamento, per poi affrontare le strategie di difesa.
Soggetti interessati: ASD, SSD, collaboratori, dirigenti e prestatori occasionali
Nel contesto dei compensi sportivi dilettantistici, diversi attori possono essere coinvolti, ciascuno con un ruolo specifico e potenziali obblighi. Dal punto di vista del debitore che deve difendersi da un accertamento, è utile distinguere tra: – L’ente erogatore del compenso (di solito un’Associazione Sportiva Dilettantistica – ASD, oppure una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata – SSD); – Il percettore del compenso, ossia il collaboratore sportivo dilettante (allenatore, istruttore, atleta, dirigente, etc.) che ha ricevuto la somma poi contestata.
A seconda della natura dell’accertamento, il “debitore” nei confronti del Fisco può essere l’uno o l’altro (o talvolta entrambi, in diversi ambiti). Ad esempio, un avviso di accertamento IRPEF per omessa dichiarazione di redditi colpirà il collaboratore percettore; viceversa un avviso di addebito contributivo (INPS) per mancati versamenti colpirà l’ASD in qualità di datore di lavoro di fatto. Ancora, un atto impositivo dell’Agenzia Entrate potrebbe essere indirizzato all’ASD per recuperare ritenute non operate su compensi erogati, oppure per revocare l’agevolazione fiscale dell’ente stesso. Esaminiamo dunque le caratteristiche dei vari soggetti:
- Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD): è un ente privato senza scopo di lucro, tipicamente costituito in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, con finalità di promozione di uno sport a livello amatoriale. Le ASD, se iscritte nel Registro CONI (oggi confluito nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche), godono delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR e dalla L. 398/1991 . Ciò comporta, tra l’altro, la decommercializzazione dei proventi istituzionali (quote associative, contributi dei soci, ecc.) e la possibilità di optare per un regime forfettario di determinazione del reddito e IVA sulle attività commerciali marginali. In tema di compensi sportivi, l’ASD funge da sostituto d’imposta: è tenuta a rispettare le soglie di esenzione e ad applicare eventuali ritenute, oltre a certificare i compensi corrisposti. Affinché i compensi erogati dall’ASD siano considerati dilettantistici ed esenti, l’ASD stessa deve rispettare i requisiti statutari e operativi di legge (divieto di distribuzione utili, democraticità interna, uso di denominazione “sportiva dilettantistica”, affiliazione a federazione/ENTE di promozione riconosciuto, tenuta dei rendiconti, ecc.) . In caso di violazioni sostanziali (ad es. attività effettivamente commerciale mascherata), l’ASD rischia di perdere la qualifica di ente non commerciale per l’anno in questione, con pesanti conseguenze fiscali: tassazione di tutti i proventi e disconoscimento delle esenzioni sui compensi erogati . Dunque, l’ASD deve vigilare sia sulla correttezza formale (libri verbali, registro soci, mod. EAS, ecc.) sia sulla coerenza economica della propria gestione (ad es. evitare compensi palesemente eccessivi ai propri dirigenti o soci). Come affermato dalla Cassazione, pagare compensi fuori mercato a soggetti apicali costituisce un forte indizio di scopo di lucro indiretto . In caso di accertamento, all’ASD può essere contestato: la decadenza dal regime 398/91, l’omessa applicazione di ritenute, l’errata qualificazione di proventi come istituzionali, e sul fronte contributivo l’eventuale omissione di iscrizione di collaboratori come lavoratori (con relative sanzioni). Dal punto di vista difensivo, l’ASD dovrà provare di aver operato come vero ente dilettantistico (onere della prova in capo suo ) e che eventuali irregolarità formali non inficiavano la sostanza non lucrativa .
- Società Sportiva Dilettantistica (SSD): introdotta dall’art. 90 della L. 289/2002, è una società di capitali (tipicamente S.r.l. o S.r.l.s) che opera nello sport dilettantistico rispettando anch’essa vincoli di non lucratività (divieto di dividendi, obbligo di reinvestire gli utili nelle attività sportive). Le SSD godono delle stesse agevolazioni fiscali delle ASD, potendo optare per la legge 398/91, e sono equiparate ai fini dei compensi sportivi (possono erogare compensi dilettantistici esenti entro le medesime soglie). Una differenza è che la SSD è soggetta alle regole civilistiche delle società, con bilancio, amministratori, ecc., ma non può distribuire utili se vuole mantenere le agevolazioni. Ai fini di un eventuale accertamento, le SSD sono spesso oggetto di verifiche su due fronti: (1) il rispetto dei requisiti sportivi dilettantistici (come per le ASD) e (2) l’eventuale corretta distinzione tra attività commerciale e istituzionale. Ad esempio, se una SSD dilettantistica (es. una S.S.D. a r.l. che gestisce una palestra) realizza proventi quasi interamente da abbonamenti di non soci o sponsorizzazioni elevate, il Fisco potrebbe dubitare della prevalenza dell’attività sportiva dilettantistica rispetto a quella commerciale . Le SSD, come le ASD, quando subiscono un accertamento in materia di compensi sportivi dovranno difendersi mostrando di aver correttamente applicato la normativa (soglie, ritenute, autocertificazioni post-2023, ecc.) e di essere enti genuinamente dilettantistici e non imprese mascherate.
- Collaboratore sportivo dilettante (istruttore, allenatore, atleta, etc.): è il soggetto che presta l’attività sportiva o gestionale e percepisce il compenso. Spesso è una figura che svolge questa collaborazione nel tempo libero o come integrazione di reddito, potendo anche avere altro lavoro principale. Fino al 2022 questi collaboratori venivano trattati fiscalmente come “persone fisiche percettrici di redditi diversi” e in molti casi non presentavano dichiarazione se restavano sotto le soglie. Con la riforma 2023, diventano a tutti gli effetti “lavoratori sportivi”, sebbene con tutele e oneri ridotti. Dal punto di vista del rischio accertamento, il collaboratore potrebbe ricevere un avviso di accertamento IRPEF qualora il Fisco rilevi che ha percepito compensi sportivi tassabili che non ha dichiarato. Ciò può avvenire, ad esempio, se ha superato la soglia esente e non ha dichiarato la parte eccedente, oppure se i compensi provenivano da un ente non riconosciuto (per cui non spettava l’esenzione) o ancora se l’attività non era veramente dilettantistica. Un caso tipico: un istruttore di palestra percepisce €12.000 nel 2022 da una ASD, pensando di non dover fare nulla; l’ASD però avrebbe dovuto applicare la ritenuta sul 23% su €2.000 (eccedenti i 10k) ma non l’ha fatto, oppure l’ha fatto ma il soggetto aveva altri redditi e comunque avrebbe dovuto dichiarare qualcosa. Il Fisco incrocia i dati (tramite le comunicazioni CU o verifiche bancarie) e invia un accertamento al collaboratore per “omessa dichiarazione di €X di redditi di lavoro autonomo/sporivo”. In tali frangenti, il collaboratore deve difendersi mostrando di rientrare nelle condizioni di esenzione (se applicabili) o contestando eventuali errori dell’Ufficio (ad esempio, che quel reddito era già soggetto a imposta sostitutiva e non andava dichiarato). Spesso, tuttavia, il collaboratore ha meno strumenti informativi: molti fanno affidamento sull’ASD per le ritenute. È importante sapere che l’ente erogante è responsabile d’imposta per le ritenute non operate, ma ciò non esonera il percettore dall’obbligo dichiarativo se le somme dovevano essere tassate ordinariamente. Dal punto di vista contributivo, il collaboratore dilettante prima del 2023 era totalmente escluso da contribuzione (non maturava pensione su quei compensi); ora, se supera i 5k annui, avrà un conto contributivo (utile anche per lui). Un caveat: se un collaboratore sportivo percepisce compensi da un soggetto che non è un’ASD/SSD riconosciuta, tali somme non rientrano affatto nel regime agevolato (esempio: un personal trainer pagato da un privato club non affiliato CONI, o da una SRL commerciale). In tal caso, quelle somme sarebbero redditi di lavoro autonomo o dipendente a tutti gli effetti e la mancata dichiarazione configurerebbe un’evasione. Il collaboratore dovrà allora argomentare – se possibile – che credeva in buona fede di operare in contesto dilettantistico, ma questa difesa è debole sul piano strettamente tributario (può invece rilevare per chiedere la non applicazione di sanzioni, invocando l’esimente di incertezza normativa oggettiva o l’affidamento ex L. 212/2000).
Allenatori e istruttori sportivi dilettanti spesso dedicano tempo e competenze alle associazioni senza perseguire un guadagno, ricevendo solo rimborsi o piccoli compensi. Il regime fiscale di favore li esonera da imposte entro certe soglie, riconoscendo la natura amatoriale del loro impegno. Tuttavia, se tali collaborazioni si trasformano in occupazioni abituali e ben retribuite, l’Amministrazione finanziaria può riqualificarle come lavoro vero e proprio, con obbligo di versare imposte e contributi.
- Dirigenti e amministratori dell’ASD/SSD: spesso all’interno di un’associazione sportiva dilettantistica, i membri del direttivo (presidente, consiglieri, ecc.) operano a titolo gratuito o con semplici rimborsi spese. La normativa agevolata consente di corrispondere compensi sportivi anche ai dirigenti che svolgano funzioni indispensabili per lo sport dilettantistico non retribuite da altri (ad esempio un direttore di gara, o un dirigente accompagnatore di una squadra) . Tuttavia, quando i dirigenti percepiscono stipendi o indennità elevate, scatta il rischio di ripresa fiscale: come evidenziato, compensi ai dirigenti superiori del 20% ai livelli di mercato sono considerati utili mascherati . Se un accertamento evidenzia ad esempio che il presidente dell’ASD ha ricevuto €50.000 annui di “compenso sportivo” (magari formalmente come istruttore), il Fisco può contestare sia al presidente (omessa dichiarazione di reddito da lavoro) sia all’ASD (indebita distribuzione di utili e decadenza dalle agevolazioni). La difesa in questo caso può essere complicata: occorrerebbe dimostrare che la somma era giustificata da reali prestazioni e non era in eccesso. Ma la Cassazione su questo punto è stata drastica, introducendo una presunzione assoluta di elusione se i compensi eccedono del 20% i contratti collettivi . Ciò toglie spazio a giustificazioni quali qualifiche personali superiori o straordinari (giudicate irrilevanti) . In sostanza, i dirigenti di ASD devono accettare compensi modesti, altrimenti l’ASD rischia grosso. Dal punto di vista sanzionatorio, va ricordato che i rappresentanti legali pro-tempore dell’ASD rispondono in solido con l’ente per le obbligazioni tributarie dell’associazione, anche se riferite a periodi precedenti al loro mandato . Dunque, se viene accertata un’evasione fiscale per compensi non dichiarati dall’ASD, l’Agenzia Entrate può chiedere il pagamento anche all’attuale presidente (nei limiti della solidarietà prevista dal D.Lgs. 472/1997, art. 11).
- Prestatori occasionali nello sport: la categoria dei “prestatori di lavoro sportivo occasionale” è stata formalizzata dal 2023, ma ancor prima molte ASD ricorrevano a collaborazioni saltuarie remunerate tramite prestazioni occasionali ex art. 2222 c.c. (quindi non rientranti nel perimetro art. 67 TUIR). Ad esempio, il custode del campo sportivo pagato a chiamata, o un istruttore che sostituisce saltuariamente il titolare per poche lezioni, spesso venivano inquadrati come autonomi occasionali. La distinzione è sottile: se il prestatore occasionale non svolge attività sportiva in senso stretto ma un servizio accessorio, o se comunque l’ASD preferisce non qualificarlo come sportivo dilettante, può applicare le regole ordinarie del lavoro autonomo occasionale (ritenuta d’acconto 20% oltre €5.000 annui complessivi, obbligo di dichiarazione oltre €5.000, etc.). Tali compensi non godono della esenzione sportiva. In sede di controllo, può succedere il contrario: il Fisco talvolta riqualifica come lavoro subordinato ciò che l’ASD qualificava come “prestazione occasionale sportiva”. Ad esempio, un custode che ogni giorno apre e pulisce gli impianti per un compenso fisso mensile, pur senza contratto, in caso di ispezione potrà essere considerato dipendente di fatto (come accaduto nell’esempio pratico più avanti). In uno scenario simile (accertamento misto fiscale-previdenziale), l’ASD si vede contestare il mancato versamento di ritenute IRPEF e contributi su quello che di fatto era un stipendio più che un compenso dilettantistico. La difesa consisterà nel cercare di dimostrare la reale saltuarietà/occasionalità del rapporto, oppure almeno nel negoziare un inquadramento come co.co.co. sportivo anziché lavoro subordinato, per ridurre sanzioni.
Riassumendo, ASD/SSD e collaboratori sono legati da un rapporto che nel mondo ideale è di volontariato retribuito simbolicamente, ma nella pratica può assumere connotati lavorativi. Il Fisco e l’INPS vigilano su questo confine. Nella tabella seguente riepiloghiamo i tipi di soggetti e il regime applicabile ai compensi:
| Soggetto/figura | Inquadramento dei compensi | Tassazione IRPEF | Contributi INPS |
|---|---|---|---|
| ASD/SSD (ente erogante) | Reddito dell’ente non commerciale (se requisiti ok). Se perde requisiti: proventi tassati come enti commerciali. | Esenti su attività istituzionali; forfettari regime 398 su commerciali. Ritenute su compensi dilett. > soglia. | Datori di lavoro se collaborazioni qualificate come lavoro. Obblighi contributivi se collaboratore >€5k (dal 2023). Solidarietà del rappresentante legale. |
| Collaboratore sportivo dilett. | Fino al 2022: reddito diverso art. 67 TUIR. Dal 2023: reddito da lavoro (dipendente o autonomo) con regime speciale. | Fino a €10k (ora €15k) esente; eccedenza: 23% imposta sostitutiva (ante 2023) o tassazione ordinaria (post 2023). Obbligo dichiarazione se > soglia (post-riforma). | Nessuno fino a €5k. Oltre €5k annui: iscrizione gestione sport INPS, contribuzione su eccedenza. No contributi pre-2023 se prestazione dilettantistica genuina (onere prova su ASD). |
| Dirigente di ASD/SSD | Se svolge mansioni sportive/gestionali dilett.: può percepire compensi ex art. 67 TUIR (fino al 2022) o lavoro sport (dal 2023). | Come collaboratore dilett. (ma attenzione a limiti: >20% CCNL = utili). Oltre soglia tassazione come reddito diverso (pre-23) o reddito lavoro (post-23). | Stesse regole collaboratore. Se però compenso elevato e continuativo: alto rischio riqualificazione a lavoro subordinato con contributi dovuti. |
| Prestatore sport occasionale** | Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) se non rientra in ambito sport dilett. riconosciuto. | Tassazione ordinaria con ritenuta d’acconto 20% se >€5k (soglia oltre la quale va dichiarato). Non beneficia di esenzione 10k/15k perché fuori ambito art. 67. | Contributi gestione separata INPS se >€5k annui (con aliquota 33%). Non rientra nel regime sport se prestazione non inquadrata come “lavoro sportivo”. |
(Tabella 1: Tipologie di soggetti e trattamento fiscale/previdenziale dei compensi sportivi dilettantistici)
Cause più comuni di accertamento per “omissione di compensi” sportivi
Dopo aver delineato chi sono i protagonisti e qual è la cornice normativa, esaminiamo quando e perché scatta un accertamento fiscale relativo ai compensi sportivi dilettantistici. L’“omissione di compensi” in questo contesto può riferirsi a diverse situazioni, tra cui: redditi non dichiarati dal percipiente, ritenute non operate dall’associazione, mancato pagamento di imposte o contributi dovuti su tali somme, oppure ancora la perdita di agevolazioni che rende retroattivamente imponibili importi inizialmente esenti. Ecco le cause più frequenti:
- Superamento della soglia esente senza adeguata tassazione: come visto, esiste un limite annuo (€10.000 fino al 2022, €15.000 dal 2023) entro il quale i compensi sportivi sono esenti. Se un collaboratore eccede questo limite e l’eccedenza non viene tassata o dichiarata correttamente, si configura un’omissione. Ad esempio, Tizio allenatore percepisce €12.000 nel 2022 da un’ASD, la quale però non gli ha applicato alcuna ritenuta sui €2.000 eccedenti i 10k; né Tizio li ha indicati in dichiarazione (magari perché erroneamente convinto di non doverla presentare). L’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati (l’ASD avrebbe dovuto in teoria comunicare tali compensi nel modello 770/CU), rileva che Tizio ha “nascosto” €2.000 di redditi e gli notifica un avviso di accertamento per IRPEF evasa su quell’importo. Oppure, Caio atleta nel 2024 percepisce €18.000 e non dichiara i €3.000 oltre soglia 15k: caso analogo. Queste situazioni sono un tipico bersaglio dei controlli automatizzati o formali.
- Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nonostante la dovuta: collegato al punto precedente, molti collaboratori sportivi non presentavano alcuna dichiarazione ritenendo (spesso a ragione) di essere esenti. Ma se in un anno hanno avuto anche solo €1 oltre la soglia esente che non era coperto da ritenuta a titolo d’imposta, allora formalmente avrebbero dovuto presentare il Modello Redditi e includere quella parte di reddito. L’Agenzia Entrate, per legge, può contestare dichiarazione omessa se il contribuente non ha presentato il modulo pur avendo imposte dovute. Nel caso dei compensi sportivi, finché vigeva la ritenuta imposta fino a ~30k, la maggioranza dei percettori non era tenuta a dichiarare nulla. Dal 2024 però la parte eccedente i 15k è soggetta a tassazione ordinaria e dunque deve essere dichiarata. Di conseguenza, aumenteranno i controlli sulle dichiarazioni dei percettori di compensi sportivi significativi. Inoltre, se il contribuente aveva anche altri redditi (es. da lavoro dipendente) tali da obbligarlo comunque al dichiarativo, l’omessa indicazione dei compensi sportivi (anche sotto soglia) può essere contestata come infedele dichiarazione.
- Compensi erogati da enti non qualificati o non riconosciuti: la norma agevolativa richiede che l’erogatore sia il CONI, federazioni, enti di promozione o organismi riconosciuti dal CONI (come le ASD/SSD iscritte) . Se i compensi provengono da un soggetto che non rientra in tali categorie, non godono dell’esenzione. Un caso tipico è l’associazione che non è iscritta al Registro CONI (magari perché decaduta dall’iscrizione o perché è una mera associazione culturale che fa anche sport). Oppure un ente che perde successivamente la qualifica. La Cassazione ha sottolineato che l’affiliazione formale al CONI è condizione necessaria ma non sufficiente per le agevolazioni ; tuttavia, se manca, automaticamente il Fisco considera l’ente come non avente diritto al regime. Pertanto, i compensi pagati da quell’ente diverrebbero redditi imponibili ordinariamente. In un controllo potrebbe emergere che i collaboratori avrebbero dovuto dichiarare quelle somme (ad esempio come lavoro autonomo occasionale). L’omessa dichiarazione in capo ai percettori è quindi contestata. In parallelo, l’ente potrebbe ricevere un atto per aver indebitamente applicato l’esenzione.
- Riqualificazione del rapporto in lavoro professionale o subordinato: questa è una causa frequente di rilievi previdenziali ma con riflessi fiscali. Se un’ASD paga mensilmente un istruttore per anni, con orari e compiti analoghi a quelli di un dipendente, gli organi ispettivi (INPS o Ispettorato del Lavoro) potrebbero riqualificare quel rapporto come subordinato. Come conseguenza: l’ASD avrebbe dovuto versare contributi e operare ritenute IRPEF da lavoro dipendente sin dal principio. Nel caso affrontato dalla Cassazione nel 2025, ad esempio, un’associazione sosteneva che istruttori e segretarie rientrassero nell’esenzione sportiva, ma i giudici hanno verificato che l’attività era svolta con abitualità e continuità professionale, svelando la natura di vero rapporto di lavoro e negando l’esenzione . Risultato: contributi INPS dovuti su tutti i compensi erogati e, dal lato fiscale, quei compensi andavano trattati come normali salari (quindi con ritenute progressive IRPEF, 13esima, ecc.). L’accertamento può originare da un verbale ispettivo INPS (avviso di addebito per omissione contributiva), spesso seguito da segnalazione all’Agenzia Entrate per la parte tributaria. In sintesi, ciò che inizialmente era esente diventa base imponibile, generando richieste di imposta e sanzioni per “compensi non gestiti correttamente”. La difesa in tal caso deve cercare di contestare la riqualificazione (dimostrando l’assenza degli indici di subordinazione/professionalità) oppure limitare il periodo e l’importo del ricalcolo.
- Omissione di ritenute alla fonte da parte dell’ASD: se l’associazione non ha operato la ritenuta del 23% dove era dovuta (ad esempio sul pezzo eccedente i 10.000 euro ante 2023), l’Agenzia può emettere un atto di contestazione verso l’ASD come sostituto d’imposta. In tal caso, l’ufficio chiede all’ente il versamento delle ritenute non fatte, più sanzione del 20% su di esse (D.Lgs. 471/97 art. 14) e interessi. Questo è un accertamento diverso dall’omessa dichiarazione del percettore, e può accadere parallelamente. Per continuare l’esempio di Tizio allenatore con €12.000 nel 2022: l’Agenzia potrebbe chiedere a Tizio l’IRPEF su €2.000 (percepiti e non tassati) e contemporaneamente sanzionare l’ASD per non aver trattenuto il 23% su quei €2.000. Esiste infatti una responsabilità solidale ma distinta: il sostituto che omette la ritenuta è obbligato in solido al pagamento dell’imposta non trattenuta e delle relative sanzioni. Una difesa qui potrebbe sostenere che quei €2.000 erano comunque stati considerati dall’ASD in altra maniera (difficile) oppure puntare su un’istanza di remissione in autotutela (ad esempio se per errore di calcolo non si applicò la ritenuta, l’ufficio potrebbe ridurre sanzioni se l’ASD paga subito). Importante: l’ASD ha un dovere generale di corretta applicazione delle ritenute come ogni sostituto.
- Compensi eccessivi o indebiti, con perdita delle agevolazioni: scenario delicato è quando l’Agenzia contesta all’ASD di aver elargito compensi tali da violare il divieto di distribuzione di utili. Un caso pratico: due soci amministratori di un’ASD percepiscono nel 2015 compensi superiori del 30% rispetto ai parametri di un CCNL pertinente (poniamo, incarico di direttore tecnico retribuito €40k quando un pari livello in un club professionistico ne prenderebbe €25k). Il Fisco potrebbe emettere un avviso di accertamento dichiarando che l’ASD ha distribuito utili in maniera indiretta e quindi non è più ente non profit per il 2015. Le conseguenze: tutti i ricavi “istituzionali” di quell’anno diventano commerciali e tassati, l’ASD perde l’IVA agevolata, e i compensi stessi ai soci devono essere trattati come redditi da lavoro dipendente o assimilato. In sostanza, uno scenario catastrofico. Nel caso reale (Cass. 17487/2022, e successiva ord. 2025 citata), la Cassazione ha dato ragione all’Agenzia: la norma (art. 10, c.6, lett. e, D.Lgs. 460/1997) va applicata alla lettera, oltre +20% è sempre utili . La difesa tentata dall’ASD (giustificare i maggiori compensi con straordinari, notturni, competenze specifiche) è stata rigettata perché irrilevante rispetto alla presunzione assoluta . In sede di accertamento, l’ASD in questione era riuscita a vincere nei gradi di merito, ma la Cassazione ha cassato la sentenza favorevole e disposto il riesame . Dunque se un’associazione si vede contestare una simile violazione, la strategia difensiva è complessa: occorre evitare di trovarsi con la pistola fumante (cioè compensi fuori misura). Se ciò è già avvenuto, si può provare a sostenere che il contratto collettivo di riferimento non era quello indicato dal Fisco, o che il paragone doveva includere alcune voci di costo (ma come visto la Cassazione vuole confronto al lordo, senza costi aziendali) . In pratica, su questo punto la difesa può solo limitarsi a contestazioni procedurali o cercare un accordo in adesione per attenuare le sanzioni.
- Altre irregolarità formali sostanziali: infine, ci sono una serie di mancanze che, pur non riguardando direttamente i compensi, portano a contestazioni che indirettamente colpiscono anche quelli. Ad esempio, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (obbligo per ASD di pagare spese oltre €1000 con mezzi tracciati): se un controllo della GdF scopre compensi pagati in contanti oltre soglia, potrebbe applicare sanzioni e considerare quei pagamenti come indici di irregolarità fiscale, talora insinuando che fossero “in nero” oltre ai libri contabili. Oppure, la mancata presentazione del modello EAS (comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali per enti associativi) entro i termini: la giurisprudenza recente per fortuna non punisce più con la perdita automatica delle agevolazioni se l’EAS è tardivo ma l’ente è sostanzialmente corretto . Tuttavia, l’Ufficio può usarlo come elemento a sfavore in un contenzioso, sostenendo che l’associazione era poco trasparente. Anche la tenuta incompleta del libro soci o dei verbali può essere contestata come elemento sintomatico (ma non sufficiente di per sé a far decadere il regime, secondo alcune CTR e Cassazione ). Se però questi elementi si sommano a compensi ingestibili, il quadro accusatorio si aggrava: ad esempio, l’associazione che non convoca mai assemblee, non aggiorna i soci e intanto paga cifre elevate a uno staff ristretto di persone rischia di apparire come un’azienda di fatto.
In conclusione, un accertamento fiscale in ambito di sport dilettantistico nasce sovente da un sospetto di abuso o irregolarità: o l’ente sta mascherando attività commerciali/professionali (utile d’impresa o rapporti di lavoro) dietro lo schermo dilettantistico, oppure il singolo contribuente ha beneficiato indebitamente dell’esenzione non dichiarando redditi imponibili. L’Agenzia delle Entrate motiva i propri avvisi di regola evidenziando questi aspetti, spesso basandosi su verbali di verifica della Guardia di Finanza o su controlli incrociati (es. dati dei pagamenti, accrediti bancari, assenza di dichiarazioni a fronte di CU trasmesse, ecc.).
È utile evidenziare che la Corte di Cassazione ha ormai delineato una sorta di “decalogo” dei requisiti per riconoscere l’agevolazione fiscale alle ASD/SSD . Questo decalogo comprende: il rispetto puntuale di tutti i requisiti formali ex art. 148 TUIR e art. 90 L.289/2002 (niente distribuzione utili, denominazione corretta, affiliazione, democraticità, devoluzione patrimonio, ecc.) , e soprattutto la verifica che l’attività svolta in concreto sia prevalentemente sportiva dilettantistica e non commerciale . I giudici tributari di merito devono controllare se i soci partecipano davvero alla vita associativa, se esiste un fine promozionale genuino, e se eventuali entrate commerciali (sponsorizzazioni, corsi aperti a non soci, ecc.) rimangono mezzi per sostenere lo sport e non il fine principale . In mancanza di ciò, l’ente decade dai benefici e i proventi – compensi inclusi – vengono tassati ordinariamente . Questo orientamento giurisprudenziale severo fa sì che spesso in giudizio la questione centrale diventi dimostrare la genuinità o meno del fine non lucrativo: da un lato il Fisco porta indizi di “imprenditorialità occulta” (conti economici anomali, utili girati a dirigenti, assenza di attività sportiva rivolta ai soci, ecc.), dall’altro l’associazione difende la propria missione mostrando tornei, eventi sociali, piccole perdite, bilanci trasparenti, ecc. . Anche per i compensi, dunque, la loro sorte fiscale dipende in larga parte dal contesto: elargizioni moderate in un contesto chiaramente dilettantistico saranno viste con favore; retribuzioni elevate in un ente opaco desteranno presunzione di lucro.
Procedura di accertamento fiscale: fasi, garanzie e tempi
Quando un’associazione sportiva o un collaboratore viene sottoposto a verifica fiscale, si innesca un iter procedurale che ha regole ben definite dal D.P.R. 600/1973 (per le imposte sui redditi) e dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000). Conoscerne le fasi è importante per poter esercitare pienamente i propri diritti di difesa in ogni momento. Di seguito descriviamo sinteticamente le tappe tipiche di un accertamento fiscale in questo ambito:
- Accesso, ispezione e verifica: Spesso tutto inizia con un controllo presso la sede dell’ASD/SSD da parte della Guardia di Finanza o funzionari dell’Agenzia Entrate. Questi accessi possono essere mirati (ad esempio, se l’ASD è in una lista di controlli per chi ha optato legge 398/91, o se sono arrivate segnalazioni) oppure derivare da incroci di banche dati. Durante la verifica, i funzionari esaminano libri contabili, rendiconti, statuto, ricevute e altri documenti . Possono anche sentire a verbale i rappresentanti o raccogliere testimonianze (nel caso contributivo-lavoristico, anche i collaboratori possono essere intervistati per capire la natura del rapporto). Ad esempio, nel caso citato di Cass. 2025 su istruttori, fu determinante la testimonianza di una collaboratrice che descrisse orari e ordini ricevuti, provando la subordinazione . Lo Statuto del Contribuente garantisce alcune tutele in questa fase: l’accesso deve avvenire in orari di ufficio, consegnare copia del ordine di accesso, e l’ASD può farsi assistere da un professionista. Se la verifica è complessa, i verificatori possono richiedere documenti integrativi e proseguire fuori sede le analisi. Nel frattempo, l’ASD farebbe bene a collaborare e iniziare a raccogliere eventuali memorie difensive.
- Processo Verbale di Constatazione (PVC): al termine dell’ispezione, la Guardia di Finanza o l’ufficio redige un PVC, in cui vengono elencati i fatti accertati e le violazioni riscontrate. Ad esempio, un PVC potrebbe contestare: “accertata la corresponsione di €X a titolo di compensi sportivi non documentati da quietanze, riteniamo siano ricavi non dichiarati”; oppure “verificata la mancanza dei requisiti statutari, l’ente va considerato commerciale nel 20XX”; o ancora “riscontrato rapporto di lavoro dipendente con Tizio non registrato, contributi e ritenute evase per €Y”. Il PVC deve essere consegnato (notificato) al contribuente. Da quel momento scattano le garanzie dell’art. 12 c.7 L.212/2000: il contribuente ha diritto a presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni, e l’ufficio non può emettere avviso di accertamento prima di tale termine (salvo casi di particolare urgenza, come scadenza termini di decadenza) . Questa pausa procedimentale è cruciale: consente all’ASD (o al contribuente) di predisporre una memoria difensiva per confutare le conclusioni del PVC . Ad esempio, se nel PVC si contesta un utile di €5.000 del bar sociale come ricavo imponibile, l’ASD potrà nei 60 gg provare che in realtà quel bar era in perdita e i 5k erano frutto di un’analisi errata . E infatti è proprio ciò che dovrebbe fare: allegare documenti, fornire giustificazioni, evidenziare errori di calcolo o interpretazione nel PVC. La presentazione di osservazioni non è obbligatoria ma altamente raccomandata: in alcuni casi l’ufficio può accogliere in autotutela parziale le istanze e ridurre o annullare alcune contestazioni prima di emettere l’atto finale. Nel nostro esempio, l’ASD ha inviato una memoria spiegando che il bar era gestito in perdita, allegando fatture di costi superiori ai ricavi, e che certi pagamenti soci in contanti erano stati regolarizzati .
- Emissione dell’Avviso di Accertamento: trascorsi (o anche proprio allo scadere) i 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di accertamento, che è l’atto formale con cui si quantificano le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti. L’avviso deve essere motivato (cioè spiegare su quali elementi si basa, spesso richiamando il PVC) e notificato al contribuente. Nel nostro esempio, l’avviso arrivò pochi mesi dopo il PVC, chiedendo €2.500 tra imposte e sanzioni all’ASD per IRAP e IRES su presunti utili non dichiarati e compensi al custode . L’atto imponeva anche, come da prassi, il versamento di 1/3 delle somme se si voleva fare ricorso (cosiddetta “condizione di efficacia” del ricorso introduttivo, poi abolita dal 2022 per importi sotto €50k, ma in generale l’ufficio invita sempre al versamento cautelativo) . A questo punto il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per decidere come reagire: può pagare (tutto o con acquiescenza agevolata), oppure avviare un procedimento di definizione dell’accertamento (adesione), oppure presentare ricorso in Commissione Tributaria (ora rinominata Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado). Nella sezione successiva dettagliamo queste opzioni difensive. Qui rileviamo che l’avviso può riguardare diversi tributi: IRPEF, IVA, IRAP, ritenute, addizionali, ecc., a seconda di cosa è contestato. Nel caso di compensi sportivi, tipicamente si avrà IRPEF e addizionali evase per il collaboratore, o IRES/IVA/IRAP negate per l’ASD se perde il regime, oppure sanzioni per ritenute omesse.
- Pagamento, adesione o impugnazione: queste sono le strade possibili. Il contribuente/debitore deve valutare i pro e contro:
- Se paga integralmente entro 60 giorni, beneficia di una riduzione delle sanzioni a 1/3 (c.d. acquiescenza ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 218/97) e chiude la questione . Questa opzione ha senso se l’accertamento è fondato e l’importo non eccessivo, oppure se si vuole evitare spese legali e interessi di mora. Nel fare acquiescenza bisogna rinunciare a impugnare.
- Se intende trattare con l’ufficio, può presentare istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) entro gli stessi 60 giorni. Ciò sospende i termini per l’eventuale ricorso e apre una fase di contraddittorio bonario, in cui contribuente e Agenzia discutono e possono trovare un accordo su un importo ridotto. Di solito l’adesione porta a una riduzione sia della pretesa (base imponibile ricalcolata) sia delle sanzioni (per legge ridotte a 1/3 del minimo) . Ad esempio, sanzione del 90% potrebbe scendere al 30%. Approfondiremo a breve questo strumento.
- Se il valore in contestazione (imposte al netto interessi e sanzioni) non superava €50.000 e l’atto è stato notificato prima del 2024, era obbligatorio presentare prima un reclamo-mediazione all’ufficio (art. 17-bis D.Lgs. 546/92). Dal 2024 la mediazione non è più obbligatoria per i nuovi ricorsi , ma rimane possibile su base volontaria. In sostanza, la mediazione tributaria era un tentativo di accordo pre-processuale simile all’adesione ma attivato col deposito del ricorso stesso. Ne parleremo più avanti tra gli strumenti deflattivi.
- Se si opta per la via giudiziale, entro 60 giorni va notificato il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) competente. Per gli atti 2023 e seguenti non serve più passare dal reclamo obbligatorio, quindi si può andare diretti in causa. Nel ricorso si espongono i motivi per cui l’avviso sarebbe illegittimo o infondato. Nel nostro esempio, l’ASD ha presentato ricorso puntando sugli errori di valutazione del Fisco (contestando il calcolo dell’utile del bar e la natura dell’attività) . Ha anche versato intanto il 33% delle somme per ottenere la sospensione automatica della riscossione (norma che prevedeva tale versamento per importi sopra soglia, ma anch’essa è stata modificata con la riforma del processo tributario 2022). In ogni caso, il ricorso può essere accompagnato da istanza di sospensione dell’atto se il pagamento immediato arreca danno grave.
- Fase contenziosa: qualora si vada in giudizio, si apre la causa tributaria. Questo va oltre lo scopo di questa guida entrare nei dettagli processuali; tuttavia, è bene sapere che in primo grado si discuterà davanti a giudici tributari specializzati (dal 2023 c’è anche la figura del giudice monocratico per cause sotto €3.000, innalzato a €5.000 , ma raramente applicabile in queste materie che di solito superano tali importi). Durante il processo, è ancora possibile trovare un accordo con l’ufficio tramite la conciliazione giudiziale: in ogni stato e grado le parti possono conciliare, con vantaggi sulle sanzioni (ridotte al 40% del minimo in primo grado, o 50% in appello) . Ad esempio, se emerge che l’ASD ha qualche ragione e l’AdE vuole chiudere, potrebbero accordarsi riducendo imposta e sanzioni, il tutto formalizzato in una conciliazione omologata dal giudice. Se invece si arriva a sentenza, la Corte tributaria deciderà se annullare l’atto (in tutto o in parte) o confermarlo. In caso di esito negativo, resta la possibilità di appello in secondo grado e infine in Cassazione per motivi di diritto. Nel frattempo, le somme dovute (un terzo dopo la sentenza di primo grado, due terzi dopo l’appello) devono essere versate salvo sospensioni.
Nel contesto in esame, molti contenziosi vertevano – e verteranno – su questioni di fatto (la natura effettiva dell’attività, la documentazione, ecc.) e questioni di diritto (interpretazione delle norme agevolative, condizioni di decadenza, ecc.). La Cassazione ad esempio ha dovuto chiarire alcuni aspetti giuridici controversi, come: l’effetto del tardivo modello EAS, la portata delle clausole statutarie obbligatorie, la qualificazione delle entrate “istituzionali” e “commerciali”. Saper citare in ricorso la giurisprudenza favorevole è spesso decisivo per orientare il giudice di merito.
Un ultimo elemento procedurale: i termini di decadenza per l’accertamento. Normalmente l’Agenzia Entrate può notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (se omessa, entro il settimo). Per i redditi 2017, ad esempio, il termine era fine 2023. Ciò implica che per i compensi sportivi 2018-2022 c’è ancora spazio temporale per controlli (fino a fine 2024-2028 rispettivamente). Sul fronte contributivo, l’INPS ha termini di prescrizione quinquennali. Quindi, anche a distanza di diversi anni dagli eventi, un’associazione potrebbe ricevere accertamenti su annualità passate.
Strumenti deflattivi e strategie di difesa del contribuente
Di fronte a un accertamento per omessi compensi da attività sportiva dilettantistica, il contribuente (sia esso l’ASD/SSD o il singolo collaboratore) dispone di vari strumenti per evitare o ridurre il contenzioso, nonché di argomentazioni difensive sostanziali per far valere le proprie ragioni. In questa sezione esamineremo le principali strategie difensive, distinguendo tra quelle attuabili in fase pre-contenziosa (autotutela, accertamento con adesione, mediazione) e quelle da impiegare in sede di ricorso (motivi di impugnazione, prove a discarico, ecc.).
Autotutela: far correggere o annullare l’atto dall’ufficio stesso
L’autotutela è il potere/dovere dell’Amministrazione finanziaria di correggere spontaneamente i propri errori. Il contribuente può sollecitare l’autotutela presentando un’istanza motivata all’ufficio che ha emesso l’atto, evidenziando errori di fatto o di diritto che rendono l’accertamento invalido o improprio. In materia di compensi sportivi, esempi di errori correggibili in autotutela possono essere: – Errore di calcolo: es. l’ufficio ha computato due volte lo stesso compenso, sovrastimando l’importo evaso. – Errore di persona: l’avviso indirizzato al collaboratore X per un compenso percepito, ma in realtà quel compenso era percepito da Y (scambio di codici fiscali). – Violazione del diritto di contraddittorio: l’accertamento è stato emanato prima dei 60 giorni dal PVC senza urgenza, violando l’art. 12 c.7 L.212/2000 (in taluni casi la giurisprudenza annulla l’atto per questo vizio). L’ufficio in autotutela potrebbe rinnovare l’atto rispettando il termine, se ancora nei termini. – Evidente sussistenza dei requisiti agevolativi: ad esempio, l’ufficio ha contestato mancanza di affiliazione CONI ma il contribuente allega certificato CONI comprovante l’iscrizione nel periodo d’imposta. Di fronte a prova evidente, l’ufficio può annullare la parte di rilievo. – Errore nell’applicazione delle soglie: ad es. l’accertamento chiede IRPEF su €8.000 di compensi credendo fossero oltre il limite, ma il contribuente dimostra con documenti che in quell’anno aveva altri €2.000 di rimborsi fuori comune documentati, quindi in realtà era sotto soglia tassabile; l’ufficio potrebbe riconoscerlo in autotutela.
Va detto che l’autotutela è discrezionale: l’Ufficio non è obbligato a concederla nemmeno se il contribuente ha ragione (salvo in casi di palese errore di persona o doppia imposizione). Tuttavia, tentarne la via è sempre opportuno, magari parallelamente ad altre azioni. Un’istanza di autotutela ben documentata, inviata subito dopo la notifica dell’accertamento, può indurre l’Ufficio a rivedere parzialmente le sue pretese. Non sospende i termini di ricorso: quindi va fatta senza contare su un riscontro certo, per cui ci si deve comunque preparare a fare ricorso o adesione entro 60 giorni.
Nel nostro esempio, l’ASD aveva già di fatto esercitato una forma di autotutela preventiva presentando la memoria dopo il PVC (che è un momento “semi-autotutelare”). Se l’ufficio avesse accolto, avrebbe potuto non emettere affatto l’avviso su quella parte. Nei casi più macroscopici (erronee duplicazioni, chiusura per condono non considerata, ecc.) a volte l’Agenzia annulla l’atto in autotutela anche dopo l’impugnazione, cessando la materia del contendere.
Consigli pratici: presentare l’istanza di autotutela indirizzata al dirigente dell’ufficio accertatore, indicando gli estremi dell’atto, spiegando chiaro l’errore e allegando la prova. Se la situazione lo consente, contattare telefonicamente o recarsi in ufficio per discuterne con il funzionario può accelerare la soluzione. Mai limitarsi solo all’autotutela se il termine di ricorso incombe, perché non dà garanzie sospensive.
Accertamento con adesione: negoziare un accordo favorevole col Fisco
L’accertamento con adesione (disciplinato dal D.Lgs. 218/1997) è uno strumento fondamentale per chi vuole evitare una lite lunga e incerta, cercando invece un compromesso con l’Agenzia Entrate. Si tratta in sostanza di una trattativa: il contribuente (o il suo difensore) discute con i funzionari le contestazioni e può ottenere una riduzione della pretesa sia come base imponibile che come sanzioni. Vediamo come funziona e quando conviene utilizzarlo, riferito al nostro contesto:
Procedura: Dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento (o anche un invito a comparire o un PVC specificatamente “adesivabile”), il contribuente può presentare istanza di adesione all’ufficio entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. L’istanza sospende automaticamente il termine per fare ricorso per 90 giorni. L’ufficio a questo punto convoca il contribuente (o può anche rispondere negativamente, ma di solito convoca) per un contraddittorio orale, durante il quale le parti espongono le proprie ragioni. Il contribuente può portare nuovi documenti, elementi attenuanti, evidenziare incertezze interpretative, ecc. L’ufficio, dal canto suo, valuterà se concedere uno “sconto” su imponibili o sanzioni, tenendo conto delle argomentazioni e anche della possibilità di incassare subito evitando un contenzioso dall’esito incerto.
Vantaggi: In caso di accordo, si redige un atto di adesione con il nuovo importo concordato. Le sanzioni vengono automaticamente ridotte ad 1/3 di quelle minime previste per la violazione (o di quelle irrogate se minori) . In soldoni, anziché pagare il 100% o 90% di sanzione per infedele dichiarazione/omessa, si paga circa il 30%. Inoltre non si pagano le spese di giudizio (perché il giudizio viene evitato). Altro vantaggio: il pagamento può essere rateale (fino a 8 rate trimestrali se importo alto). L’adesione evita anche il rischio di sanzioni penali tributarie (in genere il compimento dell’adesione esclude la punibilità per dichiarazione infedele se i debiti sono estinti). Va chiarito che, diversamente dall’acquiescenza, nell’adesione vi è spazio per ridurre la base imponibile: ad esempio, l’Agenzia contesta €50k di ricavi non dichiarati, ma concorda che in realtà erano €30k (magari riconoscendo dei costi); così il contribuente paga su 30k e non su 50k. L’acquiescenza invece richiede il pagamento integrale di quanto contestato (con sanzione ridotta).
Applicazione ai compensi sportivi: Immaginiamo un caso in cui un collaboratore abbia omesso di dichiarare €20.000 imponibili e l’Agenzia chieda IRPEF su tale importo + sanzione 100% = €4.400 di imposte + €4.400 di sanzioni. In adesione, il contribuente potrebbe convincere l’ufficio che €5.000 di quei 20k erano in realtà rimborso spese documentato fuori comune (quindi non imponibile): la base scende a €15k; di questi, €10k erano no tax area, quindi la parte imponibile forse solo €5k (se l’ufficio accetta di considerare quell’anno come dilettantistico regolare): su €5k, imposta 23% = €1.150. Sanzione 1/3 del 90% = 30% = €345. Quindi firmerebbe adesione per €1.495 anziché €8.800 originari – un risparmio enorme. Certo è un caso ideale, ma serve a mostrare il potenziale. Spesso in adesione sul campo i funzionari riconsiderano situazioni borderline: ad esempio, ammettono qualche spesa in più, riconoscono magari che l’ASD è decaduta dal regime solo da un certo mese e non tutto l’anno, ecc. Anche in contesti come la presunzione sui compensi eccessivi >20%, l’ufficio potrebbe in adesione accettare di limitare la contestazione se, ad esempio, quell’anno l’ASD era in perdita e i compensi erano in realtà parzialmente giustificati. Dipende molto dalla forza degli argomenti e dalla discrezionalità dei capi team dell’AdE.
Quando conviene: L’accertamento con adesione è consigliabile quando: – Ci sono effettivamente alcune violazioni, ma si hanno elementi per ridimensionarle. – La documentazione e le argomentazioni sono complesse e si preferisce spiegare a voce all’ufficio (che potrebbe recepire meglio che non in un atto giudiziario). – Si vuole guadagnare tempo (ricordiamo che l’istanza sospende il termine di ricorso di 90 giorni extra). – Le sanzioni sono molto elevate e ridurle a 1/3 sarebbe di per sé un grosso vantaggio. – Non ci sono importanti questioni di principio da far valere in giudizio o l’incertezza sull’esito è alta.
Quando sconsigliabile: se l’accertamento appare del tutto infondato e si hanno precedenti giurisprudenziali solidi per farlo annullare in toto, magari l’adesione potrebbe sembrare un arrendersi. Va anche detto che presentare istanza di adesione non preclude poi di fare ricorso se non ci si accorda o se l’accordo è insoddisfacente. Quindi in realtà tentare l’adesione non toglie diritti (se non il tempo speso). Una volta firmato però l’atto di adesione, non è impugnabile: diventa definitivo e vincolante.
Nel nostro caso esemplificativo, l’ASD ha deciso di non fare adesione perché riteneva la cifra piccola e di avere ragione piena . È una scelta plausibile: su 2.500 € magari neanche l’ufficio avrebbe scontato molto. Su cifre più alte, di solito vale la pena.
Reclamo e mediazione tributaria: situazione attuale e consigli pratici
L’istituto del reclamo-mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92) è stato, fino al 2023, un passaggio obbligato per le controversie di valore fino a €50.000: prima di arrivare davanti al giudice, il contribuente doveva presentare un ricorso in via amministrativa all’ufficio, che fungeva anche da proposta di mediazione. Dal 1° gennaio 2024, la mediazione tributaria non è più obbligatoria per i nuovi ricorsi, in seguito alla riforma operata con D.Lgs. 156/2015 e la Legge Delega n. 111/2023 (attuata poi col D.Lgs. 130/2022 e D.Lgs. 119/2023) . In pratica, per gli atti notificati dal 2024, si può ricorrere direttamente al giudice senza dover esperire il reclamo. Ciò non significa che la mediazione sparisca del tutto: essa rimane possibile su base volontaria, e all’atto pratico può convergere con la conciliazione giudiziale.
Per gli avvisi di accertamento notificati fino al 31/12/2023, invece, se il valore della lite (imposte contestate, al netto sanzioni e interessi) non superava €50.000, era necessario iniziare con un reclamo. Ad esempio, se a un collaboratore veniva contestato €8.000 di IRPEF evasa, doveva proporre reclamo all’ufficio entro 60 giorni, aspettare 90 giorni (termine di risposta/meditazione) e poi, se non c’era accordo, il reclamo si trasformava in ricorso e si andava avanti in Commissione. In quella fase l’ufficio poteva accogliere parzialmente il reclamo o proporre una mediazione con rideterminazione delle somme. I vantaggi della mediazione erano simili a quelli della conciliazione: sanzioni ridotte (la prassi le riduceva al 40% del minimo, secondo circolare 33/2012 , anche se alcuni autori parlavano di 35% in proposte di riforma mai attuate ) e pagamento rateale. Con l’abrogazione dell’obbligatorietà, oggi il contribuente in fascia bassa può direttamente fare ricorso e poi eventualmente cercare la conciliazione col supporto del giudice.
Consiglio: per accertamenti su compensi sportivi di modesta entità (sotto 50k) notificati nel 2023 o prima, se si è ancora nei termini, conviene comunque allegare al ricorso una proposta di mediazione o richiesta di esame in autotutela, in modo da manifestare apertura a soluzioni. L’ufficio potrebbe, anche se non più costretto, contattare per un accordo. Per gli atti dal 2024 in poi, ci si concentra sull’adesione (prima dell’eventuale ricorso) o direttamente sulla conciliazione in giudizio.
Difendersi in giudizio: motivi di ricorso e prove a favore del contribuente
Se si arriva al ricorso tributario, è fondamentale impostare adeguatamente i motivi di impugnazione dell’avviso e raccogliere tutte le prove e argomentazioni giuridiche a proprio favore. Nel contesto che trattiamo, i possibili motivi di ricorso includono sia vizi formali/procedurali dell’atto, sia questioni di merito sulla corretta interpretazione delle norme e valutazione dei fatti. Elenchiamo i più frequenti motivi difensivi che un contribuente (meglio se assistito da un avvocato tributarista esperto in fiscalità sportiva) può invocare:
- Violazione del contraddittorio endoprocedimentale: come accennato, se l’ufficio ha notificato l’accertamento prima dei 60 giorni dal PVC senza urgenza motivata, si può eccepire la nullità dell’atto per violazione dell’art. 12 c.7 L.212/2000. La Cassazione a Sezioni Unite nel 2015 (sent. n. 24823) ha statuito che in ambito di tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRAP) tale violazione comporta nullità se il contribuente poi deduce in giudizio un concreto pregiudizio difensivo . Nel nostro scenario di compensi, si può argomentare che non avendo atteso i 60 giorni, l’ASD non ha potuto esporre elementi che avrebbero potuto portare a un diverso esito. Questo motivo ha possibilità di successo se effettivamente c’è sostanza da esporre.
- Difetto di motivazione o motivazione per relationem invalida: l’avviso deve spiegare le ragioni della pretesa; se si limita a rinviare al PVC GdF, il PVC va allegato o riprodotto. Se non c’è e l’atto non è autonomamente chiaro, si può eccepire nullità per difetto di motivazione (art. 42 D.P.R. 600/73). Inoltre, se l’atto non considera le osservazioni presentate dal contribuente dopo il PVC, omettendo di motivare sul loro rigetto, ciò può costituire vizio (non pacifico però: lo Statuto dice che vanno valutate ma non prevede nullità esplicita).
- Errata applicazione di norme tributarie: qui rientrano i nodi giuridici. Esempi: l’ufficio ha applicato retroattivamente la disciplina, tassando oltre 10k in un anno 2022 come se la soglia fosse 15k (ipotesi); oppure ha considerato imponibile un rimborso spese fuori comune documentato, violando art. 69 TUIR. O ancora, ha disconosciuto l’agevolazione sportiva per un vizio formale ormai sanato (ad es. l’ASD non aveva indicato “dilettantistica” nel nome, ma la Cassazione dice che da solo non basta a negare il regime ). Il difensore deve citare le fonti normative corrette e la giurisprudenza a supporto. Ad esempio: “erroneamente l’Ufficio assoggetta a imposta €3.000 di rimborsi spese di trasferta al fuori comune, in violazione dell’art. 69 co.2 TUIR che li esenta espressamente ”.
- Travisamento dei fatti e difetto di prova: spesso l’accertamento si basa su presunzioni (es. movimenti bancari non giustificati -> compensi in nero). È onere del Fisco provare che quei movimenti erano redditi imponibili. Il contribuente può contestare che manca la prova, o fornire una spiegazione alternativa. Nel contenzioso su ASD, ad esempio, l’Agenzia potrebbe arguire che “i versamenti sul c/c del presidente indicano compensi occulti”. Il presidente può controbattere portando testimonianze o tracciati che mostrano che erano donazioni dei genitori per acquistare le maglie, ecc. Naturalmente, servono elementi concreti.
- Onere della prova sull’effettiva natura dilettantistica: qui la questione è delicata. La Cassazione sostiene che l’onere di provare la genuinità non lucrativa è a carico dell’associazione . Quindi, se l’atto di accertamento afferma “non hai provato di essere non profit, quindi ti tolgo le agevolazioni”, in giudizio l’ASD deve portare prova contraria. Ciò implica presentare una serie di documenti: libri soci e verbali per mostrare la partecipazione associativa, bilanci per mostrare che non c’è utile distribuibile (o se c’è avanzo modesto, vincolato a scopi istituzionali), evidenze che i soci praticano sport, che esiste vita associativa reale (foto di eventi, trofei, manifestazioni pubbliche, articoli stampa locale), ecc. Più questi elementi convincono il giudice che l’ASD in concreto operava come ente dilettantistico, più chance ci sono di ribaltare la presunzione del Fisco. Ad esempio, in un caso la CTR ha creduto all’associazione nonostante mancasse il libro soci, perché dai documenti risultava che lo spirito dilettantistico c’era . Viceversa, portare poca documentazione rischia di lasciare spazio alla tesi del Fisco che tutto era simulato. Quindi la strategia processuale dovrebbe essere: tempestivamente depositare documenti, eventualmente far testimoniare alcuni soci o genitori di allievi (nel processo tributario la testimonianza formale è vietata, ma si può produrre dichiarazioni sostitutive o far testimoniare come “parte” in cause con rappresentante persona fisica). Va anche considerato se far nominare un CTU contabile per ricostruire correttamente i rendiconti dell’ASD, specie se si discute sull’ammontare di un utile o di spese deducibili.
- Buona fede e obiettive condizioni di incertezza: per cercare almeno di ottenere l’annullamento delle sanzioni, si può invocare l’art. 6 comma 2 D.Lgs. 472/97, secondo cui nessuna sanzione per violazioni tributarie se la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza normativa. Nel mondo dei compensi sportivi, si può argomentare che la disciplina era complessa e soggetta a interpretazioni contrastanti (specie prima della riforma), e che il contribuente ha agito in buona fede confidando magari in prassi favorevoli. Ad esempio, l’ASD potrebbe dire: “Ero convinta che bastasse l’iscrizione al CONI per essere a posto, posizione avallata anche da alcune circolari”; oppure il collaboratore: “Non ho dichiarato quei 2000 € perché il presidente mi disse che erano esenti e non ho saputo dell’obbligo”. La giurisprudenza non sempre assolve per questi motivi, però in alcuni casi di incertezza oggettiva (es: regime transitorio 2023, oppure dubbio se quell’attività fosse sportiva o no) il giudice può annullare o ridurre fortemente le sanzioni, pur confermando il tributo. Vale la pena inserire sempre in subordine tale richiesta, evidenziando la collaborazione prestata e l’assenza di dolo nel comportamento (magari l’ASD aveva fatto tutto con conti in chiaro, non nascondendo nulla volutamente).
- Errori formali senza evasione sostanziale: un’altra linea difensiva è far leva sul principio di sostanza economica e di non punibilità di irregolarità formali che non incidono sulla base imponibile. Ad esempio, se il modello EAS è stato inviato in ritardo di pochi giorni ma ciò non ha comportato omissione di ricavi, oppure se le ricevute ai soci erano tenute in modo disordinato ma tutte le entrate sono in conto, si può sostenere che non c’è stato pregiudizio all’azione accertatrice e l’atto è meramente punitivo. Questo può convincere i giudici ad essere indulgenti se la sostanza fiscale è salva. Anche qui può riflettersi almeno sulle sanzioni (art. 6 c.5-bis D.Lgs 472/97 consente di non punire irregolarità formali senza impatto sostanza).
In definitiva, difendersi efficacemente significa unire: un’ottima conoscenza della normativa e delle sentenze (per supporto giuridico) con un meticoloso lavoro di ricostruzione dei fatti e raccolta prove (per convincere sul piano fattuale). Spesso, come rimarcato, “la sostanza prevale sulla forma” nelle valutazioni dei giudici: quindi un’associazione genuinamente dilettantistica anche se un po’ confusionaria potrà spuntarla, mentre una formalmente in regola ma sostanzialmente commerciale verrà colpita.
Chiudiamo questa sezione strategica con un consiglio: documentare tutto sin dall’inizio. Un ente sportivo farebbe bene a predisporre annualmente un “dossier” con statuto, organigramma, elenco soci e relativi atleti, foto e rassegna di attività svolte, conti economici chiari che mostrino come vengono impiegate le risorse. Questo non è richiesto per legge, ma in caso di accertamento diventa prezioso per consegnarlo a supporto (magari già in fase di PVC). Allo stesso modo, un collaboratore sportivo dovrebbe sempre tenere traccia scritta di quanto percepito e a che titolo (ad es. ricevendo la certificazione dei compensi e magari scambiando email in cui l’ASD gli ricorda i limiti di esenzione – segno che c’era consapevolezza e non dolo). Più trasparenza e tracciabilità si hanno ex ante, più facile difendersi ex post.
Giurisprudenza recente: sentenze chiave su sport dilettantistico e fisco
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione e le Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie) si sono espresse ripetutamente sulle questioni fiscali e contributive inerenti alle associazioni sportive dilettantistiche e ai relativi compensi. Analizziamo alcune sentenze recenti e rilevanti che hanno inciso sull’interpretazione delle norme, fornendo principi utili per la difesa del contribuente:
- Cass., Sez. Trib., ord. n. 30008/2021: Questa pronuncia (richiamata anche in successive sentenze ) ha sancito un principio di portata generale: “Ai fini del riconoscimento della fiscalità di favore, l’ASD/SSD ha l’onere di dimostrare non solo la ricorrenza di tutti i requisiti formali previsti dall’art. 148, co. 8 TUIR, ma anche che l’attività principale svolta sia realmente quella sportiva dilettantistica e non quella commerciale”. La sentenza conferma che il semplice rispetto formale (statuto ok, affiliazione) non basta se poi la sostanza rivela un’attività lucrativa. Questo orientamento mette in guardia le associazioni: in caso di verifica, dovranno provare con dati concreti che lo scopo non era di lucro. La Cass. 30008/21 fu emessa in un caso in cui l’ASD di fatto ricavava quasi tutto da sponsorizzazioni e clienti esterni, e aveva trascurato la vita associativa .
- Cass., Sez. Trib., ord. n. 6361/2023 (2 marzo 2023): Questa ordinanza ha fatto scalpore perché – come anticipato – ha offerto un vero “decalogo” su cosa controllare in un’ASD. La Suprema Corte ha cassato con rinvio una decisione favorevole all’ASD perché i giudici regionali non avevano verificato: (a) il rispetto di tutti i requisiti formali ex art. 148 co.8 TUIR e art. 90 L.289/2002 (divieto utili, devoluzione patrimonio, democraticità, ecc.) ; (b) la natura concreta dell’attività svolta dall’ente . Nel caso di specie, un’associazione sportiva motoristica organizzava competizioni con piloti non soci e puntava più alle sponsorizzazioni che alla promozione sportiva di base . Inoltre mancavano affiliazione CONI nei primi anni e la denominazione non era adeguata . La Cassazione ha quindi stabilito che bisogna approfondire se l’ente operava come schermo commerciale. Il “decalogo” estrapolabile include: verifica di denominazione, affiliazione, libro soci, democraticità, destinazione patrimonio, nonché analisi di come l’ente svolge concretamente lo sport (chi sono i destinatari, soci o terzi? ci sono finalità educative? ecc.). Questa pronuncia è un monito: la Cassazione controllerà rigorosamente tali elementi e se le CTR non lo fanno, annullerà le loro decisioni.
- Cass., Sez. Lav., ord. n. 22340/2025 (pubbl. 02/08/2025): In ambito contributivo/previdenziale, questa recentissima ordinanza (in materia lavoro) affronta il tema degli istruttori sportivi e addetti di segreteria in un’ASD . La Cassazione ha confermato le decisioni di merito che qualificavano quei rapporti come lavorativi (subordinati), con conseguente obbligo di versare contributi. Principi affermati: l’esenzione contributiva per i dilettanti non è automatica, ma richiede la prova che le prestazioni siano rese senza professionalità e direttamente in funzione di attività sportiva dilettantistica . L’onere della prova di tali requisiti ricade sull’ASD che invoca l’esenzione . Inoltre, l’ordinanza chiarisce che la semplice iscrizione al CONI o il fatto di essere un’ASD non garantiscono di per sé l’assenza di obblighi contributivi : conta la natura sostanziale del rapporto. Se l’istruttore svolge l’attività in modo abituale e sistematico (professionalità soggettiva) essa perde il carattere dilettantistico e va assoggettata a contributi . Questa pronuncia, pur sul lato lavoro, ha riflessi fiscali: infatti un rapporto riqualificato come subordinato implica anche che i compensi erano redditi da lavoro dipendente, con possibili sanzioni per ritenute non fatte. Rappresenta dunque un precedente importante per tutte quelle situazioni ibride: l’ASD dovrà pensarci due volte prima di pagare compensi “fissi” a istruttori pensando di essere esente, e in caso di accertamento dovrà portare forti evidenze del carattere volontario/occasionale.
- Cass., Sez. Trib., ord. n. 17487/2022 (31 maggio 2022): Questa sentenza ha riguardato il tema dei compensi eccessivi e distribuzione indiretta di utili e si ricollega al caso trattato poi dalla Cassazione nel 2025 (di cui Lexced 21/8/25 ha parlato). La Cass. 17487/22 ha ribadito l’applicazione stringente dell’art. 10, c.6, D.Lgs. 460/97: se un’ASD paga ai propri lavoratori/collaboratori stipendi superiori del 20% ai CCNL, ciò costituisce violazione del divieto di distribuzione utili e fa perdere il regime agevolato . Ha inoltre chiarito che il confronto va fatto tra il salario lordo corrisposto e il salario lordo da CCNL per mansioni analoghe, senza considerare altri costi o voci (straordinari, costo aziendale, ecc.) . La CTR aveva dato ragione all’ASD ritenendo di poter considerare il costo aziendale e le specifiche competenze del personale per giustificare l’extra . La Cassazione ha trovato questo ragionamento errato in diritto e ha cassato la sentenza. Dunque il principio è molto rigido. In difesa di un’ASD colpita da questa contestazione, l’unica via potrebbe essere cercare di dimostrare che il CCNL preso a riferimento dall’Ufficio non era corretto (magari quell’istruttore non aveva un equivalente nel CCNL indicato) oppure che il 20% non è stato superato se si considerano le ore effettive lavorate. Ma come presunzione assoluta, riduce i margini di discussione.
- Cass., Sez. Trib., ord. n. 29510/2023: questa pronuncia (settembre 2023) affronta un altro aspetto procedurale: la responsabilità personale dei rappresentanti legali di un’ASD per le obbligazioni tributarie dell’ente. La Cassazione ha chiarito che i legali rappresentanti pro-tempore di un’associazione non riconosciuta rispondono solidalmente dei tributi non versati dall’ente quando sussiste un obbligo loro imposto (come nel caso delle ritenute d’acconto) . Inoltre, tale responsabilità si estende anche per violazioni commesse prima del loro incarico, se il debito si manifesta durante la loro rappresentanza e non si attivano per sanarlo. Questo aspetto è rilevante perché un avviso di accertamento per ritenute non versate potrebbe essere indirizzato non solo all’ASD ma anche personalmente al presidente. In giudizio si potrebbe eccepire magari l’insussistenza di dolo o colpa grave del presidente successore, ma la norma di riferimento (art. 11 D.Lgs. 472/97) è abbastanza oggettiva nel prevedere la solidarietà. Dunque occhio ai dirigenti: non pensino di essere del tutto al riparo se ereditano situazioni fiscali pendenti.
- Sentenze di merito (CTR): Oltre alla Cassazione, vanno menzionate alcune pronunce delle Commissioni Tributarie (ora CGT) che hanno fatto giurisprudenza in questo settore:
- CTR Lombardia n. 7292/2022: caso riportato in dottrina , trattava di un’ASD e questione di requisiti; probabilmente confermava la decadenza dal regime per difetto di sostanza. Molti autori la citano come esemplificativa.
- CTP/CTR e Cass. ord. n. 8182/2020 e 4331/2021: citate anch’esse nelle rassegne , riguardano l’interpretazione dell’art. 148 TUIR e la fruizione delle agevolazioni. In particolare, Cass. 8182/2020 sottolinea come l’affiliazione al CONI e le clausole statutarie siano condizioni necessarie, e Cass. 4331/2021 ribadisce la distinzione proventi istituzionali vs commerciali (forse relativamente ai corsi svolti anche a non soci).
- Cass. n. 10393/2018 e 11492/2019: menzionate in commenti più datati , affermavano anch’esse il concetto che uno statuto perfetto non salva se poi l’attività è lucrativa; insomma già dal 2018 la Cassazione era su questa linea.
In sintesi, la giurisprudenza attuale in materia di fisco sportivo dilettantistico è caratterizzata da un approccio rigoroso: forte enfasi sull’onere probatorio in capo alle ASD, tolleranza zero verso abusi (compensi esagerati, attività commerciali mascherate), e riconoscimento delle agevolazioni solo in presenza di una chiara finalità sportiva non profit dimostrata. Questo panorama giurisprudenziale deve guidare sia il comportamento preventivo delle associazioni (impostando regole interne e compensi nel rispetto dei limiti) sia le strategie difensive nel contenzioso. Conoscere queste sentenze permette di prevedere gli argomenti che la controparte (Agenzia Entrate) userà e quali resistenze si troveranno in Cassazione. Ad esempio, sapendo della presunzione 20% e del decalogo Cassazione, un difensore punterà, se possibile, a distinguere il proprio caso da quei precedenti (mostrando magari che i compensi non eccedevano i parametri, o che l’associazione per il resto era impeccabile e con finalità sociali evidenti).
Esempi pratici: casi di accertamento e possibili soluzioni
Per calare quanto detto nella realtà operativa, presentiamo di seguito alcuni casi esemplificativi di situazioni in cui può incorrere un accertamento relativo a compensi sportivi dilettantistici, illustrando contestazioni e possibili difese. Queste simulazioni pratiche riguardano solo il contesto italiano e sono semplificate per evidenziare i punti chiave.
Esempio 1: Istruttore dilettante oltre soglia con ritenuta omessa
Scenario: Marco è un istruttore di tennis che collabora con l’ASD “Tennis Club XX”. Nel 2022 ha ricevuto compensi per €12.000. L’ASD, ritenendo tali somme esenti fino a €10.000, non ha operato ritenute sui primi 10k e – per errore – non ha applicato la ritenuta del 23% sui €2.000 eccedenti (avrebbe dovuto versare €460 di ritenuta). Marco, convinto di essere sotto la no tax area salvo quella piccola parte, non ha presentato dichiarazione dei redditi, anche perché non ha altri redditi significativi. Nel 2024, l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati del modello 770 dell’ASD (che però riporta solo 10k esenti e non menziona ritenute) con l’assenza di dichiarazione di Marco. Parte un controllo.
Contestazione: L’Agenzia notifica a Marco un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2022, imputandogli €2.000 di “redditi diversi” non dichiarati, con imposta dovuta €460 e sanzione 90% (€414) oltre interessi. Contestualmente, notifica all’ASD un atto di contestazione per omesso versamento di ritenute su €2.000, chiedendo €460 di imposta (che avrebbe dovuto trattenere) + sanzione 20% (€92) + interessi.
Difesa di Marco: Marco può eccepire che in realtà quei €2.000 erano soggetti a ritenuta a titolo d’imposta e quindi non andavano dichiarati. Ma l’ASD non li ha trattenuti: l’Agenzia replica che allora l’imposta è rimasta a carico suo. Tuttavia, Marco può presentare istanza di accertamento con adesione, argomentando che: (a) egli era in buona fede, (b) se l’ASD avesse fatto la ritenuta, nulla sarebbe stato dovuto in più, (c) propone comunque di pagare l’IRPEF dovuta ma chiede clemenza sulle sanzioni invocando l’art. 6, co.2 D.Lgs.472/97 (incertezza normativa: dopotutto egli ha seguito le indicazioni dell’ente). L’ufficio in sede di adesione potrebbe ridurre la sanzione da 90% a, poniamo, 30%. Marco pagherà così €460 + €138 = €598 + pochi interessi. Se l’ufficio fosse rigido, Marco può valutare ricorso puntando sulla non punibilità per forza maggiore: era l’ASD tenuta a trattenere. La giurisprudenza talvolta esclude sanzioni al percettore se dimostra di non aver pagato le imposte per fatto del sostituto. Non c’è una norma precisa, ma il giudice potrebbe applicare equità.
Difesa dell’ASD: L’ASD qui ha poca via di scampo sull’omessa ritenuta: l’errore c’è stato. Può però chiedere in autotutela una riduzione delle sanzioni se finora contribuente corretto, o puntare sul cumulo giuridico se avesse più violazioni. Però conviene che paghi subito i €552 (460+92) per evitare ulteriori sanzioni e mostrare collaborazione (ciò tra l’altro aiuterebbe Marco nella sua tesi di buona fede). Se l’ASD nota che la contestazione è arrivata oltre i termini (difficile, 2024 su 2022 è nei tempi), potrebbe eccepire prescrizione per la sanzione, ma non è il caso. Quindi l’ASD probabilmente definisce l’atto con acquiescenza o adesione e sistema.
Esito: Marco, dopo un confronto, accetta l’adesione proposta: imposta confermata €460, sanzione ridotta del 50% (dall’Agenzia generosa in mediazione) a €207. Totale €667. L’ASD versa le sue somme. Marco non viene perseguito penalmente perché importi bassi (soglia penal tributaria omessa dichiarazione è 50k imposta evasa). Impara la lezione e dal 2023 si premura di chiedere sempre se c’è ritenuta dovuta. L’ASD si dota di un consulente che le eviti simili sviste.
Esempio 2: Compenso al dirigente e presunzione di utili
Scenario: L’ASD “CalcioAmici” nel 2021 ha corrisposto al suo direttore tecnico (che è anche vicepresidente e socio fondatore) un compenso annuo di €30.000, qualificandolo come “premio sportivo dilettantistico”. Formalmente l’ASD è in 398/91, ha registri soci e affiliazione regolare. Tuttavia, la Guardia di Finanza nel 2022 effettua un controllo perché l’ASD ha chiuso il 2021 con solo €5.000 di spese per attività sportiva giovanile e quel grosso compenso al vicepresidente. Si scopre che il CCNL degli istruttori di categoria prevederebbe per un ruolo analogo (allenatore di Promozione) uno stipendio di €20.000 lordi annui. Il compenso erogato è quindi del 50% superiore.
Contestazione: L’Agenzia delle Entrate emette avviso di accertamento dichiarando che nel 2021 l’ASD ha effettuato una distribuzione indiretta di utili ai sensi dell’art. 10 c.6 D.Lgs.460/97 e, per l’effetto, decade dal regime agevolato. Conseguenze: viene richiesta l’IRES al 24% su tutti i proventi 2021 (inclusi 40k di sponsorizzazioni che l’ASD aveva tassato forfettariamente al 3% con legge 398), più IVA piena su incassi di pubblicità, e IRAP sul presumibile costo del personale (compenso). Inoltre, al vicepresidente viene imputato un reddito da lavoro dipendente di €30.000 non dichiarato (avendo egli magari dichiarato solo 10k come “premio esente”). La botta: l’ASD riceve una cartella di €12.000 tra imposte e sanzioni; il vicepresidente un avviso per IRPEF 38% su 30k (€11.400) + sanzioni.
Difesa: Questo è un caso spinoso. L’ASD tramite il suo legale contesta che la norma antiutili non sia applicabile perché il soggetto era un allenatore tesserato e non un socio percipiente utili – in realtà lo è, socio – e che comunque 30k era congruo per 10 mesi di incarico full-time considerata la carenza di altri tecnici qualificati. Purtroppo, la Cassazione è chiarissima: >20% CCNL = utili . Forse l’unica è verificare quale CCNL considerare: se l’ASD dimostrasse che il contratto di riferimento non era quello usato dal Fisco (es: il DT non è equiparabile all’allenatore di Promozione ma a un dirigente amministrativo di Federazione, con altro parametro), potrebbe provare a ridurre lo scostamento sotto 20%. Difficile. Una strategia potrebbe essere tentare un accordo in adesione accettando la decadenza dal regime ma riducendo il quantum: ad esempio convincendo l’ufficio a considerare quell’importo come se includesse rimborsi spese o altre voci che non configurano utili. Anche questo complesso. Probabilmente il contenzioso è inevitabile: in CTP si punterà su argomenti di “sostanza vs forma”, magari sostenendo che quei 30k erano in realtà 15k di compenso e 15k di rimborso forfetario per trasferte (se c’è appiglio). Il vicepresidente come contribuente singolo potrebbe cercare di transare col Fisco pagando l’IRPEF dovuta ma chiedendo sanzioni ridotte e magari rateazione lunga.
Esito possibile: Vista la presunzione assoluta, è probabile che l’ASD perda la causa sulla qualifica di ente non commerciale per quell’anno. Potrebbe però ottenere, in fase di appello o conciliazione, di limitare la tassazione agli importi direttamente oggetto di utili (ad esempio evitando che vengano tassate anche le quote sociali dei ragazzi). La sanzione per utili indiretti è generalmente la revoca totale delle agevolazioni: in sede politica qualcuno critica la durezza, ma è lex. Il vicepresidente alla fine paga caro: quei 30k gli costano imposte e sanzioni, anche perché difficilmente potrà negare di averli ricevuti (ci sarà traccia contabile).
Lezione appresa: Non pagare mai i propri dirigenti oltre i limiti di mercato – piuttosto frazionare i ruoli tra più persone, o documentare in modo diverso le spese.
Esempio 3: Collaborazione riqualificata come lavoro dipendente
Scenario: L’ASD “Fitness Club” ha un istruttore di sala pesi, Luca, che dal 2019 al 2021 ha percepito €800 al mese dall’associazione, per circa 20 ore settimanali di lavoro. Luca non ha altri lavori ed è presente tutti i giorni in palestra seguendo i soci. L’ASD lo ha sempre pagato come “compenso sportivo dilettantistico” esente (annualmente 9.600 euro, sotto 10k, quindi senza ritenute né contributi). Nel 2022, a seguito di una segnalazione anonima o ispezioni sul lavoro, l’INPS compie un accertamento.
Contestazione: L’INPS emette un avviso di addebito chiedendo i contributi previdenziali per un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra l’ASD e Luca nel 2019-2021. In parallelo, segnala il caso all’Agenzia Entrate. Quest’ultima nel 2023 notifica all’ASD un atto di contestazione: per i periodi 2019-2021 l’ASD avrebbe dovuto operare ritenute IRPEF sui compensi di Luca in quanto redditi da lavoro dipendente, e non lo ha fatto; chiede quindi il versamento delle ritenute evase (supponiamo €9.600 * 23% * 3 anni ≈ €6.624) più sanzioni e interessi. Inoltre, Luca riceve un avviso di accertamento IRPEF per gli anni 2019-2021 contestandogli di non aver dichiarato quei redditi (che secondo AdE non erano più esenti perché non redditi diversi ma lavoro dip).
Difesa: L’ASD farà opposizione all’avviso INPS davanti al Tribunale del Lavoro, e parallelamente ricorso contro l’atto dell’Agenzia Entrate in Commissione Tributaria. L’esito di uno può influenzare l’altro. Davanti al giudice del lavoro, l’ASD punterà a dimostrare che Luca era un collaboratore autonomo (co.co.co sportivo dilettantistico) e non un dipendente: argomenti possibili, la mancanza di orario fisso contrattualizzato (anche se di fatto c’era, ma magari formalmente no), il fatto che Luca era libero di organizzarsi le lezioni, che percepiva un compenso modesto non da lavoro pieno, ecc. Cercherà testimoni tra altri istruttori per dire che l’ambiente era volontaristico. Tuttavia, se le evidenze sono contrarie (Luca timbrava un registro presenze, seguiva direttive del presidente su orari e pulizie, ecc.), sarà dura vincere. La Cassazione 2025 su istruttori è scoraggiante: abitualità = professionalità . D’altra parte Luca potrebbe testimoniare a suo favore? No, Luca ora è dalla parte dell’INPS perché se riconoscono lavoro dipendente avrà contributi per la pensione. Quindi lui spingerà per la riqualificazione. Un bel conflitto di interessi… In Commissione Tributaria invece si potrebbe chiedere sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa lavoro, perché la qualifica del rapporto è questione pregiudiziale; oppure portare come prova l’esito eventualmente favorevole.
Se la riqualificazione viene confermata dal giudice del lavoro, a quel punto la difesa fiscale residua è solo su sanzioni e interessi. L’ASD potrebbe eventualmente patteggiare un’adesione per pagare in forma agevolata le ritenute (magari ottenendo sanzioni 1/3). Luca come contribuente persona fisica potrebbe sostenere in CTP che, essendo state chieste le imposte all’ASD (sostituto), a lui non spetta nulla (c’è una norma che prevede che se il sostituto paga allora il sostituito è liberato, e in genere l’AdE preferisce riscuotere dal sostituto). Quindi Luca potrebbe ottenere l’annullamento dei suoi avvisi se l’ASD paga, o comunque far presente che sarebbe doppia imposizione far pagare entrambi. Dovrà però allora dichiarare quei redditi per il futuro.
Esito: Ipotizziamo che la riqualificazione regga almeno in parte: il giudice del lavoro riconosce che Luca era in realtà un co.co.co continuativo (non proprio dipendente ma comunque da iscrivere gestione separata). L’INPS ricalcola contributi con aliquota minore, l’ASD paga. Sul versante AdE, se Luca era co.co.co, fiscalmente i compensi restano nell’ambito sportivo dilettantantistico art. 67 (perché la legge sport dilettant riconosce i co.co.co gestionali). L’ASD potrebbe allora far presente ciò all’AdE: “vedete, era co.co.co sportivo quindi esente IRPEF” e ottenere sgravio. In tal caso sarebbe quasi vittoria per l’ASD, pagando solo contributi. Alternativa: se invece vien detto che era proprio dipendente, l’ASD pagherà le ritenute evase con sanzioni ridotte in adesione; Luca probabilmente non verrà perseguito oltre se l’ASD si fa carico. L’ASD avrà tuttavia perso l’opportunità di stare in regola e subito dopo dovrà assumere Luca o cessare il rapporto.
Morale: è fondamentale inquadrare correttamente i rapporti: se una collaborazione diventa strutturale, conviene regolarizzarla come co.co.co sportivo (dal 2023 esistono i contratti sportivi dilettanti proprio per questo). Meglio pagare qualche contributo che rischiare un accertamento retroattivo.
Questi esempi mostrano che, a seconda delle situazioni, le leve difensive cambiano: a volte occorre negoziare (adesione), a volte combattere su principi (in giudizio), altre volte sistemare retroattivamente le cose (ad es. far firmare tardivamente un contratto a progetto sportivo per sanare). L’importante per il “debitore” è mantenere un atteggiamento proattivo e documentato: mai lasciar decadere i termini, mai ignorare le comunicazioni del Fisco, e presentarsi preparati con conti e carte in regola quando si discute.
Domande frequenti (FAQ) su compensi sportivi dilettantistici e accertamenti
D1: Cosa si intende esattamente per “compensi da attività sportiva dilettantistica”?
R: Si intendono tutte le somme corrisposte, in contesto sportivo non professionistico, a persone che svolgono ruoli sportivi o amministrativi senza carattere imprenditoriale né professionale abituale. Comprende le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi gara e i compensi per collaborazioni continuative ma non professionali, erogati da CONI, Federazioni, Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute . Esempi tipici: il rimborso spese all’allenatore della squadra dilettanti, il premio partita all’arbitro amatoriale, la “paghetta” al custode del campo, purché dati da un ente sportivo dilettante per attività legate allo sport dilettantistico.
D2: Fino a che importo annuale questi compensi sono esenti da tassazione?
R: La soglia di esenzione IRPEF è stata €10.000 annui fino al 30/6/2023 . Dal 1° luglio 2023 la soglia è elevata a €15.000 annui , in virtù dell’art. 36 D.Lgs. 36/2021. Ciò significa che, rispettando le condizioni di legge, un collaboratore sportivo non paga IRPEF sui primi 10.000 € (prima) o 15.000 € (ora) percepiti in un anno. Attenzione: per il 2023 c’è stata una disciplina transitoria un po’ complessa, ma in sostanza si è garantita l’esenzione totale fino a €15.000 sul totale anno .
D3: Cosa succede se il compenso supera tale soglia?
R: Per la parte di compenso che eccede la soglia esente, cambia il regime fiscale: – Fino al 2022 (vecchia disciplina): la parte eccedente €10.000 e fino a ~€30.658 era soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 23% (quindi tassazione fissa, senza ulteriori obblighi per il percettore) . Oltre €30.658, la parte ulteriore subiva ritenuta 23% a titolo di acconto e andava dichiarata nella dichiarazione dei redditi . – Dal 2023 (nuova disciplina): la parte eccedente €15.000 annui concorre al reddito complessivo del percipiente e viene tassata con le normali aliquote IRPEF progressive . In pratica, diventa reddito di lavoro dipendente (se c’è subordinazione) o assimilato (co.co.co) o autonomo, a seconda dei casi, e va dichiarata. L’ente pagatore di norma opererà una ritenuta d’acconto sulle somme eccedenti (ad esempio come sostituto d’imposta per redditi assimilati).
In sintesi: superata la soglia, prima c’era una tassa piatta 23%, ora c’è la tassazione ordinaria sulla parte in eccesso. Inoltre oggi chi supera la soglia deve fare la dichiarazione dei redditi perché quel reddito entra nel cumulo.
D4: Un collaboratore sportivo dilettante deve fare la dichiarazione dei redditi?
R: Dipende dalla situazione: – Se i compensi percepiti non superano la soglia esente (10k o 15k a seconda dell’anno), e non ha altri redditi che lo obblighino, non è tenuto a presentare la dichiarazione . L’esenzione fiscale li esclude proprio dal reddito imponibile. – Se i compensi superano la soglia, occorre distinguere: fino al 2022, se anche superavano ma erano assoggettati interamente a ritenuta a titolo d’imposta (fino a 30.6k), il percettore non era obbligato a dichiararli . Dal 2023 invece, la parte eccedente 15k non è coperta da ritenuta d’imposta ma solo d’acconto, quindi va dichiarata obbligatoriamente. Dunque, ad esempio nel 2024, un istruttore che percepisce 20.000 € dovrà presentare il Modello Redditi o 730 indicando i (20k-15k)=5.000 € eccedenti come redditi di lavoro. – Se il collaboratore ha altri redditi (es. un lavoro dipendente principale), potrebbe dover dichiarare il cumulo. In alcuni casi però i compensi sportivi (se sotto soglia o soggetti a imposta sostitutiva) non richiedono cumulo. Meglio farsi consigliare: per sicurezza, chi ha più fonti di reddito presenti sempre dichiarazione, inserendo eventualmente i compensi sportivi in apposite sezioni (indicando che sono già tassati a imposta sostitutiva, se è il caso).
D5: Quali sono le sanzioni in caso di omessa dichiarazione di compensi sportivi?
R: Se il contribuente non dichiara dei redditi imponibili, la violazione è “dichiarazione infedele” (se ha presentato dichiarazione ma con reddito in meno) o “omessa dichiarazione” (se proprio non l’ha presentata ed era obbligato). Le sanzioni amministrative, previste dal D.Lgs. 471/1997, sono: – Infedele dichiarazione: sanzione dal 90% al 180% dell’imposta evasa (minimo 90%). Ad esempio, se su €5.000 non dichiarati l’imposta evasa era €1.150, la sanzione minima è €1.035 (90%). Può essere aumentata in caso di redditi occultati superiori al 10% del dichiarato o altri aggravanti. – Omessa dichiarazione: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con minimo €250. Questo si applicherebbe se, ad esempio, uno doveva dichiarare (perché aveva compensi tassabili) ma non ha proprio presentato il modello. Se però l’imposta è stata in parte versata tramite ritenute, la sanzione può essere ridotta. In entrambi i casi, se si regolarizza spontaneamente col ravvedimento operoso, le sanzioni diminuiscono moltissimo (fino a 1/10 del minimo se si fa entro un anno). Se invece arriva l’accertamento, come visto, si può ridurle a 1/3 con adesione o acquiescenza, o al 40% con conciliazione, etc. Quindi raramente si paga il 90% pieno se si chiude in via agevolata.
D6: L’associazione sportiva è responsabile delle tasse sui compensi dei collaboratori?
R: In parte sì. L’ASD/SSD, in quanto sostituto d’imposta, aveva ed ha l’obbligo di trattenere e versare: – La ritenuta del 23% sui compensi che eccedevano la fascia esente (nel regime ante 2023) . Se non l’ha fatto, l’Agenzia può chiedere all’ente di versarla (anche se poi eventualmente la recupera dal collaboratore). – La ritenuta a titolo d’acconto (aliquota variabile a seconda del tipo di reddito, es. 20% sui co.co.co) sulla parte eccedente 15k nel regime nuovo. Ad esempio, nel 2024 se pagano €20k a un istruttore co.co.co, dovranno trattenere sulla parte oltre 15k come acconto IRPEF. – In generale, se l’ASD configura quel compenso come lavoro dipendente (caso borderline ma possibile), deve fare le ritenute IRPEF mensili come datore di lavoro. Se l’associazione non adempie a questi obblighi, viene considerata inadempiente e può ricevere sanzioni per omesso versamento di ritenute (30% dell’importo non versato, ridotto a 20% se versa entro 90 giorni). Inoltre, come visto, in casi estremi l’ente può essere ritenuto corresponsabile dell’evasione del collaboratore. Di converso, se l’ASD ha trattenuto correttamente le imposte, il collaboratore non verrà tassato due volte su quelle somme (al più, se erroneamente presentasse dichiarazione includendole, avrebbe diritto a rimborso). Quindi è cruciale che l’ASD gestisca correttamente la parte fiscale, sia per non incorrere in sanzioni proprie sia per tutelare i collaboratori.
D7: Cosa cambia con la riforma dello sport dal 2023 per chi collabora con un’ASD?
R: Cambia molto: dal 1° luglio 2023 i collaboratori sportivi dilettanti diventano giuridicamente “lavoratori sportivi”. In pratica: – Il compenso non è più chiamato “reddito diverso” ma è inquadrato come reddito da lavoro (dipendente, co.co.co o autonomo occasionale). Questo implica che l’ASD formalizzerà il rapporto: ad esempio, molti ex collaboratori sono stati trasformati in co.co.co sportivi con un contratto scritto (rinnovabile annualmente). – Fiscalmente, come detto, fino a €15.000 non pagano IRPEF, oltre pagano IRPEF normale cumulandosi con altri redditi . – Contributivamente, acquisiscono diritti previdenziali: l’ASD dovrà iscriverli al registro lavoratori sportivi e versare contributi all’INPS (Gestione Separata Sport) sulla parte di compenso oltre €5.000 annui . Questo era un onere prima inesistente. In molti casi, di fronte a questa novità, le ASD hanno ridotto i compensi o rivisto i rapporti perché sostenere contributi può essere pesante. Tuttavia per il lavoratore è un vantaggio (maturazione pensionistica, copertura infortuni). – Cambiano alcuni adempimenti: il lavoratore deve rilasciare autocertificazione dei compensi percepiti in anno ; l’ASD deve fare comunicazione al Centro per l’Impiego dei co.co.co (prima non necessario per sportivi) anche se in forma semplificata. In sintesi, dal 2023 il settore si “professionalizza” un po’ di più. Ciò non toglie che rimanga la grande agevolazione fiscale fino a 15k. Chi però guadagnava molto dovrà ora fare i conti con tasse progressive e contributi. E le associazioni dovranno stare ancora più attente a rispettare la normativa lavoristica (niente più istruttori pagati in nero spacciandoli per volontari).
D8: Cosa posso fare se ricevo un avviso di accertamento per compensi sportivi non dichiarati?
R: Non ignorarlo! Entro 60 giorni dalla notifica devi reagire. I passi consigliati: 1. Analizza l’atto o fallo analizzare da un esperto (avvocato tributarista, commercialista): capire cosa contestano (IRPEF su tot euro, quali anni, quali violazioni). 2. Raccogli la documentazione: certificati dei compensi percepiti, ricevute, statuto ASD, eventuali comunicazioni dell’ASD che ti facevano credere tutto regolare, ecc. Servirà per difenderti. 3. Valuta con l’esperto se ci sono errori nell’accertamento o margini di trattativa. 4. Scegli se proporre accertamento con adesione (spesso consigliabile per ridurre sanzioni) presentando istanza all’Agenzia delle Entrate. Questo ti dà più tempo e possibilità di accordo. 5. In parallelo, valuta se pagare subito (se la somma è piccola e riconosci l’errore, l’acquiescenza con sanzioni ridotte può chiudere la faccenda rapidamente). 6. Se non trovi accordo o non vuoi pagare tutto, prepara un ricorso entro 60 giorni (o 150 se hai fatto adesione e non concluso accordo). Nel ricorso dovrai spiegare perché l’atto è errato (es. tu eri sotto soglia esente, oppure l’ASD non era riconosciuta e tu non lo sapevi – quest’ultima non ti esonera, ma può servire a chiedere clemenza sulle sanzioni). 7. Puoi anche contestualmente attivare la mediazione (se ancora prevista per il tuo caso, visti i cambiamenti). In generale, fatti assistere: le norme sono tecniche. Potresti scoprire che qualche scappatoia c’è, ad esempio che quell’anno l’ASD non era in regola quindi dovevi pagare, ma magari rientri in un condono se il governo ne ha fatti (nel 2023 c’era la “definizione agevolata liti pendenti” che permetteva di chiudere cause con sconti, ma bisogna vedere il momento). Insomma, agisci attivamente.
D9: Un’ASD può pagare compensi ai propri soci o dirigenti senza perdere le agevolazioni?
R: Sì, ma con cautela e moderazione. La normativa non vieta di pagare soci o dirigenti per servizi resi all’associazione, purché: – Il compenso sia effettivamente per una prestazione resa (es: il presidente che allena una squadra può percepire compenso come allenatore). – Sia di entità contenuta, in linea con il carattere dilettantistico. C’è un parametro rigido: non superare del 20% i compensi di mercato/CCNL per ruoli analoghi . Se si supera, scatta la presunzione di utili distribuiti e si perdono i benefici . Quindi pagare i dirigenti solo se necessario e in misura quasi simbolica rispetto a stipendi professionistici. – Inoltre, lo statuto deve comunque vietare la distribuzione di utili. Quindi ogni pagamento deve potersi giustificare come spesa funzionale all’attività sportiva, non come profitto per il socio. Ad esempio, un rimborso forfettario al consigliere per il carburante usato andando alle gare è ok; un bonus di fine anno ai soci perché l’ASD ha fatto utili no, non si può. Riassumendo: le ASD possono retribuire soci e dirigenti se questi operano come tecnici, arbitri, ecc., ma devono stare entro i confini dilettantistici nei compensi. Una buona prassi è far deliberare dall’assemblea o dal direttivo l’eventuale compenso, motivandolo (es. “al tesoriere viene riconosciuto un compenso annuo di €2.000 per l’attività amministrativa svolta”). Trasparenza e misura aiutano a difendersi in caso di contestazione.
D10: Quali strumenti ho per evitare di andare in causa col Fisco (deflazione del contenzioso)?
R: Come discusso, gli strumenti principali sono: – Istanza in autotutela: se l’atto è evidentemente sbagliato su qualche punto, chiedi all’ufficio di correggerlo o annullarlo. Non costa nulla tentare. – Accertamento con adesione: consente di trattare e ottenere sconti su imposte e (automatico) su sanzioni (ridotte a 1/3) . Va richiesto entro 60 gg dall’avviso, sospende i termini e porta a un contraddittorio. – Reclamo-mediazione: se ancora applicabile (atti pre-2024 fino 50k), presenti il ricorso come “reclamo” e l’ufficio può accogliere in toto o fare proposta. Non obbligatoria dal 2024, ma potresti comunque proporre una mediazione volontaria. – Acquiescenza: paghi entro 60 giorni e chiudi beneficiando di sanzioni ridotte a 1/3. Utile se la cifra non è alta e riconosci la violazione. – Conciliazione giudiziale: una volta in giudizio, puoi trovare un accordo con l’ufficio davanti al giudice, con sanzioni al 40% del minimo . Ciò può avvenire in primo grado (o anche in appello con sanzioni al 50%). – Definizioni agevolate speciali: talvolta il legislatore introduce condoni o sanatorie (ad esempio, la “definizione liti pendenti 2023” permetteva di chiudere cause pagando solo il 10% se avevi vinto in primo grado, ecc.). Bisogna stare all’erta: se capitano, valutare se conviene aderire. Oltre a ciò, ricorda il ravvedimento operoso: se ti accorgi di aver fatto un errore (ad esempio nel 2021 hai sforato i 10k e non hai dichiarato), ma il Fisco non ti ha ancora contestato nulla, puoi presentare una dichiarazione integrativa spontanea e pagare il dovuto con sanzioni ridotte (in genere 1/8 o 1/5 del minimo). Il ravvedimento però non è più possibile se hai già ricevuto la notifica di accertamento per quell’anno. Quindi è un’azione preventiva.
D11: Quanti anni indietro può andare il Fisco per controllare questi compensi?
R: In generale l’Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per emettere accertamenti (art. 43 D.P.R. 600/73). Se la dichiarazione è stata omessa, i anni diventano sette. Nel caso specifico dei compensi sportivi: – Se tu non avevi obbligo di dichiarazione (perché tutto esente o tassato alla fonte), e non hai presentato la dichiarazione, formalmente non c’è omessa dichiarazione perché non eri obbligato. Ma se l’Agenzia ritiene che dovevi presentarla (ad es. perché avevi parte imponibile), può considerarla omessa -> 7 anni. – Esempio: compenso 2018 non dichiarato (dovevi) -> possono notificare accertamento fino al 31/12/2025. Attenzione che con la pandemia ci sono stati proroghe dei termini per gli accertamenti 2019/20. Comunque, realisticamente, nel 2025 possono ancora accertare fino al 2019 compreso (dichiarazione 2020 per redditi 2019, quinto anno 2025). Per contributi INPS, il termine è 5 anni dalla scadenza di pagamento (quindi qui 2018 sarebbe prescritto da fine 2023, ecc.). Da notare: se c’è ipotesi di reato tributario (es. dichiarazione fraudolenta, ma difficile in questi casi), i termini fiscali si allungano di due anni. Non comune per omessi compensi a meno che siano importi enormi e magari false attestazioni – scenario improbabile dilettanti.
D12: In caso di controversia, conviene rivolgersi a un avvocato esperto o posso fare da solo?
R: Dato il livello avanzato e la specificità delle norme, è consigliabile farsi assistere da un professionista esperto in diritto tributario, meglio se con esperienza nel settore sportivo dilettantistico. Le ragioni: – Ci sono tecnicismi normativi e procedurali (es. legge 398/91, statuto contribuente, adesione) che un professionista sa maneggiare per evitare decadenze e sfruttare ogni appiglio. – Un avvocato tributarista potrà interloquire efficacemente con l’ufficio in sede di adesione o mediazione, parlando “la stessa lingua” dei funzionari, aumentando le chance di un accordo vantaggioso. – In giudizio, la presenza di difensore è obbligatoria per controversie oltre €3.000 di valore. Inoltre, un difensore saprà citare la giurisprudenza appropriata (come quelle discusse sopra) per sostenere il tuo caso – una differenza spesso decisiva. – Infine, c’è anche un aspetto psicologico: presentare memorie firmate da un legale e mostrare di essere pronti a far valere i propri diritti può indurre l’ufficio a più miti consigli (mentre il contribuente da solo potrebbe essere preso meno sul serio). In sintesi, per importi piccoli potresti valutare di fare da solo al massimo fino al reclamo, ma per contenziosi sostanziosi o complessi (ad esempio perdita regime ASD, contributi, ecc.) investire in una buona assistenza legale può farti risparmiare molto di più in sanzioni evitate.
Conclusioni
Dal punto di vista del debitore-contribuente, affrontare un accertamento per omessa dichiarazione di compensi sportivi dilettantistici può sembrare un percorso ad ostacoli tra normative tributarie, requisiti sportivi e procedure processuali. Tuttavia, come abbiamo visto, conoscenza e preparazione sono le armi migliori per difendersi efficacemente. Sul piano preventivo, le associazioni sportive devono operare con trasparenza e rigore, evitando zone d’ombra (compensi sproporzionati, rapporti simulati) che possano offrire facile terreno alle contestazioni del Fisco. Dal lato dei collaboratori, è importante essere consapevoli dei propri obblighi fiscali (specialmente alla luce delle novità 2023) e non dare per scontato che “tanto è tutto esente”: informarsi, chiedere all’ente pagatore chiarimenti, e in caso di dubbi dichiarare il reddito, è preferibile a incorrere in sanzioni dopo.
Qualora l’accertamento arrivi, questa guida mostra che esistono strumenti e strategie per far valere le proprie ragioni o quantomeno mitigare le conseguenze. L’accertamento con adesione e le procedure deflattive spesso consentono soluzioni equilibrate, evitando lunghe dispute e sanzioni punitive. Dove invece è necessario andare fino in fondo in giudizio, la giurisprudenza recente offre principi chiari – talvolta severi – di cui tenere conto: da un lato l’Amministrazione finanziaria ha stretto le maglie contro gli abusi nel settore sportivo dilettantistico, dall’altro il contribuente ben consigliato può ancora trovare riconoscimento alle proprie ragioni se effettivamente operava in buona fede e nel rispetto dello spirito non lucrativo che sta alla base delle agevolazioni.
In ultima analisi, difendersi con successo significa combinare un’attenta analisi tecnica (norme fiscali e sportive, sentenze di riferimento) con la dimostrazione fattuale della propria correttezza sostanziale. Un’associazione che documenta di aver promosso davvero lo sport dilettantistico e un collaboratore che prova di aver agito nell’ignoranza incolpevole di un errore troveranno più facilmente comprensione da parte del Fisco o dei giudici tributari. Al contrario, chi avesse approfittato in modo spregiudicato delle agevolazioni probabilmente vedrà confermate le pretese fiscali.
Infine, il punto di vista del debitore deve sempre considerare costi e benefici delle scelte difensive: a volte riconoscere l’errore e chiudere subito la partita è la scelta più saggia (con costi contenuti e cancellazione del rischio penale), altre volte è giusto combattere per un principio (ad esempio evitare un precedente che potrebbe danneggiare l’intero settore). Ogni caso fa storia a sé, ma la conoscenza approfondita – come quella che abbiamo cercato di fornire qui – è il presupposto imprescindibile per decidere consapevolmente.
In conclusione, “come difendersi” da un accertamento sui compensi sportivi dilettantistici significa prima di tutto conoscere le regole del gioco fiscale, così come si conoscono quelle del gioco sportivo che tanto appassiona. Solo così si può scendere in campo – in questo caso, la “partita” con il Fisco – con la strategia giusta e puntare alla vittoria o almeno a limitare i danni, tutelando la prosecuzione serena dell’attività sportiva e associativa che costituisce, ricordiamolo, un valore socialmente prezioso riconosciuto anche dall’ordinamento tributario.
Fonti: Normativa: DPR 917/1986 (TUIR) art. 67, 69, 148; Legge 398/1991; D.Lgs. 36/2021 art. 25, 36; L. 289/2002 art. 90; D.Lgs. 117/2017 (Terzo Settore); L. 212/2000 (Statuto contrib.). Circolari: Agenzia Entrate 18/E/2018 ; risposta AE interpello 474/2023 . Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 24823/2015; Cass. 30008/2021 ; Cass. 6361/2023 ; Cass. 17487/2022; Cass. 22340/2025 (ord.) ; Cass. 29510/2023; Cass. 10393/2018; Cass. 11492/2019; Cass. 25353/2020; Cass. 8182/2020; Cass. 4331/2021. Sentenze tributarie di merito: CTR Lombardia 7292/2022 , altre cit. in testo.
- Entrate – Risposta n. 474/2023 : Attività sportive dilettantistiche – IRPEF tra vecchia e nuova disciplina
- RIFORMA SPORT. Cosa è cambiato dal 1° luglio 2023
- Circolare del 03/08/2012 n. 33 – Agenzia delle Entrate
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta di non aver dichiarato i compensi percepiti da attività sportive dilettantistiche? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta di non aver dichiarato i compensi percepiti da attività sportive dilettantistiche?
Vuoi sapere quali sono le conseguenze e come puoi difenderti?
I compensi percepiti da associazioni e società sportive dilettantistiche godono di un regime fiscale agevolato, ma devono comunque essere dichiarati. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociati con i dati delle ASD, delle federazioni sportive e dei pagamenti tracciati, per verificare se i beneficiari hanno rispettato le regole.
👉 Non sempre, però, le contestazioni sono fondate: spesso derivano da errori formali o da un’errata qualificazione dei redditi.
⚖️ Quando scatta la contestazione
- Omessa dichiarazione dei compensi percepiti come collaboratore sportivo;
- Superamento della soglia di esenzione fiscale prevista dalla legge;
- Pagamenti non tracciati o non giustificati da contratti o delibere dell’ASD;
- Compensi qualificati come redditi diversi quando il Fisco li ritiene redditi da lavoro;
- Errori nella dichiarazione dei redditi o mancata applicazione della ritenuta.
📌 Conseguenze possibili
- Recupero delle imposte non versate sui compensi percepiti;
- Sanzioni dal 90% al 180% delle somme contestate;
- Interessi di mora;
- Nei casi più rilevanti, accertamenti retroattivi fino a 7 anni;
- Possibile riqualificazione del rapporto come lavoro dipendente o autonomo con obblighi contributivi.
🔍 Come difendersi
- Analizza l’avviso di accertamento: individua i compensi contestati e il periodo d’imposta.
- Raccogli la documentazione: contratti, delibere del consiglio direttivo, ricevute di pagamento, attestazioni della ASD o federazione.
- Dimostra il rispetto delle soglie di esenzione e la natura dilettantistica del rapporto.
- Contesta le presunzioni del Fisco: non tutti i pagamenti ricevuti sono imponibili.
- Predisponi memorie difensive o ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la contestazione e verifica la corretta qualificazione dei compensi;
- 📌 Ricostruisce la posizione fiscale con prove documentali;
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi contro le pretese del Fisco;
- ⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nei giudizi tributari;
- 🔁 Ti assiste anche in soluzioni agevolate, come adesione o ravvedimento, per ridurre sanzioni e interessi.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in fiscalità dello sport dilettantistico;
- ✔️ Specializzato in contenzioso tributario e difesa da accertamenti su compensi sportivi;
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Un accertamento per omissione di compensi da attività sportive dilettantistiche può avere conseguenze pesanti, ma non sempre è fondato.
Con una difesa legale mirata puoi dimostrare la natura agevolata dei compensi, ridurre le pretese fiscali e proteggere i tuoi diritti.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti sui compensi sportivi inizia qui.