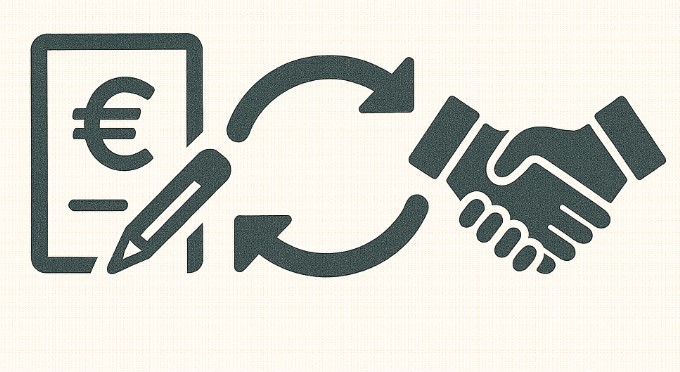Hai ricevuto un avviso di accertamento o sei in contenzioso con il Fisco e vuoi evitare anni di processo e costi elevati? In molti casi puoi chiudere la controversia con un accordo stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate, che ti permette di ridurre imposte, sanzioni e interessi, definendo la lite in modo rapido e vantaggioso.
Che cos’è l’accordo stragiudiziale
L’accordo stragiudiziale è uno strumento che consente al contribuente e al Fisco di trovare un’intesa senza arrivare a una sentenza. Può avvenire in diverse forme:
– Accertamento con adesione: si discute con l’ufficio e si trova un accordo sull’imposta dovuta, con riduzione delle sanzioni
– Conciliazione giudiziale: se il processo è già iniziato, le parti possono chiudere la lite con un’intesa davanti al giudice tributario
– Definizioni agevolate: procedure straordinarie che permettono di chiudere le liti pendenti con condizioni di favore stabilite dalla legge
Quando conviene un accordo con l’Agenzia delle Entrate
– Se l’accertamento contiene elementi discutibili ma fondati in parte
– Se vuoi ridurre sanzioni e interessi evitando l’incertezza di un processo
– Se desideri rateizzare le somme dovute e bloccare azioni esecutive
– Se preferisci avere certezza immediata sui costi invece di rischiare una condanna più pesante in giudizio
Vantaggi dell’accordo stragiudiziale
– Riduzione consistente delle sanzioni (fino a un terzo del minimo previsto)
– Possibilità di pagare a rate quanto concordato
– Chiusura rapida della controversia senza anni di processo
– Maggiore prevedibilità sui costi effettivi da sostenere
– Eliminazione dei rischi legati a un giudizio sfavorevole
Come si fa per bene un accordo stragiudiziale
– Analizzare attentamente l’avviso di accertamento e le contestazioni del Fisco
– Raccogliere i documenti utili a sostenere la propria posizione
– Avviare il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate tramite adesione o conciliazione
– Valutare la convenienza economica dell’accordo rispetto al rischio di lite
– Formalizzare l’intesa con il pagamento (anche rateale) delle somme concordate
Il ruolo dell’avvocato nella trattativa
– Individuare i punti deboli delle contestazioni fiscali e usarli come leva negoziale
– Preparare la documentazione difensiva più efficace
– Condurre la trattativa con l’Agenzia delle Entrate con approccio tecnico-giuridico
– Garantire che l’accordo sia conveniente e rispetti i diritti del contribuente
– Evitare che l’intesa diventi più onerosa di quanto lo sarebbe stato il processo
Cosa puoi ottenere con una difesa mirata
– La chiusura definitiva della lite col Fisco
– La riduzione sostanziale di imposte, sanzioni e interessi
– La possibilità di rateizzare senza rischi di pignoramenti o sequestri
– La protezione del tuo patrimonio personale e aziendale
– Un risparmio di tempo e denaro rispetto a un processo lungo e incerto
⚠️ Attenzione: non tutti gli accordi sono realmente vantaggiosi. Firmare senza analisi preventiva può portare a pagare più del dovuto. Serve un esame attento della convenienza, da fare insieme a un professionista.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e negoziazione con il Fisco – ti spiega come funziona un accordo stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate e come farlo per bene per proteggere i tuoi interessi.
👉 Hai ricevuto un avviso di accertamento e vuoi valutare un accordo con l’Agenzia delle Entrate? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso, valuteremo la convenienza della trattativa e costruiremo la strategia più efficace per chiudere la lite alle migliori condizioni.
Introduzione
Negoziare un accordo stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate significa risolvere pendenze fiscali senza affrontare un lungo contenzioso in tribunale. Dal punto di vista del debitore, cercare una soluzione bonaria può evitare sanzioni aggiuntive, ridurre l’importo dovuto e scongiurare azioni esecutive (come pignoramenti). Tuttavia, il Fisco (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate–Riscossione) è vincolato da norme precise: non è possibile “trattare” liberamente l’entità delle imposte dovute, se non entro i limiti previsti dalla legge. I percorsi stragiudiziali efficaci sono quelli stabiliti dalla normativa, che consentono sconti su sanzioni e interessi o piani di pagamento agevolati, garantendo comunque allo Stato la riscossione del dovuto.
In questa guida approfondita (aggiornata a luglio 2025), esamineremo tutti gli strumenti deflativi del contenzioso e le procedure di definizione agevolata dei debiti fiscali. Illustreremo le norme italiane rilevanti, con riferimenti a leggi e sentenze recentissime, offriremo tabelle riepilogative e simulazioni pratiche. Il taglio è avanzato: pensato per avvocati, imprenditori e privati che vogliono capire come “fare per bene” un accordo con il Fisco, in linguaggio giuridico ma accessibile. Le possibili strategie saranno esaminate dal punto di vista del debitore: come massimizzare i benefici di legge ed evitare errori, mantenendo la legalità e prevenendo conseguenze peggiori.
Nota: Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate nella sezione finale Fonti e Riferimenti.
Perché cercare un accordo stragiudiziale con il Fisco conviene
Affrontare l’Agenzia delle Entrate con un accordo stragiudiziale conviene in molti casi sia ai contribuenti sia all’Amministrazione finanziaria. Ecco i motivi principali:
- Riduzione di sanzioni e spese: Molti istituti deflativi prevedono un abbattimento significativo delle sanzioni amministrative. Ad esempio, mediante conciliazione giudiziale le sanzioni possono essere ridotte al 40% del minimo in primo grado e al 50% in appello, e persino al 60% in Cassazione secondo le ultime riforme. In alcuni casi speciali (come la conciliazione agevolata 2023), si è arrivati perfino a sanzioni ridotte a 1/18 del minimo. La riduzione delle sanzioni abbassa drasticamente il totale dovuto.
- Risparmio di tempo e costi del contenzioso: Un accordo evita anni di battaglie legali dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie) e la possibile escalation fino in Cassazione. Si ottiene una chiusura definitiva della lite spesso in pochi mesi, evitando anche le spese legali future. Dal lato dell’Erario, si incassa prima e con meno impiego di risorse amministrative.
- Minor aggravio di interessi e nessuna mora ulteriore: Definire subito il debito evita l’accumularsi di interessi di mora (che decorrono durante la riscossione coattiva). Alcune definizioni agevolate azzerano proprio gli interessi di mora e le misure aggiuntive di riscossione (aggio) su periodi pregressi. Inoltre, finché è in corso un procedimento di accordo o una rateazione attiva, sono sospese le azioni esecutive e non maturano ulteriori sanzioni (salvo decadenza dall’accordo, di cui diremo oltre).
- Possibilità di pagamento rateale e sostenibile: Gli accordi con il Fisco spesso consentono la rateizzazione degli importi dovuti. Ad esempio, un accordo in conciliazione giudiziale permette di dilazionare il pagamento concordato; le definizioni agevolate come la “rottamazione” prevedono piani fino a 18 rate in 5 anni; le rateizzazioni ordinarie possono arrivare ora fino a 10 anni in casi di difficoltà. Ciò aiuta il debitore a onorare l’accordo “per bene”, evitando nuovi default.
- Certezza del debito e pace fiscale: Raggiungere un accordo stragiudiziale chiude le pendenze in modo definitivo (nel caso di definizione della controversia) o comunque stabilizza la situazione. Ad esempio, con un accertamento con adesione o una conciliazione, il contribuente conosce esattamente quanto deve pagare (ridotto) e, rispettando i termini, sa che non avrà ulteriori pretese su quella materia. Si ottiene così una sorta di “pace fiscale” individuale, distinta dalle sanatorie generali.
Ovviamente, non sempre è possibile o conveniente accordarsi: tutto dipende dalla situazione specifica del debito (importo, tipo di tributo, fondatezza delle contestazioni, capacità finanziaria del debitore). Nelle sezioni seguenti, vedremo quali strumenti offre la normativa per definire bonariamente le pretese del Fisco, e in quali circostanze conviene utilizzarli (o evitarli).
Quadro Generale degli Strumenti Deflativi e di Definizione Agevolata
La normativa italiana prevede una serie di strumenti – alcuni amministrativi, altri giudiziari, altri ancora legislativi straordinari – che consentono al contribuente di risolvere una pendenza fiscale senza arrivare (o proseguire) fino alla sentenza definitiva. Possiamo distinguere due grandi categorie:
- Strumenti deflativi del contenzioso tributario: sono procedure endoprocedimentali o endoprocessuali che intervengono prima che il debito diventi definitivo, o comunque prima che si concluda il giudizio. Includono:
- Autotutela amministrativa;
- Acquiescenza all’accertamento;
- Accertamento con adesione;
- Mediazione tributaria (per le liti minori);
- Conciliazione giudiziale (in primo, secondo grado e ora anche in Cassazione).
- Strumenti di definizione agevolata della riscossione: operano dopo che il debito è iscritto a ruolo o comunque in fase di riscossione, offrendo piani di pagamento o sconti su interessi e sanzioni. Comprendono:
- Rateizzazioni ordinarie e straordinarie dei carichi affidati all’Agente della Riscossione;
- Definizioni agevolate dei ruoli (le cosiddette rottamazioni delle cartelle);
- Saldo e stralcio (misure speciali per contribuenti in difficoltà, attivate in casi straordinari per legge);
- Transazione fiscale e contributiva nell’ambito di procedure di crisi (concordati, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata);
- Altri provvedimenti legislativi di condono o stralcio, come la cancellazione automatica di mini-debiti.
Nelle prossime sezioni analizzeremo in dettaglio ciascuno di questi strumenti. Per prima cosa, presentiamo una tabella riepilogativa che li mette a confronto:
Tabella 1 – Strumenti deflativi vs. strumenti di definizione debiti fiscali
| Strumento | Normativa di riferimento | Quando si applica | Benefici per il debitore | Limiti e condizioni |
|---|---|---|---|---|
| Autotutela (annullamento d’ufficio) | Art. 2-quater D.L. 564/1994, L. 212/2000 (Statuto contrib.) | Fase amministrativa: atto impositivo palesemente errato o illegittimo | Annullamento totale/parziale dell’atto senza costi | Discrezionale per l’ufficio; non sospende termini ricorso se non accolto. |
| Acquiescenza all’accertamento | Art. 15 D.Lgs. 218/1997 (adesione) e L. 289/2002 (condoni) | Dopo notifica accertamento esecutivo, entro termini per ricorso | Riduzione sanzioni a 1/3 del minimo (o altre % previste) pagando entro 30 gg; rate fino a 8 trimestri | Preclusa se si presenta ricorso; implica accettazione integrale del tributo accertato. |
| Accertamento con adesione | D.Lgs. 218/1997 | Dopo avviso di accertamento (imposte dirette, IVA, registro, etc.) prima del ricorso | Riduzione sanzioni a 1/3 del minimo; definizione concordata dell’imponibile; pagamento rateale fino a 8 rate trimestrali | Richiesta di adesione sospende termini ricorso per 90gg; accordo formalizzato con atto firmato; decadenza se non si paga la 1ª rata nei termini (atto nullo). |
| Mediazione tributaria | Art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 (come mod. da D.L. 50/2017) | Controversie fino a €50.000 in primo grado (obbligatoria prima del ricorso) | Possibile annullamento parziale dell’atto o accordo con sgravio; se mediazione riesce, sanzioni ridotte al 35% (norma previgente) – ora assorbita dalla conciliazione pre-udienza | Necessaria istanza entro 30gg dalla notifica atto; silenzio 90gg = rifiuto (si procede in giudizio); non applicabile oltre soglia valore. (Sostituita in parte dalla conciliazione su proposta del giudice introdotta nel 2023). |
| Conciliazione giudiziale | Art. 48, 48-bis, 48-ter D.Lgs. 546/1992 (mod. L. 130/2022 e D.Lgs. 220/2023) | Contenzioso in corso in CGT 1° o 2° grado; dal 2024 anche in Cassazione | Possibile riduzione del tributo contestato per accordo tra le parti; sanzioni ridotte al 40% in 1° grado, 50% in appello, 60% in Cassazione; interessi da riscossione dimezzati; pagamento rateale fino a 8 rate trimestrali; giudizio estinto con sentenza di cessata materia del contendere. | Proposta da contribuente, AdE o giudice (48-bis.1); accordo omologato dal giudice. Decadenza se salta una rata: si perde accordo e AdE recupera l’importo originario con sanzioni piene. Non applicabile per sanzioni penali (solo amministrative). |
| Rateizzazione ordinaria (ruoli) | Art. 19 DPR 602/1973 (mod. D.Lgs. 110/2024) | Dopo notifica cartella/avviso esecutivo; per dilazionare importi dovuti | Piano fino a 72 rate mensili (6 anni) automatico se debito ≤ €120.000. Dal 2025: fino 84 rate per richieste 2025-26. Nessuna garanzia richiesta. Sospende azioni esecutive pendenti. | Necessario stato di temporanea difficoltà (anche autocertificato per importi medio-piccoli). Per debiti > €120.000 serve prova di grave difficoltà e possibile piano fino a 120 rate (10 anni). Decadenza se saltano 8 rate anche non consecutive (nuova soglia 2024); dopo decadenza si perde beneficio e l’intero carico è immediatamente esigibile. |
| Rateizzazione straordinaria | Art. 19 DPR 602/1973 e D.M. 6/11/2013 | (Vedi sopra; disciplina unificata con ordinaria dal 2025) | Prevista per “comprovata e grave difficoltà” su debiti grandi: consente fino a 120 rate anche se debito ≤ €120.000. Dal 2025 introdotte soglie progressive: es. richieste 2025-26 possibili 85–120 rate se documentata difficoltà anche su debiti minori. | Richiede documentazione della crisi di liquidità (indici di bilancio, ISEE, etc.); concessione discrezionale ma uniformata da criteri di legge e provvedimenti attuativi. Decadenza dopo 8 rate non pagate. Possibile una sola proroga per nuovi piani se in regola con requisiti. |
| Definizione agevolata dei ruoli (“Rottamazione” cartelle) | Leggi di bilancio/Decreti speciali: es. art. 1 commi 231-252 L. 197/2022 (rottamazione-quater) | Prevista da leggi straordinarie (2016, 2018, 2023 ecc.) per carichi affidati in certe date. Domanda del debitore entro scadenza prevista (es. 30/6/2023 per rottamazione 2023). | Stralcio integrale di sanzioni e interessi di mora su debiti ammessi; pagamento solo dell’imposta/capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ridotti); nessun aggio di riscossione dovuto. Piano fino a 18 rate in 5 anni con interesse agevolato 2%. Sospensione immediata di pignoramenti e fermi pendenti. | Ammessi solo ruoli affidati in specifici anni (es. fino al 30/6/2022 per rottam.-quater). Occorre presentare la dichiarazione di adesione entro la scadenza di legge e rinunciare ai giudizi pendenti sui debiti rottamati. Decadenza se una rata paga con oltre 5 giorni di ritardo: perdita di tutti i benefici, importi già versati imputati a acconto e cartella revives con sanzioni/ interessi originari. (Nota: nel 2025 è stata prevista la riammissione eccezionale per chi è decaduto entro il 2024, v. oltre.) |
| Saldo e stralcio (persone fisiche in difficoltà) | Art. 1 commi 184-198 L. 145/2018 (Saldo e stralcio 2019); normative simili in DL 34/2019 | Misura una tantum (2019) per cartelle di persone fisiche su alcune imposte non versate, con ISEE familiare ≤ €20.000. Scadenza domande 2019 (conclusa). | Stralcio parziale del debito: pagamento percentuale ridotta (16%, 20% o 35% del dovuto a seconda dell’ISEE e tipologia) in 5 rate fino al 2021. Azzeramento sanzioni e interessi. | Applicabile solo ai debiti specificati (es. omessi versamenti dichiarazioni annuali) e a persone in grave difficoltà economica (ISEE documentato). Termine scaduto, non riproposto nelle sanatorie 2023-25 (salvo ipotesi future). Chi decadde dal saldo e stralcio confluisce nei ruoli ordinari. |
| Stralcio automatico mini-debiti | Leggi speciali: es. art. 4 DL 41/2021 conv. L. 69/2021; art. 1 c. 227 L. 197/2022 | Previsto da norme di “stralcio” per importi esigui: ad es. cancellazione debiti fino €5.000 affidati 2000-2010 (DL 41/2021); fino €1.000 affidati 2000-2015 (L. 197/2022). Attuato d’ufficio dall’Agente Riscossione. | Cancellazione totale del debito quota residua (capitale, interessi, sanzioni) per i ruoli ammessi, senza necessità di domanda. Comunicazione al contribuente dell’avvenuto annullamento. | Limite di importo e di periodo di riferimento rigorosi. Non copre debiti per recupero aiuti di Stato, danno erariale, multe penali, ecc. Effetto una tantum alla data fissata dalla legge; se il carico non rientrava nei parametri resta dovuto per intero. |
| Transazione fiscale e contributiva (in procedure di crisi) | Art. 182-ter R.D. 267/1942 (vecchia L. Fall.); oggi: art. 63 D.Lgs. 14/2019 (Codice Crisi) | Concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti del debitore in stato di crisi/insolvenza, oppure in esito a composizione negoziata della crisi. Il debitore propone un trattamento dei debiti fiscali (e INPS) falcidiandoli o dilazionandoli. | Possibile “saldo e stralcio” sui tributi dovuti: pagamento parziale del credito tributario o contributivo e/o pagamento dilazionato oltre i limiti normali. Sospensione delle azioni esecutive una volta ammessa la procedura (misure protettive nel concordato o composizione). Se la transazione è approvata, il debitore esce dalla crisi pagando meno tasse di quanto dovuto originariamente, senza ulteriori pretese future (il residuo è inesigibile). | Necessario dimostrare che la proposta è più conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione fallimentare mediante relazione giurata di un professionista indipendente. Accettazione espressa richiesta: nell’accordo di ristrutturazione o composizione negoziata l’AdE deve aderire formalmente all’accordo (no cram-down). Nel concordato preventivo omologato, invece, il tribunale può imporre il cram-down fiscale se la maggioranza degli altri creditori approva e la proposta è equa (norme introdotte nel 2021, art. 180 L.F. / art. 112 CCII). L’AdE segue procedure interne rigorose: il direttore regionale/provinciale può sottoscrivere l’accordo solo con parere conforme dell’Ufficio “Crisi d’impresa” centrale. |
| Piani del consumatore / Ristrutturazione debiti del consumatore | L. 3/2012 (abrogata); ora art. 67-73, 77 CCII (concordato minore, ristrutt. soggetti non fallibili) | Persone fisiche sovraindebitate non soggette a fallimento, in stato di crisi conclamata. Si propone un piano ai creditori (anche Fisco) con pagamento parziale dei debiti. Necessaria omologazione del tribunale. | Possibile anche qui falcidiare debiti tributari (previo parere dell’AdE, salvo cram-down analoghi a sopra); al termine, se il piano è eseguito, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione: liberazione da eventuali debiti residui non pagati, compresi quelli fiscali (salvo debiti per dolo). | Complessità procedurale: serve assistenza di un OCC (Organismo composizione crisi) o gestore nominato dal tribunale. Il piano deve rispettare le cause di esclusione (no atti in frode). Per i debiti con privilegio (es. IVA) di norma va proposto un pagamento parziale non inferiore a quanto otterrebbero in liquidazione. Se AdE non aderisce, giudice può omologare se la ritiene comunque conveniente. Rischio penale per eventuali reati tributari resta (come in concordato). |
| Composizione negoziata della crisi | D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021; ora art. 12-25 CCII (Titolo II) | Imprese in crisi (anche piccole) che vogliono evitare il fallimento. Procedura volontaria e confidenziale con ausilio di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. Possibile sbocco in un contratto o accordo stragiudiziale con i creditori, inclusa l’AdE. | Procedura stragiudiziale protetta: l’imprenditore negozia coi creditori sotto tutela di misure protettive (blocco dei pignoramenti, ecc.) autorizzate dal tribunale. Novità 2022-2023: anche in un accordo di composizione negoziata è ammessa la transazione fiscale sui debiti tributari e contributivi, grazie al rinvio dell’art. 23, c.2 CCII all’art. 63 CCII. L’impresa può proporre un saldo e stralcio fiscale o una dilazione straordinaria nell’accordo. Se l’AdE accetta, l’accordo è stragiudiziale ma dotato di efficacia esecutiva tra le parti; in caso di successo il piano può evitare l’insolvenza e godere di misure premiali (riduzione sanzioni al minimo, nessuna segnalazione centrale rischi). | L’accordo è volontario: niente cram-down dal giudice in composizione negoziata (se AdE rifiuta, non si può forzarla). Serve anche qui relazione di esperto attestatore sulla convenienza della proposta per il Fisco rispetto all’alternativa liquidatoria. La trattativa è riservata ma va conclusa di norma entro 180 + 180 gg. Se non si raggiunge un accordo, l’imprenditore può accedere a procedure concorsuali formali (concordato, ecc.). |
(Legenda: CGT = Corte di Giustizia Tributaria, nuovo nome delle Commissioni Tributarie provinciali/regionali dal 2023; CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019.)
Come si evince dalla tabella, esistono molteplici vie stragiudiziali per affrontare il Fisco. La scelta dello strumento dipende dalla fase in cui ci si trova e dalla natura del debito:
- Se il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o una contestazione (ancora prima di una cartella esattoriale), può valutare adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione in corso di causa. Queste soluzioni puntano a chiudere il contenzioso con la minor pretesa possibile da parte del Fisco, in cambio di un rapido pagamento.
- Se invece esistono già cartelle esattoriali o ruoli iscritti a carico, gli strumenti diventano la rateizzazione o le definizioni agevolate (quando offerte da leggi speciali). In assenza di “rottamazioni” attive, la rateazione ordinaria è spesso l’unica strada per evitare misure esecutive immediate.
- In situazioni di grave crisi finanziaria del debitore (specie imprese), entrano in gioco le procedure concorsuali o para-concorsuali: solo attraverso di esse è possibile ottenere un effettivo taglio dell’imposta dovuta (il cosiddetto saldo e stralcio) al di fuori di condoni legislativi. Ciò richiede però il rispetto di formalità e garanzie (voto dei creditori, controllo del tribunale, pareri tecnici) per assicurare che lo Stato non rinunci a crediti se non strettamente necessario per evitare un male peggiore (il fallimento con incasso nullo o esiguo).
Nei prossimi paragrafi approfondiremo i principali strumenti, con riferimenti pratici e giurisprudenziali.
Soluzioni in sede amministrativa: autotutela, acquiescenza e accertamento con adesione
Prima ancora di arrivare in giudizio tributario, il contribuente può tentare di risolvere le contestazioni in via amministrativa:
- Autotutela: consiste nell’istanza all’ufficio fiscale (Agenzia delle Entrate) di annullare o correggere un atto impositivo palesemente errato o illegittimo. Ad esempio, se viene notificata una cartella per un importo già pagato o prescritto, si può chiedere all’ente creditore l’annullamento in autotutela. È uno strumento unilaterale dell’Amministrazione: il contribuente non ha un diritto soggettivo all’autotutela, ma solo un interesse. L’ufficio valuta e, se riconosce l’errore, adotta un provvedimento di annullamento parziale/totale o di sgravio. Vantaggi: evita il contenzioso e azzera subito l’atto. Limiti: non sospende automaticamente i termini di ricorso (conviene comunque presentare ricorso per sicurezza se i termini stringono) e non è impugnabile il rifiuto (Cass., Sez. Trib., nn. 7388/2007, 3698/2009). Dunque va usata in casi lampanti di errore materiale o duplicazione di imposizione, ove spesso l’AdE è collaborativa nel correggere.
- Acquiescenza all’accertamento: se il contribuente ritiene di non voler contestare un avviso di accertamento (magari perché la violazione c’è stata e non vede margini di vittoria in giudizio), può prestare acquiescenza all’atto pagando quanto dovuto entro i termini di legge. La normativa premia chi non intasa i ricorsi prevedendo la riduzione delle sanzioni irrogate: tipicamente, pagamento entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni ad 1/3 (oppure ad 1/6 in caso di rinuncia a impugnare avvisi di liquidazione, ecc.). Ad esempio, un avviso con sanzione del 30% dell’imposta, se definito in acquiescenza, vede la sanzione ridotta al 10%. Questo strumento è disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. 218/1997 e da norme speciali. Vantaggi: sanzioni ridotte e possibilità di rateizzare fino a 8 rate trimestrali se l’importo > €5.000. Attenzione: l’acquiescenza impedisce qualsiasi successiva impugnazione: si accetta integralmente l’accertamento. Inoltre, occorre pagare nei termini: il mancato versamento fa perdere il beneficio e l’atto torna dovuto per intero.
- Accertamento con adesione: è un vero “accordo” bilaterale prima del giudizio. Previsto dal D.Lgs. 218/1997, consente al contribuente che riceve un avviso di accertamento (o un processo verbale di constatazione, in certi casi) di chiedere un contraddittorio all’ufficio. Durante l’incontro, si discute la pretesa fiscale e si può “mediare” sull’imponibile: l’ufficio, valutati gli elementi, può rideterminare a ribasso l’imposta dovuta, tenendo conto delle osservazioni del contribuente. Se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto di adesione con le nuove somme. I benefici per il contribuente sono: sanzioni ridotte a 1/3 del minimo (ad esempio sanzione del 90% passa al 30%) e possibilità di pagamento in rate trimestrali (fino a 8 rate se importo > €50.000, altrimenti 6). L’adesione comporta la definitività dell’accertamento per le parti concordate: non si può impugnare l’atto definito, salvo vizi di volontà (ad esempio annullabilità per errore materiale o dolo). È quindi fondamentale “trattare per bene”: verificare che l’ufficio abbia effettivamente rivisto la pretesa in modo equo. Spesso l’AdE accorda riduzioni su sanzioni e interessi e, talvolta, riconosce parzialmente le ragioni del contribuente (es. abbattendo alcuni imponibili contestati). Limiti: l’adesione non è ammessa per alcune materie (ad es. non sugli avvisi bonari o atti di mera liquidazione). Inoltre, se il contribuente dopo aver firmato l’adesione non paga la prima rata entro 20 giorni, l’accordo si risolve di diritto (come se mai raggiunto) e l’AdE potrà procedere per l’intero importo originario, detratto quanto eventualmente versato a titolo di acconto. Bisogna quindi essere certi di poter rispettare i pagamenti concordati.
Simulazione pratica: Mario riceve un accertamento per redditi non dichiarati con €50.000 di maggiore IRPEF e €25.000 di sanzioni (50%). Ritenendo l’importo troppo elevato ma conscio di avere qualche irregolarità, Mario presenta istanza di adesione. Durante il contraddittorio, evidenzia costi deducibili non considerati dall’ufficio e ottiene la riduzione dell’imponibile, con un nuovo IRPEF dovuta di €30.000. L’ufficio applica la sanzione minima del 90% sull’imposta evasa, ma grazie all’adesione questa sanzione è ridotta ad 1/3: quindi sanzione effettiva 30% di €30.000 = €9.000 (contro i €25.000 iniziali). Mario accetta e firma l’atto, impegnandosi a pagare €39.000 (imposta + sanzioni ridotte + interessi legali) in 6 rate trimestrali. Risultato: debito complessivo ridotto di oltre €16.000 rispetto all’atto iniziale, niente contenzioso, e pagamento dilazionato in 18 mesi. Mario deve però pagare puntualmente le rate: se ne saltasse una, l’accordo salterebbe e tornerebbe dovuto il vecchio importo (€75.000 più mora).
Mediazione e conciliazione nel processo tributario
Quando la fase amministrativa si chiude senza accordo (o per atti per cui non è prevista l’adesione), il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Provinciale). Anche all’interno del procedimento giurisdizionale esistono opportunità di accordo stragiudiziale:
- Mediazione tributaria: per le liti di valore non eccedente €50.000, fino al 2022 era previsto l’obbligo di presentare un’istanza di reclamo-mediazione prima di andare in udienza (art. 17-bis D.Lgs. 546/92). In pratica, il ricorso introduttivo fungeva anche da proposta di mediazione: l’ufficio locale dell’AdE poteva accoglierla in tutto o in parte entro 90 giorni. Se accoglieva parzialmente, l’accordo si perfezionava con il pagamento del dovuto rideterminato e con sanzioni ridotte al 35% (secondo la disciplina ante 2023). Questa forma di mediazione amministrativa ha avuto successo limitato e spesso sfociava in un nulla di fatto (silenzio rigetto), rimandando la soluzione al giudice. Novità: la riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) ha rafforzato la conciliazione e di fatto superato la mediazione obbligatoria, almeno come la conoscevamo. Dal 2023, il giudice tributario può formulare d’ufficio una proposta conciliativa già all’udienza, e se una parte la richiede l’udienza può essere rinviata per valutare l’offerta. Ciò consente di risolvere le liti minori in tempi ancor più rapidi. La mediazione ex art. 17-bis rimane in vigore come filtro formale, ma nei fatti viene inglobata nel nuovo istituto della conciliazione facilitata. (Va comunque ricordato che per i ricorsi notificati fino al 30/6/2023 la mediazione era necessaria: se omessa, il ricorso era inammissibile.)
- Conciliazione giudiziale: è il vero cardine per chiudere le liti tributarie già avviate senza attendere la sentenza. Prevista dagli artt. 48 e segg. D.Lgs. 546/92, può avvenire in udienza o fuori udienza. Le parti (contribuente e funzionario AdE) concordano un importo transattivo: in genere, il contribuente accetta di pagare una parte del tributo originariamente preteso, e l’ufficio rinuncia al resto e riduce sanzioni e interessi secondo la legge. Come già accennato, la conciliazione comporta per legge le seguenti riduzioni sulle sanzioni amministrative applicate:
- 40% del minimo edittale se l’accordo si perfeziona in primo grado (in pratica, sconto 60% sulla sanzione);
- 50% del minimo in caso di conciliazione raggiunta in appello (sconto 50% sulla sanzione);
- 60% del minimo per conciliazioni in sede di Corte di Cassazione (introdotto dal D.Lgs. 220/2023, applicabile ai ricorsi in Cassazione notificati dal 5 gennaio 2024). Ciò significa un minor beneficio, ma comunque una riduzione del 40% sulla sanzione dovuta.
Domanda: “Conviene sempre conciliare con l’AdE se ho un ricorso pendente?”
Risposta: Non sempre. La conciliazione è vantaggiosa se il contribuente ha chance incerte in giudizio e preferisce garantirsi uno sconto oggi che rischiare una sconfitta domani (che comporterebbe pagare tutto e magari aggravio di spese). Inoltre conviene se l’importo in gioco e le sanzioni sono elevati: lo sconto del 50-60% sulle sanzioni e la possibile riduzione del tributo sono appetibili. Viceversa, se il contribuente ha ottime probabilità di vincere annullando tutto (per es., un vizio procedurale chiaro), potrebbe proseguire la causa. Anche in caso di giurisprudenza incerta, spesso le parti preferiscono accordarsi evitando il “tutto o nulla” del giudizio. Da notare che dal 2023 la legge incoraggia la conciliazione persino in Cassazione: segno che il legislatore stesso la vede come strumento cardine per deflazionare il contenzioso. In pratica, conviene valutare la conciliazione caso per caso, facendosi consigliare da un fiscalista: si bilanceranno i rischi di causa, la tenuta finanziaria (cosa posso pagare subito) e l’interesse del Fisco a chiudere.
Definizioni agevolate dei debiti in fase di riscossione: rateazioni e “rottamazioni”
Se il debito tributario è già iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), la partita si sposta sul terreno della riscossione. In questa fase il contribuente non può più discutere nel merito (salvo vizi di notifica o prescrizioni, da far valere con opposizioni specifiche), ma può negoziare tempi e modalità di pagamento. Vediamo gli strumenti principali:
Rateizzazione ordinaria delle cartelle
La rateizzazione è il classico strumento per dare respiro al debitore. La disciplina di riferimento è l’art. 19 del DPR 602/1973, oggetto di recenti modifiche significative (da ultimo il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, attuativo della delega fiscale). Ecco le regole aggiornate al 2025:
- Per importi fino a €120.000, il contribuente può ottenere un piano fino a 72 rate mensili (6 anni) con semplice istanza e autodichiarazione di temporanea difficoltà. Non serve più documentare l’ISEE o produrre garanzie; l’accesso è automatico se si rispettano importo e tempi. Novità: dal 1° gennaio 2025, il limite di 72 rate è stato elevato a 84 rate (7 anni) per le richieste presentate nel 2025-2026. Ciò significa che ad esempio un debito di €60.000 può essere dilazionato in 84 mesi su semplice richiesta, riducendo la rata mensile.
- Per importi superiori a €120.000 (o se si vuole una dilazione più lunga di quella “automatica”), occorre comprovare una grave e comprovata difficoltà economica. In tal caso l’Agente della Riscossione può concedere piani fino a 120 rate mensili (10 anni) indipendentemente dall’importo. Gli indici per misurare la difficoltà sono fissati dal DM 6/11/2013 (rapporto tra rata e reddito disponibile per le persone fisiche, o indici di liquidità per le imprese). Importante: sempre dal 2025 sono state introdotte soglie graduali anche qui: ad esempio, per debiti ≤ €120.000 se uno vuole più di 84 rate, può averle ma almeno 85 rate se domanda nel 2025-26 (range 85-120), almeno 97 rate nel 2027-28, ecc. In pratica:
- Debito ≤120k, nessuna prova = max 84 rate (2025-26); con prova = min 85 rate, fino 120.
- Debito >120k, con prova = fino 120 rate comunque.
- Tasso di interesse: sulle rateazioni ordinarie si applicano gli interessi di dilazione dal giorno successivo alla notifica dell’atto. Il tasso è determinato annualmente (era 3,5% annuo, poi 4,5%, per il 2023 è salito al 6% data l’inflazione). Sulle rate da 2024 può essere intorno al 6% annuo (da verificare sul sito AdER). Nelle definizioni agevolate, invece, si applicano tassi ridotti (es. 2% per rottamazione-quater).
- Decadenza: la legge ora è più clemente. Dal 2022 la soglia di tolleranza è salita e nel 2024 è stata uniformata: il debitore decade dal piano solo se omette il pagamento di 8 rate complessive, anche non consecutive. Prima erano 5 rate. Ciò consente qualche “distrazione” in più: ad esempio, non pagando per 7 mesi (anche alternati), il piano rimane comunque valido; al mancato pagamento dell’ottava rata, si perde invece il beneficio per legge. Attenzione: per piani concessi prima delle nuove norme, vale la soglia prevista al momento (spesso 5 rate).
- Effetti della rateazione: ottenuto il provvedimento di accoglimento, sono sospese le azioni esecutive. L’Agente della Riscossione non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche e non può procedere a pignoramenti salvo il caso di decadenza. Se vi erano pignoramenti in corso, restano sospesi (possono essere estinti se il creditore aderisce). Inoltre, l’eventuale durata della rateazione sospende la prescrizione. Non vengono meno eventuali garanzie (fermi già iscritti di solito restano finché non si pagano un certo numero di rate).
- Cumulo di più debiti: si può chiedere una rateazione unica per più cartelle o anche mantenere piani separati. Dal 2023 la legge consente di ottenere nuove rateazioni anche se si ha già un piano attivo per altri debiti. In passato c’era il divieto di rateare nuove cartelle se si era decaduti da una precedente negli ultimi 2 anni, ora superato. Attualmente, se si decade da un piano, è possibile chiederne un nuovo sullo stesso debito solo pagando prima tutte le rate scadute del vecchio (o in alcuni casi, attendendo 30 giorni dalla decadenza); su questo le norme sono tecniche, ma la riforma ha eliminato molte preclusioni per favorire il rientro.
Domanda: “Ho una cartella di €10.000, posso chiedere 10 anni di tempo per pagarla?”
Risposta: Per un importo di €10.000, senza dover provare nulla puoi ottenere fino a 84 rate (7 anni) se presenti la domanda nel 2025-2026. Per arrivare a 10 anni (120 rate) dovresti però documentare una seria difficoltà economica (es. ISEE basso, stato di crisi finanziaria) perché la dilazione straordinaria a 120 mesi richiede prova. Inoltre, se richiedi l’estensione massima su un debito così piccolo, dal 2025 devi chiedere almeno 85 rate. In pratica, potresti ottenere ad esempio 100 rate mensili da circa €100 l’una. Valuta però gli interessi: su 10 anni maturerebbero interessi di dilazione (al tasso attuale intorno al 5-6%) che aumentano il costo complessivo. Se riesci, meglio 7 anni o meno.
Le “Rottamazioni” delle cartelle (Definizioni agevolate dei ruoli)
Negli ultimi anni il legislatore italiano è più volte intervenuto con misure straordinarie di definizione agevolata dei carichi a ruolo, note come “rottamazione delle cartelle”. Si tratta di disposizioni temporanee che consentono ai contribuenti di pagare i debiti iscritti a ruolo con uno sconto consistente: tipicamente vengono azzerati le sanzioni e gli interessi di mora, richiedendo solo il pagamento del capitale e degli interessi “da ritardata iscrizione” (quelli calcolati dall’anno d’imposta fino al ruolo) se dovuti.
Le varie edizioni:
- Rottamazione 2016 (D.L. 193/2016): copriva ruoli 2000-2016, con pagamento entro 2018.
- Rottamazione-bis 2017 (D.L. 148/2017): ampliò ad alcuni esclusi e ruoli 2017.
- Rottamazione-ter 2018 (D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018): copriva ruoli fino a 2017, pagamento a rate fino al 2021.
- Rottamazione-quater 2023 (L. 197/2022, commi 231-252): copre ruoli affidati dal 2000 al 30 giugno 2022, con pagamento in 18 rate dal 2023 al 2027.
Focus su Rottamazione-quater (la più recente e rilevante al 2025):
- Bisognava presentare domanda entro il 30 giugno 2023 (poi per alcuni casi di alluvione prorogata al 30/9/2023).
- Il debitore doveva indicare in dichiarazione le cartelle che intende definire e dichiarare l’eventuale presenza di giudizi pendenti su di esse, impegnandosi a rinunciarvi. La legge (art. 1 c. 236 L.197/2022) prevedeva infatti che i giudizi fossero sospesi dal giudice su richiesta, e che si estinguessero solo a completamento del pagamento agevolato. (Tuttavia, come visto, la Cassazione ha interpretato in modo più favorevole al contribuente l’effetto processuale, ritenendo sufficiente l’adesione per dichiarare cessata la materia del contendere, con eventuale reviviscenza solo su istanza se salta la definizione).
- Una volta presentata l’istanza, l’Agente della Riscossione inviava la comunicazione delle somme dovute (entro il 30/6/2023, poi prorogato al 30/9/2023). Il pagamento poteva avvenire: in unica soluzione (scadenza iniziale 31/10/2023) oppure in max 18 rate così strutturate: 2 rate nel 2023 (scadenze 31/10, 30/11/2023) ciascuna pari al 10% del dovuto, e le restanti 16 rate ripartite dal 2024 al 2027, con scadenze fisse 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno. È prevista la tolleranza di 5 giorni su ogni scadenza.
- Interesse di dilazione sulle rate: 2% annuo (notevolmente inferiore ai tassi ordinari).
- Benefici: come detto, completo condono di sanzioni e interessi di mora. In più, non si pagano le somme aggiuntive come l’aggio di riscossione e le spese di notifica. Restano dovuti: il capitale originario, gli interessi “da ritardata iscrizione a ruolo” (ossia quelli calcolati dall’anno d’imposta fino alla consegna in cartella, se previsti, ad esempio sugli omessi versamenti), e le spese vive (poche decine di euro per eventuali procedure già avviate). In pratica, sul grosso delle cartelle fiscali (IRPEF, IVA) si paga solo l’imposta. Su quelle da controllo automatizzato (avvisi bonari non pagati confluiti in cartella), in genere si paga l’imposta più gli interessi da ritardata iscrizione (4% annuo per le imposte dirette) ma non la sanzione 10%. Un affare, insomma, per chi ha molte sanzioni pendenti.
- Decadenza: la rottamazione perde efficacia se non si pagano le rate nei termini previsti (con i 5 gg di tolleranza). Non è ammesso ritardo maggiore, né compensazione, né ritardo anche di una sola rata: l’intero beneficio decade e i versamenti parziali effettuati vengono semplicemente scalati dal debito residuo, che torna esigibile in via ordinaria. Non c’è possibilità di dilazione ulteriore di quel debito residuo in via ordinaria? In realtà, ora c’è: vedi riammissione e nuove regole infra.
La rottamazione-quater ha riscosso molto interesse: milioni di cartelle sono state inserite nelle domande. Tuttavia, non tutti sono riusciti a rispettare le prime scadenze, oppure non hanno fatto in tempo a presentare la domanda. Il legislatore è intervenuto nuovamente con il Decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. 198/2023 conv. in L. 15/2025): questa legge ha riaperto i termini per alcuni casi e introdotto nuove opportunità per i debiti non rottamati:
- Riammissione dei decaduti 2024: I contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione-quater per non aver pagato una o più rate in scadenza nel 2023 o 2024 hanno potuto chiedere di rientrare nel beneficio. Bisognava presentare istanza entro il 30 aprile 2025 e pagare le rate arretrate (o l’importo dovuto spalmato) in massimo 10 rate a partire dal 31 luglio 2025. In pratica, se uno non aveva pagato le rate di ottobre/novembre 2023 o quelle di febbraio/maggio 2024, è stato “perdonato”: ha potuto ridividere il debito residuo in 10 rate con scadenze presumibilmente simili alle originali (la prima al 31/7/2025). Questa riammissione, però, non vale per chi è decaduto dopo il 31/12/2024 (es. chi non paga una rata del 2025): costoro, al momento, restano fuori (si vedrà se in futuro vi saranno ulteriori proroghe).
- Riapertura per carichi non rottamati: sempre la L. 15/2025 ha previsto che chi non aveva presentato affatto domanda di rottamazione-quater (ad esempio perché le sue cartelle erano state affidate dopo il 30/6/2022, quindi escluse, o per dimenticanza) può usufruire di piani di rateazione più lunghi alle nuove condizioni dal 2025. In altre parole, non c’è stata una “rottamazione-quater bis” nel 2025, ma si offre l’alternativa: se non hai sanato col 2023 e ora non rientri, puoi comunque chiedere una dilazione fino a 7 o 10 anni (84 o 120 rate) grazie alla riforma delle rateazioni. Certo, non c’è lo sconto di sanzioni: si pagherà tutto, però almeno a lungo termine.
- Nessuna nuova rottamazione generale nel 2024-2025: la Legge di Bilancio 2024 non ha introdotto una “rottamazione-quinquies” onnicomprensiva, e neppure il DL “Alluvioni” o il DL Fiscale di fine 2024. Dunque, chi sperava in un altro condono integrale è rimasto deluso. Tuttavia, come detto, il Milleproroghe 2025 ha esteso le chance di rientro e di dilazione. Alcune voci su una possibile “rottamazione-quater estesa” si sono rincorse nel 2025, ma al momento (luglio 2025) non c’è una norma di riapertura per chi non ha usufruito della definizione agevolata su ruoli ante-2022. Si discute, piuttosto, di alleggerire il carico futuro: ad esempio, c’è l’idea di una “rottamazione permanente” delle sanzioni per chi paga subito, come parte della delega fiscale. Ma per ora nulla di concreto in vigore.
Domanda: “Sono decaduto dalla rottamazione-ter anni fa: posso fare qualcosa ora?”
Risposta: La rottamazione-ter (2018) aveva un suo calendario di pagamenti, poi prorogato causa Covid fino al 2021. Se sei decaduto da quella, purtroppo la rottamazione-quater 2023 non copriva automaticamente i debiti già “saltati”, a meno che tu non abbia presentato domanda includendo quei carichi rimasti. Se non l’hai fatto, ora quei debiti sono tornati attivi con sanzioni e interessi pieni. Nel 2023-25 non c’è stata una riammissione dei decaduti dalla rottamazione-ter (salvo il caso di definizione in concordato o simili). L’unica strada è chiedere una rateizzazione ordinaria di quei carichi. Buona notizia: dal 2025 puoi ottenere 10 anni anche per quelli (se dimostri difficoltà), quindi la botta si spalma. Ma lo sconto su sanzioni è perso. In futuro, non si esclude che nuove edizioni di rottamazione possano includere di nuovo quei residui (come accaduto in passato, es. la -quater includeva anche chi aveva aderito alla -ter ma decaduto, purché rifacesse domanda).
Domanda: “Ho in corso un ricorso contro una cartella, ma vorrei aderire alla rottamazione: che succede al processo?”
Risposta: Devi dichiarare al giudice (tramite l’istanza di adesione allegata) che intendi definire il debito con la rottamazione e ti impegni a rinunciare al giudizio. Il giudizio viene sospeso fino a fine pagamento. Formalmente, la legge dice che il processo si estinguerà solo a pagamento completato e dopo che produci le quietanze. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che, una volta comunicata la volontà di definire e avendo l’AdER accettato l’istanza, la causa può considerarsi chiusa per cessata materia del contendere anche prima di aver finito di pagare le rate. In sostanza, l’accordo di definizione agevolata elimina la controversia sul merito. Se poi non paghi, l’AdER riscuoterà il debito residuo ma tu non potrai riaprire la causa. Quindi pondera bene: se aderisci, hai rinunciato a contestare. Assicurati di portare a termine i pagamenti, altrimenti ti ritroverai con la cartella “rianimata” e nessun ricorso in corso.
Procedure di crisi d’impresa e da sovraindebitamento: la transazione fiscale “salva azienda”
Quando i debiti fiscali (e non solo) di un soggetto diventano insostenibili, e si profila l’insolvenza, la legge offre procedure concorsuali che, sebbene giudiziali, rappresentano comunque una forma di “accordo” globale con i creditori, incluso l’Erario. In tali procedure rientra la transazione fiscale, ovvero la possibilità di proporre allo Stato un pagamento parziale dei tributi, al fine di evitare il fallimento/liquidazione, scenario in cui spesso l’Erario recupererebbe ancora meno.
Le principali procedure sono: il concordato preventivo (per imprese), gli accordi di ristrutturazione dei debiti (per imprese o grandi esposizioni), il concordato minore o il piano di ristrutturazione del consumatore (per piccoli imprenditori e privati sovraindebitati) e la già citata composizione negoziata della crisi (fase extragiudiziale assistita). Analizziamo la transazione fiscale in questi contesti:
- Concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII): l’imprenditore in crisi propone un piano ai creditori, che può prevedere la soddisfazione parziale (falcidia) dei crediti privilegiati solo in alcune condizioni. Tradizionalmente, l’IVA e le ritenute non versate erano considerate infalcidiabili (dovevano essere pagate integralmente) salvo casi di incapienza in liquidazione. La normativa però si è evoluta: la Legge 232/2016 ha modificato l’art. 182-ter L.F. permettendo la falcidia dell’IVA in concordato in continuità, a condizione che lo Stato riceva almeno quanto avrebbe ottenuto in caso di fallimento. La Corte di Giustizia UE (causa C-546/14) aveva aperto a questa possibilità, e l’Agenzia delle Entrate con Circolare 16/E del 2018 ha preso atto che è legittimo proporre il pagamento parziale dell’IVA nel concordato preventivo senza incorrere in illegittimità comunitaria. Quindi, oggi, in un concordato, l’azienda può proporre di pagare, ad esempio, il 30% dell’IVA dovuta se dimostra che in caso di fallimento l’Erario prenderebbe magari il 5% (perché il 30% è più conveniente del realizzo liquidatorio). La transazione fiscale nel concordato viene votata dall’AdE come creditore privilegiato. Se AdE vota contro, c’è il meccanismo del cram-down fiscale: l’art. 112, comma 2 CCII (ex art. 180 L.F.) consente al tribunale di omologare comunque il concordato nonostante il dissenso dell’Erario, se: (a) il suo voto è determinante ai fini delle maggioranze; (b) la proposta soddisfa il Fisco in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria; (c) un esperto indipendente attesta la rispondenza del trattamento a quella convenienza e la fattibilità. La Cassazione a Sezioni Unite nel 2021 ha avallato la legittimità di questo cram-down (introdotto dal DL 125/2020 conv. L. 159/2020), purché rigorosamente applicato. Dunque, l’imprenditore in concordato ha due strade: cercare il consenso dell’AdE su una transazione o chiedere al giudice di omologare ugualmente se l’AdE rifiuta irragionevolmente. In entrambi i casi, l’obiettivo è ridurre il carico fiscale per rendere possibile la prosecuzione dell’attività o la liquidazione ordinata.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII, ex art. 182-bis L.F.): qui non c’è un voto collettivo, ma un accordo privatistico con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (per l’omologazione). Per i crediti fiscali, l’art. 63 CCII consente di includere una transazione fiscale anche in questi accordi. Serve comunque l’adesione formale dell’AdE all’accordo, e si applicano i medesimi criteri di convenienza e pareri visti sopra. L’accordo viene omologato dal tribunale se non vi sono opposizioni; in caso di opposizione dell’AdE, torna utile il cram-down: il nuovo art. 61 CCII consente l’omologazione forzata dell’accordo anche senza adesione dell’Erario, se è rispettato l’art. 63 (cioè se la proposta è per lui più vantaggiosa del fallimento). Ad esempio, se un imprenditore ha €1 milione di debiti di cui 300k col Fisco, potrebbe ottenere accordo con le banche e al contempo proporre all’AdE di pagare, diciamo, 150k su 300k. Se l’AdE rifiuta ma il piano da 150k è comunque provato essere superiore al ricavabile in liquidazione (dove magari il Fisco avrebbe preso 50k su 300k essendo chirografo parziale), il tribunale può omologare l’accordo imponendolo anche all’AdE. Sentenze recenti: Cass. civ. Sez. I, ord. 26 maggio 2022 n. 17552 ha di fatto “sdoganato” l’idea che il tribunale possa superare il dissenso erariale negli accordi, in linea con la ratio di assicurare il going concern più proficuo. Inoltre, la prima giurisprudenza di merito post-riforma ha applicato l’art. 58 CCII autorizzando transazioni con cram-down (Trib. Roma, 2023). L’AdE su questo è ora più attenta: come visto, con provvedimenti interni (Prot. 21447/2024, 456918/2024) ha organizzato unità specializzate per valutare queste proposte, così da concedere il parere conforme solo quando il vantaggio è reale. Dal lato del debitore, conviene presentare proposte serie, suffragate da perizie e magari con pagamento per cassa almeno in parte, per convincere l’Erario all’adesione.
- Procedura di sovraindebitamento (oggi “concordato minore” o “ristrutturazione del consumatore”): queste sono analoghe al concordato ma per chi non può fallire (privati, piccoli imprenditori). Qui la transazione fiscale non è un istituto separato: il Fisco è un creditore come gli altri, soggetto a falcidia nel piano. L’art. 74 CCII però prevede che il tribunale, nel omologare, verifichi che il trattamento di eventuali crediti privilegiati (tra cui IVA, contributi) non sia deteriore rispetto al realizzo in una ipotetica liquidazione controllata. In pratica, se un consumatore propone di pagare zero su un debito IVA, ma in liquidazione dai suoi beni l’Erario avrebbe recuperato qualcosina, il giudice non omologa. Invece, se anche liquidando tutti i suoi beni l’Erario non prenderebbe nulla, può omologare anche il saldo zero (caso di nullatenente). Una volta eseguito il piano (ad es. pagamento del 20% dei debiti chirografari in 4 anni), il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione di tutti i debiti residui, fiscali compresi. Anche la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) di una persona fisica porta, dopo 4 anni, all’esdebitazione generale dei debiti non soddisfatti, salvo quelli derivanti da illeciti. Ciò significa che, pur non essendoci un “accordo” con l’AdE, alla fine il soggetto può essere liberato anche dalle cartelle non pagate, a patto di aver messo a disposizione tutto il proprio patrimonio. È l’extrema ratio per il sovraindebitato onesto ma incapiente.
Domanda: “Ho una società con grossi debiti IVA e INPS: posso trattare un saldo e stralcio senza fallire?”
Risposta: Sì, ma non in via informale: dovrai probabilmente utilizzare una procedura di composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione. In sede extragiudiziale pura, l’AdE non può spontaneamente rinunciare a metà dell’IVA salvo che tu aderisca a qualche sanatoria di legge (oggi non attiva). Però con la composizione negoziata – procedura stragiudiziale introdotta nel 2021 – puoi negoziare con il Fisco un accordo che includa una transazione fiscale. Dovrai convincerli, con numeri alla mano, che se non accettano, la tua azienda fallirà e loro recupereranno meno. Occorre un attestatore che certifichi questo. Se l’Agenzia accetta, avrai un accordo omologato (nel caso di concordato o accordo in tribunale) o formalizzato (nel caso di composizione negoziata) in cui, ad esempio, paghi solo il 50% dell’IVA e dilazionato in 5 anni. Tieni presente che l’AdE deve seguire un iter interno autorizzativo rigoroso, quindi le tue proposte devono essere molto ben fondate e documentate. Inoltre, occhio al penale: l’omesso versamento IVA sopra €250k per annualità è reato; anche se il concordato ti fa pagare il 50%, per la legge penale resterebbe comunque un’omissione in parte. Attualmente, se non paghi integralmente l’IVA prima della sentenza penale, il reato non si estingue. Quindi potresti salvare l’azienda ma non evitare completamente i guai giudiziari (anche se in prassi un concordato omologato e pagato può influire positivamente sul trattamento sanzionatorio).
Domanda: “Come faccio a sapere se la mia transazione fiscale sarà accettata dall’Agenzia?”
Risposta: Non c’è garanzia assoluta, ma ci sono criteri chiave. L’Agenzia oggi valuta centralmente la convenienza della transazione: dal 2024 esiste un apposito Ufficio Crisi d’impresa presso la Direzione centrale, che deve dare parere conforme perché la Direzione regionale/provinciale possa firmare l’accordo. In pratica, decidono a livello nazionale con standard uniformi. Il criterio principe è: Stato creditore ottiene di più con l’accordo rispetto a un fallimento/liquidazione. Quindi tu, assistito da un professionista, devi presentare una relazione dettagliata sul perché la tua proposta (es.: pagamento 30% in 4 anni) è vantaggiosa: mostra cosa otterrebbero in caso di procedure alternative (pignoramenti, fallimento). Considerano anche la tua affidabilità (storia di adempimenti) e il motivo della crisi (meglio se esterna, es. calo mercato). Inoltre, la legge ora consente al Fisco di accettare stralci anche di IVA e contributi, cosa prima vietata, ma solo appunto se c’è quel vantaggio comparativo. Se la tua proposta è troppo penalizzante per l’Erario, sarà rigettata. Puoi comunque migliorarla (magari offrendo qualche garanzia, ad es. equity della società, o coinvolgendo un nuovo investitore che apporta liquidità destinata in parte al Fisco).
Conclusione: accordarsi “per bene” conviene, ma con prudenza
Abbiamo visto che l’ordinamento offre molteplici possibilità di accordo stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate, dal semplice piano di dilazione al saldo e stralcio in sede concorsuale. Per il debitore, utilizzare al meglio questi strumenti significa ottenere riduzioni importanti del carico fiscale e più tempo per pagare, evitando misure invasive come ipoteche, pignoramenti e, nei casi peggiori, il dissesto finanziario.
Tuttavia, “fare per bene” un accordo col Fisco richiede prudenza e consapevolezza:
- Conoscere le regole specifiche di ogni istituto (scadenze, condizioni, effetti legali) è fondamentale: un giorno di ritardo o una formalità mancante possono vanificare tutto (ad es. decadenza da rottamazione per 5 giorni di ritardo, in passato inesorabile). Questa guida ha fornito il quadro aggiornato a luglio 2025, ma le norme fiscali evolvono; tenetevi informati su eventuali proroghe o nuove definizioni agevolate.
- Valutare la propria situazione finanziaria con realismo: mai assumere un impegno di pagamento senza la ragionevole certezza di poterlo mantenere. È preferibile, ad esempio, chiedere subito il massimo delle rate se si è al limite, piuttosto che sottoscrivere un accordo più breve e poi fallire alle scadenze. La legge oggi dà margine (fino a 8 rate saltabili in piani di rateazione), ma abusarne porta a perdere ogni beneficio.
- Tenere in conto i riflessi penali quando si tratta di imposte non versate penalmente rilevanti. Un accordo con l’AdE potrebbe non bastare a mettere la parola fine se c’è un processo penale di mezzo: servono strategie coordinate (ad es. chiedere la sospensione del processo penale in attesa dell’esito del concordato, o valutare il patteggiamento tenendo conto dell’accordo fiscale).
- Comunicare con l’Agenzia: sembra banale, ma molte soluzioni stragiudiziali nascono dal dialogo. Ad esempio, in sede di adesione o conciliazione è determinante presentarsi preparati, con documenti e argomenti, mostrando collaborazione (magari pagando un acconto spontaneo, segnale di buona fede). L’immagine di affidabilità conta: l’ufficio sarà più incline a concedere dilazioni o transigere se percepisce il contribuente come collaborativo e realmente in difficoltà, piuttosto che come un “furbo” che cerca di non pagare.
In conclusione, l’accordo stragiudiziale col Fisco conviene quasi sempre quando c’è un’incertezza sull’esito del contenzioso o una difficoltà oggettiva a pagare. Le leggi attuali, tra “pace fiscale” e riforme della riscossione, offrono opportunità storiche di regolarizzare la propria posizione risparmiando. È interesse di entrambe le parti – debitore e Stato – trovare un punto di equilibrio: il debitore si libera del fardello (o lo riduce) e lo Stato incassa in tempi ragionevoli. L’importante è sfruttare questi strumenti informandosi bene, rispettando gli accordi presi e, se necessario, facendosi assistere da professionisti qualificati (avvocati tributaristi, commercialisti esperti in crisi d’impresa) per non commettere passi falsi. Solo così l’“accordo stragiudiziale” sarà fatto davvero per bene, portando beneficio a tutte le parti coinvolte.
Fonti e Riferimenti
Norme di legge citate: D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione); D.Lgs. 546/1992 artt. 17-bis, 48-48-ter (mediazione e conciliazione); DPR 602/1973 art. 19 (rateazione ruoli) come mod. da D.Lgs. 110/2024; Legge 197/2022 commi 231-252 (Definizione agevolata 2023); Legge 15/2025 (Milleproroghe); Codice della Crisi D.Lgs. 14/2019 artt. 57-63 (accordi e transazione fiscale), 112 (cram-down concordato), 48 (cram-down accordi).
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 16/E del 23 luglio 2018, “Chiarimenti sulla transazione fiscale (art. 182-ter L.F.) e falcidia IVA in concordato”.
Decreto Legislativo 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), art. 23 c.2 lett. a) e art. 63 – Transazione su crediti tributari e contributivi anche negli accordi di composizione negoziata.
Corte di Cassazione – Sez. Trib. ord. 11 settembre 2024 n. 24428, “Rottamazione-quater e effetti sul processo: estinzione della lite senza aspettare il pagamento integrale”.
Corte di Cassazione – Sez. III pen. sent. 29 maggio 2019 n. 23061, in tema di reati tributari ex D.Lgs. 74/2000 art. 13, “Pagamento integrale del debito tributario come condizione di non punibilità”.
Agenzia Entrate-Riscossione – Comunicato su Legge 15/2025 (Milleproroghe 2025), “Riammissione dei decaduti dalla Definizione agevolata e nuove regole di rateizzazione dal 1° gennaio 2025”.
Hai ricevuto un avviso di accertamento o una contestazione dall’Agenzia delle Entrate e vorresti chiudere la questione senza arrivare a un processo tributario? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento o una contestazione dall’Agenzia delle Entrate e vorresti chiudere la questione senza arrivare a un processo tributario?
In molti casi è possibile concludere un accordo stragiudiziale che riduce imposte, sanzioni e interessi, evitando anni di contenzioso.
👉 L’accordo stragiudiziale non è un “favore” del Fisco, ma una procedura regolata dalla legge che, se gestita nel modo giusto, può portare a un risparmio significativo e a una soluzione definitiva della controversia.
⚖️ Cosa significa accordo stragiudiziale
Si tratta di una procedura di definizione bonaria tra contribuente e Agenzia delle Entrate, che può avvenire in diverse forme:
- Accertamento con adesione: si concordano le somme dovute prima che l’accertamento diventi definitivo.
- Conciliazione giudiziale: si raggiunge un accordo durante un processo tributario già iniziato.
- Definizione agevolata (quando prevista): possibilità di chiudere le pendenze con sconti su sanzioni e interessi.
In tutti i casi, l’obiettivo è lo stesso: trovare un compromesso equilibrato che metta fine alla lite fiscale.
📌 Vantaggi dell’accordo stragiudiziale
- Riduzione delle sanzioni (spesso fino a un terzo o anche meno);
- Rateizzazione del debito con piani di pagamento sostenibili;
- Chiusura definitiva della controversia senza rischiare anni di giudizi;
- Risparmio su spese legali e interessi;
- Maggiore certezza sugli importi da pagare, evitando aggravi futuri.
🔍 Come si fa per bene: i passaggi
- Analisi dell’atto ricevuto: valutare se ci sono margini per un accordo.
- Quantificazione del debito: distinguere tra imposte, interessi e sanzioni.
- Predisposizione della proposta: presentare all’Agenzia una richiesta motivata e documentata.
- Contraddittorio: partecipare agli incontri con i funzionari, difendendo le proprie ragioni.
- Formalizzazione dell’accordo: sottoscrivere l’atto e rispettare i termini di pagamento.
👉 Un accordo stragiudiziale va gestito con competenza: un errore procedurale può far perdere l’opportunità di chiudere la lite in modo vantaggioso.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’accertamento o la cartella e individua i margini di trattativa;
- 📌 Predispone la documentazione necessaria per sostenere la tua posizione;
- ✍️ Formula proposte difensive e di accordo calibrate sul tuo caso;
- ⚖️ Ti assiste nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate;
- 🔁 Cura la sottoscrizione e il rispetto dell’accordo, valutando rateizzazione o altre agevolazioni.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in accertamenti fiscali e definizioni stragiudiziali;
- ✔️ Specializzato in contenzioso tributario e soluzioni negoziali;
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Un accordo stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate può trasformare un accertamento pesante in una soluzione sostenibile e definitiva.
Con l’assistenza giusta, puoi ridurre sanzioni e interessi, rateizzare il debito e mettere fine al contenzioso senza anni di cause.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: il tuo accordo stragiudiziale con il Fisco inizia qui.