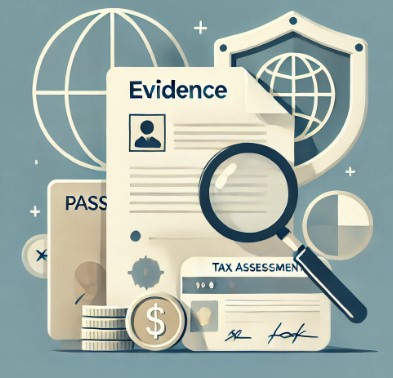Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi o conti all’estero?
Quando il Fisco italiano avvia un accertamento legato a capitali o attività detenute fuori dal Paese, utilizza dati provenienti dallo scambio automatico di informazioni internazionali. Questi elementi, però, spesso sono solo presunzioni e possono essere ribaltati con prove adeguate. Sapere quali documenti raccogliere è decisivo per difendersi.
Quando scatta un accertamento dall’estero
– Se non hai compilato il quadro RW per il monitoraggio fiscale
– Se non hai dichiarato interessi, dividendi, plusvalenze o redditi da immobili esteri
– Se i dati trasmessi da banche o autorità estere non coincidono con quanto dichiarato in Italia
– In caso di movimenti bancari transfrontalieri ritenuti incoerenti con il reddito dichiarato
Quali sono le prove più utili per difendersi
– Estratti conto bancari esteri che dimostrino la provenienza lecita delle somme
– Contratti di lavoro, locazione o attività estere che giustifichino i redditi percepiti fuori dall’Italia
– Certificazioni fiscali estere che attestino il pagamento delle imposte nel Paese di origine
– Documentazione successoria o donazioni se le somme derivano da eredità o trasferimenti familiari
– Prove di risparmi accumulati in anni precedenti, per dimostrare che i capitali non derivano da redditi occultati
– Bollette, contratti di affitto, residenza estera per dimostrare l’effettivo radicamento fuori dall’Italia
Come contestare l’accertamento
– Verificare l’attendibilità dei dati trasmessi dal Paese estero (spesso incompleti o duplicati)
– Dimostrare con prove concrete che le somme non costituiscono redditi imponibili in Italia
– Richiamare le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni per evitare tassazioni ingiuste
– Presentare memorie difensive in sede di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
– Impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini di legge
Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento
– La riduzione delle sanzioni grazie alla dimostrazione della buona fede
– La sospensione delle procedure esecutive collegate all’atto
– La tutela del patrimonio personale e familiare
– La possibilità di pagare solo quanto realmente dovuto
Attenzione: i dati provenienti dall’estero vengono spesso considerati dal Fisco come prove automatiche, ma in realtà si tratta di presunzioni. Solo con documenti solidi e ben presentati si può dimostrare la reale natura delle somme.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fiscalità internazionale e difesa da accertamenti esteri – ti spiega quali prove servono per contestare un accertamento dall’estero e come impostare la migliore strategia difensiva.
Hai ricevuto un accertamento legato a redditi o conti esteri?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Valuteremo i dati contestati, raccoglieremo la documentazione utile e predisporremo la strategia difensiva più efficace per proteggerti.
Introduzione
Cosa significa accertamento dall’estero?
È un atto emesso da un’autorità estera (fiscale o amministrativa) che richiede a un soggetto di pagare tributi, dazi, sanzioni o altre somme. In pratica:
- Imposte o dazi UE: ad esempio un avviso di pagamento dell’erario francese o tedesco rivolto a un residente in Italia, per tasse non pagate all’estero.
- Multe e sanzioni UE: come una contravvenzione stradale commessa in un altro Stato membro, o un’ammenda amministrativa estera.
- Crediti extra-UE: richieste di pagamento provenienti da Stati fuori dall’Unione Europea (ad es. multe svizzere, tasse USA), che però non sono automaticamente esecutive in Italia se non tramite specifici accordi.
- Atti italiani basati su elementi esteri: l’Agenzia delle Entrate può emettere accertamenti in Italia fondati su redditi/attività detenuti all’estero, grazie allo scambio di informazioni internazionale.
Cosa può contestare un’autorità estera?
– Debiti tributari: mancato pagamento di imposte, IVA o dazi doganali all’estero (es. redditi non dichiarati in un Paese estero, dazi all’importazione non versati).
– Sanzioni amministrative: multe per violazioni del Codice della Strada in UE (eccesso di velocità, divieto di sosta, ecc.), sanzioni pecuniarie per violazioni normative (es. ambientali, doganali) accertate da enti esteri.
– Sanzioni penali pecuniarie: ammende inflitte da tribunali stranieri per reati o illeciti amministrativi equiparati (spesso il caso delle multe stradali UE, considerate “decisioni di condanna” ai sensi della normativa comunitaria).
– Contributi e altri oneri: potenzialmente, contributi previdenziali esteri o altre somme dovute a enti pubblici stranieri, se previsti accordi di cooperazione.
Cosa comporta ricevere un accertamento dall’estero?
– Notifica di atti esteri in Italia: l’atto può pervenire con traduzione e indicazione di come pagare e ricorrere. Per multe UE, la lettera deve indicare chiaramente dati dell’infrazione, modalità di pagamento, termini e autorità per l’eventuale ricorso.
– Rischio di riscossione forzata in Italia: grazie a strumenti internazionali, l’importo può essere iscritto a ruolo in Italia con emissione di cartella esattoriale da Agenzia Entrate-Riscossione, oppure eseguito tramite pignoramenti, fermi amministrativi ecc., trattandosi di un titolo esecutivo riconosciuto.
– Equiparazione a un debito italiano: nel caso di crediti fiscali UE, il debito estero viene trattato come fosse un credito dello Stato italiano. Ciò significa che, una volta attivata la procedura di cooperazione, valgono le stesse regole esecutive italiane (interessi di mora, sanzioni aggiuntive, misure cautelari come fermo auto ecc.).
– Termini stringenti: ricevuto l’atto o la cartella, il debitore ha in genere 60 giorni per pagare o impugnare (come per gli atti italiani). Trascorso tale termine senza opposizione, il debito diviene definitivo ed esecutivo anche in Italia.
Come difendersi da un accertamento estero?
– Contestare nel Paese d’origine: Prima di tutto, verificare se il credito è stato già contestato nello Stato estero. La cooperazione UE richiede che il credito non sia oggetto di contestazione nello Stato richiedente. Se possibile, presentare ricorso nell’autorità estera (commissione tributaria locale, giudice o ente amministrativo estero) per far annullare o ridurre l’accertamento.
– Verificare la notifica e i termini: controllare che l’atto estero sia stato notificato regolarmente. Una notifica oltre i termini (es. oltre 360 giorni per multe estere, secondo l’art. 201 CdS) o senza le formalità previste può rendere nulla la sanzione. Se la notifica è viziata o assente, si potrà far valere tale vizio in sede di opposizione in Italia, chiedendo l’annullamento per mancata conoscenza dell’atto.
– Raccolta prove a discolpa: predisporre documenti che dimostrino l’insussistenza del debito o errori dell’accertamento: ad esempio ricevute di pagamento già effettuato, documenti fiscali che attestano la residenza fiscale in un altro Stato (per confutare una pretesa di doppia residenza), estratti conto che mostrano come somme contestate all’estero fossero già tassate in Italia, contratti di vendita dell’auto o denuncia di furto (per multe auto non proprie), ecc.
– Assistenza legale specializzata: attivare un avvocato sia in Italia sia, se necessario, nello Stato estero, esperto di diritto tributario internazionale o di sanzioni transfrontaliere, per coordinare la difesa. Lo studio del caso concreto è fondamentale per scegliere il foro giusto e i motivi di opposizione più efficaci.
– Sospensione della riscossione: se il credito è già in fase di riscossione in Italia (cartella esattoriale notificata), è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione sia all’Agente della Riscossione (in presenza di un ricorso pendente all’estero) sia al giudice competente italiano, allegando la prova del ricorso estero o dei vizi di notifica, al fine di bloccare temporaneamente pignoramenti e fermi in attesa del giudizio.
Quali prove presentare per contestare l’accertamento?
– Prova di residenza fiscale estera: se l’accertamento fiscale estero si basa sulla pretesa che il soggetto fosse residente in quel Paese, è decisivo produrre evidenze della propria effettiva residenza in un altro Stato (iscrizione AIRE, contratto di lavoro all’estero, bollette e utenze estere, affitti, conti bancari all’estero, eventuale dichiarazione dei redditi presentata altrove). Ad es., contro una contestazione di esterovestizione o doppia residenza si esibiranno i documenti che attestano il centro degli interessi all’estero (casa, famiglia, attività lavorativa).
– Documenti di pagamento o sgravio: se si è già pagato in tutto o in parte il debito contestato all’estero, occorre fornire le ricevute di pagamento ufficiali. In base alla normativa UE, il pubblico ministero italiano informa l’autorità estera di eventuali pagamenti parziali chiedendo la deduzione dell’importo. Analogamente, se nello Stato d’origine l’accertamento è stato annullato o ridotto (sgravio, decisione del giudice estero), è fondamentale produrne copia per far cessare la riscossione in Italia.
– Prova di errori o scambi di persona: nel caso di multe stradali, è utile presentare documenti che smentiscano la violazione: ad esempio, se il veicolo era venduto prima dell’infrazione, allegare l’atto di vendita; se il destinatario non era conducente, dichiarazioni o denunce che lo provino. Per contestare errori materiali dell’atto (targa sbagliata, data errata) vanno evidenziati i dati corretti (foto del veicolo, biglietti aerei che provano la propria assenza in loco, ecc.).
– Prova della prescrizione/decadenza: raccogliere elementi sulla data di notifica e di esecutività del credito. In Italia i crediti da sanzioni si prescrivono in 5 anni dalla definitività (salvo atti interruttivi); se il credito estero risulta molto datato e l’assistenza è stata chiesta tardivamente, si può eccepire la prescrizione (o la decadenza dall’obbligo di cooperazione, sebbene la Cassazione abbia escluso una decadenza rigida in ambito UE). Ad es., se un’amministrazione estera chiede all’Italia di riscuotere un debito IVA dopo molti anni, il contribuente può evidenziare che è decorso il termine di prescrizione applicabile secondo la legge straniera o italiana.
– Documenti contabili e fiscali: in caso di accertamenti fiscali su redditi esteri non dichiarati in Italia (es. conti esteri, investimenti offshore), per contestare l’atto servono prove che tali redditi erano esenti o già tassati altrove: ad esempio attestati di tassazione nel Paese estero, certificati di doppia imposizione evitata, documenti che mostrano trattarsi di movimentazioni patrimoniali e non redditi (trasferimenti tra conti dello stesso titolare, eredità, donazioni). Queste prove aiutano a smontare le presunzioni dell’Agenzia delle Entrate (come la “presunzione di evasione” per capitali esteri non dichiarati), dimostrando la legittima provenienza delle somme.
Cosa si può ottenere con una difesa efficace?
– Annullamento totale o parziale del debito: se si dimostra che l’accertamento estero è infondato (ad esempio perché non si era soggetti a tassazione in quel Paese, oppure perché la multa è affetta da vizi formali gravi), si può ottenere l’annullamento integrale. In alternativa, prove robuste possono condurre a una rideterminazione dell’importo (sgravio parziale, eliminazione di sanzioni e interessi).
– Sospensione e archiviazione della riscossione: presentando un ricorso fondato o prove di pagamento, il debitore può ottenere la sospensione della cartella esattoriale italiana e delle misure esecutive, in attesa dell’esito del contenzioso. In caso di esito favorevole (annullamento del titolo estero o risoluzione bonaria), l’Agente della Riscossione dovrà archiviare la procedura e liberare i beni da fermi o ipoteche.
– Tutela del patrimonio in Italia: evitando che un’accusa ingiusta dall’estero si traduca in pignoramenti o prelievi sul conto in Italia. Con una difesa tempestiva si può impedire che un credito straniero venga forzatamente soddisfatto, ad esempio opponendosi prima che vengano venduti all’asta beni pignorati.
– Chiusura concordata della pendenza: in alcuni casi, una difesa ben articolata può portare a soluzioni transattive. Ad esempio, se emerge che la persona era effettivamente residente fiscale in Italia e non doveva pagare un tributo richiesto all’estero, l’autorità estera potrebbe rinunciare alla riscossione. Viceversa, se il debito è dovuto ma eccessivo, si può negoziare una rateizzazione o riduzione degli interessi con l’ente estero tramite l’intermediazione dell’autorità italiana (possibile per i tributi UE, trattati come crediti italiani, con concessione di dilazioni analoghe a quelle nazionali).
– Prevenzione di conseguenze penali: in ambito fiscale, contrastare con successo un accertamento estero (es. una contestazione di esterovestizione o di omessa dichiarazione di redditi esteri) evita anche possibili denunce penali per evasione fiscale transnazionale. Ottenere l’annullamento dell’atto tributario significa dimostrare l’assenza di dolo evasivo, scongiurando incriminazioni per reati tributari collegati.
- Chiarezza sulla propria posizione fiscale: una volta risolta la controversia, il contribuente ottiene certezza sulla ripartizione della potestà impositiva tra Stati (utile in caso di future verifiche) e tutela da doppie imposizioni. In prospettiva, le prove raccolte e il precedente favorevole costituiranno un valido supporto documentale per eventuali ulteriori accertamenti similari, in Italia o all’estero.
Introduzione
L’internazionalizzazione delle attività economiche e degli spostamenti delle persone ha reso sempre più frequente il caso di accertamenti dall’estero: atti con cui autorità fiscali straniere o enti esteri chiedono il pagamento di imposte, tasse o sanzioni a soggetti collegati all’Italia. Dal punto di vista del contribuente (o debitore destinatario della pretesa), difendersi può risultare complesso, poiché occorre districarsi tra normative di diversi Paesi e procedure di cooperazione internazionale. Un avviso di accertamento tributario emesso all’estero, ad esempio, può essere riscosso in Italia tramite iscrizione a ruolo, mentre una multa stradale europea non pagata può trasformarsi in una cartella esattoriale italiana a tutti gli effetti. Come tutelarsi in questi casi? Quali prove servono per contestare efficacemente la pretesa proveniente da uno Stato estero?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario internazionale e tutela dei debitori – ti spiega quali prove presentare e quali strategie adottare per contestare un accertamento dall’estero. Vedremo il quadro normativo italiano ed europeo aggiornato a luglio 2025, con particolare attenzione all’ambito tributario (Direttiva 2010/24/UE e D.Lgs. 149/2012 per i crediti fiscali, Convenzione OCSE 1988) e a quello delle sanzioni amministrative transfrontaliere (Decisione Quadro 2005/214/GAI attuata col D.Lgs. 37/2016). Esamineremo la prassi delle autorità (Agenzia delle Entrate, Agenzia Riscossione) e le più recenti sentenze delle corti italiane – dalle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie) ai giudici ordinari (Giudice di Pace, Cassazione) – che hanno affrontato casi di riscossione internazionale. Saranno fornite tabelle riepilogative dei principali strumenti di cooperazione e dei mezzi di difesa, nonché simulazioni pratiche in vari scenari (multa UE non pagata, cartella estera per tasse, accertamento fiscale italiano su redditi esteri) dal punto di vista del debitore. Una sezione Domande e Risposte chiarirà i dubbi più frequenti di cittadini, professionisti e imprenditori alle prese con atti d’oltremare. Infine, illustreremo le strategie difensive davanti ai giudici italiani competenti e gli strumenti deflattivi eventualmente esperibili (come la mediazione tributaria o l’accertamento con adesione, ove applicabili), concludendo con un elenco completo delle fonti normative e giurisprudenziali citate.
Quadro normativo: cooperazione internazionale e accertamenti esteri
Quando un’autorità estera emette un accertamento o una sanzione nei confronti di un soggetto collegato all’Italia, entrano in gioco diverse normative che permettono la cooperazione tra Stati. È essenziale individuare quale strumento normativo si applica, poiché da ciò dipendono le modalità di notifica, la riscossione in Italia e i limiti entro cui il contribuente può far valere le proprie ragioni. In generale, occorre distinguere tra: (A) accertamenti tributari (imposte, tasse, dazi) e (B) sanzioni pecuniarie (multe, ammende) non pagate, e tra situazioni in ambito UE e extra-UE.
Assistenza reciproca per crediti tributari nell’UE (Direttiva 2010/24/UE e D.Lgs. 149/2012)
In Unione Europea vige un meccanismo avanzato di cooperazione fiscale disciplinato dalla Direttiva 2010/24/UE del Consiglio (16 marzo 2010) sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. L’Italia ha recepito questa direttiva con il D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 149, che rappresenta la base normativa per riscuotere in Italia crediti tributari vantati da altri Stati membri (e viceversa). I punti chiave di tale normativa sono:
- Ambito di applicazione: copre la totalità dei tributi e dei dazi (imposte sui redditi, IVA, accise, dazi doganali, contributi nel finanziamento di bilanci pubblici, e relative sanzioni amministrative) dovuti in uno Stato UE. Restano escluse solo fattispecie specifiche come i contributi previdenziali obbligatori diversi da quelli coperti da regolamenti UE, e sanzioni penali non pecuniarie. In pratica, qualsiasi importo accertato da un’amministrazione finanziaria UE rientra nello strumento, sia esso un’imposta evasa, un dazio all’importazione, interessi o multe fiscali.
- Autorità competenti: ogni Stato designa un’Autorità centrale di collegamento. In Italia è l’Agenzia delle Entrate – Settore Internazionale, in coordinamento con Agenzia Entrate-Riscossione per la fase esecutiva. Le richieste estere di notifica o riscossione vengono ricevute da questa Autorità e attuate tramite gli enti impositori o riscossori nazionali competenti.
- Titolo esecutivo uniforme UE: la direttiva introduce il concetto di titolo uniforme europeo di riscossione. Lo Stato estero richiedente trasmette all’Italia un titolo uniforme (standardizzato) basato sul proprio accertamento definitivo. Tale titolo è automaticamente riconosciuto ed esecutivo nello Stato richiesto senza bisogno di ulteriori formalità o omologhe giudiziarie. In altri termini, la cartella esattoriale italiana emessa su richiesta estera non richiede un procedimento di delibazione: ha la stessa forza di una cartella relativa a un credito italiano.
- Trattamento come credito interno: il credito estero viene trattato alla stregua di un credito dello Stato italiano. L’Agenzia Entrate-Riscossione procede secondo le norme italiane (D.P.R. 602/1973 per le cartelle, ecc.), applicando interessi di mora e procedure esecutive nostrane. Ad esempio, un debito fiscale originato in Francia, una volta “preso in carico” dall’Italia, segue le regole italiane su termini di pagamento (60 giorni), possibilità di dilazione, aggi di riscossione, misure cautelari (fermi, ipoteche) e prescrizione (di norma 10 anni per i tributi definitivi in base all’art. 2946 c.c., salvo diversa indicazione). Importante: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che non si applica un termine di decadenza fisso per avviare la procedura di assistenza dopo l’emissione del titolo estero. In passato si discuteva se il limite di cinque anni dell’art. 12 D.Lgs. 149/2012 costituisse decadenza; le SS.UU. (sent. n. 34981/2023) hanno escluso che decorso tale termine il credito si estingua, ritenendo invece che dopo 5 anni venga meno solo l’obbligo di cooperazione ma non la facoltà, rimettendo alla discrezionalità dello Stato se procedere comunque. Dunque anche crediti “datati” possono essere riscossi oltre il quinquennio, purché non prescritti.
- Notifica di atti e documenti: la cooperazione comprende anche la notifica di atti formali. L’art. 8 della direttiva prevede che lo Stato richiesto effettui la notifica di qualsiasi documento relativo a un credito su istanza dello Stato richiedente. Ad esempio, l’Italia può notificare al contribuente sul proprio territorio un avviso di accertamento estero o un invito al pagamento prima ancora della riscossione coattiva. La notifica avviene “secondo le forme nazionali” (art. 17 Dir.): l’Italia notificherà l’atto estero con le stesse modalità di un atto italiano equivalente (messo notificatore, raccomandata A/R, PEC se destinatario digitale, ecc.). Ciò garantisce efficacia alla notifica, anche se l’atto è redatto in lingua straniera – usualmente viene fornita una traduzione sommaria in italiano per comprensibilità. Sul punto linguistico, non vige un obbligo assoluto di traduzione dell’atto estero, purché al destinatario sia chiaro il contenuto minimo; tuttavia, se la mancata traduzione compromette il diritto di difesa, il contribuente potrà eccepirlo.
- Condizione di esigibilità – definitività del credito: condizione imprescindibile per l’assistenza è che il credito sia definitivo e non contestato nello Stato d’origine. Ciò significa che se il contribuente ha presentato ricorso nel Paese estero e la causa è pendente, l’assistenza (sia notifica che riscossione) dovrebbe essere sospesa fino a definizione. All’atto pratico, l’autorità estera richiedente nel modulo standard deve dichiarare che non vi sono ricorsi pendenti e che il titolo è esecutivo. Questo tutela il debitore da doppie impugnazioni: il foro competente per contestare il merito del credito rimane quello del Paese d’origine. La Corte di Giustizia UE ha sottolineato che la direttiva 2010/24 si fonda sul principio di reciproca fiducia tra Stati: lo Stato italiano non può sindacare la validità sostanziale del credito estero, ma solo atti e procedure esecutive proprie. In particolare, un ricorso presentato in Italia contro la cartella esattoriale derivante da un credito UE non può comportare un esame della legittimità del credito tributario estero. Le eventuali censure di merito (importo, applicazione della legge, ecc.) vanno fatte valere innanzi all’autorità straniera che ha emesso l’accertamento.
- Eccezioni (ordine pubblico e diritti fondamentali): Lo Stato richiesto può rifiutare l’assistenza in casi eccezionali, ad es. se l’esecuzione lederebbe l’ordine pubblico dello Stato adito. Un tipico caso è la violazione dei diritti di difesa: se il contribuente prova che non ha mai ricevuto alcuna notifica nel Paese d’origine e non ha potuto impugnare (violazione dell’art. 47 Carta UE, diritto a un ricorso effettivo), le autorità italiane possono sospendere o rifiutare la cooperazione fino a garantire che il soggetto abbia avuto la possibilità di difendersi. La Corte UE (causa C-34/17, Donnellan, 2018) ha ammesso che l’assenza di corretta notifica nel Paese estero possa giustificare un diniego di esecuzione da parte dello Stato richiesto, in via del tutto eccezionale, proprio per tutelare i diritti fondamentali. Inoltre, la cooperazione può essere negata se il credito è già stato pagato o è inesigibile (ad es. per amnistia, prescrizione intervenuta nello Stato d’origine, doppia punizione per gli stessi fatti, ecc. – situazioni previste dall’art. 14 della direttiva e recepite nell’art. 20 del D.Lgs. 149/2012). Ad esempio, se in uno Stato UE interviene un condono fiscale che azzera il debito, l’Italia non procederà alla riscossione.
In sintesi, nell’ambito UE un accertamento fiscale estero “segue” il contribuente in Italia: grazie al titolo uniforme, la cartella italiana può essere impugnata solo per vizi propri (es. vizi di notifica in Italia, errori di persona, pagamento già effettuato) ma non per contestare il merito della pretesa tributaria. Il contribuente deve aver sollevato le sue difese nel Paese d’origine. La giurisdizione del giudice tributario italiano è dunque tendenzialmente limitata ai profili formali o estintivi sopravvenuti (come vedremo nel dettaglio nella sezione sul contenzioso).
Esempio: un cittadino italiano riceve una cartella da Agenzia Entrate-Riscossione per €10.000 di imposte non pagate in Francia. Questo significa che l’amministrazione francese ha attivato il D.Lgs. 149/2012. Il contribuente potrà impugnare la cartella in Italia solo per far valere, ad esempio, che in Francia non era mai stato notificato l’avviso di accertamento, oppure che ha già pagato in parte il dovuto (allegando ricevute). Non potrà invece chiedere al giudice italiano di ricalcolare il reddito imponibile o le aliquote: quelle questioni dovevano essere contestate davanti al fisco francese nei termini previsti. Se però il contribuente, ottenuta la cartella, scopre per la prima volta l’esistenza di quel debito (magari mai notificato in Francia), potrà attivarsi contestualmente in Francia (impugnando tardivamente se possibile, o chiedendo un riesame) e in Italia chiedendo la sospensione della riscossione per manifesta violazione del diritto di difesa.
Crediti tributari di Stati extra-UE: convenzioni e principio di reciprocità
Fuori dall’Unione Europea, il recupero di crediti fiscali segue le convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali stipulate dall’Italia, oltre al generale principio di reciprocità. Non esiste un meccanismo automatico paragonabile a quello UE, ma negli ultimi anni molti Paesi (Italia inclusa) hanno aderito alla Convenzione OCSE-Consiglio d’Europa del 1988 sulla mutua assistenza in materia fiscale, modificata dal Protocollo del 2010, che estende la cooperazione a livello globale.
- Convenzione di Strasburgo del 1988 (Mutual Assistance Convention): l’Italia l’ha ratificata con L. 10 febbraio 2005 n. 19, rendendola operativa dal 1º luglio 2005. Essa permette, tra Stati aderenti (circa 140 giurisdizioni ad oggi, inclusi ad es. Svizzera, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone…), scambio di informazioni, notifica di documenti e assistenza alla riscossione, in termini simili alla direttiva UE. Ad esempio, l’art. 11-12 della Convenzione prevedono che, su richiesta, lo Stato richiesto prenda misure di riscossione come se il tributo estero fosse un proprio credito. Viene utilizzato un titolo uniforme anche in questo ambito (Concetto di “strumento di riscossione allegato” alla richiesta). La differenza è che la cooperazione è volontaria e subordinata a eventuali limitazioni o dichiarazioni fatte dai Paesi (ad esempio alcuni Stati escludono di prestare assistenza per tributi minori o per propri cittadini). Inoltre, le lingue e le modalità pratiche possono variare: spesso occorre tradurre gli atti nella lingua dello Stato richiesto.
- Trattati bilaterali con clausola di assistenza al recupero: l’Italia in molte Convenzioni contro le doppie imposizioni (DTA) inserisce l’articolo sull’assistenza nella riscossione (sulla falsariga dell’art. 27 del Modello OCSE). Ad esempio, il trattato Italia–USA contiene una clausola di reciproco aiuto nel riscuotere le imposte, così come quelli con Canada, Germania (benché UE, il trattato pre-UE contiene analogo articolo), ecc. Tali clausole, quando invocate, consentono di mutuare l’esecuzione coattiva: uno Stato potrà procedere nei confronti dei beni del contribuente come se si trattasse delle proprie imposte. Tuttavia, spesso i trattati bilaterali prevedono limiti: ad esempio, uno Stato non è tenuto a soddisfare richieste dell’altro se il contribuente è suo cittadino (clausola frequente) oppure per misure contrarie alla sua politica interna.
- Procedura interna: il D.Lgs. 149/2012 non si applica ai Paesi extra-UE, ma l’Italia può utilizzare la legge n. 19/2005 (ratifica Convenzione 1988) e all’occorrenza norme di coordinamento. Ad esempio, l’art. 7 comma 2 della L. 19/2005 prevede che le domande di assistenza in riscossione siano trattate secondo le modalità già previste per quelle UE (anticipando di fatto l’uso della struttura di Agenzia Entrate). In pratica, se arriva una richiesta da un Paese extra-UE convenzionato, l’Agenzia delle Entrate verifica che vi sia reciprocità ed emette un provvedimento che dichiara esecutivo in Italia il titolo estero, poi affida all’Agente della Riscossione l’incarico di riscuotere. Viene formata così una cartella esattoriale o un’ingiunzione di pagamento nazionale. Il contribuente riceverà quindi un atto italiano contro cui può opporsi nei limiti consentiti (analoghi al caso UE: no riesame del merito del tributo straniero). Ad esempio, dal 2020 l’Italia collabora con la Svizzera: un cittadino italiano che non abbia pagato imposte cantonali potrebbe vedersi recapitare una cartella di pagamento di Agenzia Entrate-Riscossione su istanza elvetica, sebbene la Svizzera non sia UE (ma è parte della Convenzione OCSE). Similmente, l’Agenzia delle Entrate può chiedere agli USA di riscuotere debiti fiscali di un residente in California che aveva imposte italiane pendenti, dato che gli USA hanno firmato la Convenzione (pur con alcune limitazioni operative).
- Assenza di accordi: se il Paese estero non ha accordi di mutua assistenza con l’Italia, i suoi accertamenti non hanno efficacia diretta in Italia. Il creditore estero, per colpire beni in Italia, dovrebbe passare per vie giudiziarie ordinarie (es.: ottenere un giudizio civile in Italia per il riconoscimento del debito, cosa generalmente esclusa perché i tributi esteri non rientrano tra le materie riconoscibili ex Regolamento UE 1215/2012 né via exequatur, essendo “materia fiscale” o “amministrativa pubblica”). Ciò significa che moltissimi crediti extra-UE non sono in concreto riscuotibili oltreconfine, salvo che il debitore volontariamente paghi o detenga beni nel paese creditore. Ad esempio, una cartella dell’IRS statunitense non può essere notificata e resa esecutiva in Italia se non attraverso gli strumenti convenzionali. Lo stesso vale per multe e sanzioni: senza un trattato ad hoc, una multa del Brasile o del Giappone resterà per l’Italia un semplice pezzo di carta, non coercibile.
In ogni caso, anche per i crediti extra-UE, l’orientamento italiano è di applicare principi simili a quelli UE: rispetto dei diritti difensivi, comunicazione al contribuente con atti tradotti, possibilità di opporsi per vizi formali, e centralità della contestazione nello Stato d’origine. Il contribuente farà bene, qualora riceva richieste dall’estero, a informarsi immediatamente sull’esistenza o meno di accordi di cooperazione con quel Paese.
Esempio pratico: Tizio riceve dalla Svizzera un invito a pagare tasse arretrate. Non paga. La Svizzera, grazie alla Convenzione, chiede all’Italia assistenza. L’Agenzia Entrate emette un provvedimento di riconoscimento e incarica Agenzia Riscossione, che notifica a Tizio una cartella di pagamento di pari importo. Tizio potrà impugnare la cartella davanti alla Corte di Giustizia Tributaria italiana, ma solo lamentando magari che quel debito è decaduto secondo la legge svizzera, o che non gli fu notificato correttamente l’atto originario. Il giudice italiano, se ritiene provato che in Svizzera l’avviso non venne mai comunicato a Tizio (violazione essenziale), potrà sospendere la cartella e richiedere chiarimenti, eventualmente portando allo stop della procedura per motivo di ordine pubblico (diritto di difesa violato). Se invece si tratta solo di eccepire che il calcolo fiscale svizzero era errato, la Commissione tributaria dichiarerà il ricorso inammissibile o infondato, indicando che andava fatto valere in Svizzera.
Riconoscimento ed esecuzione di sanzioni pecuniarie estere in ambito UE (Decisione Quadro 2005/214/GAI e D.Lgs. 37/2016)
Oltre ai tributi, un capitolo fondamentale riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate all’estero – tipicamente le multe stradali, ma anche ammende per violazioni amministrative varie – e non pagate dal trasgressore. Per queste, all’interno dell’UE opera la Decisione Quadro 2005/214/GAI del Consiglio (24 febbraio 2005) sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. L’Italia ha attuato tale Decisione Quadro con il D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 37, entrato in vigore a marzo 2016. Grazie a questa normativa:
- Principio del reciproco riconoscimento: una sanzione pecuniaria definitiva emessa da un’autorità (giudiziaria o amministrativa) di uno Stato membro deve essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza ulteriori formalità. Ciò vale per una vasta gamma di illeciti: reati e contravvenzioni puniti con ammenda, incluse le violazioni stradali e altre infrazioni amministrative (sono escluse solo materie strettamente fiscali o doganali già coperte da altri strumenti, e poche eccezioni). In pratica, se non paghiamo una multa presa in Francia o Spagna, quella sanzione può “seguirci” in Italia.
- Competenza al riconoscimento: in Italia la Decisione Quadro è implementata attribuendo la decisione sul riconoscimento al Corte d’Appello del distretto in cui il destinatario risiede, ha beni o domicilio. L’autorità estera trasmette la decisione di condanna e un certificato standard. La Corte d’Appello italiana verifica i requisiti e decide con ordinanza il riconoscimento e l’esecuzione della sanzione. Non c’è un vero contraddittorio con il destinatario in questa fase, se non per certi casi di opposizione eventuale: di regola la Corte decide de plano sulla base dei documenti.
- Condizioni e motivi di rifiuto: il D.Lgs. 37/2016 elenca una serie di casi in cui la Corte d’Appello può rifiutare il riconoscimento, ad esempio: se il certificato è incompleto; se il fatto non costituisce reato/illecito anche in Italia (doppia incriminazione, salvo eccezione per 39 categorie di infrazioni – come quelle stradali – per cui non si richiede verifica di doppia incriminazione); se il destinatario ha meno di 14 anni; se la sanzione è sotto una certa soglia; se il responsabile non ha avuto possibilità di difesa (es. non comparso per ragioni non dipendenti da sua volontà); se già pagata o prescritta; ecc. Uno dei motivi più pratici è l’importo minimo: se la sanzione è inferiore a €70, la Corte d’Appello può decidere di non riconoscerla per ragioni di economia. Questo vale a filtro: multe di importo irrisorio spesso non vengono inoltrate affatto dagli Stati esteri, ma anche se inoltrate, l’Italia può chiudere lì la vicenda sotto soglia.
- Notifica e lingua: il decreto prevede che la notifica originaria della multa debba rispettare le regole del Paese in cui è stata accertata l’infrazione. Ciò implica che, ad esempio, per certe multe tedesche sia considerata valida anche la notifica per posta semplice (come da legge tedesca) senza busta raccomandata, cosa che in Italia non sarebbe ammessa – ma rientra nella lex loci valida grazie al riconoscimento. Dal lato italiano, una volta riconosciuta la decisione estera, non è necessaria una nuova notifica del verbale originario al destinatario, poiché si presume che questa sia già avvenuta (anche se con modalità estere). Tuttavia, è prassi che l’interessato venga comunque a conoscenza del procedimento: in genere riceverà o una comunicazione dalla Corte d’Appello o direttamente l’atto esecutivo (cartella/ingiunzione) in Italia. Il tema della lingua: se la notifica estera non era in italiano, potrebbe costituire un vizio? La legge non impone la traduzione del verbale originario, ma se non è comprensibile al destinatario, questi può far valere la cosa come mancanza di corretta informazione. A tal fine spesso gli Stati inviano il certificato tradotto e un estratto bilingue.
- Esecuzione in Italia: una volta emesso il provvedimento di riconoscimento, la sanzione estera viene eseguita secondo le norme vigenti in Italia. Ciò significa che, ad esempio, per riscuotere l’importo si potrà iscrivere a ruolo e notificare una cartella esattoriale; oppure, se opportuno, l’autorità italiana (Ministero della Giustizia) può trasmettere il titolo ad un ufficio competente per l’esecuzione forzata civile. Nella prassi, la via più comune è la cartella esattoriale: la somma viene affidata all’Agenzia Entrate-Riscossione che emette una cartella di pagamento nei confronti del debitore, esattamente come farebbe per una multa italiana non pagata. Da quel momento, se non si paga entro 60 giorni, potranno scattare fermi amministrativi sull’auto del debitore, pignoramenti, etc. (ad es., se era una multa stradale di €150, si aggiungeranno interessi e compensi di riscossione, e l’importo potrebbe salire a oltre €200).
- Ricorsi e opposizioni: dove può difendersi il destinatario? La Decisione Quadro intende che la difesa di merito (ossia contestare di aver commesso l’infrazione, l’importo della multa, ecc.) andava fatta nello Stato in cui è avvenuto il fatto, secondo le leggi di quello Stato. Una volta che la multa è definitiva all’estero, la persona non può “riaprire” il caso in Italia. Tuttavia, è previsto il ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello sul riconoscimento (entro 30 giorni), limitatamente a motivi procedurali o di diritto (es. violazione di legge nel concedere o negare il riconoscimento). Inoltre, quando la cartella esattoriale italiana viene notificata, il destinatario può impugnarla davanti al Giudice di Pace competente, ma solo per vizi propri della fase esecutiva: ad esempio, può eccepire che la multa estera era già prescritta o pagata prima del riconoscimento; oppure che la notifica estera era talmente irregolare da violare i suoi diritti (questo motivo andava dedotto magari anche in Cassazione sull’ordinanza di riconoscimento). Il Giudice di Pace non potrà invece rimettere in discussione il merito dell’infrazione (es. non potrà dichiarare innocente il ricorrente rispetto all’eccesso di velocità in Francia). Un aspetto delicato è che formalmente la competenza a decidere su questi atti riconosciuti potrebbe appartenere al giudice dell’esecuzione (Tribunale ordinario) se li considerassimo equiparati a sanzioni penali; ma la giurisprudenza italiana sta orientandosi a ricondurre tali opposizioni nell’ambito del giudice di pace per analogia con le multe italiane. Dunque, chi riceve una cartella per multa estera in genere propone ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella, deducendo i motivi limitati suindicati.
- Prescrizione delle sanzioni: dopo il riconoscimento, la sanzione estera segue le regole italiane di prescrizione delle pene pecuniarie amministrative, che è 5 anni dal titolo esecutivo. Se però nello Stato d’origine la sanzione si prescrive prima (ad es. in alcuni Paesi dopo 3 anni), il debitore può far valere che il credito era già estinto prima del riconoscimento (rientra tra i motivi di rifiuto: sanzione già prescritta o caduta in “statute-bar” all’estero). In mancanza, prevale comunque il termine italiano quinquennale per la fase esecutiva in Italia.
- Esempio tipico – multa stradale: Caio, residente in Italia, prende una multa per eccesso di velocità in Germania. Riceve il verbale a casa (grazie alla direttiva 2015/413/UE sullo scambio di informazioni tra motorizzazioni, la Germania ha ottenuto i dati di Caio). Il verbale, scritto in tedesco con traduzione inglese, indica che Caio può pagarla o fare ricorso entro 60 giorni al locale Amt tedesco. Caio ignora la multa. Passato il tempo, l’autorità tedesca convalida la sanzione e, tramite il Ministero della Giustizia, invia all’Italia una richiesta ai sensi della Decisione Quadro 2005/214. La Corte d’Appello di Roma esamina la pratica: la violazione (eccesso di velocità) rientra tra quelle per cui non serve doppia incriminazione (è comune), Caio ha più di 14 anni, l’importo è €135 (sopra €70), la notifica iniziale risulta effettuata correttamente secondo la legge tedesca. Dunque la Corte riconosce la sanzione. Caio viene a sapere della vicenda quando riceve da Agenzia Entrate-Riscossione una cartella esattoriale da €135 + spese. A questo punto Caio può: pagare subito per chiudere la faccenda (magari con interessi); oppure proporre entro 30 giorni un’opposizione al Giudice di Pace. I motivi di opposizione potrebbero essere, ad esempio, che la multa era stata notificata oltre 360 giorni dall’infrazione (termine CdS italiano, ma attenzione: in Germania il termine è diverso; se però Caio dimostra di essere stato identificato tardivamente, potrebbe contestare l’irregolarità); oppure che il verbale non era tradotto in italiano o inglese comprensibile, ledendone il diritto di difesa. Se il Giudice di Pace ritiene fondata l’eccezione (es. verbale totalmente incomprensibile), potrebbe annullare la cartella per vizio di notifica originaria. Diversamente, Caio dovrà pagare. Inoltre, se Caio ignora anche la cartella, dopo 60 giorni potrà subire un fermo amministrativo sull’auto in Italia.
Sanzioni e multe provenienti da Stati extra-UE
Nel caso di multe o sanzioni pecuniarie inflitte da Paesi non UE, il quadro è molto più frammentato. Non esiste un obbligo generalizzato di riconoscimento come in UE, e l’Italia tende a far prevalere la sovranità: le sanzioni straniere non entrano nell’ordinamento esecutivo italiano salvo accordi specifici.
- Mancanza di esecutività automatica: una multa presa fuori dall’UE non è automaticamente esecutiva in Italia. Ad esempio, una multa per eccesso di velocità presa in Svizzera o in USA non può trasformarsi in una cartella esattoriale italiana di per sé. Potrebbe diventarlo solo se esiste un accordo bilaterale: la Svizzera ad esempio, come accennato, ha accordi nel campo fiscale ma per le sanzioni stradali utilizza piuttosto l’iscrizione a registro di frontiera (divieto di ingresso se non paghi). Il Regno Unito, divenuto extra-UE dal 2020, ha negoziato con l’UE accordi per continuare la cooperazione giudiziaria: attualmente però il riconoscimento reciproco delle multe non è automatico (il Regno Unito non applica più la Decisione Quadro, e un nuovo accordo specifico non risulta in vigore al 2025).
- Accordi bilaterali: l’Italia ha qualche accordo bilaterale mirato per il riconoscimento di sanzioni. Ad esempio, con la Svizzera esistono intese per cui grosse multe (es. in ambito doganale) possono essere recuperate via assistenza giudiziaria; analogamente con paesi come Norvegia o Islanda (che pur non UE, aderiscono a certi meccanismi tramite accordi Schengen). Ma si tratta di casi particolari. In assenza di accordo, un ente estero potrebbe chiedere all’Italia esecuzione di una sua sanzione solo passando per un procedimento civile: ad es. ottenere una sentenza italiana che condanni il debitore a pagare. Ciò è però precluso dai principi generali, poiché le multe attengono a esercizio di pubblica potestà non scrutinabile dal giudice civile italiano.
- Conseguenze pratiche: se riceviamo una multa da un Paese extra-UE, in genere siamo tenuti a pagarla direttamente a quel Paese se vogliamo evitare guai in futuro. Ignorarla non comporterà un’esecuzione forzata in Italia (nessuno verrà a pignorarci per conto, ad es., del Comune di New York), ma può avere conseguenze quando torneremo in quello Stato: rischio di fermo all’aeroporto, aggravio di sanzioni, impossibilità di ottenere visti, blocco dell’auto se entriamo con la stessa targa, etc.. Ad esempio, una multa non pagata in Canada potrebbe portare, al successivo ingresso, al fermo della persona fino al pagamento; una contravvenzione in Australia ignorata potrebbe essere addebitata dall’autonoleggio sulla carta di credito grazie a clausole contrattuali. Dal punto di vista italiano, quelle multe rimangono “all’estero”: non esiste un ufficio italiano che ce le possa riscuotere coattivamente.
In sintesi, per sanzioni extra-UE il forum di contestazione resta esclusivamente lo Stato estero che l’ha emessa. Se si ritiene la multa ingiusta, si deve fare ricorso lì (o tramite canali diplomatici se previsti). Se si sceglie di non pagare, il rischio è confinato al territorio estero (ma attenzione a eventuali accordi successivi: la situazione potrebbe cambiare se un domani entra in vigore una convenzione internazionale con quel Paese).
Esempio: Sempronio, turista italiano, prende una multa per eccesso di velocità in Marocco. Il verbale gli arriva in Francia (dove risiede) mesi dopo. Sempronio non paga. Il Marocco non ha accordi di recupero multe con l’Italia; conseguentemente Sempronio non riceverà alcuna cartella esattoriale italiana. Tuttavia, se dovesse tornare in Marocco, potrebbe essere costretto a pagare sul posto (magari al controllo passaporti risulterà la sanzione non pagata). In Italia, nessuna autorità pubblica potrà procedere contro di lui per quella multa marocchina.
Contenzioso in Italia: giudici competenti e strategie di difesa del debitore
Dal punto di vista procedurale, contestare un accertamento dall’estero implica capire quale giudice italiano (se del caso) sia competente e con quali atti introdurre la difesa. A seconda della natura del credito si attivano infatti giurisdizioni diverse:
- Crediti tributari (imposte, tasse, dazi): la competenza per le controversie relative a tali atti spetta al Giudice Tributario italiano, ossia alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (nuova denominazione delle ex Commissioni Tributarie). Ciò vale anche per questioni inerenti la notifica o validità di cartelle esattoriali emesse in Italia su richiesta estera. In pratica, se arriva una cartella per un credito fiscale estero, la si impugna con ricorso tributario entro 60 giorni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria provinciale competente per territorio (di solito quella del domicilio fiscale del contribuente in Italia, indicata nell’atto stesso). Il giudice tributario può occuparsi di: vizi formali dell’atto italiano (cartella); mancata notifica dell’atto presupposto estero; intervenuta prescrizione; ecc. Non può invece sindacare il merito del tributo estero, come visto – dichiarerebbe il motivo inammissibile per difetto di giurisdizione sul rapporto d’imposta sostanziale estero. In tali casi, il ricorso va rigettato ma il contribuente può far valere eventuali questioni di legittimità nell’altro Stato.
- Sanzioni amministrative (multe): le opposizioni a sanzioni del Codice della Strada o analoghe, quando si tratta di cartelle esattoriali o ingiunzioni di pagamento, in Italia sono di competenza del Giudice di Pace (art. 7 D.Lgs. 150/2011), senza limiti di valore. Questo principio si applica anche alle sanzioni estere riconosciute. Dunque, se riceviamo una cartella per una multa UE, il rimedio tipico è un ricorso al Giudice di Pace del luogo di esecuzione (solitamente il luogo di residenza del debitore, o dove sono stati eseguiti atti). Il ricorso è in forma di citazione od opposizione ex L. 689/81, da depositare entro 30 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo. Davanti al Giudice di Pace il debitore potrà far valere motivi come la mancata notifica originaria, errori di persona, prescrizione, ecc., chiedendo l’annullamento della cartella. Come detto, questi giudici non possono annullare la multa estera per motivi di merito, ma possono dichiarare non dovuto il pagamento se riscontrano vizi procedurali. Ad esempio, il Giudice di Pace di Milano potrebbe accogliere l’opposizione avverso cartella per multa spagnola se accerta che l’ordinanza sanzionatoria spagnola non fu mai comunicata a conoscenza dell’opponente (violazione diritti difesa), integrando motivo di ordine pubblico per negare esecuzione.
- Provvedimenti amministrativi italiani su richiesta estera: in alcune ipotesi, l’esecuzione di atti esteri può passare per un provvedimento amministrativo nazionale – ad esempio un decreto del Ministero dell’Interno che impone una sanzione, o un’ordinanza di un Prefetto. In tali casi, essendo l’atto di natura amministrativa, la giurisdizione sarebbe del Giudice Amministrativo (TAR). Si pensi a misure come la revoca di una patente italiana su sollecitazione di uno Stato estero: se adottata dal Ministero, il destinatario dovrebbe ricorrere al TAR del Lazio (competente per atti ministeriali) per annullarla. Nell’ambito in esame, però, la gran parte delle situazioni passa per vie tributarie o giudice di pace, e l’intervento del TAR è raro. Potrebbe verificarsi in casi di sanzioni amministrative non Codice della Strada – ad esempio una sanzione antitrust UE (che comunque verrebbe impugnata in sede UE) o, fuori UE, un provvedimento di confisca amministrativa richiesto diplomaticamente. In assenza di specifiche previsioni, in genere un atto amministrativo italiano che desse esecuzione a un provvedimento estero potrebbe essere portato al TAR contestando eccesso di potere o violazione di legge (mancata base normativa per incidere su diritti in Italia).
- Giudice dell’esecuzione civile: qualora il credito estero sia ormai definitivo e si sia passati alla fase esecutiva forzata (pignoramenti, aste), alcune problematiche potrebbero essere trattate dal giudice dell’esecuzione ordinario (Tribunale civile). Ad esempio, se viene pignorato un immobile in Italia per un credito tributario estero, il contribuente potrebbe proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che il titolo su cui si fonda il pignoramento non era stato notificato regolarmente (quindi in realtà quell’atto non poteva considerarsi definitivo). La Cassazione ha però chiarito che se la doglianza attiene alla validità dell’atto impositivo (mancata notifica della cartella o dell’accertamento), la cognizione resta tributaria: il contribuente dovrebbe attivare, anche in via tardiva, il giudice tributario per far dichiarare la nullità dell’atto. L’opposizione al giudice civile è invece ammissibile solo per questioni proprie dell’esecuzione (vizi del pignoramento stesso, sopravvenuta prescrizione già in fase esecutiva). In sostanza, si ha un riparto: contestazioni sul titolo → giudice tributario; contestazioni sull’atto esecutivo → giudice civile. Nella pratica, è preferibile rivolgersi comunque al giudice tributario ove ci siano dubbi, poiché l’orientamento estensivo vede la gran parte delle eccezioni come rientranti nella sua competenza. Solo se l’esecuzione è avanzata e si rileva un vizio non più deducibile in sede tributaria, allora il giudice dell’esecuzione potrà intervenire (ad es. se dopo anni dal ruolo, senza ricorsi tributari, emerge che l’ipoteca è stata iscritta oltre i limiti, il debitore può fare opposizione esecuzione sul fatto estintivo del credito).
Strumenti deflativi e soluzioni alternative: in materia di accertamenti dall’estero, gli strumenti deflattivi del contenzioso (che in ambito italiano sono il reclamo/mediazione tributaria, l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ecc.) trovano applicazione limitata. Infatti, se il merito della pretesa è estero, non vi è margine di negoziazione presso l’ente italiano: l’Agente della Riscossione non può “ridurre” il debito estero se questo è dovuto integralmente secondo lo Stato richiedente. Tuttavia, due scenari: (a) Accertamenti fiscali italiani su redditi esteri – qui siamo pur sempre in ambito nazionale, quindi il contribuente può certamente attivare un accertamento con adesione con l’Agenzia delle Entrate (es. in caso di contestazione per attività estere non dichiarate, si può cercare un accordo riducendo sanzioni) o presentare istanza di mediazione se il valore rientra (oggi fino a €50.000) prima di fare ricorso, così come tentare la conciliazione in giudizio. (b) Crediti esteri in cooperazione UE – in questo caso, l’unica forma di “composizione” possibile è pagare spontaneamente con riduzione delle maggiorazioni: ad esempio, se si paga una cartella entro 60 giorni, si evitano gli interessi di mora e l’aggio ulteriore. Oppure chiedere una rateizzazione: l’Italia, trattando il credito come proprio, può concedere al debitore una dilazione in base alle norme interne (es. fino a 72 rate mensili se sussistono i requisiti di difficoltà economica, secondo l’art. 19 D.P.R. 602/1973). La rateazione sospende le azioni esecutive purché si rispettino i pagamenti. Va detto che per i tribuli UE l’accertamento con adesione non ha senso, perché l’accertamento è già definitivo; mentre per le multe UE, l’unica valvola di sfogo prima dell’esecuzione era eventualmente il ricorso al Prefetto nel Paese estero o analoghi strumenti di composizione locale.
Rimessione in termini: un elemento a tutela del contribuente estero è la possibilità di ottenere la rimessione in termini nel caso non abbia potuto impugnare entro i termini per cause non imputabili. La giurisprudenza tributaria italiana ammette che, se un soggetto residente all’estero riceve con grande ritardo o in modo irregolare l’avviso di accertamento, possa presentare un ricorso oltre il 60° giorno e chiedere al giudice di considerarlo comunque ammissibile, provando la causa di forza maggiore (es. notifica nulla poi sanata tardivamente). Ciò è coerente col principio che nessuno deve perdere la possibilità di difendersi per un vizio di notifica non dipendente da lui. Quindi, anche se formalmente il termine standard è di 60 giorni dalla notifica per ricorrere, se la notifica è viziata il ricorso può essere accolto come tempestivo quando proposto appena avuta conoscenza effettiva dell’atto. Questo strumento sarà prezioso nel caso di atti esteri mai giunti regolarmente a destinazione: il contribuente, appena scopre l’esistenza del debito (magari dall’arrivo di una cartella), potrà attivarsi immediatamente invocando la rimessione.
Domande frequenti (Q&A) sugli accertamenti dall’estero
D: Ho ricevuto una cartella da Agenzia Entrate-Riscossione riferita a imposte di un altro Paese UE. Devo rivolgermi al fisco estero o ai giudici italiani?
R: In primo luogo, verifica se puoi ancora agire nel Paese estero (ad esempio presentando un ricorso tardivo o chiedendo una revisione). Parallelamente, puoi impugnare la cartella in Italia davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente, ma solo per motivi formali (vizi di notifica, prescrizione, ecc.). Non potrai far valere in Italia ragioni di merito sul calcolo delle imposte estere. Quindi è spesso necessario un doppio binario: difesa nel merito all’estero, eccezioni procedurali in Italia. Se il ricorso all’estero è pendente, informa subito l’Agente della Riscossione e richiedi la sospensione della cartella per evitare pagamenti duplici.
D: Posso evitare che una multa stradale estera diventi una cartella esattoriale in Italia?
R: Sì, la via migliore è pagarla o contestarla tempestivamente nel Paese dove hai preso la multa. Se paghi entro i termini indicati nel verbale estero, la pratica si chiude e non verrà attivata l’assistenza internazionale. Se ritieni la multa ingiusta, proponi ricorso all’autorità estera competente (es. giudice o ente locale) entro i termini (spesso 30 o 60 giorni). In caso di ricorso pendente, la Decisione Quadro UE non consente di avviare la riscossione transfrontaliera. Quindi contestando formalmente la multa all’estero blocchi l’iter verso l’Italia. Se invece ignori la multa, trascorsi alcuni mesi/anni essa potrà essere trasmessa per l’esecuzione: a quel punto riceverai una cartella e dovrai pagarla integrale con aggiunte, o provare a opporla per motivi limitati (che raramente portano all’annullamento totale, se l’illecito c’è stato).
D: Ho scoperto che il fisco estero mi perseguiva solo quando ho ricevuto atti in Italia. Posso far valere la mancata notifica estera?
R: Sì. La mancata o irregolare notifica originaria è uno dei principali motivi di opposizione a tua disposizione. Se dimostri che non hai mai ricevuto l’atto impositivo o il verbale estero (ad es. perché inviato a un indirizzo errato, o perché residente altrove), potrai chiedere al giudice italiano di dichiarare non esecutivo il titolo per violazione del diritto di difesa. In ambito tributario, questo si traduce nell’annullamento della cartella per nullità della notifica presupposta; in ambito multe, il giudice di pace può rigettare l’esecuzione per ordine pubblico. Attenzione: se invece l’atto estero fu notificato secondo le regole locali (magari per compiuta giacenza) ma tu non l’hai visto, è più difficile sostenere la nullità: la controparte dirà che era tua cura aggiornare l’indirizzo, ecc. In ogni caso, porta in giudizio qualsiasi elemento (es. certificato AIRE con indirizzo diverso) che mostri l’irregolarità.
D: Perché il giudice italiano non può ricalcolare o annullare il tributo estero?
R: Perché vige il principio che ogni Stato ha sovranità sulla propria pretesa tributaria. Il meccanismo UE di mutua assistenza si basa sulla fiducia reciproca: l’Italia esegue i crediti altrui senza sindacarli, confidando che siano legittimi. Consentire ai giudici italiani di riesaminare nel merito un accertamento francese o tedesco equivarrebbe a mettere l’una giurisdizione sopra l’altra, generando conflitti e forum shopping. Dunque, la legge (art. 14 Dir. 2010/24) lo esclude esplicitamente. Per analoga ragione, un giudice straniero non può rivedere un accertamento emesso dall’Agenzia Entrate italiana contro un residente all’estero: sarà il nostro giudice tributario a decidere su quello. Quello che il giudice italiano può fare è tutelare i tuoi diritti processuali (notifica, prescrizione, ecc.) e assicurarsi che l’assistenza non si traduca in un abuso.
D: Nel caso delle multe UE, posso evitare il passaggio in Corte d’Appello e rivolgermi subito al Giudice di Pace?
R: Il destinatario di solito non partecipa alla fase di riconoscimento in Corte d’Appello – questa avviene d’ufficio su impulso del PM o Ministero. Verrai a conoscenza del procedimento, se accade, solo attraverso l’ordinanza finale o la cartella esattoriale. Non hai modo di presentare ricorso preventivo al CoA, se non dopo che ha deciso (ricorso in Cassazione). Pertanto, il primo vero contraddittorio spesso si ha davanti al Giudice di Pace con l’opposizione alla cartella. È importante però che, se intendi contestare, tu non faccia decorrere i 30 giorni dalla notifica della cartella: diversamente la multa diventa definitiva anche qui e poi potrai solo pagare. Quindi, sì, in pratica il Giudice di Pace sarà il tuo primo giudice di merito su questioni esecutive. In parallelo, il tuo legale potrà esaminare l’ordinanza di riconoscimento (se disponibile) e valutare un ricorso per Cassazione per eventuali errori di diritto (ad es. la CoA ha riconosciuto una sanzione che non rientrava nel campo di applicazione della legge). Cassazione e Giudice di Pace sono due binari diversi: la Cassazione valuta la legittimità del provvedimento di riconoscimento, il GdP valuta la legittimità dell’esecuzione.
D: Cosa succede se pago in Italia un credito estero, ma poi riesco a farlo annullare all’estero?
R: In tal caso hai diritto alla restituzione di quanto pagato. Dovrai comunicare l’esito favorevole (sentenza o provvedimento di annullamento) sia all’Agente della Riscossione italiana sia all’autorità estera. Normalmente, il denaro riscosso dall’Italia viene trasferito allo Stato estero richiedente; se arriva l’annullamento, l’autorità estera dovrebbe rimborsare l’importo e l’Italia provvederà a rimborsarti a sua volta. Il D.Lgs. 149/2012 prevede che, qualora il credito estero venga meno dopo la riscossione, l’importo venga restituito dal Paese richiedente come indebito. Potrebbe volerci tempo e qualche sollecito diplomatico. Se invece l’annullamento è parziale (debito ridotto), verrà rimborsata la differenza. Importante: attiva subito la procedura di rimborso presentando istanza di rimborso all’Agente della Riscossione con copia del provvedimento estero; e, se tardano, valuta un ricorso in Commissione Tributaria per ottenere l’indebito. In ogni caso, conserva tutte le ricevute e le sentenze per far valere i tuoi diritti.
D: La prescrizione del credito estero come si calcola?
R: Di regola, dopo che un credito tributario o una multa sono stati resi esecutivi in Italia, vale la prescrizione italiana per quella tipologia di atto (es. 10 anni per tributi, 5 anni per sanzioni amministrative). Tuttavia, se nello Stato d’origine il credito si prescrive prima, è prassi rispettare quel termine. Ad esempio, se una multa in Belgio si prescrive in 5 anni e in Italia in 5 anni, problema non c’è; ma se in Belgio fosse 3 anni, dopo 3 anni non si dovrebbe più procedere. La direttiva e la decisione quadro indicano che non si assiste in caso di credito prescritto nello Stato di emissione. Quindi, in un’opposizione, puoi sempre eccepire: “secondo la legge X dello Stato estero, il credito è prescritto il giorno tot”. Servirà magari una perizia o documentazione di legge straniera. Se convinci il giudice, l’esecuzione decade. In mancanza di eccezione, l’Italia potrebbe andare avanti fino al limite nazionale. Dunque, informarsi sui termini di prescrizione esteri è utile. Ad esempio, sai che in Romania le multe stradali si prescrivono in 6 mesi? Un dato del genere potrebbe salvarti da una richiesta tardiva.
D: Se non pago né contesto una multa UE, possono togliermi punti patente o altre sanzioni accessorie?
R: No, le sanzioni accessorie (decurtazione punti, sospensione patente) non rientrano nel meccanismo di cooperazione. Quelle restano di competenza dello Stato in cui hai commesso l’infrazione. Ad esempio, una multa per eccesso di velocità in Francia potrebbe prevedere in Francia la sospensione della patente per 3 mesi: ma la Francia non può chiedere all’Italia di sospendere la tua patente italiana. Ti chiederà solo di pagare la multa. Diverso è se torni in Francia guidando: lì potresti non poter guidare per quei 3 mesi. Allo stesso modo, i punti patente: un italiano che commette infrazione all’estero non subisce decurtazione punti sulla patente italiana, perché non c’è interconnessione sui punti (tranne accordi bilaterali particolari, es. con Austria per i camionisti professionali, ma sono eccezioni). Quindi, almeno da questo punto di vista, le conseguenze non pecuniarie non “viaggiano” verso l’Italia con la stessa facilità delle multe.
D: Ho un conto bancario all’estero non dichiarato e temo un accertamento dall’Italia: come si incardina questo caso nel contesto “dall’estero”?
R: Qui l’accertamento sarebbe dall’Italia verso l’estero, ossia la situazione opposta: l’Agenzia delle Entrate che, grazie allo scambio internazionale, viene a sapere di tuoi redditi esteri e ti contesta evasione. Pur non essendo un accertamento emesso da estero, coinvolge comunque prove estere. In questo scenario, sei davanti a un normale avviso di accertamento italiano, impugnabile in Italia come qualsiasi atto impositivo. Tuttavia, sarà fondamentale procurarti prove dall’estero: ad esempio documenti bancari, attestati di avvenuto pagamento di imposte all’estero (per ottenere credito d’imposta), documentazione su eventuale residenza estera (se vuoi sostenere che in quell’anno non eri soggetto all’imposta italiana). La difesa richiede spesso perizie estere o traduzioni giurate. In pratica, pur non rientrando nella cooperazione di cui sopra, il “know how” sulle prove dall’estero torna utile anche qui: l’onere di dimostrare eventuali esimenti (soldi già tassati, investimenti di capitale e non redditi) spetta al contribuente, pena il consolidarsi della pretesa fiscale italiana.
D: Sono iscritto AIRE e ho ricevuto un accertamento dell’Agenzia Entrate mentre ero all’estero: hanno notificato alla vecchia residenza italiana, è valido?
R: No, se l’Amministrazione era a conoscenza dell’iscrizione AIRE, doveva notificare all’estero (salvo domicilio eletto in Italia). La notifica presso il vecchio indirizzo italiano di un soggetto residente fuori è nulla. La Cassazione ha più volte affermato l’illegittimità di notifiche “fittizie” in Italia a cittadini italiani con residenza estera conosciuta. Quindi potrai impugnare l’atto eccependo nullità della notifica e ottenere annullamento, a meno che l’ente non dimostri che ignorava l’indirizzo estero. Attenzione però: la nullità può sanarsi se hai fatto ricorso senza eccepirla, o se hai avuto conoscenza aliunde dell’atto. In linea generale, l’Agenzia Entrate oggi dispone di canali di notifica all’estero (convenzioni, posta estera, PEC): l’iscrizione AIRE costituisce indirizzo ufficiale per recapiti. Se hanno sbagliato, farai valere il vizio e l’atto dovrà essere rinotificato correttamente (se ancora nei termini) o altrimenti decadrà.
D: Che differenza c’è tra contestare un accertamento estero e uno nazionale, in termini probatori?
R: In un accertamento nazionale (es. l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi non dichiarati in Italia) spesso la diatriba è su ricostruzioni fattuali: oneri deducibili, qualificazioni giuridiche, ecc., e la prova può essere ripartita (talvolta presunzioni a carico del Fisco e onere di prova contraria sul contribuente). Nel caso di un accertamento estero, il merito non è ridiscusso qui: quindi ciò che devi provare sono essenzialmente fatti estintivi o procedurali (pagamento, prescrizione, vizio di notifica). L’onere probatorio di questi aspetti è tendenzialmente tuo, poiché invochi eccezioni. Ad esempio, se sostieni di aver pagato, devi provarlo; se sostieni la prescrizione, devi documentare il dies a quo e la norma applicabile. Non dovrai invece provare che “non dovevi quelle tasse” – sarebbe materia del giudizio di merito estero. Quindi il contenzioso in Italia su atti esteri è più limitato e spesso documentale: si gioca sulle carte (lettere di notifica, ricevute, cronologie). Invece un contenzioso interno può prevedere anche testimonianze (non nel processo tributario, ma sì nel civile) o CTU tecniche; qui raramente.
D: Se il mio debito estero viene riscosso in Italia, devo pagare due volte l’avvocato (uno in Italia e uno all’estero)?
R: Purtroppo, può essere necessario avere un duplice supporto legale: un professionista in loco per gestire il merito nel Paese d’origine, e un avvocato in Italia per tutelare i tuoi interessi contro l’esecuzione. Alcuni studi legali internazionali offrono pacchetti integrati, ma sono costi aggiuntivi. Valuta tuttavia l’entità del debito: se è modesto (poche centinaia di euro di multa), spesso conviene pagare piuttosto che attivare contenziosi costosi. Se invece sono cifre importanti (accertamenti fiscali per decine di migliaia di euro), investire in una difesa coordinata è opportuno. Ricorda che se vinci all’estero, normalmente hai diritto a non dover pagare in Italia; se hai pagato e vinci, verrai rimborsato – e talvolta le spese legali sono rifondibili dallo Stato soccombente, secondo le regole locali o convenzionali.
Simulazioni pratiche
Per illustrare concretamente come utilizzare le prove e le difese disponibili, esaminiamo alcuni casi pratici emblematici, dal punto di vista del debitore italiano alle prese con accertamenti esteri.
Caso 1: “Cartella dall’Europa” – Debito fiscale estero riscosso in Italia
Mario, cittadino italiano residente a Bologna, riceve da Agenzia Entrate-Riscossione una cartella di pagamento di €25.000. Dalla descrizione capisce che si tratta di imposte non pagate in Francia negli anni in cui aveva lavorato lì (la cartella cita “Impôt sur le revenu 2018 – Trésor Public”). Mario in effetti ha lavorato in Francia nel 2018 ma credeva di essere in regola, avendo presentato la dichiarazione francese. Cosa può fare? Mario contatta un fiscalista francese e scopre che il fisco francese gli aveva inviato un avviso di accertamento per un errore nella dichiarazione, ma all’indirizzo vecchio: quindi quell’avviso non è mai giunto a Mario, diventando però definitivo per decorrenza dei termini. Ora la Francia ha attivato l’Italia per la riscossione. Strategia: Mario presenta entro 60 giorni un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Bologna. Come motivi indica: (a) mancata notifica in Francia dell’avviso (allega certificato di residenza e copie di bollette che mostrano che in quel periodo viveva altrove in Francia); (b) non debenza nel merito (fornisce copia della dichiarazione dei redditi presentata e afferma che l’accertamento era infondato). Il motivo (b) verrà probabilmente dichiarato inammissibile dal giudice italiano, ma serve a “raccontare la storia”. Il fulcro è il (a): Mario prova di non aver ricevuto nulla. La Commissione Tributaria potrebbe sospendere l’esecuzione e, in applicazione dei principi UE, sollevare questione di diritto di difesa. È possibile che il giudice italiano decida di interpellare l’autorità francese (tramite rogatoria o ordine di esibizione via Agenzia Entrate) per verificare le modalità di notifica. Se emerge che la notifica fu davvero inesistente o nulla, il giudice italiano potrebbe annullare la cartella per inesistenza del titolo esecutivo estero valido in Italia. In parallelo, Mario – tramite l’avvocato francese – farà riaprire il caso in Francia (istanza di rimessione in termini) forte del fatto che la prima comunicazione l’ha avuta solo ora. Se la Francia riconosce l’errore e annulla l’accertamento, manderà notizia in Italia e la riscossione cesserà. Mario avrà così evitato di pagare €25.000 ingiusti grazie alle prove sulla notifica carente. Se invece fosse risultato che la Francia aveva notificato regolarmente (es. mediante deposito alla mairie e lettera non ritirata), Mario avrebbe perso il ricorso in Italia: a quel punto, per evitare pignoramenti, dovrebbe valutare un pagamento rateale, e magari chiedere un riesame in extremis in Francia adducendo forze maggiori.
Caso 2: “Multa tedesca ignorata” – Mancato pagamento di contravvenzione UE
Luisa, cittadina di Firenze, in vacanza in Germania riceve una multa per divieto di sosta (€50). Butta il preavviso, non paga. Trascorsi 2 anni, riceve a casa (via posta ordinaria) un sollecito bilingue tedesco-italiano di pagamento ormai salito a €150, dall’ufficio sanzioni tedesco, che la avvisa che in mancanza si procederà per vie legali internazionali. Luisa ignora anche questo. Dopo altri 8 mesi, le viene notificata via PEC una cartella di pagamento da Agenzia Entrate-Riscossione di €180 (comprensiva di interessi e spese) per conto del Comune tedesco. Opzioni: Essendo l’importo modesto, Luisa potrebbe valutare di pagare e chiudere la vicenda, considerando anche che aveva torto. Tuttavia è infastidita e decide di opporsi per principio. Presenta ricorso al Giudice di Pace di Firenze entro 30 giorni. Quali motivi ha? Dato l’importo basso, poteva eccepire che fosse sotto soglia (€50) e quindi non doveva essere eseguito: però il totale cartella è €180, sopra €70 (la soglia va calcolata sull’importo della sanzione originale? In teoria sì: decisione quadro parla di “importo inferiore a €70”). Luisa argomenta quindi che la Decisione Quadro non doveva essere attivata perché la multa originaria era €50 (sotto soglia). Inoltre sostiene che la notifica tedesca via posta ordinaria del sollecito non era conforme ai suoi diritti (in Italia, comunicazione così importante andrebbe raccomandata). Il Giudice di Pace valuterà: se concorda che €50 è sotto soglia, potrebbe annullare la cartella dichiarando che l’esecuzione non andava accolta dall’Italia. Se invece ritiene che, essendo diventata €150 con aggravio, la soglia è superata, allora considererà valida la cooperazione. Sulla notifica: essendo essa avvenuta secondo legge tedesca (valida col semplice invio), forse non sarà ritenuta irregolare a livello di ordine pubblico. Luisa rischia quindi di perdere l’opposizione. In tal caso dovrà pagare, con ulteriore aggravio di spese legali. Morale: per importi minimi, contestare è possibile ma spesso sconveniente; l’eccezione della soglia €70 è un’arma a doppio taglio perché se il Paese estero attiva comunque la procedura, l’Italia può discrezionalmente rifiutare ma non è obbligata a farlo. Avrebbe potuto essere più efficace contestare subito in Germania (dove magari sarebbe bastata una lettera per far annullare la multa per vizio di forma).
Caso 3: “Residenza fittizia e doppia imposizione” – Contestazione di esterovestizione persona fisica
Stefano, imprenditore, si trasferisce fiscalmente nel Regno Unito nel 2024 (iscrizione AIRE) ma mantiene interessi in Italia. Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate italiana gli notifica (via PEC all’estero) un avviso di accertamento contestando che nel 2024 era ancora residente in Italia e non ha dichiarato €200.000 di redditi esteri. Equivalente di un “accertamento dall’estero” in senso inverso: il fisco italiano attinge informazioni estere (movimenti su conti UK) e presume che Stefano abbia simulato la residenza estera (esterovestizione personale). Difesa di Stefano: trattandosi di atto dell’AdE, Stefano deve impugnarlo entro 60 giorni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in Italia, facendo valere che era genuinamente residente in UK. Le prove che presenterà includono: certificato di iscrizione Aire 2024; contratto di locazione della sua casa a Londra; bollette UK; attestazione di tax residency emessa dall’HMRC britannico; copia della dichiarazione dei redditi presentata in UK per il 2024; biglietti aerei che mostrano che è stato in Italia meno di 30 giorni l’anno. Inoltre, evidenzierà che i €200.000 erano dividendi già tassati in UK e, comunque, c’è la convenzione contro le doppie imposizioni con credit d’imposta. Questo arsenale di prove mira a dimostrare che l’accertamento italiano è infondato. In parallelo, Stefano potrebbe attivare un procedimento di accertamento con adesione per mostrare informalmente le prove al Fisco sperando in un annullamento in autotutela. Se l’AdE non molla, in giudizio il suo esito dipenderà dalla valutazione delle prove: l’onere in questi casi è in parte del Fisco (provare che Stefano era in Italia) e in parte del contribuente (provare di essersi stabilito all’estero sostanzialmente). Cassazione ha chiarito che l’iscrizione Aire da sola non basta, conta la realtà di vita. Stefano quindi punta su elementi sostanziali. Se le prove sono forti, la Commissione annullerà l’accertamento. A Stefano poi converrà attivarsi per evitare che in futuro situazioni simili si ripetano: ad esempio, presentando istanza di interpello o segnalando la residenza effettiva per via amministrativa per ottenere un’attestazione italiana di non residenza fiscale.
Caso 4: “Dazio doganale extra-UE” – Cooperazione internazionale dogane
Una società italiana importa merce dalla Turchia, sdoganando in Italia. L’agenzia dogane turca accerta che l’esportatore turco aveva sottovalutato il valore all’uscita e contesta un dazio all’esportazione non pagato di 100.000 € alla società importatrice (ritenuta corresponsabile). La Turchia, non essendo UE, chiede assistenza all’Italia tramite la Convenzione OCSE 1988. L’Agenzia delle Entrate, riconosciuto il titolo turco, affida il compito all’Agenzia Riscossione, che notifica una ingiunzione fiscale (strumento alternativo alla cartella in certi casi) alla società italiana per €100.000. La società ritiene di non dover nulla perché ha pagato tutto in Italia. Come reagire? Presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Trieste (sede portuale) sostenendo: (a) incompetenza delle autorità turche su di essa (questione di merito che però il giudice italiano non potrà valutare); (b) soprattutto violazione del ne bis in idem internazionale: la stessa differenza di dazio è stata riscossa dall’Italia come dazi UE (se ciò è avvenuto); (c) eccesso di potere nell’assistenza, perché trattasi di dazio su esportazione e l’Italia secondo i propri principi di ordine pubblico non eseguirebbe dazi all’export altrui (un argomento complesso). Inoltre, data la delicatezza, la società chiede un incontro con l’Agenzia Entrate per discutere. Questo scenario è più raro ma mostra che per crediti “ibridi” (dazi extracomunitari) la difesa può coinvolgere elementi di diritto internazionale e consuetudini. L’esito dipenderà anche dalla posizione del MEF italiano: se ritiene la richiesta turca legittima, spingerà per l’esecuzione. La società, parallelamente, potrà cercare di trattare in Turchia (magari pagando il dovuto ridotto per chiudere la questione e poi far cessare la procedura qui). In tal caso, presenterebbe la prova del pagamento effettuato e l’Agenzia delle Entrate comunicherebbe lo storno del residuo. Questo caso evidenzia come in situazioni extra-UE la componente diplomatica e pratica prevalga: a volte conviene negoziare piuttosto che combattere sul piano strettamente giuridico.
Tabelle riepilogative
Di seguito proponiamo alcune tabelle riassuntive che sintetizzano i principali aspetti degli accertamenti esteri e delle relative procedure di contestazione:
Tabella 1 – Strumenti di cooperazione internazionale per riscossione di crediti esteri
| Tipologia di credito estero | Base giuridica per esecuzione in Italia | Autorità italiana coinvolta | Grado di riesame nel merito in Italia |
|---|---|---|---|
| Tributi e dazi (Stati UE) | Direttiva 2010/24/UE – D.Lgs. 149/2012 (titolo esecutivo uniforme UE) | Agenzia Entrate (richiesta) + Agente Riscossione (esecuzione) | ❌ Nessun riesame merito (solo vizi formali/estintivi) |
| Tributi e dazi (Stati extra-UE) | Convenzione mutua assistenza 1988 (OCSE) o clausole trattati bilaterali | MEF/Agenzia Entrate (riconoscimento) + Agente Riscossione | ❌ Nessun riesame merito (solo vizi formali/diritti difesa) |
| Multe/sanzioni (Stati UE) | Dec. Quadro 2005/214/GAI – D.Lgs. 37/2016 (ricon. reciproco sanzioni) | Corte d’Appello (riconoscimento) + Agente Riscossione | ❌ Nessun riesame merito (solo motivi rifiuto limitati) |
| Multe/sanzioni (Stati extra-UE) | Nessuno strumento automatico (salvo accordi specifici es. bilaterali) | – (eventuale caso per caso via Ministeri/Giustizia) | ✔️ Sì, riesame completo se portato davanti a giudice italiano (ma raro) |
Legenda: ❌ = no, non ammesso; ✔️ = sì, possibile.
Come si evince, all’interno dell’UE vige l’automatismo del riconoscimento reciproco e la limitazione delle difese al piano procedurale. Fuori dall’UE, invece, la mancanza di automatismi fa sì che o non vi sia proprio il contenzioso (perché il credito resta all’estero), oppure se un provvedimento straniero viene volontariamente eseguito in Italia (casi rari), allora il giudice italiano potrà conoscerne anche il merito (perché non c’è una norma che lo inibisce, salvo volere applicare analogia di principio).
Tabella 2 – Difese del debitore e prove rilevanti per tipologia di accertamento
| Scenario | Difese principali in Italia | Prove/elementi chiave da produrre | Giudice competente (Italia) |
|---|---|---|---|
| Cartella esattoriale per tributo estero UE | – Eccepire mancata/irregolare notifica atto originario– Eccepire prescrizione o decadenza del credito– Prova di pagamento totale/parziale– Errori di persona (non è il soggetto giusto) | – Documenti su residenza o domicilio estero (notifica)– Copia atto estero e modalità notifica (AR, pubblici proclami, ecc.)– Ricevute versamenti effettuati– Estratti legge estera su prescrizione | Corte Giustizia Tributaria (ex Comm. Trib.) |
| Avviso di accertamento italiano su redditi esteri | – Contestare residenza fiscale (se applicabile)– Dimostrare doppia imposizione (credito imposta dovuto)– Provare esimenti (es. redditi esenti) | – Iscrizione Aire, prove di vita all’estero– Certificati residenza fiscale estera (tax certificate)– Dichiarazioni estere presentate– Documenti finanziari (conti, contratti) collegati ai redditi | Corte Giustizia Tributaria |
| Multa UE non pagata (cartella/ingiunzione) | – Contestare notifica (verbale non ricevuto o non tradotto)– Sanzione già estinta (pagata o prescritta)– Importo sotto soglia €70– Identità errata (ad es. veicolo venduto prima) | – Copia verbale estero e relative buste (se disponibili)– Contratto vendita veicolo, denuncia furto (se applicabile)– Normativa estera su termini di notifica/prescrizione (esibire estratto legge)– Eventuale ricevuta di pagamento se effettuato tardivamente all’estero | Giudice di Pace (o Cassazione su profili di diritto riconoscimento) |
| Multa extra-UE (non eseguibile in Italia) | – N/A (nessun procedimento in Italia, salvo eccezioni accordi) | – Comunicazioni ricevute dall’estero (per capire stato pratica)– Eventuale corrispondenza con noleggiatori, ambasciate (es. per chiedere annullamento) | – (competenza del Paese estero) |
| Sanzione amministrativa estera (non stradale) UE | – Analoghe alla multa stradale: notifica, prescrizione, ecc.– Verifica doppia incriminazione (se reato non riconosciuto in Italia) | – Testo decisione estera e certificato trasmesso– Documenti su eventuale ricorso estero pendente– Estratto norme italiane per mostrare che il fatto non è illecito qui (se rilevante) | Giudice di Pace / Tribunale (a seconda materia, di regola GdP se sanzione amm.va) |
| Provvedimento amministrativo italiano su input estero (es. ritiro patente) | – Contestare legittimità provvedimento (eccesso potere, difetto istruttoria)– Verificare se vi era base convenzionale per l’azione– Chiedere misure alternative (es. convertire sanzione) | – Copia provvedimento italiano (es. decreto Prefetto)– Testo accordo internazionale invocato (se esiste)– Documenti personali (es. necessità patente per lavoro – per questioni equitative) | TAR (giurisdizione amm.va) |
Le tabelle confermano che le prove documentali giocano un ruolo centrale: ricevute, attestazioni ufficiali, certificati di legge straniera. La cooperazione legale internazionale spesso include anche scambio di informazioni: ad esempio si può ottenere tramite rogatoria la prova che un atto non fu notificato perché restituito al mittente. Un avvocato esperto saprà attivare anche questi canali probatori.
Conclusioni
Contestare un accertamento proveniente dall’estero richiede un approccio multidisciplinare e transnazionale. Dal punto di vista del debitore, è fondamentale: (1) conoscere gli strumenti giuridici con cui il credito estero può essere perseguito in Italia; (2) attivarsi prontamente sia nel Paese d’origine (se possibile) sia in Italia per far valere i propri diritti; (3) raccogliere ogni elemento probatorio che dimostri vizi procedurali o l’inesigibilità della pretesa; (4) rivolgersi al giudice competente con il corretto rito, rispettando i termini (60 giorni in ambito tributario, 30 giorni per opposizioni a sanzioni). La normativa italiana offre vari mezzi di tutela – dalla possibilità di ricorso tardivo per notifica nulla, alla sospensione giudiziale della riscossione, fino al rigetto della cooperazione in casi estremi di violazione di diritti – ma il contribuente deve attivarsi e fornire al giudice gli appigli necessari sotto forma di prove.
Abbiamo visto come le recenti sentenze (Corte di Giustizia UE, Cassazione SS.UU. 2023, Cass. 2021 n. 23378, Cass. 2023 n. 26660, ecc.) confermino l’importanza della regolarità delle notifiche e del rispetto del contraddittorio: un accertamento “a sorpresa” non regge, neppure oltreconfine. Allo stesso tempo, però, il merito della pretesa fiscale o sanzionatoria estera non può essere riesaminato in Italia, sancendo una linea di demarcazione netta.
Il debitore deve quindi muoversi su due fronti: contestare l’accertamento alla fonte, presentando magari documenti che smentiscono la pretesa (a volte basta interloquire: molti Paesi prevedono strumenti di autotutela simili ai nostri), e contestare l’esecuzione in Italia per assicurarsi che non avvenga in violazione di legge. In tal senso, l’assistenza di professionisti competenti in entrambe le giurisdizioni può fare la differenza tra subire passivamente un atto estero e riuscire a neutralizzarlo o ridimensionarlo.
In conclusione, “le prove servono” – e servono in fretta: biglietti, contratti, comunicazioni, norme… vanno raccolti e presentati ordinatamente. Un accertamento dall’estero non è una condanna senza appello: con la giusta strategia legale e probatoria, il debitore può vedere riconosciute le proprie ragioni e bloccare pretese illegittime, evitando esborsi indebiti.
Fonti normative e giurisprudenziali utilizzate:
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 58 (domicilio fiscale AIRE) e art. 60-bis (notifiche estere, introdotto dal 2012).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 26 (notifica cartelle), art. 19 (rateazione).
- Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1988 sulla mutua assistenza in materia fiscale (rat. L. 19/2005), art. 17-21 (notifica atti), art. 11 e 14 (assistenza riscossione).
- Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, 16 marzo 2010 (assistenza recupero crediti dazi/imposte), attuata con D.Lgs. 149/2012. In particolare art. 8 (notifica documenti), art. 12 (titolo uniforme), art. 14 (limiti alla contestazione, ordine pubblico).
- Decisione Quadro 2005/214/GAI del Consiglio, 24 febbraio 2005 (riconoscimento sanzioni pecuniarie UE), attuata con D.Lgs. 37/2016. In particolare art. 4 DF (ambito reati/sanzioni), art. 7 (competenza Corte Appello), art. 9 (condizioni riconoscimento), art. 10 (motivi rifiuto), art. 14 (importo soglia €70).
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): art. 201 (notifica entro 360 giorni a residenti estero); art. 207 (cauzione per stranieri, irrilevante qui); L. 689/1981 (opposizione sanzioni amm.ve) e D.Lgs. 150/2011 art. 7.
- Cassazione Civile, Sez. Unite, 13 dicembre 2023 n. 34981 – Procedura recupero crediti UE, nessuna decadenza quinquennale per richiesta assistenza.
- Cassazione Civ., Sez. Trib., 24 agosto 2021 n. 23378 – Notifica cartella a cittadino estero AIRE: illegittimità se fatta in Italia anziché all’estero.
- Cassazione Civ., Sez. Trib., 15 settembre 2023 n. 26660 – Notifica atti impositivi a mezzo posta: necessità di prova ricezione CAD; principi su nullità notifica e rimedi.
- Corte Giust. UE, causa C-26/18 (Donnellan), 26 aprile 2018 – Su art. 14 Dir. 2010/24: possibilità rifiuto esecuzione se credito non notificato correttamente e diritto a ricorso effettivo (art. 47 Carta UE).
- Corte Giust. UE, causa C-233/08 (Kyrian), 2010 – Ordine pubblico come limite a mutua assistenza (precedente a Donnellan).
- Circolari e linee guida dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia Riscossione su cooperazione internazionale (ad es. circ. AdE 4/2013 su D.Lgs. 149/2012).
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate contesta la tua residenza o redditi dall’estero? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate contesta la tua residenza o redditi dall’estero?
Vuoi sapere quali prove servono per difenderti e dimostrare la tua posizione?
Quando si vive o si lavora all’estero, il fisco italiano può presumere che il contribuente sia ancora residente in Italia, soprattutto se mantiene legami familiari o patrimoniali. Per contestare un accertamento di questo tipo occorre fornire documentazione chiara e concreta, come:
- iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);
- contratto di lavoro estero o iscrizione a enti previdenziali stranieri;
- contratto di locazione o acquisto casa nel Paese estero;
- iscrizione scolastica dei figli;
- conti bancari e rapporti finanziari all’estero;
- eventuali certificati fiscali rilasciati dalle autorità straniere.
Queste prove possono dimostrare che il centro degli interessi vitali non è in Italia e che i redditi sono già stati tassati all’estero.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’avviso di accertamento e le motivazioni legate alla residenza o ai redditi esteri
📌 Verifica la documentazione disponibile e individua eventuali prove mancanti da reperire
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi per dimostrare la residenza estera effettiva e l’assenza di obblighi fiscali in Italia
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in caso di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate
🔁 Ti supporta anche nella pianificazione fiscale internazionale per evitare future contestazioni sulla residenza e sui redditi esteri
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in fiscalità internazionale e difesa da accertamenti legati alla residenza estera
✔️ Specializzato in contenzioso tributario e gestione di prove a supporto della residenza fiscale
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Contestare un accertamento dall’estero è possibile solo con prove concrete e documentazione solida.
Con la giusta strategia legale puoi dimostrare la tua effettiva residenza, evitare la doppia imposizione e proteggere i tuoi redditi esteri.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti fiscali dall’estero comincia da qui.