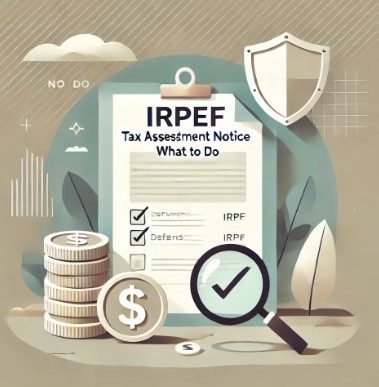Hai ricevuto un avviso di accertamento IRPEF e non sai come muoverti?
L’Agenzia delle Entrate può emettere un avviso di accertamento quando ritiene che il reddito dichiarato dal contribuente non corrisponda a quello effettivo. Si tratta di un atto immediatamente esecutivo che può portare al recupero di imposte, interessi e sanzioni. Sapere cosa fare e come difendersi è fondamentale per evitare conseguenze pesanti.
Quando scatta un avviso di accertamento IRPEF
– Se ci sono incongruenze tra il reddito dichiarato e i dati in possesso del Fisco
– In presenza di redditi non dichiarati o dichiarati in misura inferiore al reale
– A seguito di controlli incrociati con banche dati, conti correnti, dichiarazioni di terzi
– Per errori, omissioni o detrazioni/deduzioni non spettanti
– In caso di controlli formali o accertamenti sintetici sul tenore di vita
Cosa contiene un avviso di accertamento IRPEF
– L’indicazione del maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate
– La liquidazione delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni
– La motivazione dell’accertamento con il riferimento agli elementi di prova
– L’intimazione al pagamento entro un termine preciso
Cosa fare se ricevi un avviso di accertamento IRPEF
– Verificare attentamente la notifica e la correttezza formale dell’atto
– Controllare i calcoli del Fisco e le prove su cui si basa la contestazione
– Raccogliere documentazione utile (estratti conto, contratti, giustificativi di spese e redditi esenti)
– Valutare la possibilità di aderire all’accertamento con riduzione delle sanzioni, se la pretesa è fondata
– Presentare memorie difensive in fase di contraddittorio
– Impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni se ci sono motivi validi
Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’avviso se infondato o viziato
– La riduzione delle somme richieste grazie a ricorso o accertamento con adesione
– La sospensione delle procedure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) collegate all’atto
– La tutela del patrimonio personale e familiare
– La possibilità di pagare solo quanto realmente dovuto, evitando sanzioni sproporzionate
Attenzione: l’avviso di accertamento IRPEF è immediatamente esecutivo. Questo significa che, in assenza di reazione, può trasformarsi in cartella esattoriale e dare luogo a procedure esecutive. Agire subito è l’unico modo per difendersi.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa del contribuente – ti spiega cosa fare se ricevi un avviso di accertamento IRPEF e quali strategie legali puoi adottare per proteggerti.
Hai ricevuto un avviso di accertamento IRPEF?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo l’atto, valuteremo le prove e predisporremo la strategia più efficace per difendere i tuoi diritti.
Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento IRPEF è un evento critico per qualsiasi contribuente (persona fisica, imprenditore individuale o società di persone). Si tratta di un atto formale attraverso cui l’Amministrazione finanziaria – tipicamente l’Agenzia delle Entrate – contesta al contribuente un’omissione o irregolarità fiscale, ritenendolo debitore di ulteriori imposte rispetto a quanto dichiarato. In altre parole, l’avviso di accertamento comunica l’esito di controlli o verifiche dai quali emergono maggiori redditi imponibili o errori dichiarativi: il Fisco rettifica i dati dichiarati o accerta d’ufficio redditi non dichiarati, quantificando le imposte dovute (IRPEF e relative addizionali, IVA se applicabile, ecc.) oltre interessi e sanzioni. Dal momento della notifica di un avviso, per il contribuente scattano precisi doveri (come quello di pagare entro termini brevi se non intende contestare) ma anche diritti di difesa (la possibilità di attivare strumenti deflattivi o di proporre ricorso davanti al giudice tributario).
Questa guida – aggiornata ad agosto 2025 – fornirà un quadro completo e di livello avanzato in materia di accertamenti IRPEF, con taglio tecnico‐giuridico ma tono divulgativo. Saranno richiamate le norme italiane vigenti, le prassi amministrative e le più recenti pronunce giurisprudenziali in tema di accertamento tributario. Particolare attenzione sarà data alla prospettiva del contribuente (“debitore”): cosa controllare nell’atto ricevuto, quali opzioni ha a disposizione (“pagare o impugnare?”), come funzionano i vari strumenti di difesa (dall’adesione all’eventuale contenzioso in Commissione/Corte di giustizia tributaria) e quali sono pro e contro di ciascuna scelta. Troverete anche tabelle riepilogative dei termini chiave e un confronto tra le soluzioni possibili, oltre a una sezione di domande e risposte frequenti (FAQ) e alcune simulazioni pratiche con esempi, per chiarire gli effetti concreti delle diverse strategie.
In sintesi: l’obiettivo è guidare contribuente e professionista attraverso le fasi successive alla notifica di un avviso di accertamento IRPEF, dalla valutazione iniziale dell’atto fino alla eventuale definizione amministrativa o giudiziale della pretesa fiscale, evidenziando gli strumenti di tutela disponibili e i recenti sviluppi normativi (come l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale dal 2024 e la riforma del processo tributario 2023).
(Nota: tratteremo principalmente l’IRPEF – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – e i relativi accertamenti su persone fisiche, incluse le ditte individuali e i soci di società di persone, con cenni alle differenze rispetto alle società di capitali quando utile. Ci concentreremo sul contenzioso tributario e gli aspetti amministrativi dell’accertamento, senza addentrarci nei profili penali se non per segnalare le soglie rilevanti.)
Cos’è un avviso di accertamento IRPEF
Un avviso di accertamento è l’atto impositivo con cui l’Amministrazione finanziaria contesta formalmente ad un contribuente maggiori imposte dovute, a seguito di controlli sulle sue dichiarazioni o attività fiscali. È previsto dall’art. 42 del DPR 600/1973, che lo definisce come l’atto attraverso il quale il contribuente viene “avvisato” di irregolarità fiscali o inadempimenti riscontrati.
In pratica, l’avviso di accertamento rettifica la dichiarazione dei redditi del contribuente (se presentata) oppure accerta d’ufficio il reddito imponibile (in caso di omessa dichiarazione), quantificando le imposte evase e irrogando le relative sanzioni amministrative tributarie. Viene emesso dall’ufficio competente (Agenzia Entrate – Direzione Provinciale/Regionale) e deve essere motivato: deve cioè indicare i presupposti di fatto (es. redditi non dichiarati, errori, elementi scoperti in verifica) e le ragioni giuridiche alla base della pretesa. Inoltre, se l’atto fa riferimento per la motivazione a documenti non conosciuti dal contribuente (es. un PVC – Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza), tali documenti devono essere allegati all’avviso o comunque messi a disposizione, a pena di nullità. L’atto indica anche l’ufficio emittente e il nome del responsabile del procedimento, come richiesto dallo Statuto del Contribuente – va però precisato che secondo la Cassazione la mancata indicazione del responsabile non comporta nullità dell’avviso di accertamento, a differenza di quanto previsto per le cartelle esattoriali.
Dal 2011 in poi, l’avviso di accertamento ha assunto anche natura esecutiva: ciò significa che, decorso il termine per fare ricorso, esso vale direttamente come titolo per la riscossione coattiva (senza necessità di una cartella di pagamento successiva). In sostanza, l’avviso di accertamento oggi è un atto impo-esattivo: contiene sia la determinazione del tributo dovuto sia l’intimazione di pagamento entro un termine, trascorso il quale si procede all’esecuzione. Questa caratteristica lo distingue nettamente dalle più semplici comunicazioni di irregolarità (cd. avvisi bonari ex art. 36-bis DPR 600/73), che invece non sono atti impugnabili né esecutivi, ma semplici inviti a pagamento di piccole differenze – se non vi si ottempera, il loro esito sarà l’iscrizione a ruolo e una cartella esattoriale, non un avviso di accertamento.
Riassumendo, l’avviso di accertamento IRPEF è il principale strumento attraverso cui il Fisco rettifica la posizione fiscale di un contribuente persona fisica, quando ritiene che questi abbia versato meno imposte del dovuto in uno o più periodi d’imposta. È un atto autonomamente impugnabile in giustizia tributaria (espressamente elencato nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992) e dà avvio, se non definito bonariamente, a un contendibile tributario che può svolgersi nelle apposite Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie).
Differenza tra avviso di accertamento e avviso bonario
È importante non confondere l’avviso di accertamento con altri atti del Fisco. In particolare: le comunicazioni di irregolarità o “avvisi bonari” inviati dopo controlli automatici (ex art. 36-bis DPR 600/1973 o 54-bis DPR 633/1972) non sono avvisi di accertamento. Si tratta di semplici comunicazioni di errore formale o versamento carente, con invito a pagare la differenza (di solito con sanzione ridotta al 10%). Se il contribuente non paga l’avviso bonario entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione a ruolo e alla notifica di una cartella di pagamento, ma non viene emesso un avviso di accertamento in quella sede. L’avviso di accertamento, invece, consegue tipicamente a verifiche più approfondite (ispezioni fiscali, controlli incrociati, indagini finanziarie, segnalazioni, ecc.) e arriva direttamente con le sanzioni piene previste (es. 90% dell’imposta evasa per dichiarazione infedele). Dunque: se ricevete una comunicazione ex 36-bis per piccoli errori e la ignorate, arriverà una cartella, non un avviso di accertamento; viceversa, se siete stati oggetto di una verifica fiscale (es. PVC della Guardia di Finanza) e non avete definito nulla, è probabile che dopo 60 giorni vi venga notificato un avviso di accertamento formale.
Normativa di riferimento (base giuridica)
L’istituto dell’accertamento tributario e i poteri-doveri del Fisco in materia di IRPEF trovano fondamento in diverse fonti normative. Ecco le principali norme di riferimento (aggiornate al 2025) che disciplinano l’avviso di accertamento e il successivo contenzioso:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni sull’accertamento delle imposte sui redditi: articoli 37-43. In particolare l’art. 42 D.P.R. 600/73 regola forma, contenuto e sottoscrizione dell’avviso di accertamento (obbligo di motivazione, firma del capo ufficio o delegato, indicazione del responsabile, ecc.), mentre l’art. 43 fissa i termini di decadenza per la notifica degli accertamenti. (Si veda più avanti la sezione sui “Termini di decadenza” per il dettaglio.)
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (e D.Lgs. nn. 472 e 473/1997) – Sanzioni tributarie: disciplina le sanzioni amministrative applicabili in caso di omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, omessi versamenti, ecc. Tali sanzioni vengono normalmente irrogate contestualmente all’imposta nell’avviso di accertamento. Ad esempio, per dichiarazione infedele l’art. 1 D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta evasa; per omessa dichiarazione la sanzione va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (minimo €250). Questi range sanzionatori sono di regola indicati nell’atto.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente: sancisce principi generali di garanzia. In particolare l’art. 7 Statuto impone la motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria (“indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche”) e l’allegazione degli atti richiamati non conosciuti dal contribuente. Lo Statuto prevede inoltre all’art. 7 che l’atto indichi l’ufficio competente e il responsabile del procedimento; all’art. 12, c.7 introduce il diritto al contraddittorio endoprocedimentale al termine delle verifiche fiscali (cioè il contribuente ha 60 giorni per memorie prima che l’ufficio emetta accertamenti basati su PVC) e altre importanti tutele (come il divieto, per alcune materie, di notificare avvisi nel mese di agosto). Dal 18 gennaio 2024, con l’attuazione della delega fiscale 2023, è stato inserito nello Statuto anche l’art. 6-bis che generalizza il diritto al contraddittorio preventivo per tutti gli atti impugnabili, a pena di nullità, salvo eccezioni per accertamenti automatizzati o casi di particolare urgenza. (Vedi paragrafo dedicato al contraddittorio più avanti.)
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Disciplina gli strumenti deflativi del contenzioso, ovvero le procedure di definizione agevolata degli accertamenti. In particolare: gli artt. 2–15 regolano l’accertamento con adesione (concordato con l’ufficio) e l’art. 15 la acquiescenza agli accertamenti. Questo decreto stabilisce i benefici sulle sanzioni in caso di definizione: adesione (sanzioni ridotte a 1/3 del minimo) e acquiescenza (sanzioni ridotte a 1/3 di quelle irrogate). Prevede inoltre le modalità e tempi delle istanze di adesione e il meccanismo di sospensione dei termini processuali (art. 6 D.Lgs. 218/97).
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Norme sul processo tributario (aggiornato da riforme successive, tra cui D.Lgs. 156/2015 e da ultimo la L. 130/2022 con D.Lgs. 119/2022 e D.Lgs. 149/2022). Questo decreto elenca all’art. 19 gli atti impugnabili (incluso espressamente l’avviso di accertamento) e disciplina le fasi del ricorso tributario in primo e secondo grado, nonché gli istituti di sospensione giudiziale dell’atto impugnato (art. 47) e di conciliazione giudiziale (art. 48). Le riforme entrate in vigore nel 2023 hanno apportato novità significative: è stato abrogato l’obbligo del reclamo/mediazione per le liti di valore fino a €50.000 (per i ricorsi notificati dal 2024); è stato introdotto il giudice monocratico per le cause di modico valore (fino a €3.000); ed è stata ammessa in via sperimentale la prova testimoniale in forma scritta nel processo tributario (prima totalmente vietata). Queste modifiche mirano a rendere il contenzioso più efficiente e giusto.
- Altre norme: numerose altre disposizioni possono rilevare in casi particolari. Ad esempio: l’art. 32 D.P.R. 600/1973 sulle indagini finanziarie (presunzioni legali relative su movimenti bancari non giustificati); l’art. 38 DPR 600/73 sul redditometro (accertamento sintetico basato sul tenore di vita); l’art. 10-bis L. 212/2000 sull’abuso del diritto (utilizzabile dall’ufficio per contestare operazioni elusive); l’art. 2495 c.c. e art. 28 D.Lgs. 175/2014 sulla notifica di accertamenti a società cessate e responsabilità di soci e liquidatori; l’art. 36 D.P.R. 602/1973 sulla responsabilità di amministratori e soci per imposte societarie in caso di società estinte; ecc. Non ultime, le norme penali tributarie (D.Lgs. 74/2000) che prevedono soglie oltre le quali le violazioni fiscali costituiscono reato – ad esempio, dichiarazione infedele oltre €150.000 di imposta evasa. Queste norme penali non incidono direttamente sull’accertamento (che segue il suo corso), ma comportano possibili implicazioni parallele (denunce, indagini GdF, ecc., v. FAQ).
Quando e perché viene emesso un avviso di accertamento IRPEF
Presupposti sostanziali dell’accertamento
L’avviso di accertamento IRPEF viene emesso al termine di un processo di controllo da parte del Fisco, quando emerge una difformità tra il dichiarato e il dovuto in termini di imposta. In altre parole, l’ufficio delle Entrate notifica l’atto dopo aver riscontrato che per un determinato periodo d’imposta il contribuente ha versato meno IRPEF di quanto dovuto, oppure ha violato obblighi fiscali (come presentare la dichiarazione dei redditi). Le situazioni più tipiche che danno luogo ad accertamento IRPEF sono:
- Omissione della dichiarazione dei redditi: se il contribuente non presenta la dichiarazione annuale (pur essendovi obbligato), l’Agenzia può procedere ad accertare d’ufficio i redditi, in base a dati e presunzioni disponibili. In caso di dichiarazione omessa, la legge prevede sanzioni aggravate (dal 120% al 240% dell’imposta evasa) e termini di accertamento più lunghi (fino al 7º anno, come vedremo). Un avviso per omessa dichiarazione in genere “ricostruisce” l’intero reddito presunto dell’anno non dichiarato, applicando l’aliquota IRPEF dovuta e la sanzione edittale minima elevata (120%).
- Dichiarazione infedele: il contribuente ha presentato la dichiarazione, ma ha sottostimato il reddito o indicato indebite detrazioni/deduzioni, pagando meno imposte. Esempi comuni: redditi non dichiarati (compensi “in nero”, affitti non dichiarati, plusvalenze occultate), oppure costi non deducibili indicati per abbattere il reddito (spese non inerenti, fatture false, ecc.). In questi casi l’ufficio effettua un accertamento in rettifica: ricalcola il reddito imponibile aggiungendo quanto scoperto e riliquida IRPEF e addizionali. Tipicamente si basa su attività come verifiche della Guardia di Finanza (PVC), controlli incrociati con banche dati, segnalazioni di anomalie (ad es. studio di settore/ISA fortemente incoerente), o indagini finanziarie sui conti correnti (l’ufficio presuppone che movimenti bancari non giustificati siano redditi evasi, ex art. 32 DPR 600/73).
- Errori formali o di calcolo che però hanno comportato minor imposta versata: es. mancata applicazione di una norma che aumenta l’imponibile, errata determinazione di acconti, ecc. Questi casi minori, se rilevati in sede di controllo formale, di solito danno luogo a un avviso bonario. Ma se l’errore emerge in altri modi (es. verifica mirata), potrebbe comunque generare un avviso di accertamento (con sanzione per infedele). Un esempio è il disconoscimento di una detrazione fiscale ritenuta indebita: l’ufficio contesta l’utilizzo indebito di detrazioni/crediti d’imposta, aumentando l’IRPEF dovuta.
- Accertamento sintetico del reddito (“redditometro”): l’ufficio, in base alle spese sostenute e al tenore di vita del contribuente (e della famiglia), ricostruisce indirettamente il reddito presunto e, se questo risulta significativamente superiore a quello dichiarato, emette avviso di accertamento per redditi in parte non dichiarati. Ad esempio, se Tizio dichiara 20.000 € ma possiede beni e sostiene spese incompatibili con meno di 100.000 € annui, il Fisco può presumere un maggior reddito. (Va osservato che l’accertamento sintetico prevede comunque la previa instaurazione del contraddittorio col contribuente, il quale può giustificare le spese con redditi esenti, risparmi, ecc., prima dell’avviso).
- Altri motivi: esistono altre ipotesi come il recupero di crediti d’imposta indebitamente fruiti, la rettifica di minusvalenze o detrazioni (in campo IRPEF meno frequenti, più tipiche per imprese in ambito IRES), oppure accertamenti legati a norme antielusive/abuso del diritto (quando il contribuente ha usufruito di vantaggi fiscali tramite costruzioni artificiose, poi contestate ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto). Anche il caso di attività estere non dichiarate (quadro RW) comporta accertamenti particolari, con sanzioni specifiche e termini raddoppiati (si presume un reddito derivante da quegli asset non monitorati).
In tutte queste situazioni, l’avviso di accertamento formalizza l’esito di un’indagine già conclusa. L’atto viene emesso quando l’ufficio ha raccolto elementi ritenuti sufficienti a fondare la pretesa tributaria. Va sottolineato che, benché “definitivo” nelle conclusioni dell’Amministrazione, l’accertamento rimane contestabile dal contribuente in sede amministrativa (tramite adesione) o contenziosa (ricorso) – su ogni avviso è infatti esplicitato che può essere impugnato entro 60 giorni presso la Commissione/Corte Tributaria competente.
Tempistica di emissione e termini di decadenza
La legge impone all’Amministrazione finanziaria di notificare gli avvisi di accertamento entro termini perentori, decorso i quali l’azione impositiva decade (diviene vietata). Ciò risponde ad un principio di certezza del diritto: il contribuente, una volta trascorso un certo lasso di tempo dalla dichiarazione, deve poter confidare che il periodo d’imposta sia “chiuso” e non soggetto a ulteriori accertamenti. I termini vigenti (dopo le modifiche legislative del 2016) sono i seguenti:
- Dichiarazione validamente presentata: l’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi 2019 (anno d’imposta 2018, presentata nel 2019), il termine è il 31 dicembre 2024. Se la dichiarazione è stata presentata nei termini, qualsiasi avviso notificato oltre il 5° anno è nullo per decadenza.
- Dichiarazione omessa (o nulla): in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Ad esempio, omessa dichiarazione dei redditi 2018 (dove il termine ordinario di presentazione era nel 2019) – l’accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre 2025. Anche qui, decorso tale termine l’atto è decaduto. (La stessa finestra settennale si applica se la dichiarazione è nulla, ad es. perché priva di firma o presentata tramite un canale non valido: viene equiparata all’omissione).
- Termini per IVA e altre imposte: va notato che per le imposte sui redditi e per l’IVA oggi valgono termini allineati (5 e 7 anni), mentre per i tributi locali come IMU restano i 5 anni dal fatto imponibile (come indicato dall’art. 1 c.161 L. 296/2006). Nel caso di IRAP e ritenute, essendo collegate a dichiarazioni annuali, si applicano anch’esse i termini di 5/7 anni.
- Eccezioni: la normativa prevede alcune estensioni straordinarie dei termini in specifiche situazioni:
- Per le attività finanziarie detenute all’estero non dichiarate nel quadro RW, opera un raddoppio dei termini (introdotto dal D.L. 78/2009): 10 anni se il contribuente ha presentato la dichiarazione (anziché 5) e 14 anni se omessa. Questo riguarda però il monitoraggio fiscale e le relative sanzioni (spesso contestate con atto a sé).
- In passato esisteva il cosiddetto raddoppio dei termini in caso di violazioni fiscali penalmente rilevanti (art. 43-bis DPR 600/73, ora abrogato). Dal 2016 tale raddoppio è stato di fatto eliminato per i nuovi accertamenti. Oggi, se emergono reati tributari, l’ufficio deve comunque notificare l’atto entro i termini ordinari (5 o 7 anni), salvo aver presentato la denuncia penale entro detta scadenza (in tal caso l’azione penale segue il suo corso, ma l’accertamento fiscale non è prorogato oltre i termini ordinari stessi – diversamente da quanto accadeva in passato).
- Proroghe per eventi eccezionali: ad esempio, a causa dell’emergenza COVID-19, i termini di decadenza al 31/12/2020 sono stati prorogati al 28/02/2022 (per gli accertamenti sull’anno d’imposta 2015). Analogamente, quelli al 31/12/2021 furono prorogati al 31/03/2023 (per l’anno 2016). Tali proroghe straordinarie, previste dal DL 34/2020 e DL 41/2021, hanno esteso eccezionalmente i tempi del Fisco, ma al 2025 i loro effetti sono ormai esauriti. È comunque utile verificare se l’annualità oggetto di accertamento rientri in qualche finestra di proroga normativa.
Tabella riepilogativa – Termini di decadenza (imposte sui redditi)
| Anno d’imposta | Dichiarazione presentata entro | Notifica avviso entro | Se dichiarazione omessa, entro |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 31/12/2023 (termine ormai scaduto) | 31/12/2024 (scaduto) |
| 2018 | 2019 | 31/12/2024 (in scadenza) | 31/12/2025 |
| 2019 | 2020 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| 2020 | 2021 | 31/12/2026 | 31/12/2027 |
| 2021 | 2022 | 31/12/2027 | 31/12/2028 |
| 2022 | 2023 | 31/12/2028 | 31/12/2029 |
| 2023 | 2024 | 31/12/2029 | 31/12/2030 |
| 2024 | 2025 | 31/12/2030 | 31/12/2031 |
(Note: per l’anno 2015 il termine ordinario 31/12/2020 è stato prorogato al 26/03/2022 – ciò ha portato alcuni accertamenti 2015 a essere notificati fino a febbraio 2022. Ad agosto 2025 comunque tali annualità pregresse sono chiuse. I termini indicati sopra sono quelli a regime attuale, introdotti dalla L. 208/2015 per periodi d’imposta dal 2016 in poi.)
Se un avviso di accertamento IRPEF viene notificato oltre i termini di decadenza sopra indicati, il contribuente potrà eccepirlo come motivo di nullità in sede di ricorso, ottenendo l’annullamento dell’atto. È una delle prime verifiche da compiere quando si riceve un avviso (vedi oltre “Cosa fare appena ricevuto l’avviso”).
Coordinamento con termini penali
È utile precisare la relazione tra termini di accertamento e procedimento penale. Attualmente, l’obbligo di denuncia per reati tributari (es. dichiarazione infedele > €150.000 imposta evasa, omessa dichiarazione > €50.000 imposta, utilizzo fatture false, ecc.) non estende i termini di decadenza fiscale di per sé. L’ufficio, se riscontra un reato, deve trasmettere una notitia criminis alla Procura (art. 331 c.p.p.), ma ciò non gli concede più tempo per l’accertamento salvo presentare la denuncia entro la scadenza ordinaria (condizione che evitava la decadenza per gli anni fino al 2015). Dal 2016 in poi, eliminato il vecchio “raddoppio automatico”, eventuali ritardi non sono consentiti: l’atto emesso fuori termine resta nullo anche se vi è un processo penale in corso. In caso di reato, dunque, spesso il Fisco notifica l’avviso entro i termini normali e parallelamente la questione penale segue il suo corso (si veda FAQ sul coordinamento con indagini GdF/Procura).
Contenuto dell’avviso di accertamento e controlli da effettuare
L’avviso di accertamento è soggetto a precisi requisiti formali e di motivazione, la cui mancanza può talora inficiarne la validità. Quando si riceve l’atto, è consigliabile esaminarlo attentamente in ogni sua parte. Ecco gli elementi essenziali che un avviso di accertamento IRPEF deve contenere (e cosa verificare al riguardo):
- Intestazione e riferimenti dell’atto: l’avviso indica l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che lo ha emesso (Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale del contribuente) e il numero di protocollo. Deve inoltre riportare il nome del responsabile del procedimento (ex art. 7 L.212/2000) e gli estremi dell’eventuale atto di delega alla firma se non è sottoscritto dal capo ufficio. Verifica: che l’atto sia effettivamente emanato dall’ufficio competente e sottoscritto da un dirigente o funzionario delegato. La mancanza di firma è causa di nullità insanabile (Cass. SS.UU. 22810/2015). La mancata indicazione del responsabile, invece, come detto non comporta nullità, ma è un’irregolarità da segnalare.
- Anagrafica del contribuente e annualità accertata: sono indicati i dati identificativi del destinatario (nome, CF/P.IVA, indirizzo) e l’anno d’imposta oggetto di accertamento (es. “periodo d’imposta 2018”). Verifica: che i dati siano corretti e che l’avviso riguardi effettivamente un periodo di vostra competenza. Errori materiali sui dati anagrafici non invalidano l’atto se non vi è incertezza sul destinatario.
- Imposte e basi imponibili contestate: l’atto elenca gli importi di reddito non dichiarato accertati o le variazioni apportate, distinguendo per tipologia di reddito (lavoro autonomo, d’impresa, fondiario, etc.) e calcola le maggiori imposte dovute (IRPEF ed eventuale addizionali regionali/comunali). Se pertinente, include anche recuperi di IVA o IRAP (in tal caso l’atto funge da accertamento anche per quelle imposte). Verifica: controllare la quantificazione: quali redditi aggiuntivi sono stati imputati e con quali criteri? Se ad esempio l’avviso deriva da un PVC, i maggiori ricavi o redditi dovrebbero corrispondere a quelli indicati nel PVC. Verificate che non vi siano errori di calcolo nell’imposta.
- Sanzioni applicate: l’avviso specifica le sanzioni amministrative irrogate, generalmente in misura percentuale sull’imposta dovuta. Ad esempio, per infedele dichiarazione vedrete indicata una sanzione pari al 90% (o altro valore) della maggiore IRPEF accertata. È prassi degli uffici applicare il minimo edittale previsto dalla legge (se non vi sono aggravanti). Verifica: la sanzione corrisponde al minimo di legge? (In molti casi sì: es. 90% per infedele, 120% per omessa). Se l’ufficio ha applicato una percentuale superiore, dovrebbe esservi spiegazione (aggravanti per importi elevati, recidiva, ecc.). In ogni caso, occorre sapere che tramite acquiescenza o adesione queste sanzioni possono essere ridotte sensibilmente (vedi sezioni dedicate).
- Motivazione: questo è il cuore dell’atto. La motivazione deve spiegare in modo chiaro cosa viene contestato e perché. Deve indicare i fatti accertati (ad es. “si sono riscontrati ricavi non dichiarati per €100.000 emersi da movimenti bancari non giustificati”) e le norme violate o applicate (ad es. “violazione dell’art. 2 co. 2 D.Lgs. 74/2000 – dichiarazione infedele – con applicazione art. 1 D.Lgs. 471/97 sanzione 90%”). La motivazione può essere “per relationem”, cioè rimandare ad altri atti (come il PVC): in tal caso tali documenti devono essere allegati o già conosciuti dal contribuente. Verifica: leggere attentamente la parte motiva. Cercare incongruenze o lacune: ad esempio, se l’atto alternativamente ipotizza due tesi diverse (circostanze incompatibili), la Cassazione lo considera nullo per difetto di motivazione determinata. Cass. 13620/2023 ha annullato un avviso la cui motivazione presentava ragioni tra loro incompatibili, generando incertezza. Quindi motivazioni contraddittorie sono un vizio grave. Altro esempio: se l’avviso si fonda su un PVC o su un rapporto non allegato né previamente ricevuto, ciò viola l’art. 7 Statuto e può comportare nullità, a meno che il Fisco dimostri che il contribuente ne era comunque a conoscenza. È bene dunque controllare che tutti i documenti citati siano stati effettivamente allegati (o notificati in precedenza). Appena ricevuto l’avviso, ogni vizio di motivazione o allegazione deve essere individuato e poi fatto valere nel primo ricorso, altrimenti si rischia di precluderlo (queste eccezioni vanno sollevate subito).
- Indicazione dei rimedi e delle modalità di pagamento: l’avviso di accertamento riporta in calce le “istruzioni” per il contribuente: il termine di 60 giorni per presentare ricorso (con indicazione dell’organo competente, es. “Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di …”); avverte che in caso di ricorso occorre versare provvisoriamente un importo pari ad 1/3 delle imposte contestate entro lo stesso termine; e informa della possibilità di definire l’accertamento con acquiescenza (sanzioni ridotte a 1/3 se paghi entro 60gg) o di richiedere l’accertamento con adesione (con sospensione di 90gg dei termini). Queste indicazioni, pur non tutte espressamente richieste da norme a pena di nullità, sono generalmente incluse per trasparenza e per favorire la definizione bonaria. Verifica: controllare che l’atto indichi chiaramente entro quando pagare o ricorrere, e che siano allegati i modelli di pagamento (tipicamente mod. F24 già precompilati). La mancanza di avvertenze sul termine di impugnazione o sul pagamento del “1/3 provvisorio” non invalida l’atto (sono informazioni di cortesia, ormai standard), però in casi remoti di omissione potrebbe fornire argomenti per chiedere la remissione in termini se si cade in errore. In ogni caso, l’assenza di modelli F24 non incide sulla legittimità.
Oltre a quanto sopra, va ricordato che l’avviso deve essere notificato secondo le forme di legge (notifica a mezzo PEC, posta raccomandata o messo notificatore): la regolarità della notifica è anch’essa da verificare (si veda il prossimo paragrafo).
Controllo iniziale dell’atto – Checklist per il contribuente: appena si riceve un avviso di accertamento, è opportuno controllare: 1) la data di notifica (per calcolare i 60 giorni); 2) l’annualità accertata e la tempestività rispetto ai termini di decadenza (v. tabella sopra); 3) la completezza formale (firma dell’ufficio, responsabile indicato, riferimenti chiari); 4) la motivazione, verificando eventuali vizi logici o mancanza di allegati fondamentali; 5) l’esattezza dei calcoli (imposte, sanzioni, interessi) e la corrispondenza con gli esiti delle verifiche subite; 6) le istruzioni sul da farsi (termini per ricorso/pagamento, opportunità di adesione). Questo screening iniziale permette di individuare subito possibili motivi di ricorso (es. annullamento per difetti formali) e anche di orientare la decisione successiva (“pago o contesto?”).
Notifica dell’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, cioè portato formalmente a sua conoscenza, seguendo le regole previste per gli atti fiscali (che rimandano spesso alle norme sulle notifiche degli atti amministrativi e del CPC). In anni recenti, la notifica via PEC (Posta Elettronica Certificata) ha assunto un ruolo primario. Ecco le modalità e regole principali:
- Notifica via PEC: per i contribuenti dotati di un indirizzo PEC ufficiale (in particolare, tutti i soggetti con obbligo di PEC: società, imprese individuali, professionisti iscritti ad albi, nonché dal 1º luglio 2022 anche i cittadini che abbiano attivato un domicilio digitale), l’Agenzia delle Entrate esegue la notifica preferibilmente via PEC. L’atto viene firmato digitalmente e inviato all’indirizzo PEC risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi (INI-PEC) o da altre fonti ufficiali. La PEC ha valore legale pari alla raccomandata A/R: la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC attestante l’avvenuto recapito nella casella equivale alla relata di notifica. Cosa significa per il contribuente: la notifica PEC si considera perfezionata nel momento in cui il messaggio viene consegnato alla casella PEC (indipendentemente dalla lettura effettiva). Dunque non basta non aprire la PEC: l’avviso si dà per notificato, ad esempio, alle ore e minuti indicati nella ricevuta di avvenuta consegna. In una FAQ recente, l’Agenzia ha precisato che il mancato controllo della casella PEC non è scusante: se l’indirizzo PEC è valido ma “non letto” e l’atto va in quota di casella, la notifica è comunque valida. Pertanto è fondamentale monitorare la propria PEC regolarmente o delegarne la gestione, per non perdere atti importanti. (Un messaggio PEC non letto rimane comunque nel server e, trascorsi 30 giorni, i gestori PEC potrebbero anche cancellarlo se la casella è piena: altra ragione per controllare spesso ed eventualmente scaricare le ricevute).
- Notifica a mezzo posta raccomandata: per i contribuenti privati (persone fisiche non imprenditori o comunque sprovvisti di PEC), la notifica avviene normalmente per raccomandata con avviso di ricevimento, tramite servizio postale. L’atto è inviato in busta chiusa dall’ufficio o da un messo notificatore incaricato, e si perfeziona con la consegna al destinatario (o a persona abilitata: familiare convivente, portiere, ecc., in base all’art. 139 c.p.c.) oppure, se il destinatario è assente, tramite il deposito dell’atto presso l’ufficio postale e il successivo invio della comunicazione di giacenza (cd. CAD). Se il contribuente non ritira l’atto entro i termini di giacenza (10 giorni), la notifica si considera comunque effettuata per compiuta giacenza – in tal caso la legge fissa il perfezionamento al decorrere di 10 giorni dalla data di deposito (art. 8 L. 890/1982). Implicazioni: anche se il contribuente non ritira la raccomandata, dopo 10 giorni l’avviso è notificato a tutti gli effetti (la “compiuta giacenza” ha valore di notifica presunta). Trascorsi i 10 giorni, inizia a decorrere il termine di 60 giorni per il ricorso, anche se l’atto non è materialmente nelle mani del destinatario. Dunque ignorare gli avvisi di giacenza è molto pericoloso: si rischia di far passare i termini di impugnazione senza nemmeno vedere l’atto. Per questo è buona norma verificare la propria posta e ritirare tempestivamente eventuali raccomandate dell’Agenzia Entrate.
- Notifica tramite messo notificatore o agente: l’Agenzia delle Entrate può avvalersi di messi comunali, messi dell’ente impositore o ufficiali della riscossione per la notifica diretta a mano. Questa modalità è usata più raramente (ad es. in casi di particolare urgenza, o contestualmente ad accessi sul posto). Il messo si reca al domicilio fiscale e segue le regole degli artt. 137 ss. c.p.c.: se trova il destinatario, gli consegna copia; altrimenti, può consegnare a familiare convivente/idoneo o, in mancanza, depositare copia in Comune (affissione di avviso nella casa comunale) in caso di irreperibilità assoluta. Implicazioni: la notifica a mano è immediata se andata a buon fine (data consegna); se depositata in Comune, scatta la compiuta giacenza dopo 20 giorni dal deposito ex art. 140 c.p.c., con invio di raccomandata informativa. Anche qui, è importante tenere aggiornato il domicilio fiscale e il campanello, per evitare che il messo non trovi nessuno o non individui l’abitazione.
Riscontri pratici: se avete una PEC attiva, è molto probabile che l’avviso arrivi tramite quella. Verificate dunque la data e ora della consegna PEC (contenuta nel file .eml di ricevuta) per calcolare i termini di ricorso. Se l’avviso è arrivato per posta, controllate la data di ricezione firmata sull’avviso di ricevimento (o la data di compiuta giacenza se applicabile). Queste date sono fondamentali: da esse decorrono i 60 giorni per eventuale impugnazione.
Vizi di notifica: errori nella notifica possono talvolta dare appigli difensivi, ma la materia è complessa. Ad esempio, se la PEC è stata inviata ad un indirizzo non previsto dalla legge (errato o non risultante dagli elenchi), la notifica potrebbe essere nulla. Tuttavia, se il contribuente ha comunque avuto conoscenza dell’atto e ha potuto difendersi, spesso i giudici considerano sanato il vizio (principio di “raggiungimento dello scopo” ex art. 156 c.p.c.). Nel dubbio, è consigliabile in ogni caso reagire nel merito entro 60 giorni, sollevando anche l’eccezione di nullità della notifica: sarà la Commissione a valutarla. Un caso tipico è la notifica PEC alle società: se viene inviata alla PEC risultante dal Registro Imprese, essa è valida anche se la società non la legge più (PEC inattiva ma non ufficialmente revocata). Diverso sarebbe se la PEC fosse scaduta e cancellata: lì potrebbe emergere un vizio. Per le persone fisiche, errori di indirizzo postale (es. atto inviato a vecchio indirizzo non più domicilio fiscale) possono essere eccepiti, ma a volte l’AdE è autorizzata a notificare all’ultimo domicilio conosciuto fino a variazione comunicata. Insomma, contestare le notifiche richiede finezza giuridica e fortuna nelle circostanze: è un tema che va affrontato con l’assistenza di un legale, valutando costi/benefici, poiché l’ente spesso ripete la notifica se annullata solo per vizio formale.
Cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento – prime decisioni
Dal punto di vista del contribuente, l’arrivo di un avviso di accertamento impone di decidere rapidamente il da farsi. Il termine di 60 giorni decorre inesorabilmente e, in assenza di iniziative, l’atto diverrà definitivo e riscuotibile. Le opzioni principali sono due:
- Accettare l’accertamento e pagare (eventualmente avvalendosi delle definizioni agevolate disponibili, come l’acquiescenza o l’adesione, per ridurre sanzioni e rateizzare).
- Contestare l’accertamento, attivando il contenzioso tributario con un ricorso al giudice entro i termini, eventualmente preceduto da tentativi di soluzione bonaria (adesione, conciliazione).
Vediamo in dettaglio queste strade e i passi concreti per ciascuna, con i relativi pro e contro dal punto di vista del contribuente. È bene premettere che non esiste una risposta univoca valida per tutti: la scelta dipende dall’analisi del caso specifico (fondamento della pretesa fiscale, importi, disponibilità finanziaria, rischi di soccombenza, etc.). Di seguito forniremo criteri e strumenti per una decisione informata.
Opzione 1: Pagare (acquiescenza) o definire bonariamente l’accertamento
Se dopo attenta valutazione il contribuente ritiene fondata la pretesa (in tutto o in parte), o comunque preferisce evitare un contenzioso, può optare per il pagamento dell’avviso beneficiando delle riduzioni sanzionatorie previste per legge. Le modalità principali sono:
– Acquiescenza all’accertamento: consiste nel pagamento integrale di quanto richiesto (imposte, interessi e sanzioni) entro 60 giorni dalla notifica, rinunciando a impugnare l’atto e a presentare istanza di adesione. In tal caso, per legge le sanzioni vengono ridotte a 1/3 (un terzo) del loro importo. Ciò equivale a pagare solo il 33% delle sanzioni originarie e vedersi condonati i restanti due terzi. Esempio: se l’avviso includeva €30.000 di sanzioni, con acquiescenza ne pagherete €10.000. In formula, pagherete il 100% delle imposte e interessi e 33% circa delle sanzioni iniziali. Questo è un forte incentivo a definire subito per chi non intende fare ricorso. Per usufruire dell’acquiescenza occorre non aver presentato istanza di adesione e ovviamente non presentare ricorso. Il pagamento può essere fatto in un’unica soluzione oppure a rate (fino a 8 rate trimestrali, o 16 rate se l’importo supera €50.000, come da art. 15 D.Lgs. 218/97). Bisogna versare almeno la prima rata entro 60 giorni e comunicare all’ufficio l’avvenuto pagamento entro 10 giorni. Vantaggi: chiude subito la pendenza tributaria; riduce di molto le sanzioni (sconto ~67% su di esse); evita i costi e le incertezze di un ricorso; impedisce l’iscrizione a ruolo e ulteriori interessi di mora. Svantaggi/condizioni: richiede di accettare integralmente la pretesa (rinuncia a qualsiasi contestazione futura sul merito); necessita di liquidità sufficiente per pagare (quantomeno la prima rata) in tempi brevi; non è ammessa se nel frattempo si è presentata istanza di adesione o ricorso (quindi la decisione deve essere presa subito). Va anche ricordato che l’acquiescenza non è applicabile agli atti che contengono solo sanzioni (per quelli vi è la “definizione agevolata delle sanzioni” ex art. 16 D.Lgs. 472/97, diversa procedura).
– Accertamento con adesione: è una procedura di definizione concordata con l’ufficio accertatore (disciplinata dagli artt. 2–12 D.Lgs. 218/97) che consente di rideterminare con l’Agenzia la pretesa, trovando un accordo su imponibili e imposte. In pratica il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, può presentare istanza di adesione all’ufficio (anche semplicemente una lettera in cui chiede di essere convocato per tentare l’adesione). Ciò comporta un duplice effetto immediato: sospende automaticamente il termine per fare ricorso per ulteriori 90 giorni (dando quindi più tempo per negoziare senza perdere la facoltà di ricorrere) e sospende anche l’attività di riscossione da parte dell’Agenzia nel frattempo. L’ufficio fisserà un appuntamento (o più di uno) col contribuente o il suo difensore, durante il quale si discuteranno i rilievi. Se le parti trovano un accordo, verrà redatto un atto di adesione con le nuove somme dovute. Le sanzioni, in caso di adesione, vengono per legge ridotte a 1/3 del minimo edittale previsto per le violazioni accertate. Spesso ciò implica sanzioni ancora più basse di quelle per acquiescenza: ad esempio, se la violazione è dichiarazione infedele (minimo 90%), 1/3 del minimo è 30% dell’imposta. Può capitare che nell’avviso originale l’ufficio avesse già applicato il minimo 90%: in tal caso l’adesione porta la sanzione dal 90% al 30% dell’imposta, un notevole risparmio. Inoltre, in sede di adesione l’ufficio può anche riconoscere parzialmente le ragioni del contribuente – ad esempio riducendo il reddito accertato o eliminando alcuni rilievi: dunque anche la base imponibile contestata può diminuire. Pagamento: il contribuente versa le somme concordate (imposta, interessi e sanzioni ridotte) in unica soluzione o in rate trimestrali (anche qui, max 8 rate o 16 se importo > €50.000). La prima rata va pagata entro 20 giorni dalla firma dell’atto di adesione. Vantaggi: consente un dialogo costruttivo con l’ufficio in sede amministrativa, potendo portare documenti e argomenti senza la formalità del processo; evita il contenzioso se si raggiunge l’accordo; **riduce drasticamente le sanzioni (1/3 del minimo)】 – spesso ancor più dell’acquiescenza, come visto; permette la rateazione come l’acquiescenza; sospende i termini di ricorso di 90 gg (utile anche solo per guadagnare tempo di analisi, spesso si presenta l’adesione “in bianco” a tale scopo). Svantaggi/condizioni: richiede la disponibilità dell’ufficio a trattare – in genere l’Agenzia convoca e ascolta, ma non sempre concede forti riduzioni di imponibile a meno di evidenti errori; comporta comunque il pagamento (se non si paga decadono i benefici e l’ufficio iscrive a ruolo le somme originarie); allunga i tempi di definizione (può essere un pro se si cerca di spostare in avanti l’esborso, ma anche un contro se si vuole chiudere presto); non è impugnabile una volta perfezionato (firmare l’accertamento con adesione significa rinunciare al ricorso su quei rilievi). Da notare: se non si raggiunge l’accordo, il contribuente può comunque ricorrere entro i 60 + 90 giorni totali (senza nessuna preclusione, l’adesione non riuscita non aggrava la posizione). Recentemente (D.Lgs. 73/2022) è stato previsto che se l’avviso di accertamento è stato preceduto da contraddittorio obbligatorio già svolto, l’eventuale istanza di adesione sospende il termine di ricorso solo per 30 giorni (anziché 90). Quindi attenzione: per avvisi emessi dal 2024 dove l’ufficio vi ha già convocato prima (es. invito a comparire), la finestra aggiuntiva è più breve (istanza entro 15 gg e sospensione 30 gg).
– Altre definizioni deflattive: oltre alle due principali sopra, meritano menzione:
- La conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/92): qualora si presenti ricorso, è possibile comunque trovare un accordo in corso di causa con l’ufficio, con il beneficio di sanzioni ridotte al 40% del minimo se la conciliazione si perfeziona in primo grado, o al 50% in secondo grado. La conciliazione va formalizzata davanti al giudice tributario (su istanza di parte o su invito del giudice stesso) e comporta la cessazione della lite. Può convenire quando, emerso l’orientamento del giudice o nuovi elementi in giudizio, si preferisca chiudere pagando qualcosa ma con sanzioni ridotte e fine immediata della disputa. La useremo come opzione post-ricorso (vedi oltre).
- La definizione agevolata delle sole sanzioni: se l’avviso contiene esclusivamente sanzioni (atto di contestazione), è previsto che pagando entro 60gg si possano ridurre ad 1/3. Ma questo esula dagli avvisi IRPEF (che di solito contengono anche imposta).
- Eventuali “Pace fiscali” o sanatorie straordinarie: vanno verificate caso per caso. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) aveva previsto la definizione agevolata delle liti pendenti e la regolarizzazione degli avvisi bonari. Al momento (2025) non vi sono definizioni automatiche per avvisi di accertamento appena notificati, se non le procedure ordinarie sopra descritte. In passato c’è stata la “rottamazione delle cartelle” che però rileva dopo la fase di iscrizione a ruolo (quindi non per avvisi in corso di impugnazione). È sempre bene informarsi se la normativa vigente offre qualche definizione agevolata straordinaria (condoni, ecc.) al momento della scelta.
Confronto rapido: in generale, se il contribuente riconosce la fondatezza (o comunque decide di non litigare), conviene non aspettare passivamente ma utilizzare gli strumenti deflattivi per ottenere il massimo sconto sulle sanzioni. L’acquiescenza è indicata se si accetta totalmente l’atto e si dispone delle somme per pagare subito: sanzioni 1/3 originarie, nessuna incertezza ulteriore. L’adesione è utile se si hanno argomenti da far valere all’ufficio: c’è la chance di ridurre imponibili e imposte, oltre a sanzioni al 1/3 del minimo (quindi potenzialmente <1/3 originario). Inoltre dà più tempo (90gg) e possibilità di dialogo. Se però l’ufficio non concede nulla di sostanziale, l’adesione finisce per essere equivalente all’acquiescenza ma con un ritardo di qualche mese. In assenza di accordo, si potrà comunque fare ricorso (l’adesione “a vuoto” almeno ha preso tempo). Nota: non ci sono controindicazioni nel presentare istanza di adesione “per sicurezza” entro 60gg, anche se poi si deciderà di fare ricorso: la legge consente comunque di rinunciare all’adesione e ricorrere prima che scadano i 90gg, se si capisce che non si arriverà a intesa.
Opzione 2: Impugnare l’avviso (ricorso e processo tributario)
Se il contribuente non condivide (in tutto o in parte) le pretese dell’accertamento – ritenendole errate nei fatti o in diritto – ha il pieno diritto di contestarle presentando ricorso alla giustizia tributaria. Il ricorso apre un procedimento giurisdizionale volto ad ottenere l’annullamento (totale o parziale) dell’atto. Ecco gli aspetti salienti di questa opzione:
– Tempistiche e modalità del ricorso: il ricorso va notificato all’ente impositore entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (salvo sospensioni per adesione o periodo feriale). Come visto, se si è presentata istanza di adesione, il termine di 60gg è sospeso e riprende dopo (avendo dunque 60+90=150 gg totali, tranne eccezioni). Anche il mese di agosto sospende i termini processuali tributari: dal 1º al 31 agosto i termini sono fermi (art. 1 L. 742/1969), quindi se un termine cade in quel periodo, slitta in avanti di 31 giorni. Il ricorso va redatto per iscritto con indicazione dei motivi, sottoscritto dal difensore abilitato (o dalla parte stessa se valore della lite ≤ €3.000). Esso va notificato all’Agenzia delle Entrate (Direzione che ha emanato l’atto) tramite PEC (per via telematica) oppure via ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. Entro 30 giorni dalla notifica, il ricorrente deve poi costituirsi in giudizio depositando il ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria competente (di norma quella della provincia in cui ha sede l’ufficio). Oggi il processo tributario è telematico: la costituzione avviene con deposito sul portale SIGIT (processo tributario telematico).
– Difesa tecnica: se il valore della lite (importo dell’imposta contestata, al netto di sanzioni e interessi) supera €3.000, il contribuente deve farsi assistere da un difensore abilitato (tipicamente un avvocato tributarista o commercialista). Sotto €3.000 è ammessa l’autodifesa personale: la persona fisica può stare in giudizio da sé (le società invece, non avendo capacità di stare in proprio, devono comunque conferire procura ad un difensore). In pratica, per piccoli avvisi IRPEF fino a 3.000 € di imposta, un contribuente può presentare ricorso personalmente. Attenzione: €3.000 è il valore senza sanzioni; se ad esempio l’imposta in contestazione è €2.800 ma ci sono €2.500 di sanzioni, il valore lite è 2.800. Se invece l’avviso riguarda solo sanzioni, il valore è l’importo delle stesse. In ogni caso, vista la complessità della materia, anche nelle liti minori è spesso consigliabile almeno consultare un professionista. Le società di capitali devono sempre avvalersi di difensore e non possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, che è riservato alle sole persone fisiche a basso reddito.
– Effetti del ricorso sull’obbligo di pagamento: il fatto di proporre ricorso non sospende automaticamente la riscossione dell’atto. Per evitare che la presentazione del ricorso sia usata in modo dilatorio, la legge prevede che comunque, decorso il termine di 60 giorni, l’avviso diviene esecutivo. In particolare, se si fa ricorso, il contribuente è comunque tenuto a pagare provvisoriamente un importo pari al 1/3 delle imposte accertate (al netto di sanzioni e interessi) entro il medesimo termine di 60 giorni, a meno che ottenga una sospensione giudiziale. Questo pagamento “parziale” è detto importo provvisoriamente dovuto per effetto dell’impugnazione (art. 15 DPR 602/73 e art. 29 DL 78/2010). Significa che, impugnando l’atto, l’Agenzia può comunque riscuotere immediatamente un terzo del tributo controverso. Ad esempio, se l’avviso chiede €30.000 di imposte + sanzioni, col ricorso si dovrebbero versare intanto €10.000 (un terzo di 30k) più i relativi interessi legali. Se poi il contribuente vince la causa, avrà diritto al rimborso di quanto pagato con interessi. Se perde, l’importo già versato verrà imputato a quanto dovuto. In pratica, questo meccanismo garantisce allo Stato almeno una parte del gettito tempestivamente e serve a disincentivare ricorsi pretestuosi. Nota: se il contribuente non versa spontaneamente il 1/3, l’importo verrà comunque iscritto a ruolo e l’Agente della Riscossione emetterà una cartella di pagamento per recuperarlo. Da quel momento, si potrà eventualmente chiedere dilazione su tale cartella, ma con aggravio di interessi e compensi. È quindi consigliabile, qualora non si ottenga la sospensiva, pagare il terzo dovuto per evitare ulteriore mora. Alcuni contribuenti sperano di rateizzare il terzo direttamente, ma ciò formalmente non è previsto (il terzo va pagato entro 60gg in unica soluzione). Solo dopo che l’importo è affidato all’Agente si può ottenere un piano rate (ma con ritardo e costi). In conclusione: presentare ricorso comporta idealmente di dover mettere in conto il pagamento del 33% delle imposte contestate a breve termine, salvo vittoria immediata sulla sospensiva.
– Sospensione giudiziale (“sospensiva”): il contribuente ricorrente ha la facoltà di chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/92). Deve presentare un’istanza motivata (di solito inserita nel ricorso stesso) dimostrando grave e irreparabile danno che subirebbe dall’esecuzione dell’atto e la presenza di fondati motivi a sostegno del ricorso. In pratica, bisogna convincere il giudice che: a) pagare o subire riscossione per quelle somme creerebbe un pregiudizio serio (es. compromissione dell’attività, necessità di chiudere l’azienda o ipotecare la casa); b) il ricorso non è infondato (es. c’è un vizio evidente nell’atto). Se il giudice ritiene le condizioni sussistenti, concede la sospensione: l’atto non è esecutivo fino alla decisione di merito. In caso di sospensiva, il contribuente non deve versare il famoso 1/3 finché pende il giudizio di primo grado (o fino a revoca della sospensione). Nei fatti, le Corti concedono la sospensione se vedono effettivamente sia il periculum (rischio di danno grave, ad es. crisi di liquidità comprovata) sia un fumus di fondatezza del ricorso. Non è scontato ottenerla, ma tentare è doveroso in caso di importi elevati e difficoltà a pagare. La decisione sulla sospensione avviene di regola in tempi rapidi (30-60 giorni dalla richiesta). Se negata, il contribuente dovrà versare il terzo, altrimenti l’Agente potrà procedere. Importante: la sospensione può essere richiesta anche in secondo grado (appello) se il contribuente è soccombente in primo grado e ricorre in appello, per evitare l’esecuzione della sentenza di primo grado (che altrimenti legittima la riscossione di 2/3 delle imposte e delle sanzioni in attesa della Cassazione). Le soglie sono: dopo sentenza di primo grado sfavorevole, l’Agenzia può riscuotere fino a 2/3 dell’imposta e sanzioni per intero; dopo sentenza d’appello ancora sfavorevole, può riscuotere tutto, salvo poi restituire se si vince in Cassazione.
– Svolgimento del giudizio tributario: una volta presentato il ricorso (in primo grado), l’Agenzia delle Entrate si costituisce depositando controdeduzioni e il fascicolo con gli atti istruttori. Il processo può durare diversi mesi o anni a seconda della complessità e del carico di ruolo. Dal 2023, se il valore è ≤ €3.000 il giudizio in primo grado è affidato ad un giudice monocratico (un solo giudice); oltre tale soglia, decide un collegio di 3 giudici togati (le Commissioni miste con giudici onorari sono state soppresse dalla riforma). Il giudice esamina le prove documentali (nel processo tributario vige il principio documentale, la prova testimoniale è ammessa solo in casi limitati sperimentali) e alla fine decide con sentenza, che può accogliere il ricorso (annullando in toto l’atto o parzialmente – es. eliminando alcuni rilievi), oppure rigettarlo (confermando l’atto), o ancora dichiararlo inammissibile per vizi procedurali. La sentenza di primo grado è suscettibile di appello da parte soccombente, entro 60 giorni dalla notifica della stessa. L’appello va alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (ex Commissione Regionale). In secondo grado si ripete il rito, dinanzi a un collegio generalmente di 3 giudici (5 in casi eccezionali di particolare importanza). La sentenza d’appello è definitiva sui fatti: potrà essere impugnata in Cassazione solo per motivi di diritto (violazioni di legge o vizi di motivazione entro certi limiti). La Corte di Cassazione, a sezioni semplici o unite, è il terzo e ultimo grado: i suoi tempi sono molto lunghi e le statistiche di accoglimento del contribuente sono modeste, ma rimane l’ultima parola a livello di diritto (ad es. questioni interpretative che la Cassazione uniforma).
Durante questo iter, il contribuente dovrà valutare se e quando eventualmente transigere. Come anticipato, in qualsiasi stato del giudizio di merito (primo grado o appello) le parti possono chiudere la lite con una conciliazione: se trovano un accordo, ad esempio su un imponibile ridotto, lo formalizzano in udienza o per scritto, e la sanzione viene ridotta al 40% o 50% del minimo edittale a seconda del grado. La conciliazione è in sostanza simile all’adesione quanto a esito (importi concordati e sanzioni ridotte), ma avviene sotto l’egida del giudice. Con la riforma 2022-23 la conciliazione è incentivata come strumento deflattivo principale, tanto che il giudice stesso può farsi promotore di proposta conciliativa. Se la conciliazione si perfeziona, si estingue la causa.
– Costi del contenzioso: intraprendere un ricorso comporta alcuni costi. Oltre al suddetto eventuale esborso del “1/3 provvisorio”, c’è da considerare il compenso del difensore (che varia a seconda della complessità e del valore; spesso per contenziosi medio-grandi viene concordato a percentuale sul risparmio ottenuto). Inoltre c’è il contributo unificato tributario da versare all’atto della costituzione in giudizio: è una tassa da €30 a qualche centinaio di euro, modulata in base al valore della causa (es. €30 per lite fino a €2.582, €120 fino a €5.000, €250 fino a €25.000, €500 fino a €75.000, e così via). In caso di soccombenza, la Corte può condannare la parte perdente a rifondere le spese di lite alla controparte (onorari di avvocatura dell’ente, tipicamente liquidati qualche migliaio di euro). In passato le Commissioni spesso compensavano le spese, ma ora la tendenza è di applicare il principio di soccombenza. Dunque, chi fa ricorso senza valide ragioni rischia di pagare, oltre al debito, anche i costi legali della controparte. In casi estremi di liti temerarie, può persino essere inflitta una sanzione per abuso del processo (art. 15 D.Lgs. 546/92). All’opposto, se il contribuente vince totalmente, in teoria ha diritto al rimborso delle spese dal Fisco (anche se spesso, se vince su un vizio formale, la Corte compensa le spese).
– Esiti possibili: se il contenzioso viene affrontato fino in fondo, vi sono vari possibili esiti:
- Annullamento totale dell’avviso: il contribuente vince e nulla è dovuto (tranne eventuale rimborso se aveva versato il terzo, che l’Agenzia dovrà restituire con interessi).
- Annullamento parziale/accoglimento parziale: il giudice potrebbe ad esempio eliminare alcuni rilievi e confermarne altri. In tal caso l’imposta dovuta si riduce e anche le sanzioni decrescono proporzionalmente. Se ad esempio su 3 riprese ne cade una, le sanzioni relative a quella cadono del tutto.
- Rigetto del ricorso (conferma dell’atto): il contribuente perde e deve pagare tutto quanto richiesto nell’avviso, con aggiunta di interessi maturati durante la pendenza e spese legali se liquidate. Tuttavia, avendo eventualmente già versato 1/3 all’inizio, dovrà pagare il residuo (altri 2/3 imposte + sanzioni + interessi). L’Agenzia a quel punto iscriverà a ruolo la differenza. Se il rigetto avviene in primo grado, si può appellare (in tal caso il Fisco nel frattempo può riscuotere 2/3 imposte, come detto). Se avviene in appello, si può valutare ricorso in Cassazione.
In generale, prima di avventurarsi in causa occorre valutare le chance di successo. È bene consultarsi con un esperto per capire se esistono validi motivi di ricorso sul merito (es. il rilievo è infondato, vi sono prove contrarie) o sul procedimento (vizi formali, violazione di diritti – p.es. mancato contraddittorio, motivazione carente, ecc.).
Focus – Contraddittorio endoprocedimentale: un tema spesso sfruttabile in contenzioso è la mancata instaurazione del contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso. Fino al 2023 la giurisprudenza era altalenante: la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 24823/2015) aveva stabilito che, salvo specifiche previsioni di legge, non era obbligatorio per l’ufficio invitare il contribuente a un confronto prima di emettere accertamenti in materia di imposte “interne” (come IRPEF), a meno che il contribuente dimostrasse in giudizio uno specifico pregiudizio alla sua difesa dalla mancata attivazione del contraddittorio. Faceva eccezione l’IVA (imposta armonizzata UE) per cui la Corte UE e la Cassazione avevano riconosciuto un obbligo generale di contraddittorio pena nullità. Tuttavia, con la riforma 2023, come detto, il legislatore italiano ha introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio: l’art. 6-bis Statuto, in vigore da gennaio 2024, prescrive che “tutti gli atti impugnabili dinanzi alle giurisdizioni tributarie siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”, tranne per gli atti di controllo automatizzato/formale o di “pronta soluzione” individuati da apposito decreto MEF. In sostanza, dal 2024 gli uffici devono invitare il contribuente a presentare osservazioni prima di emettere un avviso di accertamento, salvo casi semplici (es. liquidazioni, errori aritmetici) o situazioni di urgenza (pericolo per la riscossione). Se ciò non avviene, l’atto sarà annullabile su ricorso. Questa è una novità di enorme rilievo. Già nel 2024 si apriranno contenziosi interpretativi su tale obbligo, ad esempio per capire quali atti rientrano tra quelli “automatizzati o di pronta liquidazione” esentati dal contraddittorio. Un decreto ministeriale del 24/4/2024 ha elencato in dettaglio tali atti (per lo più avvisi di liquidazione per tributi minori, atti derivanti da controlli incrociati banche dati, ecc.). In linea generale, se ricevete un avviso nel 2025 senza essere stati invitati dall’ufficio a fornire spiegazioni prima, ciò potrebbe costituire motivo di ricorso. Ad esempio, un accertamento “da tavolino” su IRPEF 2022 senza contraddittorio potrebbe violare l’art. 6-bis Statuto, a meno che l’ufficio non dimostri che trattavasi di controllo formale o atto semplificato. Questo elemento va dunque valutato con cura insieme al legale. (Per gli atti precedenti al 2024 resta applicabile la giurisprudenza precedente: il mancato contraddittorio non è motivo di nullità per imposte dirette, salvo accertamenti basati su verifiche in loco dove vigeva già l’obbligo ex art.12 c.7 Statuto – in quel caso, l’emissione dell’avviso prima di 60 giorni dal PVC senza urgenza è nullità insanabile, v. Cass. SS.UU. 37/2015).
Riassumendo: ricorrere o no? La scelta del contenzioso ha senso quando il contribuente ha fondati motivi per ritenere illegittimo o infondato l’accertamento, e dispone delle risorse (economiche e di tempo) per sostenere la lite. Se l’importo è elevato o la questione di principio, vale la pena combattere – tenendo presente che in caso di vittoria si azzera il dovuto, mentre in caso di perdita si pagherà tutto più interessi e costi. Invece, se l’accertamento appare corretto o comunque le probabilità di successo sono scarse, può convenire usare le leve deflattive e chiudere con sconti sulle sanzioni (vedi tabella comparativa oltre). A volte si opta per una via intermedia: impugnare l’avviso ma con l’obiettivo di conciliare in corso di causa a condizioni migliorative. Questa strategia permette di vedere le carte dell’ufficio (memorie difensive, eventuali prove) e magari ottenere un accordo conoscendo l’orientamento del giudice. Naturalmente è un percorso più lungo e dispendioso dell’adesione immediata.
Conseguenze del mancato pagamento o della mancata impugnazione
Il worst case scenario per un contribuente è non fare nulla entro 60 giorni dall’avviso di accertamento. In tal caso l’atto diventa definitivo a tutti gli effetti: non più contestabile e immediatamente esecutivo. Ciò significa che l’ufficio può procedere con la riscossione coattiva delle somme indicate. Nello specifico, scaduti i 60 giorni senza ricorso né pagamento, trascorsi ulteriori 30 giorni l’Agenzia delle Entrate affiderà il carico all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate – Riscossione) per il recupero forzoso. Non arriverà una cartella di pagamento (poiché l’avviso ne fa le veci), ma l’Agente è tenuto a inviare al debitore una comunicazione di presa in carico via PEC o raccomandata semplice, che informa che l’incarico per la riscossione è stato affidato. Da tale comunicazione devono trascorrere almeno 180 giorni prima che possano iniziare azioni esecutive, salvo casi di particolare urgenza (in cui potrebbero agire prima, ma per prassi quei 180 giorni solitamente decorrono). Durante questi 180 giorni, il contribuente può ancora pagare spontaneamente quanto dovuto, oppure chiedere una rateizzazione all’Agente della Riscossione. Trascorsi i 180 giorni senza pagamento, potranno scattare misure cautelari ed esecutive: fermo amministrativo di veicoli, ipoteca su immobili, pignoramenti di conti correnti, stipendi, immobili, ecc.. In sintesi, ignorare l’avviso porta inevitabilmente alla fase esecutiva con aggravio di interessi di mora e aggi (onorari di riscossione).
Inoltre, come già accennato, se l’accertamento definitivo riguarda importi elevati sopra soglie di punibilità, l’Agenzia procederà a denuncia penale. Ad esempio, IRPEF evasa oltre €150.000 annui configura il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); omessi versamenti IVA oltre €250.000 art. 10-ter, ecc. Quindi un accertamento non definito può fare da preludio a un procedimento penale a carico del contribuente (o, nel caso di società, dei legali rappresentanti). La Guardia di Finanza spesso si attiva già durante la verifica; in altri casi la segnalazione parte dall’Agenzia a seguito dell’esito dell’accertamento. Dal punto di vista pratico, una volta emesso l’avviso e scaduti i termini, pagare integralmente il dovuto prima del dibattimento penale può costituire causa di non punibilità per alcuni reati tributari (ad es. per dichiarazione infedele e omessa dichiarazione l’art. 13 D.Lgs. 74/2000 prevede l’esclusione della punibilità se il debito tributario, sanzioni e interessi compresi, è estinto prima dell’apertura del giudizio). Dunque, ignorare completamente il problema non è mai una buona strategia: se non si intende o non si riesce a impugnare, è preferibile quantomeno attivarsi per pagare/rateizzare, anche al fine di evitare guai peggiori.
In breve: se entro 60 giorni non fate ricorso né aderite né pagate, l’accertamento “va a ruolo” e diventerete un debitore iscritto a riscossione coattiva. Da lì in avanti tratterete con l’Agente della Riscossione (Ader/Ex Equitalia), con possibilità di rate fino a 72 rate mensili (6 anni) o 120 rate in casi di grave difficoltà. Ma avrete perso ogni chance di contestare il merito. Pertanto, è cruciale non lasciar decorrere il termine dei 60 giorni senza aver almeno presentato l’adesione (che sospende il termine) o il ricorso, a meno che decidiate di pagare. In caso di dubbi, anche presentare un ricorso “preventivo” può essere una tutela per guadagnare tempo ed evitare decadenze, riservandosi magari di conciliare o rinunciare più tardi.
Tabelle riepilogative
Per avere un colpo d’occhio sulle informazioni chiave illustrate, si forniscono di seguito alcune tabelle di sintesi, riguardanti i termini essenziali e il confronto delle diverse opzioni difensive del contribuente.
Tabella 1 – Termini essenziali relativi all’accertamento IRPEF
| Evento/Scadenza | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Termine decadenza accertamento (dich. presentata) | 31 dicembre del 5º anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Esempio: Dichiarazione presentata nel 2019 (redditi 2018) ⇒ avviso notificabile fino al 31/12/2024. | Art. 43 co.1 DPR 600/73; Art. 57 co.1 DPR 633/72 |
| Termine decadenza accertamento (dich. omessa) | 31 dicembre del 7º anno successivo a quello di scadenza dichiarazione. Esempio: Omessa dichiarazione 2018 ⇒ avviso fino al 31/12/2025. | Art. 43 co.2 DPR 600/73; Art. 57 co.2 DPR 633/72 |
| Notifica avviso – modalità | PEC per titolari di domicilio digitale; altrimenti raccomandata AR o messo notificatore secondo CPC. Compiuta giacenza dopo 10 gg (postale) o 20 gg (deposito comunale). | Art. 60 DPR 600/73; L. 890/82; Art. 140 CPC |
| Termine impugnazione (ricorso) | 60 giorni dalla notifica dell’avviso (esclusi i periodi di sospensione: agosto e adesione). | Art. 21 D.Lgs. 546/92 |
| Sospensione feriale | Il termine di ricorso è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno (si aggiungono 31 gg). | Art. 1 L. 742/1969 |
| Sospensione termini per adesione | +90 giorni di sospensione presentando istanza di adesione entro 60 gg. (Novità: +30 gg se contraddittorio già svolto, con istanza entro 15 gg). | Art. 6 co.3 D.Lgs. 218/97 (mod. da D.Lgs. 73/2022) |
| Pagamento per acquiescenza | Entro 60 giorni dalla notifica – pagamento intero di imposte e interessi, sanzioni ridotte a 1/3 del loro importo (riduzione 66,7%). Rate fino a 8 trimestri (16 se importo ≥ €50.000). | Art. 15 D.Lgs. 218/97 |
| Pagamento in caso di ricorso (assenza sospensiva) | Entro 60 giorni dalla notifica – pagamento provvisorio di 1/3 delle imposte accertate (al netto di sanzioni e interessi su quel terzo). | Art. 29 DL 78/2010 conv. L. 122/2010; Art. 15 DPR 602/73 |
| Sospensione giudiziale dell’atto | Può essere richiesta con il ricorso; decisione cautelare in ca. 1-3 mesi. Se concessa, blocca la riscossione finché pende il giudizio (o fino a revoca). | Art. 47 D.Lgs. 546/92 |
| Riscossione coattiva post-ricorso | Se nessuna sospensione concessa: decorsi 30 gg dalla scadenza pagamento (ossia 90 gg dalla notifica), l’ufficio affida il carico all’Agente riscossione, che invia presa in carico e dopo 180 gg può iniziare esecuzione (salvo pagato 1/3). | Art. 29 DL 78/2010; Art. 17-bis DL 34/2019 (180 gg) |
| Riscossione post-sentenza 1° grado | Se contribuente perde in primo grado: l’Agenzia può riscuotere i 2/3 restanti delle imposte + interessi e sanzioni per intero (detratto quanto già versato), salvo sospensione in appello. | Art. 68 D.Lgs. 546/92 (come modif. da L. 130/2022) |
| Prescrizione per riscuotere | Una volta definitivi, i crediti da avviso si prescrivono in 10 anni (termine ordinario, salvo atti interruttivi). | Orient. giurisp. costante (Cass. n. 30362/2018, etc.) |
(La tabella elenca i principali termini; per semplicità non sono inclusi casi particolari come sospensioni COVID, ecc. Il riferimento normativo è indicato per approfondimento.)
Tabella 2 – Confronto tra strumenti deflattivi e contenzioso (scenario: avviso di accertamento IRPEF con imposta accertata di 10.000 € e sanzione 90% = 9.000 €)
| Opzione | Vantaggi | Svantaggi / Condizioni | Sanzioni da pagare |
|---|---|---|---|
| Acquiescenza (pagamento entro 60 gg, senza ricorso) | – Chiude subito la pendenza (certezza immediata).– Evita i costi e i tempi del contenzioso.– Possibile rate fino a 8/16 trimestri (senza garanzia).– Nessuna iscrizione a ruolo successiva (niente cartella, niente aggravio riscossione). | – Occorre liquidità per pagare (almeno la 1ª rata entro 60 gg).– Rinuncia totale a contestare: accettazione integrale dell’atto.– Se emergono errori a posteriori, non si può più rimediare (salvo autotutela dell’ufficio, discrezionale). | 1/3 delle sanzioni irrogate (riduzione 66%).Esempio: sanz. iniziale €9.000 ⇒ paga €3.000 (oltre a imposta piena €10.000 + interessi). |
| Accertamento con adesione (istanza entro 60 gg → sospende termini 90 gg) | – Dialogo con l’ufficio: chance di ridurre imponibile/imposta in sede di accordo.– Sanzioni ridotte al 1/3 del minimo di legge (spesso inferiori alle sanz. in atto).– Più tempo per decidere (90 gg extra) e per reperire fondi.– Rateazione 8/16 trim. sulle somme dovute.– Clima meno conflittuale (sede amministrativa). | – Richiede disponibilità dell’Agenzia a trattare: l’esito è incerto (accordo o mancato accordo).– Tempi più lunghi: si aggiungono mesi di trattativa.– Bisogna comunque pagare l’importo concordato per perfezionare l’adesione (entro 20 gg dalla firma).– Una volta firmato l’accordo, non impugnabile (rinuncia al ricorso). | 1/3 del minimo edittale (per infedele, 30% dell’imposta).Esempio: sanz. min. 90% → paga 30% dell’imposta accertata.Nel nostro caso: 30% di €10.000 = €3.000. (Se nell’atto era €9.000, c’è guadagno solo se base imponibile ridotta). |
| Ricorso in tribunale (contenzioso tributario) | – Possibilità di ottenere annullamento totale o parziale dell’atto: pagare zero o meno imposte/sanzioni se si vince.– Tempo: la riscossione definitiva è rinviata fino a sentenza finale (possono passare anni).– Possibile tutela cautelare (sospensione) se ci sono gravi motivi.– Conciliazione in corso di causa: si può trovare accordo dopo aver valutato prove e orientamento giudice.– Perfezionamento definivo solo a giudizio concluso: se emergono novità, si può cambiare strategia (es. abbandonare, transigere). | – Costi legali: onorario difensore, contributo unificato, eventuali spese di soccombenza.– Pagamento parziale dovuto (1/3 imposte) entro 60 gg se niente sospensione.– Esito incerto e tempi lunghi (anche >5 anni tra appello e Cassazione).– Stress e impegno nel seguire la causa, raccogliere prove, ecc.– Se si perde, si pagano imposte + sanzioni intere + interessi maturati, più rischio di pagare le spese di giudizio alla controparte. | Nessuna riduzione di legge (sanzioni confermate al 100% se atto regolare).Nota: il giudice può disapplicare sanzioni solo in pochi casi (obiettiva incertezza normativa, errore scusabile) – eccezioni rare.In caso di conciliazione giudiziale in 1º grado: sanzioni al 40% del minimo (es. 40% di 90% = 36% imposta); in appello 50% minimo (45% imposta). |
| Non agire (inerzia) | – Nessun vantaggio, se non evitare di impiegare tempo e denaro subito. (È di fatto l’opzione peggiore.) | – Trascorsi 60 gg l’atto è definitivo: niente più difese.– L’importo integrale va a riscossione coattiva con aggravio di interessi di mora e aggi.– Possibili azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche).– Se rilevanti importi > soglia: segnalazione per reato tributario (rischio penale). | N/A (si paga 100% delle sanzioni irrogate, oltre a imposte e interessi, nei tempi della riscossione). |
(Legenda: importi sanzioni espressi come % sull’imposta evasa. Riduzione “1/3 delle sanzioni” significa pagare 33% dell’importo iniziale; “1/3 del minimo” indica 33% della sanzione edittale minima. Nell’esempio numerico sopra, l’accertamento iniziale prevede €10.000 imposte e €9.000 sanzioni = 90%.)
Come si evince dalla tabella, gli strumenti deflattivi (acquiescenza, adesione, conciliazione) offrono significative agevolazioni sulle sanzioni: acquiescenza riduce al 2/3 dell’originario (qui 20% dell’imposta, se originario 30% imposta), adesione al 1/3 del minimo (in genere 30% imposta), conciliazione al 40-50% del minimo (36-45% imposta). Il processo tributario in sé non garantisce sconti di sanzione – il giudice può semmai annullarle solo se annulla il rilievo principale, oppure in rari casi di esimenti (es. ha riconosciuto la non punibilità per obiettiva incertezza in alcune sentenze). Quindi, se l’unico scopo è ridurre le sanzioni, conviene definire in via amministrativa. La via giudiziale va intrapresa se l’obiettivo è non pagare proprio quelle imposte perché non dovute: in quel caso l’eventuale risparmio d’imposta può superare di molto qualsiasi sanzione.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa succede se ignoro un avviso di accertamento e non faccio nulla entro i 60 giorni?
R: L’avviso diventa definitivo e il debito verrà avviato a riscossione forzosa. In pratica, trascorso inutilmente il termine per ricorrere (e pagare), l’atto acquisisce efficacia di titolo esecutivo. L’Agenzia delle Entrate affiderà l’importo all’Agente della Riscossione (AER) e ti invierà una comunicazione (via PEC o posta) di presa in carico. Dopo 180 giorni da tale avviso, se non hai ancora pagato, potranno iniziare le azioni esecutive: ad esempio fermo amministrativo di veicoli, ipoteca su immobili, pignoramento di conti o stipendio. Inoltre, perderai definitivamente la possibilità di contestare il merito dell’accertamento (salvo casi eccezionali di revoca in autotutela da parte dell’ufficio, molto rari). In sintesi: ignorare l’atto ti espone a dover pagare tutto con gli interessi di mora e con il rischio di misure coattive. Conviene quindi attivarsi entro i 60 giorni, scegliendo se pagare (magari con sanzioni ridotte) o presentare ricorso.
D: Non ho liquidità sufficiente per pagare l’accertamento. Posso chiedere più tempo o una dilazione all’Agenzia prima che scadano i 60 giorni?
R: Purtroppo no, non formalmente. Nel periodo dei 60 giorni dalla notifica, l’Agenzia delle Entrate non prevede piani di rateazione “amministrativa” dell’avviso. Le uniche opzioni per diluire il pagamento entro quel termine sono: presentare istanza di accertamento con adesione, che ti dà automaticamente 90 giorni in più di tempo e possibilità, se firmi l’accordo, di rateizzare in 8 o 16 trimestri; oppure lasciare che l’atto vada a ruolo e poi chiedere una rateizzazione all’Agente della Riscossione (ma ciò comporta di far scadere i 60gg e subire l’iscrizione a ruolo, cosa sconsigliabile a meno di aver rinunciato al ricorso). In pratica, se non hai liquidità, la via dell’adesione è spesso consigliabile: ti consente di trattare per ridurre l’importo e, in caso di accordo, di ottenere un piano rate (fino a 2 o 4 anni). Se invece intendi fare ricorso, durante il processo potrai comunque chiedere una rateizzazione all’AER di eventuali somme messe a ruolo (come il terzo, se non sospeso). Ricorda: presentare l’adesione “in bianco” anche solo per guadagnare tempo è legittimo e non preclude poi il ricorso. Quindi chi è in difficoltà economica dovrebbe quasi sempre presentare adesione, quantomeno per spostare in avanti l’esborso. L’Agenzia Entrate, da parte sua, non concede dilazioni informali pre-ruolo: o incassi con adesione/acquiescenza (rate previste da DLgs 218/97), oppure passato ai riscossori.
D: Se faccio ricorso, devo comunque versare subito 1/3 delle imposte accertate?
R: Sì, a meno che tu ottenga una sospensione dal giudice. La disciplina dell’“accertamento esecutivo” prevede che, presentando ricorso, il contribuente debba versare provvisoriamente un importo pari al 1/3 delle maggiori imposte entro il termine di 60 giorni. Questo importo esclude le sanzioni (che restano sospese fino esito) e gli interessi (si pagano solo quelli maturati sul terzo, di solito già inclusi nel calcolo dell’atto). Ad esempio, se l’avviso chiede €30.000 di imposte e €15.000 di sanzioni, dovrai pagare €10.000 (un terzo di 30k) più gli interessi su quei 10k. Se poi vincerai la causa, quanto hai versato ti sarà rimborsato con interessi legali. Se invece perderai, quanto già pagato sarà scalato dal dovuto finale. Nota: se ritieni di non poter sostenere il versamento del terzo, devi necessariamente richiedere la sospensiva al tribunale tributario, contestualmente al ricorso, dimostrando il tuo grave danno in caso di pagamento. Se la sospensione viene concessa, il giudice ti esonera dal versamento finché non decide nel merito. Se non viene concessa (ipotesi frequente se non dimostri sia fumus che periculum convincente), quel terzo resta dovuto. In assenza di pagamento, come detto, l’Agenzia attenderà 90 giorni dalla notifica e poi incaricherà l’Agente della Riscossione di recuperarlo coattivamente (di solito con cartella). Perciò, pragmaticamente, chi ricorre deve mettere in conto il pagamento del terzo entro 2 mesi, oppure confidare in una sospensiva (mai garantita). In alcuni casi, se il giudizio di primo grado dura poco e c’è ragionevole certezza di vincere, si può strategicamente non pagare il terzo: se si ottiene sentenza favorevole prima che la riscossione arrivi, il problema decade. Ma è un azzardo rischioso. Meglio pagare e poi farsi rimborsare che esporsi a more e aggi.
D: La notifica via PEC dell’avviso è arrivata ad una casella PEC che non uso più o che non ho controllato: posso contestarla?
R: In generale no. Se la PEC destinataria era quella risultante dai pubblici registri (es. Registro Imprese per aziende, INI-PEC per professionisti, o domicilio digitale che hai eletto), la notifica si intende perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC. Il fatto che tu non abbia letto la PEC o che l’indirizzo fosse di fatto inutilizzato non è motivo di nullità: era tuo onere mantenerlo attivo e monitorato. La legge presume conoscenza nel momento in cui il server deposita il messaggio nella tua casella. Dunque contestare “non ho visto l’email” non serve. Diverso sarebbe il caso in cui la PEC inviata non fosse la tua PEC legale (ad es. errore di indirizzo dell’Agenzia) – ma queste situazioni sono rare. Pertanto, se hai scoperto tardivamente l’avviso perché la PEC non veniva controllata, purtroppo il termine di 60 giorni decorre comunque dalla data di consegna PEC (che risulta dalla ricevuta). Ti conviene attivarti immediatamente: se i 60 giorni non sono ancora trascorsi, puoi ancora fare ricorso (o adesione) entro il termine, recuperando il tempo perduto. Se invece i 60 giorni sono già passati quando scopri l’atto, la situazione è grave: l’avviso è divenuto definitivo. Potresti tentare un’istanza di rimessione in termini al giudice, sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza dell’atto per caso fortuito/forza maggiore, ma onestamente è una strada molto in salita quando c’è di mezzo la PEC legale (il giudice dirà che è colpa tua). In parallelo, puoi presentare istanza di autotutela all’Agenzia spiegando l’accaduto: se l’ufficio è clemente e il tuo caso difensivo appare valido, potrebbe riaprire i termini internamente. Ma è tutto discrezionale. Questa vicenda evidenzia l’importanza di tenere d’occhio la propria PEC: molte “brutte sorprese” si evitano così. In conclusione, la notifica PEC a un indirizzo ufficiale regolare è valida anche se non l’hai vista; agisci comunque il prima possibile con le armi residuali che hai.
D: Posso impugnare un avviso di accertamento solo per far ridurre le sanzioni? Cioè, non contesto le imposte ma voglio che il giudice mi tolga o abbassi le sanzioni.
R: Non direttamente. Il giudice tributario non può modificare discrezionalmente l’entità delle sanzioni per “motivi di equità” o convenienza del contribuente. Può annullare in tutto o in parte l’atto (e con esso le sanzioni) solo se accoglie i motivi di ricorso sul merito o sulla legittimità dell’accertamento. Ad esempio: se impugni sostenendo che un reddito contestato in realtà non era dovuto, e il giudice ti dà ragione su quel punto, verranno eliminate anche le sanzioni relative a quel reddito (cadendo il presupposto). Oppure, se il giudice riconosce che c’era obiettiva incertezza normativa su una questione, può dichiarare non dovute le sanzioni (art. 6 co.2 D.Lgs. 472/97) – ma questo presuppone un motivo specifico dedotto e provato, non è automatico. In sintesi, non esiste una causa di ricorso che dica “chiedo la riduzione delle sanzioni perché troppo alte”: la misura della sanzione (se rientra nei minimi di legge) non è sindacabile dal giudice. L’unica leva sarebbe far valere circostanze di non punibilità (es. errore scusabile) o la non applicabilità in toto per assenza di colpa grave – argomenti difficili. Se dunque il tuo unico obiettivo è mitigare la sanzione, non conviene fare ricorso: molto meglio sfruttare gli istituti deflattivi (acquiescenza, adesione, conciliazione) che garantiscono per legge una riduzione significativa. Ad esempio, con adesione paghi il 30% dell’imposta come sanzione, col ricorso rischi di dover pagare il 90% intero se perdi. Vale anche la pena ricordare che il giudice non può nemmeno rinviare al Mittente l’atto perché ridetermini la sanzione: o conferma o annulla, nulla in mezzo. Dunque, fare causa solo sperando nella clemenza sulle sanzioni è in generale una strategia sbagliata.
D: Ho un credito d’imposta verso l’Erario; posso “compensarlo” con le somme richieste nell’avviso?
R: Non direttamente durante la fase amministrativa. Se hai, ad esempio, un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione, non puoi semplicemente compensarlo in F24 contro l’importo dell’avviso di accertamento (che non è un debito spontaneamente versabile ma un debito accertato). Fino a qualche anno fa, quando l’accertamento veniva iscritto a ruolo, vigeva addirittura un divieto di compensazione per quei ruoli. Oggi, a quanto risulta, una compensazione è possibile solo a seguito della conversione in ruoli/cartelle e in presenza di crediti certi, liquidi, esigibili, entro i limiti di compensabilità (2 milioni annui). In pratica: se l’avviso diventa cartella esattoriale, puoi presentare richiesta di compensazione di quel debito con un tuo credito fiscale (ad esempio IVA a rimborso) seguendo la procedura dell’art. 28-ter DPR 602/73. Ma nella fase immediata dell’avviso, no, devi pagare con denaro. Un caso particolare: se definisci l’accertamento con adesione o conciliazione, nulla vieta di usare crediti in F24 per versare le somme concordate, purché rispetti i codici tributo e i limiti di compensazione. Ad esempio, se dal tuo Modello Redditi hai un credito IRPEF di 5.000 € e l’adesione comporta un debito IRPEF di 5.000 €, puoi compensare presentando un F24 a saldo zero (codice tributo dell’accertamento in debito e codice del credito in sezione Erario in credito). Bisogna però essere attenti: un uso improprio della compensazione può far decadere la definizione se l’Agenzia non la considera valida. Consiglio: verifica con un commercialista la possibilità di utilizzare crediti disponibili dopo aver quantificato l’importo da versare per definire l’avviso (acquiescenza/adesione). Non fare invece da te una compensazione senza accordi: se sbagli, l’importo resta insoluto e andrà a ruolo.
D: Se vinco il ricorso, otterrò il rimborso di quanto eventualmente pagato nel frattempo?
R: Sì. In caso di vittoria (annullamento totale o parziale dell’atto), il contribuente ha diritto al rimborso delle somme non dovute che abbia versato in pendenza di giudizio. Ad esempio, se in pendenza di giudizio hai versato il famoso 1/3 (o altri importi perché magari non avevi ottenuto sospensione, o avevi definito parzialmente qualche rilievo) e poi il giudice annulla l’atto in tutto o in parte, l’Agenzia dovrà restituire le somme versate in eccedenza, con gli interessi al tasso legale maturati dalla data del versamento. La procedura di rimborso non è immediata: dovrai presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia (citando la sentenza favorevole). L’ufficio spesso attende che la sentenza sia passata in giudicato (definitiva) prima di rimborsare, a meno che la sentenza non sia provvisoriamente esecutiva. In generale, dopo la vittoria è bene sollecitare formalmente il rimborso e, se trascorrono 90 giorni senza esito, si può presentare ricorso per ottemperanza alla Commissione. Ma di solito l’Agenzia provvede, magari compensando il credito con altre posizioni aperte se il contribuente acconsente. Insomma: i soldi del terzo (o altro) pagati indebitamente non sono persi, tornano indietro se hai ragione. Diverso scenario: se in corso di causa avevi definito in parte l’atto (es. hai fatto acquiescenza su alcuni rilievi e impugnato solo altri), su quella parte definita non hai rimborso perché hai accettato il debito. Ma su ciò che hai contestato e vinto, sì. Ricorda infine che il rimborso comprende solo l’importo versato e gli interessi, non le eventuali spese legali che hai pagato al tuo avvocato (quelle semmai vengono rifuse dall’Agenzia se il giudice ti ha liquidato le spese di lite nella sentenza).
D: Un avviso “bonario” (comunicazione di irregolarità) non pagato può trasformarsi in un avviso di accertamento?
R: Non esattamente. Le comunicazioni di irregolarità (dovute a controlli automatizzati ex art. 36-bis o formali ex 36-ter) seguono un iter diverso. Se non paghi un avviso bonario entro 30 giorni, l’importo viene iscritto a ruolo e ti sarà notificata una cartella di pagamento, non un avviso di accertamento. L’avviso di accertamento, invece, viene emesso per controlli sostanziali e approfonditi, generalmente senza essere preceduto da un invito bonario al pagamento (salvo alcuni casi dove c’è prima un PVC, ma quello non è un invito bonario bensì un atto della verifica). Per chiarire:
- Se ricevi una comunicazione 36-bis (es. liquidazione automatica per un errore aritmetico o un versamento insufficiente in dichiarazione) e non paghi, non ti arriverà un accertamento: ti arriverà direttamente la cartella esattoriale, che potrai eventualmente impugnare entro 60 gg dalla notifica della cartella, ma solo per vizi formali o di calcolo (non puoi contestare il merito del tributo dichiarato).
- Se invece ricevi un PVC dalla Guardia di Finanza e non presenti osservazioni, quello non è una richiesta di pagamento bonaria ma un verbale di constatazione: trascorsi i 60 giorni di legge, seguirà un avviso di accertamento basato su di esso (salvo che tu aderisca prima col cosiddetto invito al contraddittorio o proposta di adesione).
- Un avviso di accertamento vero e proprio di solito arriva senza sconti o inviti bonari preliminari: arriva con la sanzione piena (es. 90%) e offre la possibilità di adesione in 60 gg, ma se non fai nulla poi si passa a ruolo. Non c’è uno step intermedio di “sollecito” al 10% di sanzione come nei 36-bis.
Quindi, la regola è: avvisi bonari non pagati = cartella; rilievi da verifiche = avviso di accertamento. Occhio però: se dopo un controllo automatizzato paghi solo in parte l’avviso bonario, su ciò che resta insoluto l’Agenzia potrebbe (invece che andare a cartella) emettere un avviso di accertamento parziale. Ma è un’evenienza non comune, di solito seguono la via standard del ruolo. In ogni caso, se ricevi un avviso bonario è bene gestirlo subito: pagarlo con sanzione ridotta (se corretto) o segnalarne l’errore all’Agenzia. Evitare che vada a cartella ti risparmia sanzioni aggiuntive (la cartella non aggiunge sanzioni ma dopo 30 gg dall’iscrizione partono interessi di mora e aggi di riscossione). Ma non temere che tacendo sul bonario ti arrivi qualcosa di “peggio” tipo accertamento: semplicemente andrà in cartella.
D: Ci sono differenze nel contenzioso per una società di capitali rispetto a una persona fisica?
R: Le regole processuali e procedurali del contenzioso tributario sono praticamente le stesse. La differenza principale è che una società di capitali deve sempre farsi rappresentare da un difensore abilitato (non può stare in giudizio da sola neanche se l’importo è basso), mentre una persona fisica può autodefendersi se il valore non supera €3.000. Inoltre, la società di capitali non può accedere al gratuito patrocinio, istituto previsto per persone fisiche con redditi modesti, perché giuridicamente è esclusa (il patrocinio a spese dello Stato in ambito tributario è limitato ai contribuenti persone fisiche sotto un certo reddito). Per il resto, a livello di argomentazioni difensive, una società potrebbe avere considerazioni leggermente diverse: ad esempio, nel caso di società di persone c’è il tema del “litisconsorzio necessario” con i soci – se la società in accomandita semplice perde il ricorso, i soci devono impugnare anche i propri avvisi di reddito pro-quota, ecc. Nel caso di società di capitali, invece, l’accertamento riguarda solo la persona giuridica e non trascina direttamente i soci (a meno di situazioni specifiche come utili extrabilancio distribuiti, ma quelli sarebbero oggetto di distinti accertamenti IRPEF ai soci). Quindi, da un lato una S.p.A./S.r.l. discute solo su IRES/IVA proprie senza coinvolgere terzi; dall’altro, se la società viene meno (es. si estingue), ci sono norme particolari sulla responsabilità di ex soci o liquidatori entro certi limiti. Ma nel merito della lite fiscale (prove, vizi, ecc.) non cambia molto: l’avvocato difenderà la società come difenderebbe un individuo, contestando i rilievi o la procedura. In sintesi: differenze pratiche – la persona fisica può, in piccole liti, scegliere di fare da sé e può chiedere il gratuito patrocinio se povera; la società no, deve mettere in conto i costi legali. Inoltre, l’esito su una società di persone si riflette automaticamente sui soci (essendo l’IRPEF “trasparente”); per una società di capitali l’esito si esaurisce lì (nessuna “doppia conforme” da gestire con soci). Quindi meno complicazioni di litisconsorzio con i soci per le società di capitali.
D: Dopo un avviso di accertamento, la Guardia di Finanza potrebbe intervenire penalmente?
R: È possibile. Se l’accertamento concerne fatti che integrano reati tributari (ad esempio omessa dichiarazione di importo rilevante, dichiarazione infedele sopra soglia, emissione o utilizzo di fatture false, occultamento/distruzione di contabilità), l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di trasmettere un rapporto alla Procura della Repubblica. In molti casi la G.d.F. era già coinvolta sin dall’inizio: può darsi che la verifica sia partita come controllo amministrativo e poi abbia assunto anche risvolti penali, con la GdF che redige comunicazioni di reato parallele. La società/contribuente in sé non è soggetta a sanzioni penali (salvo rarissimi casi di responsabilità amministrativa 231 per reati tributari strumentali), ma i rappresentanti legali o amministratori sì, in quanto autori del reato fiscale. Quindi, se ricevi un pesante accertamento per evasione, è prudente mettere in conto anche una possibile indagine penale a tuo carico. In questi frangenti, attivare un legale penalista per seguire la vicenda parallela è raccomandato. Tieni presente che definire l’accertamento in sede tributaria (pagando il dovuto) può avere effetti positivi sul penale: ad esempio, per omessa dichiarazione e infedele dichiarazione, pagare tutti i debiti tributari (imposte, sanzioni e interessi) prima del dibattimento penale estingue il reato (art. 13 D.Lgs. 74/2000). Anche per altri reati, il ravvedimento operoso prima di accertamento può attenuare le pene. Ma se sei già alla fase di avviso, significa che il reato è consumato; pagare entro la soglia temporale prevista comunque evita la punibilità. In conclusione: sì, l’accertamento può preludere ad un procedimento penale per i responsabili fiscali; conviene agire su entrambi i fronti, tributario (per ridurre danno economico) e penale (per evitare condanne, magari sfruttando la causa di non punibilità con pagamento integrale). Sono due binari autonomi ma collegati nei fatti: la sentenza tributaria non vincola quella penale e viceversa, ma gli elementi probatori possono essere condivisi. Esempio: se in giudizio tributario emergono prove che l’evasione c’è stata, queste verranno usate in penale; se in penale si viene assolti perché “il fatto non sussiste”, ciò potrebbe dare adito a rivedere l’accertamento in autotutela. Tuttavia, formalmente i giudici tributari e penali decidono separatamente.
(In caso di situazioni del genere, questa guida consiglia vivamente di consultare uno specialista di diritto penale tributario: la strategia di difesa va coordinata tra i due ambiti.)
D: Posso richiedere l’annullamento dell’avviso in autotutela all’Agenzia delle Entrate?
R: Sì, ma attenzione: l’“autotutela” è il potere discrezionale dell’Amministrazione di annullare o rettificare i propri atti quando riconosce che sono errati o illegittimi. Puoi sempre presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’avviso, esponendo i motivi per cui ritieni l’atto sbagliato e chiedendone l’annullamento (totale o parziale). Ad esempio, se c’è un errore di persona, un evidente doppio conteggio, o se disponi di prove schiaccianti non valutate, segnalarlo all’ufficio può indurlo a ritirare o correggere l’atto. Tuttavia, devi sapere che:
- L’autotutela non sospende i termini di ricorso né quelli di pagamento. Devi comunque, per sicurezza, presentare ricorso entro 60 giorni se non arriva in tempo una risposta favorevole. Non fare affidamento sul fatto che l’ufficio risponderà in fretta o accoglierà la richiesta.
- L’ufficio non è obbligato ad annullare l’atto, nemmeno se tu hai ragione. È una facoltà, non un dovere (salvo casi di errori oggettivi riconoscibili tipo scambio di contribuente). Spesso le istanze di autotutela vengono respinte o ignorate, specie se la questione è controversa.
- Se l’ufficio rigetta o non risponde, non puoi impugnare il “diniego di autotutela” (non è atto autonomamente impugnabile, a meno di casi particolari). Dovrai comunque contestare l’accertamento per vie ordinarie.
In pratica, puoi tentare l’autotutela se reputi di avere elementi chiari e immediati che l’ufficio potrebbe aver trascurato. Spedisci l’istanza (meglio via PEC così resta traccia) e magari contatta il funzionario per discuterne. In certi casi funziona: se l’ufficio riconosce un palese errore (es.: ha applicato una norma abrogata, oppure hai un documento che risolve l’equivoco), può sgravare l’atto. Ma non affidarti solo all’autotutela: è prudente comunque avviare la procedura di adesione o presentare ricorso, per non farti scadere i termini. L’autotutela può avvenire anche durante il contenzioso: l’ufficio può sempre annullare l’atto se convinto, persino dopo che hai presentato ricorso (in tal caso il giudizio si estingue). In conclusione, fai domanda di autotutela come mossa parallela, ma non come unica azione. E ricorda di essere molto chiaro e documentato nell’istanza, perché deve persuadere il funzionario di un errore senza necessità di un giudice.
Esempio pratico di accertamento IRPEF e risultati delle diverse opzioni
Per comprendere l’impatto concreto delle varie soluzioni, consideriamo un caso pratico semplificato.
Scenario: Il signor Rossi, artigiano individuale, nel 2022 ha dichiarato €50.000 di reddito. Un controllo incrociato sui suoi conti correnti rivela versamenti non giustificati per €20.000. L’Agenzia delle Entrate emette nel 2025 un avviso di accertamento per redditi non dichiarati €20.000 nell’anno d’imposta 2021. Aliquota IRPEF marginale del Rossi 38% (per semplificare). Quindi:
- Maggior IRPEF accertata: €20.000 * 38% ≈ €7.600 (più addizionali €300 circa, arrotondiamo totale imposta €7.900).
- Sanzione per dichiarazione infedele: 90% dell’imposta evasa = 90% di €7.900 = €7.110.
- Interessi calcolati: poniamo €300.
- Totale atto = imposta €7.900 + sanzioni €7.110 + interessi €300 = €15.310.
Rossi riceve l’avviso e valuta le opzioni:
- Se fa acquiescenza: entro 60 gg paga imposta €7.900 + interessi €300 + sanzioni ridotte a 1/3 (€7.110 * 33,3% ≈ €2.370). Totale da pagare ≈ €10.570. Può dividerlo in rate trimestrali (es. 8 rate da €1.321). Rinuncia al ricorso. Fine della vicenda, nessun ulteriore aggravio.
- Se richiede adesione: ottiene 90gg extra. In ufficio riesce a dimostrare che €5.000 di quei versamenti erano trasferimenti da conto cointestato con la moglie (soldi propri già tassati). L’ufficio accetta di ridurre il reddito non dichiarato a €15.000 (invece di 20k). L’accordo di adesione prevede: imposta 38% su €15.000 = €5.700, addizionali €225, tot imposta €5.925; sanzione 1/3 del minimo (minimo 90% → 30% di €5.925 = €1.777); interessi €250. Quindi Rossi paga: €5.925 + €1.777 + €250 = €7.952, rateizzabili (ad es. 8 rate da €994). Risparmio rispetto all’atto iniziale: ha evitato €5.000 di reddito tassato (imp./sanz. risparmiate ~€3.500) e ha sanzioni ridotte. Totale risparmiato circa €7.358 rispetto ai €15.310 iniziali. Niente ricorso, fine vicenda.
- Se fa ricorso: il caso va in giudizio. Entro 60gg Rossi dovrebbe intanto versare 1/3 delle imposte = €7.900/3 ≈ €2.633 (interessi su questo importo trascurabili). Chiede sospensiva sostenendo che la sua attività è in crisi di liquidità. I giudici però negano la sospensione (perché non ravvisano un danno grave, e l’importo non è enorme). Rossi allora versa il terzo €2.633 per evitare problemi. In giudizio il suo difensore riesce a provare con documenti che €5.000 erano trasferimenti interni come detto. Inoltre contesta sanzioni per errore scusabile, ma su questo punto il giudice non concorda. Esito: la Corte accoglie parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito non dichiarato in €15.000 (come nell’adesione) e confermando la sanzione del 90% su questo. Dunque imposta dovuta €5.925, sanzione €5.332 (90%), interessi €250 = totale €11.507. Rossi aveva già pagato €2.633, gliene restano €8.874 da pagare. Niente sconto sanzioni perché il giudice non ha potuto applicare attenuanti. Inoltre, spese di lite compensate (ognuno paga le proprie). Rossi ha speso €3.000 di avvocato. In totale, questo percorso gli è costato: €2.633 + €8.874 + €3.000 = €14.507. Ha impiegato 2 anni per avere la sentenza. Certo, avrebbe potuto fare appello sulla sanzione, ma altri tempi e spese… Valuta la conciliazione in appello, ma ormai l’ufficio, avendo vinto in parte, è meno propenso a sconti. Morale: Rossi ricorrente ha sì ridotto l’imponibile come in adesione, ma ha finito per pagare quasi il doppio in sanzioni (90% vs 30%) e spese legali, e attendere più tempo.
- Se Rossi non avesse fatto nulla: dopo 60gg sarebbero partiti €15.310 a ruolo. Con interessi di mora, ipotizziamo altri €500 e compensi riscossione 3% (~€450). Totale dovuto a fine 180gg circa €16.260, in rate con AER se concesse. Nessuna riduzione. In più, essendo €7k imposta evasa > €50k*? (no, qui 7k < 50k quindi non reato infedele, male minore per penal… se fosse stato >150k imposta sarebbe scattato reato).
Conclusione: in questo esempio, l’adesione era la soluzione nettamente migliore per Rossi (€7.952) rispetto a ricorso (€14.507) o inattività (€16.260). L’acquiescenza sarebbe costata €10.570, più dell’adesione ma meno del ricorso. Ovviamente, se Rossi avesse avuto motivi per una vittoria totale, il ricorso avrebbe potuto evitargli €7.952; ma con motivi parziali, il mix di spese e sanzioni piene l’ha penalizzato.
Ogni caso è a sé, ma gli strumenti come adesione e conciliazione tendono a collocare l’esborso finale del contribuente tra quello dell’acquiescenza e quello di un esito processuale incerto. Si paga più che con una vittoria piena in giudizio, ma meno che con una sconfitta. Spesso conviene scegliere la via deflattiva quando si valuta che il ricorso non porterà quasi certamente ad annullare tutto.
Conclusione
Affrontare un avviso di accertamento IRPEF richiede lucidità, tempestività e una buona conoscenza dei propri diritti. Dal momento della notifica, il contribuente deve soppesare le prove e le argomentazioni a suo favore, e parallelamente considerare i costi e benefici delle opzioni disponibili: definire subito (con forti riduzioni sanzioni) o combattere in giudizio (puntando a non pagare affatto, ma con rischio di dover pagare tutto). La normativa attuale – così come la prassi delle Commissioni Tributarie – offre molti strumenti di tutela del contribuente, ma ciascuno va usato correttamente. Questa guida ha fornito un quadro completo e aggiornato al 2025 di tutte queste possibilità, dal contraddittorio preventivo all’adesione, dal ricorso alla conciliazione, con un’attenzione speciale alle novità normative (come l’obbligo generalizzato di contraddittorio) e giurisprudenziali (sentenze di Cassazione più rilevanti).
In definitiva, dal punto di vista del contribuente (“debitore”), il motto deve essere: non subire passivamente, ma esercitare i propri diritti con cognizione di causa. Che significhi contestare un avviso ingiusto fino alla vittoria, oppure trovare un accordo equo con il Fisco per chiuderla lì, l’importante è agire informati e nei tempi giusti. Ignorare l’accertamento, al contrario, è l’errore più costoso che si possa commettere.
Si raccomanda infine, specie per accertamenti di importo rilevante o giuridicamente complessi, di farsi assistere da un professionista qualificato (avvocato tributarista o commercialista esperto in contenzioso tributario). Le norme tributarie sono intricate e in evoluzione, e un difensore esperto saprà individuare i punti deboli dell’atto (magari richiamando precedenti giurisprudenziali utili, come Cass. 13620/2023 sulla motivazione contraddittoria o Cass. 17573/2024 sull’onere di allegazione) e condurre trattative efficaci con l’ufficio. Un buon esito, sia esso un annullamento in giudizio o una transazione favorevole, spesso ripaga ampiamente il costo dell’assistenza tecnica.
In ogni caso, conoscere i propri diritti – dai termini di decadenza da far valere, al contraddittorio da pretendere, fino alle possibilità di ridurre sanzioni – è il primo passo per affrontare con successo un avviso di accertamento IRPEF.
Fonti: Questa guida ha fatto riferimento alle principali norme vigenti (DPR 600/1973, D.Lgs. 218/1997, L.212/2000, D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche), alla prassi dell’Agenzia delle Entrate, nonché a recenti pronunce giurisprudenziali di rilievo, tra cui Cass. SS.UU. 24823/2015 sul contraddittorio, Cass. 1042/2023 sulla firma del responsabile, Cass. 13620/2023 sulla motivazione incoerente, Cass. 17573/2024 sulla mancata allegazione di atti, Cass. SS.UU. 37/2015 sulla nullità per violazione dei 60 giorni post-verifica. Si è tenuto conto delle novità introdotte dalla L.130/2022 e dai decreti attuativi del 2023 (obbligo di contraddittorio ex art.6-bis Statuto, giudice monocratico, abolizione reclamo/mediazione, ecc.).
Con queste informazioni, il contribuente – sia esso un privato cittadino, un imprenditore individuale o il legale rappresentante di una società – sarà in grado di orientarsi al meglio di fronte a un avviso di accertamento IRPEF, proteggendo i propri interessi e, ove possibile, limitando il peso delle pretese fiscali nei confronti suoi o della propria attività economica.
Hai ricevuto un avviso di accertamento IRPEF dall’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento IRPEF dall’Agenzia delle Entrate?
Vuoi sapere quali sono le conseguenze e come difenderti?
L’IRPEF è l’imposta principale che colpisce i redditi delle persone fisiche. Un avviso di accertamento può arrivare quando l’Agenzia delle Entrate rileva incongruenze tra i redditi dichiarati e quelli effettivi, sulla base di controlli automatici, formali o sostanziali. Le contestazioni possono riguardare redditi non dichiarati, detrazioni o deduzioni non spettanti, o errori nei calcoli. In caso di ricezione dell’atto, è importante non ignorarlo: ci sono tempi precisi per impugnare o aderire alla pretesa con strumenti agevolati.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’avviso di accertamento IRPEF e individua gli errori o le incongruenze contestate
📌 Verifica la legittimità della pretesa fiscale e il rispetto dei termini di notifica
✍️ Predispone ricorsi e memorie difensive per contestare somme non dovute
⚖️ Ti assiste nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
🔁 Ti supporta anche nella definizione agevolata o nella rateizzazione del debito, se più conveniente
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e difesa da accertamenti IRPEF
✔️ Specializzato nella tutela dei contribuenti da contestazioni su redditi delle persone fisiche
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Un avviso di accertamento IRPEF non deve essere sottovalutato: ignorarlo significa rischiare sanzioni più gravi e azioni esecutive.
Con una strategia legale mirata puoi contestare la pretesa, ridurre le somme richieste e tutelare i tuoi diritti.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti IRPEF comincia da qui.