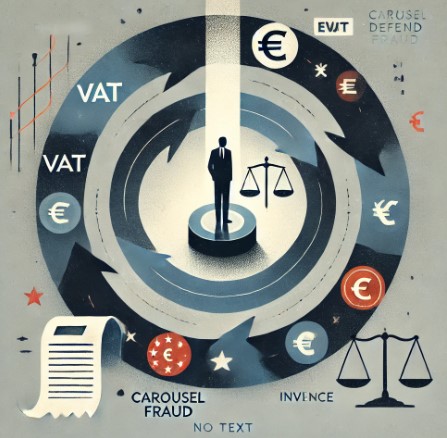Hai ricevuto una contestazione per presunta frode carosello e vuoi sapere come difenderti legalmente?
La frode carosello è uno degli schemi più contestati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza in materia di IVA: si tratta di operazioni triangolari o plurime tra società italiane ed estere, spesso con l’interposizione di “cartiere”, finalizzate a non versare l’imposta pur detraendola. Le conseguenze fiscali e penali sono gravi, ma esistono strumenti di difesa che possono evitare di pagare per responsabilità non proprie.
Cos’è la frode carosello
– È un meccanismo fraudolento che sfrutta scambi fittizi di beni o servizi tra più società, anche di diversi Paesi UE
– Una o più società intermediarie (cartiere) emettono fatture senza versare l’IVA
– Le società a valle detrattono l’IVA indebitamente, con un danno per l’erario
– Il Fisco tende ad attribuire responsabilità a tutti i soggetti coinvolti, anche a chi ha operato in buona fede
Quali sono i rischi per il contribuente
– Recupero dell’IVA detratta e indeducibilità dei costi
– Applicazione di imposte, interessi e sanzioni molto elevate
– Contestazioni penali per dichiarazione fraudolenta, emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
– Pignoramenti e sequestri a garanzia del credito tributario
Come difendersi in caso di contestazioni
– Dimostrare la propria buona fede e l’estraneità alla frode
– Documentare controlli effettuati sul fornitore (visure, DURC, iscrizioni, contratti, tracciabilità dei pagamenti)
– Provare l’effettiva esistenza delle operazioni tramite contratti, ordini, trasporti, corrispondenza commerciale
– Contestare l’uso di presunzioni generiche da parte del Fisco, prive di elementi concreti
– Far valere la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che tutela il diritto alla detrazione IVA quando non era ragionevolmente possibile accorgersi della frode
– Impugnare gli avvisi di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e difendersi in sede penale con avvocati specializzati
Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento o la riduzione delle imposte e delle sanzioni contestate
– L’esclusione della responsabilità penale se manca la prova del dolo
– La sospensione di sequestri, cartelle e procedure esecutive
– La tutela del patrimonio personale e aziendale
– Il riconoscimento della buona fede e della correttezza del comportamento fiscale
Attenzione: nelle contestazioni di frode carosello, il Fisco tende ad allargare la responsabilità anche a chi non ha tratto vantaggi diretti dalla frode. Difendersi significa dimostrare con prove concrete la regolarità delle proprie operazioni e la diligenza adottata nei rapporti commerciali.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria, contenzioso fiscale e reati IVA – ti spiega cosa fare in caso di contestazioni per frode carosello e come difenderti legalmente.
Hai ricevuto un accertamento o un procedimento per frode carosello?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo le contestazioni, raccoglieremo la documentazione utile e predisporremo una strategia difensiva per proteggere i tuoi diritti.
Introduzione
La frode carosello rappresenta una delle forme più sofisticate di evasione fiscale (tipica frode IVA) e comporta gravi conseguenze sia dal punto di vista amministrativo che penale. In questa guida analizzeremo il fenomeno della frode carosello dal punto di vista del contribuente, illustrando il quadro normativo di riferimento, le modalità operative del reato, i principali profili di responsabilità e le strategie difensive possibili. Ogni affermazione è supportata da fonti aggiornate (leggi, sentenze, articoli giuridici).
La frode carosello si configura tipicamente come uno schema fraudolento in cui più società (talvolta “cartiere” o “missing trader”) si scambiano fatture per operazioni inesistenti, abusando del meccanismo dell’IVA intracomunitaria per ottenere crediti IVA indebiti. In pratica, società intermediarie inesistenti (talvolta con fittizi acquisti intra-UE in esenzione IVA) rivendono beni applicando l’IVA, incassandola ma non versandola all’Erario, per poi sparire dopo poche transazioni. Alla fine, un’azienda “beneficiaria” finale (a sua volta eventualmente ignara) detrae indebitamente l’IVA su tali fatture “pulite” provenienti dalla catena. In definitiva, lo Stato non riceve l’IVA dovuta, mentre il gruppo di frodatori ottiene un vantaggio indebito, a danno dell’erario.
Questa pratica si inquadra in più fattispecie penali del Codice dei reati tributari (D.Lgs. 74/2000). In particolare, l’art. 2 colpisce chi uso fatture o documenti inesistenti per indicare passività fittizie (riducendo falsamente il reddito o la base imponibile). L’art. 8, “reato speculare” della frode carosello, punisce chi emettere fatture false per consentire a terzi (i veri beneficiari) di evadere le imposte. Entrambe le norme prevedono pene severe – ad esempio l’art. 2 sanziona con la reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni, l’art. 8 prevede da 4 a 8 anni – e si configurano per dolo specifico (cioè la consapevolezza e volontà di evadere le imposte).
Per difendersi efficacemente, il contribuente deve innanzitutto conoscere questi principi e prepararsi a dimostrare, quando possibile, la buona fede e la massima diligenza. Inoltre, è cruciale intervenire subito: ad esempio, nelle indagini della Guardia di Finanza o nell’accertamento tributario con memorie difensive e documentazione probatoria (contratti, documenti di trasporto, dati bancari, ecc.), ed eventualmente ricorrere in giudizio tributario o penale. Nei paragrafi che seguono vedremo nel dettaglio la normativa di riferimento, i meccanismi della frode carosello, gli aspetti processuali e le possibili strategie difensive (punto di vista debitore).
Quadro normativo di riferimento
Il reato di frode carosello si fonda principalmente sulle norme dei reati tributari introdotte con il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (“Legge sui reati tributari”). In particolare:
- Art. 2, D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Punisce chi, al fine di evadere imposte (IVA o sui redditi), si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti inserendo in dichiarazione elementi passivi fittizi. La norma richiede dolo specifico (consapevolezza e volontà di frode fiscale). La pena è da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione. Questa fattispecie ricorre sovente nel carosello quando il contribuente acquista merci da un fornitore “cartiera” inesistente: pur non avendole realmente ricevute, registra in contabilità le fatture di acquisto e detrae l’IVA corrispondente.
- Art. 8, D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti. Riguarda chi, al fine di consentire a terzi l’evasione di imposte, emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti (ovvero false). In pratica, questa norma incrimina i fornitori fittizi che producono “merce di carta”: chi emette fatture inesistenti destinando terzi a incassare indebiti crediti fiscali. La pena è la stessa (4–8 anni) prevista per chi commette il reato opposto (art. 2). Nell’ambito del carosello, l’art. 8 colpisce quindi il «fabbricante» delle fatture false, mentre l’art. 2 colpisce il «beneficiario» che le utilizza nella propria dichiarazione.
- Altre fattispecie: L’art. 3 (dichiarazione fraudolenta con altri artifici) punisce operazioni simulate o l’uso di falsi che riducono l’imponibile; l’art. 10 punisce chi si avvale di crediti o compensazioni fraudulentamente; l’art. 5/6 puniscono l’omessa dichiarazione e omesso versamento nei casi più gravi. Tali fattispecie possono intervenire nei caroselli più complessi, ma le più rilevanti restano gli art. 2 e 8 per il nucleo della frode.
Accanto alle norme penali, rilevano anche disposizioni fiscali e procedurali:
- DPR 633/1972 (Testo Unico IVA): in materia di IVA trova applicazione il principio di neutralità. Per esempio, l’art. 54 del DPR 633/1972 (comma 2) consente all’Amministrazione di utilizzare presunzioni semplici o elementi indiziari nell’ambito di accertamenti tributari. In pratica, se il Fisco contesta la reale natura di operazioni fatturate, può presumerne la fittizietà in base a indici o presunzioni (es. società senza sede, senza dipendenti, senza versamenti, ecc.).
- Statuto del contribuente (L. 27/7/2000, n. 212, art. 10): principio del legittimo affidamento e buona fede. La norma prevede che non si applicano sanzioni né interessi moratori al contribuente che si è attenuto a indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, anche se in seguito modificate. Questo significa, ad esempio, che se un contribuente ha seguito un orientamento ufficiale (circolare o prassi) dell’Agenzia delle Entrate, la sua condotta può essere tutelata dall’esonero da sanzioni. Il principio è stato rafforzato negli ultimi anni (legge delega 111/2023 e D.Lgs. 219/2023) e trova applicazione anche in tema di IVA, proteggendo l’affidamento del contribuente sulle direttive dell’Amministrazione.
- Normativa UE (Direttiva IVA 2006/112/CE): Sebbene qui non direttamente citata, va ricordato che la disciplina IVA comunitaria impone ai Paesi membri di esigere l’IVA solo se i soggetti della catena sono affidabili. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE richiede di trattare il cessionario IVA in buona fede come un normale contribuente a meno che non ci siano gravi indizi di frode (principio di protezione dell’acquirente in buona fede). Tuttavia, tale protezione collima con l’onere probatorio che vedremo in seguito.
Riepilogo delle norme principali:
| Reato tributario | Norma di riferimento | Pena |
|---|---|---|
| Dichiarazione fraudolenta (fittizie) | Art. 2 D.Lgs. 74/2000 | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni |
| Emissione fatture inesistenti | Art. 8 D.Lgs. 74/2000 | Reclusione da 4 a 8 anni |
| (Altri reati IVA: art. 3, 4, 5, 10 ecc.) | D.Lgs. 74/2000 (altri artt.) | Pene variabili |
| Neutralità IVA / Presunzioni | Art. 54 DPR 633/1972 (IVA) | – Indirizzo procedurale |
| Legittimo affidamento | Art. 10 L. 212/2000 | – Principio di tutela del contribuente |
(Vedi Tabella 1 in calce per un riepilogo comparativo di reati e sanzioni)
Come funziona la frode carosello
Per preparare una difesa va compreso il meccanismo operativo della frode carosello. In termini semplificati, lo schema tipico prevede:
- Società cartiere o “missing trader”: soggetti creati ad hoc (o utilizzati) come intermediari fittizi. Normalmente acquistano beni in intracommercio (da Paesi UE) applicando il regime di esenzione IVA. Ufficialmente, non dovrebbero versare imposta all’erario.
- Cessione e mancato versamento IVA: Successivamente, tali società rivendono i beni a prezzi competitivi sul mercato nazionale applicando l’IVA. Riscottono dunque l’imposta dal cliente, ma non la versano allo Stato e spariscono (fallendo o cessando l’attività). Il risultato è che hanno prodotto indebitamente crediti IVA a proprio favore e il bilancio dello Stato ha subito una perdita.
- Acquirenti successivi/beneficiari finali: A valle si trovano una o più imprese “clienti” (talvolta inconsapevoli). Queste ultime hanno diritto (in linea di massima) a detrarre l’IVA pagata in acquisto. Poiché l’IVA non è stata versata in precedenza dai soggetti intermedi, esse ottengono indotti crediti IVA o prezzi di acquisto stracciati. In alcuni circuiti ancora più elaborati, la merce può essere riesportata all’estero, chiudendo idealmente il cerchio (da cui il termine “carosello”); oppure può tornare al primo anello della catena.
Ad ogni passaggio, possono intervenire ulteriori società di “comodo”, anche con altri ruoli (es. per facilitare la giustificazione dei crediti IVA nei successivi rimborsi). A volte il carosello riguarda beni di largo consumo, elettronica o auto, dove è più facile nascondere il valore. L’elemento chiave è però sempre la documentazione ingannevole: fatture e documenti di trasporto simulati che attestano cessioni fittizie o soggetti diversi da quelli reali.
In concreto, se il contribuente oggetto di indagine è un imprenditore che ha acquistato merci da un fornitore comunitario poi reso “eversore di frode”, la sua posizione dovrà chiarire:
- Se le operazioni contestate sono realmente avvenute. In tal caso proverà l’effettiva fornitura (ad esempio tramite bolle di consegna, lettere di vettura, contratti, ordini, documentazione doganale, comunicazioni Intrastat, estratti conti bancari con accrediti, ecc.). La sola esibizione di fatture può non bastare.
- Se egli ignorava la natura fraudolenta delle operazioni. Ciò implica analizzare i rapporti (eventuali legami societari o familiari con i soggetti coinvolti, contesto di mercato, anomalie nell’operatività). Se non c’erano elementi che potessero ragionevolmente far insospettire l’imprenditore (prezzi in linea di mercato, eccessiva mole di operazioni, mancanza di padroncini/strutture riconoscibili, ecc.), si potrà invocare la buona fede.
Un caso classico è quello in cui un’impresa di distribuzione acquista merci a buon mercato e successivamente le rivende: se però il fornitore era un “cartiere” inesistente, l’IVA su quel acquisto era fraudolenta. Il compratore può difendersi mostrando che – ad esempio – aveva un sito web legittimo il fornitore, che ha pagato con bonifico, che sono state emesse fatture regolari e trasporti con firme autenticate, ecc. Tuttavia, come vedremo, la giurisprudenza tende a non privilegiare eccessivamente la mera forma: spetta al contribuente dimostrare l’effettività del contratto. La Corte di Cassazione ha stabilito che, quando l’Amministrazione contesta la veridicità di un’operazione, “non è sufficiente produrre la relativa fattura: bisogna dimostrare la stipulazione del contratto”.
Esempio pratico (simulazione): Supponiamo che la società italiana “Alpha s.r.l.” acquisti 1000 pezzi di componenti elettronici da una società ungherese “Beta Kft.”, senza versare IVA (cessione intracomunitaria). Alpha li rivende in Italia a “Gamma s.r.l.” applicando IVA. Se, successivamente, Gamma (o l’Amministrazione) scopre che Beta Kft. non esisteva o non operava sul mercato (era una cartiera), può scattare il sospetto di frode carosello. Alpha dovrà allora provare di aver realmente ricevuto la merce (bolle, dogane, bonifici, ecc.) e che Beta era in regola (ad es. i registri IVA di Beta, le comunicazioni Intrastat, ecc.). Se non troverà tali prove, l’Agenzia delle Entrate potrà rettificare l’IVA (non riconoscendo la detrazione). Se invece le indagini penali dimostrano che Alpha sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, potrà essere indagato penalmente per reati tributari (art. 2 e/o 8).
Accertamento fiscale e procedimento penale
Il contribuente coinvolto in un sospetto di frode carosello si trova spesso a dover affrontare due fronti paralleli: il contenzioso tributario (per la pretesa dell’Agenzia delle Entrate) e il procedimento penale (per eventuali accuse penali). È fondamentale capire le differenze tra questi due rami di giurisdizione:
- Accertamento tributario: L’Agenzia delle Entrate può notificare uno o più avvisi di accertamento. In tali atti l’ufficio contesta le operazioni (soggettivamente o oggettivamente inesistenti) e richiede il pagamento di IVA non versata o deduzioni fittizie, maggiorazioni sanzioni e interessi. Il contribuente può proporre ricorso in Commissione Tributaria presentando documenti a sua difesa. Nel processo tributario, il giudice valuta in primo luogo gli aspetti contabili e civilistici: esistenza o meno della cessione, effettività dei pagamenti, coerenza dei prezzi, regolarità formale delle scritture. La Cassazione ha però chiarito che nei casi di operazioni inesistenti l’Amministrazione deve provare l’alterità del fornitore e la possibile consapevolezza del contribuente; una volta fatti questi accertamenti induttivi, grava sul contribuente dimostrare la propria buona fede e diligenza.
- Procedimento penale tributario: Parallelamente, se emergono indizi di reato, la Procura (a volte sollecitata dagli accertamenti) può avviare un’indagine penale e processare l’imprenditore (o l’amministratore) accusato di frode fiscale. In sede penale l’accusa deve dimostrare il dolo specifico e la commissione del reato (parte oggettiva e soggettiva). Il difensore tecnico (avvocato penalista) deve disputare gli elementi della fattispecie (dimostrando ad esempio assenza di dolo) e può chiedere riti alternativi (abbreviato, patteggiamento se opportuno). La sentenza penale, se favorevole (assoluzione), può costituire elemento di prova nel successivo giudizio tributario secondo limiti precisi: la Cassazione ha riconosciuto che l’assoluzione penale “perché il fatto non sussiste” è vincolante nel giudizio tributario sullo stesso fatto, mentre l’assoluzione “perché non vi è colpevolezza” è meno efficace.
- Differenze di prova: Nel processo penale l’imputato gode del principio di ragionevole dubbio. L’accusa deve provare oltre ogni ragionevole dubbio la frode, e il reo può beneficiare dell’onere della prova favorevole (ad esempio dimostrando che non c’era dolo). Nel processo tributario invece vige il criterio della preponderanza e le regole procedurali civili: il giudice tributario può utilizzare elementi presuntivi e indizi forniti dal Fisco anche se non provati penalmente, purché le parti riesaminino autonomamente quelle prove.
- Verifiche e sanzioni preventive: L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono eseguire perquisizioni documentali e sequestri preventivi (anche di beni e conti correnti) se ritengono di dover cautelare l’erario. Il contribuente deve opporsi in tribunale e dimostrare la legittimità delle proprie attività. Il D.Lgs. 75/2020 (attuazione Direttiva PIF) ha introdotto norme specifiche per frodi transnazionali (soglia 10 milioni) e potenziato i sequestri, ma ha anche previsto misure straordinarie (ad es. cooperazione obbligatoria del debitore con lo Stato di richiesta se il credito non è reale).
Tabella 2 – Differenze fra procedimento penale tributario e giudizio tributario (IVA)
| Aspetto | Procedimento penale | Giudizio tributario |
|---|---|---|
| Scopo | Accertare la commissione di reati (es.: frode fiscale, omesse dichiarazioni) | Accertare la corretta determinazione dei tributi dovuti (IVA, IRES, ecc.) |
| Partecipanti | Pubblico Ministero (Procura), indagato/imputato, giudice penale | Agenzia Entrate, contribuente, giudice tributario |
| Onere della prova | Spetta al P.M. provare ogni elemento del reato (dolo incluso) | Spetta al Fisco provare induttivamente la frode (alterità e dolo del cessionario); poi il contribuente deve confutare (diligenza buona fede) |
| Regole probatorie | In dubio pro reo; necessarie prove oltre ogni ragionevole dubbio | Giudice valuta indizi e presunzioni (art.54 DPR 633/72); più favorevole al Fisco |
| Effetti sentenza | Assoluzione per “il fatto non sussiste” libera da illecito tributario negli stessi atti (giudicato penale esterno) | Sentenza tributaria (annullamento o conferma dell’accertamento) con effetti contabili e sanzionatori |
| Esempio | Condanna se provato dolo specifico (plusvalori IVA) | Annullamento dell’accertamento se fallite presunzioni sul “cartiere” (esempi) |
Ogni processo deve rispettare la propria autonomia: per esempio, il giudice tributario non può automaticamente trasformare un’assoluzione penale in vittoria del contribuente, ma deve riesaminare i fatti alla luce degli elementi contabili e del contraddittorio tra le parti. Tuttavia, la pronuncia penale costituisce “principio di diritto” e può influire (nell’ambito delle proprie regole) anche sul contenzioso tributario.
Onere della prova nelle frodi carosello
Un aspetto cruciale nella difesa è comprendere chi deve provare cosa. In materia di operazioni soggettivamente inesistenti (fatture false), la giurisprudenza ha chiarito la ripartizione dell’onere probatorio:
- Amministrazione finanziaria: Deve anzitutto provare la situazione di frode. In pratica, deve dimostrare che le operazioni fatturate sono effettivamente inesistenti (attraverso presunzioni, indici, o dati certi) e che il cessionario (il contribuente) era consapevole o avrebbe dovuto esserlo che si trattava di una evasione. In altre parole, l’Ufficio deve fornire indizi oggettivi di alterità soggettiva (il fornitore formale non è quello reale) e di consapevolezza dell’evasione. Ad esempio, può produrre risultanze di indagini penali (deposizioni di indagati, verifiche su registrazioni contabili irregolari, documenti ufficiali che attestano l’inattività del fornitore, relazioni della GdF che dimostrano la natura di società “di comodo”, ecc.). In sintesi, l’Amministrazione deve costruire una presunzione fondata sulla “non attitudine a pagare l’IVA” o su segni tipici di fraudolenza (assenza di contabilità regolare, rapporti di parentela tra soggetti coinvolti, utenze inesistenti).
- Contribuente: Una volta che l’Ufficio ha assolto il suo onere induttivo, ricade sul contribuente l’onere di provare l’estraneità alla frode. In parole semplici, deve dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza prevista per un operatore attento. Ciò significa fornire ogni elemento utile a smentire la presunzione d’evasione: contratti firmati, pagamenti effettivi (bonifici documentati e tracciabili), autenticità dei documenti di trasporto con firme reali, presenza di dipendenti e luoghi operativi nel fornitore, pagamenti di imposte o contributi da parte di quest’ultimo, rapporti commerciali precedenti e successivi coerenti, ecc. In pratica, il contribuente deve dimostrare di aver agito «con la diligenza massima esigibile», cioè di aver svolto accertamenti ragionevoli sulle controparti e di non aver ignorato segnali di allarme. Se riesce a farlo, potrà vincere il contenzioso tributario (ottenendo l’annullamento dell’avviso) e a suo favore si leverà il dubbio penale.
La Cassazione, confermando questo indirizzo, ha affermato: “incombe sull’Amministrazione [finanziaria] l’onere di provare… che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo… della sostanziale inesistenza del contraente”. E prosegue che, una volta raggiunto tale onere con indizi specifici, “grava sul contribuente la prova contraria di avere… adoperato… la diligenza massima esigibile da un operatore accorto”. In altre parole, il tribunale tributario non può condannare solo sulla base di meramente formali presunzioni: deve accertare che il contribuente poteva o doveva ragionevolmente sapere della frode, a meno che non riesca a provare il contrario con fatti concreti.
Tabella 3 – Onere della prova nelle operazioni inesistenti (frode carosello)
| Soggetto | Prova richiesta |
|---|---|
| Amministrazione finanziaria | Dimostrare (anche con presunzioni) che:- il fornitore formale era “cartiere” (inesistente o fittizio);- il cessionario/contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione era fraudolenta.(Es. atti penali, verifiche fiscali, dichiarazioni indagati) |
| Contribuente | Dimostrare il contrario, ossia:- l’operazione era reale (effettiva consegna dei beni, effettivi pagamenti);- ha agito in buona fede con la massima diligenza: nessun indizio ragionevole di frode era presente (accordi seri, situazioni aziendali normali, prezzi di mercato, rapporti chiari). |
(I consigli pratici nel contenzioso fiscale sono: produrre immediatamente ogni documento contabile e di trasporto, raccogliere testimonianze interne, segnalare irregolarità dell’informatica fiscale – ad es. segnalazione di F24 non corretti – o fare perizie su firma e carta; inoltre, evidenziare sempre l’assenza di vantaggi economici personali: se si pagava un prezzo di mercato o superiore, se non è stato fatto ricorso a compensazioni, questo può aiutare a inferire buona fede.)
Da ultimo, vale la pena ricordare che anche il principio del diritto comunitario può intervenire. La Corte di Giustizia UE ha di recente stabilito che, qualora non sussista prova della frode (ad es. operazioni inesistenti senza dolo), il contribuente va trattato come un normale acquirente IVA e può recuperare la detrazione (o chiedere restituzione). Questo vuol dire che, in difesa, si può far leva sull’assunto che “se non c’è la frode, l’IVA si rettifica e il cessionario ottiene il rimborso” (principio di tutela del legittimo affidamento nel diritto UE).
Strategie difensive nel processo tributario
Quando ci si difende nel giudizio tributario, vale la pena adottare un approccio metodico e documentato. Ecco alcune linee guida:
- Documentazione contabile e logistica: Prodotti tutti i documenti giustificativi delle operazioni contestate: fatture, bolle di consegna, contratti, estratti conto. Se possibile, presentare anche report interni, contratti quadro, e fatture di acquisto di materie prime/beni venduti in sequenza. Far notare la coerenza d’insieme (es. se tutte le bolle e fatture quadrano con consegne realmente avvenute, se esistono documenti doganali per le importazioni, ecc.). La Corte ha ammonito che, nell’accertamento induttivo-analitico, l’amministrazione non può basarsi “meramente su documenti formali… senza adeguata congruenza sostanziale”. Bisogna quindi sforzarsi di mostrare la realtà economica dietro i numeri.
- Buona fede e “massima diligenza”: Far emergere le buone prassi aziendali e il grado di coinvolgimento effettivo del legale rappresentante. Ad esempio: se l’amministratore era all’oscuro, può utilizzare l’esimente dell’errore scusabile o contestare l’aggravamento per dolo. Se ha chiesto perizie di per conto dell’azienda (valutazioni contabili, verifiche esterne, consulenze), ciò testimonia diligenza. Presentare testimonianze di dipendenti (contabili, responsabili vendite) che confermano procedure interne chiare e prassi di verifica.
- Profilo del fornitore interposto: Se possibile, indagare sullo status del fornitore estero. Far rilevare che era effettivamente registrato (con CEE VAT number), depositare eventuali certificazioni d’incarico, ditta autorizzata a svolgere l’attività. Se la Società “cartiera” risultava parimenti strutturata (sede, ragione sociale coerente, oggetto sociale comprensivo), allegare documentazione (visure camerali, visure CCIAA estere, contratti con sub-fornitori). In alcuni casi, sentenze di merito (CTR/CPT) hanno accertato che operazioni oggettivamente esistenti escludono la frode anche se il fornitore aveva scarsi requisiti (infra vedi sent. pronunte). Sottolineare comunque l’esistenza di un accordo effettivo tra le parti, come emergente dai pagamenti tracciati.
- Eccezione di non contestazione: Nella fase di appello tributario, se l’Agenzia non impugna specificamente alcuni profili evidenziati in primo grado (es. la verifica della effettiva esistenza materiale della merce), il contribuente può richiamare il principio della “non contestazione” (art. 115 c.p.c.) e chiedere che tali fatti siano considerati acquisiti. Attenzione però: la Corte di Cassazione ha chiarito che tale principio opera solo verso fatti chiaramente dedotti e non contestati.
- Rimborso e credito IVA: Se il problema centrale riguarda l’indebita detrazione IVA, si può argomentare (come già fatto dalle sezioni tributarie) che, in assenza di dolo dimostrato del cliente, la detrazione anche dal punto di vista comunitario era legittima. Ad esempio, la Corte UE ha affermato che “se l’IVA non è stata effettivamente evasa, il diritto alla detrazione rimane” (C-97/17) – un principio ripreso anche in Cassazione civile. Quindi si può chiedere il riconoscimento delle detrazioni e il rimborso (o l’annullamento dell’accertamento) anche sulla base di tale ragionamento di diritto comunitario e di legittimo affidamento europeo.
- Definizione agevolata e conciliazione: In alcuni casi, può convenire concludere il contenzioso in via stragiudiziale. Ad esempio, le definizioni agevolate per il contenzioso tributario (risoluzione delle liti) o le conciliazioni in Commissione Tributaria consentono di ridurre sanzioni e interessi, talvolta fermandosi al pagamento del tributo contestato senza penalità maggiori. Questi strumenti non preludono ad ammettere la colpevolezza, ma evitano il rischio di una sentenza sfavorevole. In alternativa, estendere il credito (saldo e stralcio) o chiedere una rateizzazione può attenuare gli effetti economici.
- Interazione con il penale: Se nel frattempo è in corso il processo penale, valutare attentamente le modalità di difesa penalistica. L’esito penale può influenzare: un’assoluzione perché “il fatto non sussiste” può costituire giudicato esterno che l’accertamento tributario deve tenere in considerazione (soprattutto se riguarda la medesima fattispecie). Viceversa, una condanna penale potrebbe, per il giudice tributario, rafforzare la conclusione sulla frode (ma formalmente non vincola come giudicato). Perciò, se il penalista ottiene un proscioglimento per insufficienza di prove, questo va enfatizzato nel ricorso tributario.
Domande e risposte (FAQs)
D.1 Che cos’è esattamente una frode carosello?
R. Una frode carosello è un meccanismo di evasione dell’IVA attraverso vendite fittizie tra società. Di solito si crea una catena in cui un’impresa italiana acquista beni da un fornitore UE a IVA zero (acquisto intracomunitario), poi rivende i beni con IVA, ma i soggetti intermedi applicano l’IVA senza versarla. Tra i soggetti coinvolti ci sono spesso società cartiere (che “producono” fatture false) e beneficiari finali che pretendono rimborsi IVA. Il risultato è che allo Stato manca l’imposta di cui non si è provveduto al versamento, mentre i frodatori ottengono illegalmente un credito IVA. Dal punto di vista giuridico la frode carosello realizza i reati fiscali di cui agli articoli 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000.
D.2 Cosa rischio penalmente se sono coinvolto in una frode carosello?
R. Chi viene ritenuto penalmente responsabile può essere accusato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti (art.2) o di emissione di fatture false (art.8) del D.Lgs. 74/2000. Entrambe le fattispecie sono delitti gravi, puniti con reclusione (vedi Tabella 1). Inoltre si possono aggiungere reati come omesse dichiarazioni (art.5), omessi versamenti (art.10) o reati societari e fallimentari connessi (se il soggetto fallisce o porta la società al dissesto). In pratica, il rischio penale è tanto più elevato quanto più appare provato il dolo: se l’indagine dimostra la consapevolezza nella frode, la pena può essere alta. Il recente incremento delle soglie di punibilità (legge 157/2019 e D.Lgs. 87/2024) ha ulteriormente inasprito le pene per i reati di frode fiscale transnazionale.
D.3 Posso evitare il carcere se pago subito il dovuto?
R. L’eventuale pagamento del debito erariale (imposte, sanzioni, interessi) non estingue automaticamente il reato penale, ma può essere preso in considerazione dal giudice come circostanza attenuante o come indicatore di buona fede attenuata. In alcuni casi l’ordinamento prevede la causa di non punibilità per “pubblico credito” (art. 5, comma 3, D.Lgs. 74/2000): se il contribuente paga interamente il debito prima della sentenza, può evitare la condanna. Tuttavia, ciò si applica solo entro i termini procedurali previsti e se non sono stati già conlusi accordi (es. patteggiamento). Nella pratica, la difesa deve valutare se raggiungere un accordo (concordato penale o patteggiamento) o procedere al dibattimento, ma in ogni caso è fondamentale mostrare al giudice la volontà di ripristinare la correttezza fiscale. Nel processo tributario, invece, il pagamento dell’imposta riduce semplicemente la maggiore imposta richiesta; resta in ogni caso possibile proporre deflazione o transazione prima della sentenza.
D.4 Come posso provare di aver agito in buona fede?
R. È essenziale raccogliere tutte le evidenze che dimostrino l’effettiva condotta diligente: contratti firmati, pagamenti tracciati (bonifici specifici per IVA), produzione consegnata e documentata, verifiche sul fornitore (ad es. che rispetta registri IVA, che i beni erano di qualità attesa). Si sottolinei sempre di aver pagato prezzi di mercato e di non aver saputo nulla di illecito (ad esempio, evidenziando che la società fornitore risultava operativa dai registri ufficiali finché ha agito). Testimonianze di dipendenti o collaboratori che hanno seguito le pratiche di controllo sono utili. Occorre spiegare ogni disallineamento formale e mostrare che l’errore (se c’è stato) non dipendeva dal contribuente ma da condotte fraudolente altrui. A volte può aiutare dimostrare anche l’esito favorevole di eventuali audit interni o consulenze legali a cui ci si era affidati.
D.5 Il fatto di non aver contestato l’IVA nell’avviso di accertamento mi pregiudica?
R. Nel processo tributario vige il principio della non contestazione (art. 115 c.p.c.), secondo cui l’Amministrazione non può ribaltare in appello questioni già decise in primo grado. Se un contribuente ha prospettato motivi precisi che il Fisco non ha contestato, tali motivi sono considerati accettati. Tuttavia, la giurisprudenza precisa che va considerato il “fatto” non contestato, non solo il fatto giuridico: in poche parole, bisogna che l’Ufficio abbia avuto piena consapevolezza del rilievo e lo abbia ignorato nelle impugnazioni. In tema di frode carosello, ciò si traduce nel dover verificare se l’Amministrazione ha effettivamente sollevato eccezioni sui profili tecnici e processuali nei motivi d’appello. In ogni caso, è un tema di procedura: la difesa dovrebbe comunque occuparsi principalmente di smontare il reato dimostrando inattendibilità delle presunzioni e attualità delle prove a suo favore.
D.6 Qual è la prescrizione per i reati di frode IVA?
R. I reati fiscali hanno prescritto con la legge di riforma del 2019 (L. 157/2019) con un termine legato alla gravità: per una frode carosello “ordinaria” (IVA), il reato prescrive in 6 anni (3+3, raddoppiato se recidiva). Se la frode ha superato certi importi (attualmente 1,5 milioni di euro di IVA evasa), la pena minima sale, e la prescrizione può arrivare fino a 8 anni. Va ricordato che il termine di prescrizione si interrompe con il processo (es. con la sentenza di primo grado). Gli avvisi di accertamento tributario, invece, si prescrivono generalmente in 5 anni (10 per reati), con possibilità di sospensione. In ogni caso, la difesa deve fare attenzione alle prescrizioni collegate (es. prescrizione dell’obbligo contributivo, dell’accertamento stesso, del reato penale) per eventualmente eccepire decadenze.
D.7 Mi hanno sequestrato i beni: come posso reagire?
R. Il sequestro preventivo è una misura cautelare disposta dal giudice penale (su richiesta del P.M.) o dal giudice tributario per bloccare beni e conti considerati profitto di reato o garanzia dell’erario. Se ciò accade, il contribuente deve proporre immediata opposizione: in sede penale può chiederne la revoca o la conversione in forme meno gravose, dimostrando cooperazione e eventuale parziale pagamento. Nel processo tributario, esistono limiti alla confisca degli illeciti: il recente D.Lgs. 87/2024 ha previsto che non si possa confiscare quanto il contribuente sta restituendo sotto forma di debito tributario riconosciuto. In genere, se il sequestro appare ingiustificato (eccesso di valore, beni estranei al reato), si deposita in Cassazione o si presenta istanza di dissequestro, facendo leva sulla mancanza dei presupposti legali (corrispondenza tra beni e presunti importi evasi, concreta integrazione del reato).
D.8 L’avere pagato il mio commercialista o consulente mi può esonerare?
R. Rivolgere la responsabilità sul professionista di turno (consulente, commercialista) può essere una linea difensiva, ma con cautela. In generale, la legge penale tributaria punisce il contribuente obbligato alla dichiarazione (o i suoi amministratori) anche se un consulente ha effettivamente compilato le carte. La Cassazione ritiene che, sebbene il professionista possa influenzare il ravvedimento del dolo, “il compimento di atti eseguiti da dipendenti o da consulenti non esime il soggetto obbligato” (Cass., 17 marzo 2015). Tuttavia, si può usare l’argomento dell’affidamento: se il contribuente ha fornito informazioni corrette e il consulente ha sbagliato, il contribuente dovrebbe non essere considerato automaticamente fraudolento. Ciò non toglie che in giudizio penale l’esperto (anche perito informatico o di bilancio) potrà essere sentito come testimone a difesa, per spiegare come siano possibili errori formali senza dolo del titolare.
D.9 L’avviso di accertamento dice “cartiere inesistenti”: come affrontarlo?
R. In presenza di un’accusa di società cartiera, bisogna opporsi mostrando documenti di effettiva operatività. È utile dimostrare che la società “incriminata” aveva reale struttura (sede, C.C.I.A.A., bilanci) e/o ha svolto attività (licenze, contratti con fornitori, relazioni periodiche alle autorità). Se esistono precedenti doc: ad es. contratti pluriennali con clienti, fatture regolarmente ricevute, registrazioni presenze di personale – tutto ciò serve a contrastare l’affermazione di “inesistenza”. A volte si ricorre a perizie su firme o verifiche notarili per confermare la validità di documenti altrimenti considerati fittizi. L’onere è pesante: come detto, spetta all’Ufficio inizialmente dimostrare con indizi specifici che quella società era di facciata, poi al contribuente dimostrare il contrario.
D.10 Che succede se esco assolto nel processo penale?
R. Se il giudice penale assolve con formula piena (“il fatto non sussiste” o “non ha commesso il fatto”), l’assoluzione diviene giudicato e può essere fatta valere nel giudizio tributario (per gli stessi fatti) come prova che non c’era frode. In tal caso, l’accertamento tributario fondato sugli stessi elementi dovrebbe cadere e pagherai solo quello che effettivamente spettava. Se invece l’assoluzione è per “non essere provato il dolo” (formula ampia di non colpevolezza), tale sentenza non è vincolante nel tributario: il giudice fiscale potrà comunque rigirare sui fatti contabili con le proprie prove. In ogni caso, un risultato penale positivo va sempre segnalato al giudice tributario (ricorso o appello), perché costituisce un elemento a favore del contribuente.
Strategie difensive nel processo penale
Nella fase penale investigativa e dibattimentale sono altrettanto essenziali alcune mosse:
- Difesa in fase di indagine: In caso di perquisizione o avviso di garanzia, esercitare il diritto al silenzio, ma nominare subito un avvocato penalista esperto di reati tributari. Vanno subito raccolti documenti contabili in copia, svolte audizioni con il proprio consulente tecnico fiscale e preparata la possibile istanza di dissequestro. Spesso si può nominare subito un perito di parte (commercialista o perito contabile) che assista alle perquisizioni e rediga una consulenza tecnica preventiva sulle posizioni contestate. Questo aiuta a contrastare sul nascere le tesi accusatorie.
- Scelta del rito: Se le prove a carico sono fragili, può convenire andare a giudizio ordinario (dibattimento) puntando a dimostrare l’assenza di dolo o l’errore. Se invece emergono prove schiaccianti ma con alcune attenuanti (per esempio pagamento integrale del debito, collaborazione), il patteggiamento o il giudizio abbreviato (con riduzione di pena fino a 1/3) possono essere opzioni. In ogni caso, la strategia dipende dalla fase: se le indagini non sono concluse, si può chiedere l’archiviazione per mancata prova; se c’è già rinvio a giudizio, si valutano gli accordi.
- Contestare il dolo: Il nocciolo del reato è il dolo specifico. La difesa deve argomentare l’assenza di consapevolezza: sottolineare che le operazioni contestate potevano apparire lecite all’imprenditore e che egli non ha mai tratto vantaggio personale indebito (i ricavi dall’operazione erano comparabili con il mercato). A tal fine può essere utile chiedere consulenze tecniche (es. perizie di prezzo di mercato o di firma) e sentire testimoni (fornitori e clienti dell’imputato) che confermino la regolarità delle operazioni o l’assenza di segnalazioni precedenti. Se l’amministratore era terzo (es. amministratore di fatto) rispetto agli autori della frode, è possibile far leva sulla propria estraneità.
- Legittimo affidamento e circolari interne: Se è provabile che il contribuente ha agito in base a errori dell’amministrazione (per es. risposte personalizzate dall’Ufficio, lettera di assistenza fiscale, equivoci su pratiche pec), si può invocare il legittimo affidamento (art.10 Statuto) anche in sede penale, come fatto recente Cass. 29153/2021. Ciò può escludere il dolo: il contribuente ha agito in ossequio a certe interpretazioni governative, non con intenzione di frodare.
- Eccesso di confisca: Se nel provvedimento cautelare sono stati confiscati beni che superano il profilo delittuoso (es. attivo patrimoniale personale), la difesa può contestare l’improporzionalità della misura. Con la riforma D.Lgs. 75/2020 e 87/2024, esistono tutele maggiori: per esempio non si può confiscare più di quanto corrisponda all’imposta evasa riconosciuta in via definitiva. Si possono proporre ricorsi specifici al Tribunale del riesame o in sede di riesame del sequestro per ottenere la rimodulazione della confisca.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Principali reati tributari connessi alla frode carosello
| Fattispecie | Norma di riferimento | Sintesi tipica |
|---|---|---|
| Dichiarazione fraudolenta (operazioni inesistenti) | Art. 2, D.Lgs. 74/2000 | Uso di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni (passività fittizie). Dolo specifico di evasione fiscale. |
| Emissione di fatture inesistenti | Art. 8, D.Lgs. 74/2000 | Emissione di fatture false con lo scopo di far evadere IVA a terzi (crediti IVA fittizi). Dolo specifico. |
| Simulazione (altri artifici) | Art. 3, D.Lgs. 74/2000 | Operazioni simulate od omesse in dichiarazione (es.: fatture alterate) fuori dai casi dell’art.2. |
| Omessa dichiarazione | Art. 5, D.Lgs. 74/2000 | Omesso invio dichiarazione periodica IVA. |
| Omesso versamento | Art. 10, D.Lgs. 74/2000 | Mancato versamento IVA contabilizzato o compensato in modo illecito. |
| Neutralità IVA / presunzioni | Art. 54, DPR 633/1972 | Presunzioni fiscali (indizi) utilizzabili per dimostrare evasione IVA. |
| Legittimo affidamento (tutela amministrativa) | Art. 10, L. 212/2000 | Esonero da sanzioni se il contribuente si è basato su indicazioni dell’Amministrazione. |
Tabella 2 – Procedimento penale vs processo tributario nel carosello IVA
| Aspetto | Procedimento penale (reato tributario) | Contenzioso tributario (accertamento IVA) |
|---|---|---|
| Oggetto | Verifica di reati tributari (dichiarazione falsa, ecc.) | Verifica del tributo dovuto e delle detrazioni IVA |
| Norme applicate | D.Lgs. 74/2000 (art. 2,8,5,10), Codice penale | DPR 633/1972 (IVA), T.U. Imposte, Norme D.Lgs. 74/2000 |
| Soggetti coinvolti | Procura/PM, indagato/imputato (contribuente, amministratore), GdF, giudice penale | Agenzia Entrate, contribuente, giudici tributari |
| Onere della prova | Spetta al P.M. provare reato (dolo specifico compreso). L’imputato può sfruttare l’onere favorevole (in dubbio pro reo). | Spetta all’Agenzia provare alterità e dolo del contribuente; poi il contribuente deve provare buona fede e diligenza massima. (Notevolmente meno gravoso per il Fisco) |
| Tipologia di prove | Necessarie prove certo e incontrovertibile (documenti, testimonianze). Comunque si applica presunzione di innocenza. | Si utilizzano indizi, presunzioni (art. 54 DPR 633/72). Il giudice tributario può basarsi su elementi documentali e presuntivi autonomamente valutati. |
| Effetti della sentenza | Assoluzione per “il fatto non sussiste” diventa giudicato esterno (vincolante) nel tributario; condanna penale aggrava (può costituire presunzione di dolo in sede civile/tributaria). | Sentenza favorevole annulla l’accertamento (determinando ricalcolo dei tributi); condanna penale formale non automatica nel civile, ma spesso convoglia motivazioni di fatto. |
| Scadenze temporali | Termine prescrizionale fino a 6-8 anni (dipende dalla pena minima prevista). | Termine di decadenza per accertamento IVA: 4 o 5 anni (10 per frodi ex artt. 2,8). Termine appello tributario: 60 gg. dal grado precedente. |
Conclusioni
Difendersi da accuse di frode carosello richiede competenze trasversali di diritto tributario e penale. Dal punto di vista del contribuente (ossia del “debitor tributario”), è fondamentale muoversi con tempestività e rigore: raccogliere prove documentali sulla propria buona fede, preparare una strategia difensiva sia per il contenzioso tributario sia per quello penale, avvalersi di consulenti tecnici adeguati (commercialisti forensi e avvocati tributaristi e penalisti).
In particolare, le parole d’ordine di una difesa efficace sono:
- Cooperazione e documentazione: fornire spontaneamente al giudice tributario prove scrupolose dell’operatività della propria azienda e della controparte.
- Buona fede e diligenza: argomentare sempre che ogni possibile passo è stato fatto per evitare la frode, e che ogni anomalia era imprevedibile.
- Legittimo affidamento: ove possibile, invocare l’affidamento su indicazioni dell’Agenzia o sulla prassi consolidata (ad es. prassi internazionali, pareri legali interni, prassi bilaterali), richiamando l’art. 10 Statuto.
- Rispetto dei tempi: contestare la prescrizione penale se intervenuta, e nel contenzioso tributario non tralasciare alcuna impugnazione nei termini di legge.
Inoltre, va segnalata sempre alle autorità la presunta frode non appena se ne abbia notizia (ad es. segnalando passaggi anomali all’Ufficio) per riparare all’errore prima dell’accertamento, anche agendo con ravvedimento operoso se possibile. Se inibiti o già coinvolti, l’organizzazione di una difesa congiunta (tra tributarista e penalista) è indispensabile per evitare contraddizioni nelle argomentazioni.
Alla fine, ricordiamo che lo Statuto del Contribuente e la Costituzione tutelano il principio di correttezza e buona fede dell’amministrazione: l’azienda che dimostra di essere «parte lesa» dal sistema di frode, anziché coautrice, può ottenere un trattamento favorevole. In virtù dell’art. 10 Statuto, l’Amministrazione dovrebbe evitare sanzioni se il contribuente ha agito in conformità a indicazioni fino a quel momento date.
Le sentenze più recenti della giurisprudenza amministrativa di merito hanno cominciato a riconoscere che in presenza di indici di operatività concreti (meccanismi di pagamento tracciati, cliente finale “pulito”, mancanza di profitti anomali) la frode non è dimostrata, ribaltando l’accertamento【50†】. Allo stesso modo, alcune pronunce penali hanno rilevato l’assenza di dolo per amministratori di fatto che non potevano sapere di falsità contabili interne. Tali orientamenti vanno sempre portati all’attenzione del giudice per evitare di cadere nella definizione passiva di “carosello”.
In conclusione, la difesa tributaria in caso di frode carosello è complessa ma non impossibile. Occorre anzitutto trasparenza e prontezza nel fornire prove a propria discolpa, un uso mirato delle tutele processuali (non contestazione, ricorso tributario, opposizione a sequestro) e, soprattutto, una chiara ricostruzione di quanto realmente avvenuto, volta a dimostrare l’assenza di dolo. Una guida esperta (avvocato specialista) è essenziale per orientare le scelte strategiche, dall’esame dell’avviso di accertamento all’eventuale rito penale. Con la giusta preparazione, anche il contribuente accusato di frode carosello può provare il proprio estraneità ai fatti e ottenere sentenze a suo favore.
Fonti e riferimenti normativi
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (“Legge sui reati tributari”), articoli 2, 3, 5, 8 e seguenti (codice penale tributario).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, Testo Unico IVA, art. 54 (onere della prova e presunzioni nei tributi indiretti).
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto del contribuente”), art. 10 (tutela del legittimo affidamento e buona fede).
- Cassazione Civile, Sez. trib., ordinanza n. 4619 del 14/2/2023 (onere della prova nelle operazioni inesistenti).
- Cassazione Penale, sez. III, sentenza n. 21949 del 27/10/2010 (fatture come prova atto partecipativo).
- Corte di Giustizia UE, sent. C‑97/17 del 20/12/2018 (tutela del cessionario in buona fede nei rimborsi IVA).
- Normativa europea e sovranazionale: Direttiva 2006/112/CE, Direttiva 2017/1371 (PIF) e loro recepimenti (D.Lgs. 75/2020), per gli aspetti comunitari in tema di frodi IVA.
Difesa tributaria e frode carosello: come difendersi legalmente
Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per presunta frode carosello?
Vuoi sapere come funziona questo tipo di accusa e quali strumenti legali hai a disposizione per difenderti?
La frode carosello è un meccanismo illecito basato su operazioni intracomunitarie fittizie: società “cartiere” emettono fatture con IVA non versata, mentre altre imprese recuperano l’imposta a credito. Spesso, però, l’Agenzia delle Entrate estende le contestazioni anche a imprese che hanno avuto rapporti inconsapevoli con fornitori sospetti. In questi casi, la difesa si fonda sulla dimostrazione della buona fede e sull’adozione di normali cautele commerciali.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Analizza gli atti di contestazione e la documentazione fiscale e commerciale delle operazioni
📌 Verifica la correttezza delle prove utilizzate dal fisco e la reale esistenza delle operazioni
✍️ Predispone ricorsi e memorie difensive per dimostrare la buona fede e la legittimità delle detrazioni IVA
⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nel contenzioso tributario
🔁 Ti supporta nella pianificazione dei rapporti futuri con fornitori per ridurre il rischio di nuove contestazioni
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e frodi IVA complesse
✔️ Specializzato in difesa da accuse di frode carosello e utilizzo di fatture inesistenti
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Essere coinvolti in un’accusa di frode carosello non significa automaticamente essere responsabili.
Con una strategia legale mirata puoi dimostrare la tua buona fede, ridurre o annullare le pretese fiscali e tutelare la tua impresa.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro la frode carosello comincia da qui.