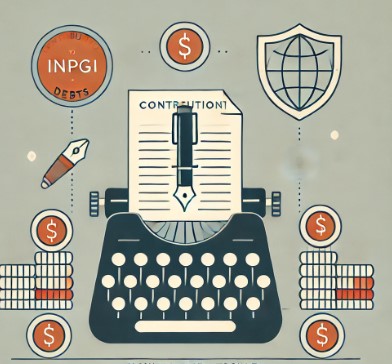Sei un giornalista e hai debiti contributivi con l’INPGI che non riesci più a pagare?
L’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) richiede agli iscritti il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Il mancato pagamento può far lievitare il debito per via di interessi e sanzioni, portando a cartelle esattoriali, pignoramenti e altre azioni esecutive. Conoscere i tuoi diritti e le strategie legali è fondamentale per evitare conseguenze gravi.
Quando un giornalista può accumulare debiti con l’INPGI
– Quando non versa i contributi minimi obbligatori per difficoltà economiche o periodi di inattività
– Quando interrompe l’attività giornalistica senza comunicare la cancellazione dall’ente
– Quando vengono richiesti contributi per periodi già prescritti o calcolati in modo errato
– Quando si sommano arretrati di più anni senza avviare piani di rateizzazione
– Quando le sanzioni e gli interessi fanno aumentare notevolmente l’importo originario
Cosa può accadere in caso di debiti con l’INPGI
– Notifica di cartelle esattoriali e avvisi di addebito
– Applicazione di interessi e more che aumentano sensibilmente il debito
– Pignoramento di conto corrente, stipendio o pensione
– Iscrizione di ipoteche su immobili di proprietà
– Difficoltà nell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali
Come difendersi legalmente
– Far verificare da un avvocato la correttezza degli importi richiesti e l’eventuale prescrizione
– Contestare contributi non dovuti o relativi a periodi di inattività documentabile
– Richiedere la rateizzazione del debito o valutare un saldo e stralcio in caso di grave difficoltà economica
– Attivare la procedura di sovraindebitamento per ridurre o cancellare legalmente le somme dovute
– Impugnare cartelle e atti esecutivi con vizi formali o sostanziali nei termini di legge
– Negoziare direttamente con l’ente o con l’agente della riscossione per ottenere condizioni sostenibili
Cosa si può ottenere con la giusta assistenza legale
– L’annullamento totale o parziale di contributi prescritti o non dovuti
– La riduzione consistente dell’importo complessivo
– La sospensione di pignoramenti e procedure esecutive
– La tutela del reddito e del patrimonio personale
– La possibilità di regolarizzare la posizione previdenziale e ripartire senza debiti
Attenzione: ignorare i debiti con l’INPGI non fa sparire la pretesa. Intervenire subito è l’unico modo per fermare l’aumento delle somme dovute e difendersi da azioni esecutive aggressive.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti previdenziali, difesa dei professionisti e sovraindebitamento – ti spiega come affrontare i debiti con l’INPGI e quali strumenti legali puoi utilizzare per proteggerti.
Hai ricevuto cartelle o avvisi di pagamento dall’INPGI?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, contesteremo eventuali somme indebite e troveremo la strategia legale più adatta per ridurre o eliminare il debito.
Introduzione
Un numero crescente di professionisti dell’informazione si trova ad affrontare debiti contributivi verso l’INPGI, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Si tratta di somme non versate al fondo pensione dei giornalisti, che possono comprendere contributi obbligatori non pagati, interessi di mora e sanzioni civili. Questa guida avanzata – aggiornata a luglio 2025 – offre un quadro completo su come difendersi da queste pretese contributive, con riferimenti normativi italiani, giurisprudenza recente (incluse sentenze di Cassazione e interventi della Corte dei conti), tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione domande & risposte.
Punto di vista del debitore: l’approccio adotterà la prospettiva di chi è tenuto al pagamento (il giornalista o il datore di lavoro obbligato), fornendo strategie legali e pratiche per tutelarsi. Il taglio è giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti legali (avvocati, consulenti) sia a privati e imprenditori che devono districarsi in questa complessa materia.
Nei paragrafi seguenti vedremo prima in sintesi che cos’è l’INPGI e chi vi è tenuto a contribuire (distinguendo la gestione principale “INPGI 1” e la gestione separata “INPGI 2”), poi analizzeremo come nascono i debiti contributivi e le loro conseguenze (interessi, sanzioni, effetti sulle pensioni), quindi passeremo alle strategie di difesa (prescrizione, opposizioni legali, strumenti di rateizzazione e definizione agevolata). Saranno evidenziate le ultime novità normative – ad esempio il passaggio della gestione principale all’INPS dal 1° luglio 2022 – e le sentenze più recenti che chiariscono questioni chiave (come l’obbligo contributivo per gli addetti stampa pubblici o il termine di prescrizione dei contributi omessi). Infine, una sezione di FAQ (domande e risposte) e tabelle riepilogative faciliteranno la consultazione rapida dei punti salienti.
Nota: tutte le fonti utilizzate sono riportate nell’ultima sezione Fonti. È fondamentale avere consapevolezza dei propri diritti e doveri in materia previdenziale: difendersi in modo efficace da richieste indebite o eccessive dell’ente previdenziale, oppure regolarizzare la propria posizione nel modo meno oneroso possibile, è possibile se si conosce la normativa e si agisce tempestivamente. Entriamo nel vivo dell’argomento partendo dalle basi: cos’è l’INPGI e quali contributi richiede ai giornalisti.
L’INPGI e gli obblighi contributivi dei giornalisti
Per comprendere come affrontare un debito contributivo con l’INPGI, occorre prima chiarire chi deve versare contributi all’INPGI e su quali redditi. L’INPGI (Istituto “Giovanni Amendola”) è la cassa previdenziale obbligatoria per la categoria dei giornalisti. Esso gestisce due regimi distinti:
- Gestione principale (INPGI 1) – riguardava i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, costituendo fino al 2022 una gestione sostitutiva dell’INPS (cioè in luogo dell’AGO, l’Assicurazione Generale Obbligatoria).
- Gestione separata (INPGI 2) – riguarda i giornalisti che svolgono attività autonoma (liberi professionisti titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, occasionali con ritenuta d’acconto, etc.). Questa gestione funziona in modo analogo alla “gestione separata” INPS per i freelance di altri settori.
Evoluzione recente: INPGI 1 confluito nell’INPS dal 2022
A causa di squilibri finanziari, il Legislatore è intervenuto con la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 103, L. 234/2021) disponendo che dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale dell’INPGI 1 fosse trasferita all’INPS. In altre parole, da quella data i giornalisti dipendenti confluiscono nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS. L’INPS è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dell’INPGI relativi alla gestione principale, garantendo la continuità delle tutele previdenziali.
Cosa significa in pratica? Che per i contributi dal 1° luglio 2022 in poi il datore di lavoro di giornalisti subordinati deve seguire le regole INPS (denuncia UniEMens, versamenti mensili con le nuove causali contributo INPS, ecc.). Anche per i periodi precedenti non ancora regolarizzati, la competenza passa all’INPS: le aziende con personale giornalistico assicurato all’INPGI 1 devono rivolgersi alle strutture territoriali INPS per sanare eventuali scoperture contributive. La gestione separata INPGI 2, invece, rimane in capo all’INPGI stesso, che continua ad operare come cassa autonoma per i giornalisti autonomi. L’INPGI dunque continua ad esistere dopo il 2022, ma limitatamente alla gestione separata (oltre a gestire alcune prestazioni minori).
Dal punto di vista del debitore, questo cambiamento implica che un debito contributivo verso l’INPGI 1 maturato fino al 30/6/2022 ora è di fatto gestito dall’INPS, mentre un debito verso INPGI 2 resta di competenza dell’INPGI. Ad esempio, se un giornalista dipendente non ha versato contributi per l’anno 2021, sarà l’INPS (succeduto all’INPGI) a occuparsi della riscossione e delle eventuali rateizzazioni dopo luglio 2022.
È importante sottolineare che il trasferimento all’INPS non ha cancellato i debiti pregressi: essi sono semplicemente passati in capo al nuovo ente creditore. L’INPS applicherà la propria disciplina per la gestione di queste esposizioni (come vedremo, ad esempio, per le richieste di rateazione).
Chi deve iscriversi e versare i contributi all’INPGI?
L’obbligo di contribuzione all’INPGI sorge in presenza di attività lavorativa di natura giornalistica esercitata da soggetti iscritti all’Albo professionale dei giornalisti (Elenco Professionisti o Pubblicisti). Vediamo le principali casistiche:
- Giornalista dipendente: ogni giornalista assunto con contratto di lavoro subordinato giornalistico (ad esempio redattore in un quotidiano, periodico, agenzia di stampa, ufficio stampa strutturato) era tenuto all’iscrizione all’INPGI 1. Il datore di lavoro doveva versare i contributi pensionistici all’INPGI, in misura analoga a quanto avviene per l’INPS (quota a carico dell’azienda e quota a carico del lavoratore trattenuta in busta paga). Questo valeva tanto per datori di lavoro privati (editori, testate, enti vari) quanto per enti pubblici che impiegassero giornalisti (si pensi agli addetti stampa nelle pubbliche amministrazioni). Da sapere: la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito in una storica sentenza del 2021 che anche i dipendenti pubblici assegnati a uffici stampa devono essere assicurati all’INPGI, a prescindere dalla qualifica formale attribuita dall’ente di appartenenza. In altri termini, se un’impiegato pubblico iscritto all’Albo svolge di fatto mansioni giornalistiche (redazione di comunicati, gestione rapporti con media, ecc.), la P.A. è tenuta a versare i relativi contributi all’INPGI, anche se il suo contratto non prevede esplicitamente il profilo di “giornalista”. Questo principio – fissato dalla Cass. SU n. 21764/2021 – ha portata generale: l’iscrizione all’INPGI dipende dall’attività effettivamente svolta (giornalismo) e dal possesso del titolo professionale, non dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
- Giornalista libero professionista: chi esercita attività giornalistica in forma autonoma (senza vincolo di subordinazione) è obbligato a iscriversi alla Gestione Separata INPGI (INPGI 2) e a versare i relativi contributi. Questo vale sia per i freelance titolari di partita IVA, sia per i collaboratori occasionali (es. pagati con ritenuta d’acconto o cessione di diritti d’autore per articoli). Non rileva il carattere abituale o occasionale dell’attività: anche poche collaborazioni possono far scattare l’obbligo contributivo, purché il soggetto sia iscritto all’Albo. La Corte di Cassazione ha affermato chiaramente che l’iscrizione all’Albo dei giornalisti fa sorgere l’obbligo contributivo INPGI per ogni attività giornalistica autonoma svolta, anche se occasionale e non abituale. Ciò che conta, oltre all’iscrizione all’Ordine, è l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato per quella attività (in tal caso sarebbe lavoro dipendente). Dunque, un giornalista pubblicista che scriva qualche articolo retribuito in modo autonomo deve comunque versare i contributi su quei compensi alla gestione separata INPGI. Esempio pratico: Tizio è iscritto all’elenco pubblicisti dal 2015 e svolge la professione di avvocato (iscritto alla Cassa Forense). Ogni tanto, però, scrive articoli per una rivista, venendo pagato con ritenuta d’acconto. Anche se l’attività giornalistica non è prevalente per Tizio, egli è tenuto a iscriversi all’INPGI 2 e a pagarvi i contributi su quei redditi giornalistici. Non vale, in questo caso, l’argomento della “doppia contribuzione”: il fatto che Tizio versi già contributi all’altra Cassa professionale per la sua attività principale (avvocato) non lo esonera dall’obbligo verso l’INPGI per l’attività giornalistica secondaria. La Cassazione ha respinto l’idea che esistesse un diritto a scegliere un solo ente di previdenza: se ci sono due attività diverse entrambe soggette ad assicurazione obbligatoria, i contributi sono dovuti in entrambi gli ambiti (salvo specifiche eccezioni di legge).
- Collaboratori coordinati e continuativi (Co.co.co.): una posizione peculiare è quella dei giornalisti parasubordinati, tipicamente collaboratori fissi di testate con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Dal 1° gennaio 2009, è stato previsto che anche i committenti che si avvalgono di giornalisti co.co.co. debbano versare i contributi alla Gestione Separata INPGI. In pratica, funziona in modo simile alla gestione separata INPS: il committente versa un’aliquota contributiva (ripartita 2/3 a suo carico e 1/3 a carico del collaboratore, trattenuto dal compenso). Per i co.co.co. giornalisti l’aliquota attuale è allineata a quella INPS (nel 2025, ad esempio, 14% sul compenso per la quota pensionistica se il collaboratore ha altra copertura previdenziale, oppure aliquota piena oltre il 30% se non ha altre coperture, oltre a un contributo minore per prestazioni di maternità e simili). Ciò significa che anche un committente non editoriale – ad esempio un’azienda privata o un ente – che stipuli un contratto di co.co.co. con un giornalista per attività giornalistica deve registrarsi all’INPGI come azienda e versare i contributi dovuti.
- Figure assimilate e casi particolari: la giurisprudenza ha incluso nell’obbligo INPGI anche figure non tradizionali, purché svolgano sostanzialmente mansioni giornalistiche. Ad esempio, è stato ritenuto dovuto l’INPGI per un webmaster impiegato in un ente pubblico le cui mansioni comportavano la pubblicazione di notizie con creatività e autonomia tipiche del lavoro giornalistico. Altro esempio, i capi ufficio stampa di aziende o enti, anche se formalmente inquadrati con qualifiche diverse, se svolgono compiti di informazione rientrano nella tutela INPGI (come confermato da numerose sentenze di merito e di Cassazione). L’obbligo contributivo all’INPGI prescinde dunque dal nomen iuris dato al rapporto di lavoro o collaborazione: ciò che rileva è la natura giornalistica dell’attività svolta.
In sintesi: deve versare all’INPGI chiunque eserciti la professione giornalistica in maniera riconosciuta, sia come lavoratore dipendente (fino al 2022 all’INPGI 1, ora INPS) sia come autonomo (INPGI 2), purché iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Non è invece tenuto all’INPGI chi non è iscritto all’Albo: ad esempio, se un’azienda impiega qualcuno per redigere testi pubblicitari o comunicazioni senza qualifica di giornalista, i contributi vanno all’INPS (come lavoro ordinario). Tuttavia, attenzione: far lavorare da “giornalista” una persona non iscritta all’Ordine può violare la legge sull’Ordine (L. 69/1963) e non esclude che l’INPGI, in caso di accertamento, possa rivendicare i contributi se ritiene che in realtà veniva svolta attività giornalistica. In passato, l’INPGI ha ottenuto l’iscrizione d’ufficio di alcuni soggetti all’Albo (registro praticanti) e il pagamento retroattivo dei contributi. Dunque, non ci si può sottrarre facilmente all’obbligo contributivo semplicemente non formalizzando il ruolo di “giornalista”: le verifiche possono arrivare.
Su quali redditi si pagano i contributi INPGI e in che misura
Per i giornalisti dipendenti (INPGI 1), la base imponibile contributiva era la retribuzione lorda annua, su cui si applicavano aliquote analoghe a quelle INPS (circa 33% complessivo, di cui 8.8% a carico dipendente). Erano previste aliquote aggiuntive per alcune prestazioni (es. 1% su quota eccedente il massimale per garanzia del fondo ex fissa). Dal 2022, queste regole sono state uniformate a quelle INPS ordinarie, con particolarità transitorie per chi aveva requisiti pensionistici maturati con l’INPGI.
Per i giornalisti autonomi (INPGI 2), la contribuzione si compone principalmente di due parti:
- il contributo soggettivo (pensione obbligatoria), calcolato sul reddito netto di lavoro giornalistico autonomo dichiarato ogni anno;
- il contributo integrativo, pari a una percentuale sul compenso lordo fatturato o percepito, che il giornalista dovrebbe aggiungere in fattura al cliente (simile all’IVA, ma trattenuto dall’INPGI).
Dal 2023-2025 le aliquote INPGI 2 sono state incrementate per rafforzare le entrate: attualmente il contributo soggettivo è del 12% sul reddito netto fino a €24.000, e del 14% sulla parte eccedente. In più vi è un contributo integrativo del 4% sul reddito lordo (senza massimale). Ad esempio, un freelance con €30.000 di reddito lordo 2025 pagherà circa €3.480 di contributo soggettivo (12% sui primi 24k = 2.880; 14% su 6k = 840) e €1.200 di integrativo (4% di 30k), per un totale di €4.680. Sono previsti contributi minimi annuali: anche in assenza di reddito, l’iscritto versa un minimo fisso per avere copertura annuale. Nel 2025, il minimale ordinario per professionisti con oltre 5 anni di anzianità è circa €426 annui, importo ridotto a €225 annui per i primi 5 anni di attività e a €275 per i pensionati che continuano a lavorare. Chi non raggiunge con i versamenti l’importo corrispondente al 12% di un reddito minimale (circa €18.555 annui nel 2025) ottiene un accredito figurativo ridotto (proporzionale) ai fini pensionistici.
Contributi sui compensi occasionali: se il giornalista percepisce compensi tramite ritenuta d’acconto o cessione diritti d’autore, anch’essi vanno denunciati all’INPGI 2. In genere su tali compensi non c’è un datore di lavoro che funga da sostituto: il giornalista dovrà versare sia il 12-14% soggettivo sia il 4% integrativo di tasca propria (il 4% può cercare di ottenerlo in più dal committente come maggiorazione, ma non sempre ciò avviene).
Periodicità dei versamenti (INPGI 2): i contributi minimi vanno versati entro una scadenza annuale (attualmente 31 luglio di ogni anno per l’anno in corso, deliberata in via amministrativa), mentre l’eventuale quota eccedente il minimo – in caso di redditi alti – a saldo entro fine ottobre (spesso frazionabile in tre rate tra ottobre e dicembre). Il giornalista autonomo deve inoltre comunicare ogni anno all’INPGI i redditi professionali dell’anno precedente (oggi tramite area online dedicata), entro la scadenza stabilita – attualmente 30 settembre dell’anno successivo. Questa comunicazione reddituale è fondamentale, come vedremo, anche ai fini della prescrizione dei contributi.
Riepilogo (tabella aliquote principali INPGI 2 nel 2025):
| Tipologia iscritto INPGI 2 | Contributo soggettivo (pensione) | Contributo integrativo (sul lordo) |
|---|---|---|
| Freelance >5 anni iscrizione | 12% del reddito netto fino €24.000; 14% oltre €24.000 | 4% del compenso lordo |
| Freelance ≤5 anni iscrizione (aliquota agevolata) | 12% del reddito (uguale fino a €24.000; dal 2024 è stata eliminata una precedente aliquota ridotta) | 4% del compenso lordo (minimo integrativo ridotto €20) |
| Pensionato che continua attività | 8% del reddito (aliquota ridotta straordinaria) | 4% del compenso lordo |
| Co.co.co. (senza altra copertura) | ~33% complessivo sul compenso (2/3 a carico committente, 1/3 trattenuto al collaboratore) | 0,72% aggiuntivo per prestazioni assistenziali |
| Co.co.co. (già assicurato altrove o pensionato) | aliquota ridotta (~24% complessivo) | 0,72% come sopra |
(Nota: aliquote soggettive in vigore nel 2025 secondo le delibere INPGI; potrebbero variare in futuro previa approvazione ministeriale. Il contributo integrativo del 4% non ha massimale e l’1% di esso viene accreditato sulla posizione individuale – cioè contribuisce alla pensione – mentre il restante 3% resta a disposizione della gestione come solidarietà.)
Ricordiamo infine che l’INPGI, pur essendo privatizzato (dal 1995 per la gestione principale e dal 1996 per la separata), resta un ente di previdenza obbligatoria soggetto a vigilanza pubblica (Ministeri del Lavoro e dell’Economia) e al controllo della Corte dei conti. Le norme statutarie e regolamentari dell’INPGI devono essere approvate dai Ministeri vigilanti; ad esempio, l’aumento delle aliquote o l’adesione a sanatorie statali (come la “rottamazione” delle cartelle) richiede un’approvazione ministeriale per essere efficace. Ciò significa che le tutele e le procedure sono in buona parte equiparate a quelle del sistema pubblico: i contributi INPGI sono obbligatori e la loro omissione comporta conseguenze giuridiche analoghe a quelle dei contributi INPS (mora, sanzioni, riscossione coattiva, persino eventuali profili penali nel caso di trattenute non versate, come vedremo).
Debiti contributivi con l’INPGI: cause e conseguenze
Un debito contributivo verso l’INPGI sorge quando i contributi dovuti non vengono versati nei termini previsti. Le situazioni possono essere diverse: dal giornalista freelance che non ha dichiarato o pagato i contributi su compensi autonomi, al datore di lavoro (azienda editoriale o ente) che ha omesso di versare i contributi per i suoi dipendenti o collaboratori giornalisti. Analizziamo anzitutto perché possono accumularsi debiti contributivi e quali effetti producono.
Perché si accumulano debiti contributivi (cause comuni)
1. Difficoltà finanziarie o crisi aziendali: Spesso l’omesso versamento è dovuto a problemi di liquidità. Un’azienda editoriale in crisi può aver trattenuto i contributi dalle retribuzioni dei giornalisti ma poi non li ha versati all’INPGI, destinando altrove le risorse. Analogamente, un freelance in difficoltà economica potrebbe aver posticipato i versamenti dei contributi per far fronte ad altre spese. Queste situazioni, pur comprensibili, configurano comunque un’inadempienza. Sul piano giuridico, la temporanea mancanza di fondi non giustifica l’omissione: il datore di lavoro resta obbligato e il debito si aggrava con sanzioni e interessi. In sede penale (per le omissioni più gravi, v. infra) lo stato di difficoltà economica può essere valutato per attenuare la responsabilità, ma serve dimostrare che era imprevedibile e non imputabile a colpa grave.
2. Mancarata o tardiva comunicazione dei redditi (per autonomi): Nel caso dei giornalisti autonomi, dimenticarsi di inviare la comunicazione annuale dei redditi all’INPGI è uno degli errori più comuni. Ciò comporta due problemi: (a) l’INPGI può non sapere dell’esistenza del reddito e dunque il giornalista resta esposto a un recupero contributivo tardivo (quando l’ente incrocerà i dati fiscali, come sta facendo di recente); (b) scattano sanzioni per omessa comunicazione (fino al 20% del contributo minimo, come da Regolamento INPGI). Molti freelance hanno scoperto di avere debiti solo quando, anni dopo, l’INPGI li ha contattati contestando il mancato invio del modulo e richiedendo i contributi dovuti. Ad esempio, a inizio 2025 l’INPGI ha avviato controlli incrociati sui redditi 2018-2019 dichiarati al fisco ma non dichiarati all’ente previdenziale: molti giornalisti autonomi stanno ricevendo lettere di accertamento per contributi non versati su quei compensi. In tali casi il debito è sorto perché il professionista non aveva provveduto spontaneamente al pagamento né alla comunicazione.
3. Errata qualificazione del rapporto di lavoro: Un’altra causa di debiti contributivi è il contenzioso sulla natura del rapporto. Ciò avviene tipicamente quando un datore di lavoro inquadra in modo improprio un giornalista per evitare contributi INPGI. Esempi: un’impresa assume un laureato in comunicazione come “impiegato amministrativo” ma in realtà lo impiega come addetto stampa; oppure una TV locale fa firmare a un redattore un contratto di consulenza come “autore programmi” invece di assumerlo come giornalista dipendente. Se, in seguito a ispezioni o cause di lavoro, viene accertato che il lavoratore svolgeva mansioni giornalistiche, l’INPGI richiederà il pagamento retroattivo dei contributi per quel rapporto. L’azienda si troverà allora un debito per contributi evasi, spesso con effetto retroattivo di 5 anni (o anche di più, se l’evasione è accertata come dolosa). Numerose pronunce confermano questo: ad esempio la Cassazione ha condannato un’azienda televisiva che aveva inquadrato un giornalista come “programmista-regista” a versare i contributi all’INPGI, ritenendo non invocabile la buona fede per aver pagato all’INPS. In quell’occasione la Suprema Corte sottolineò che l’attività di quel lavoratore – pur formalmente diversa – era in realtà giornalistica (partecipava alla redazione dei telegiornali), e dunque l’azienda non poteva sottrarsi all’obbligo verso l’INPGI.
*Caso reale:* Un Comune impiega un addetto stampa dal 2010 senza qualifica giornalistica e versa i contributi all’INPS. Nel 2022, alla luce della giurisprudenza consolidata, l’INPGI potrebbe pretendere i contributi per quell’addetto stampa retroattivamente. Il Comune rischia così un debito per tutti gli anni pregressi (per fortuna solo fino al 30/6/2022, poi il lavoratore è passato a INPS comunque). Se il Comune oppone di non aver formalmente inquadrato l’ufficio stampa, la Cassazione (SU) ha già risposto che ciò *non conta*: l’obbligo INPGI scatta “a prescindere dal contratto collettivo applicato e dalla qualifica attribuita” se in concreto c’è attività giornalistica svolta da iscritto all’Albo:contentReference[oaicite:70]{index=70}:contentReference[oaicite:71]{index=71}. Il debito andrà dunque pagato, salvo eccepire prescrizione per i periodi più risalenti (vedremo tra poco i termini).
4. Inadempienze amministrative e incertezze normative: Talvolta i debiti contributivi nascono da disguidi o errori procedurali. Ad esempio, un neo-iscritto all’Albo che avvia la partita IVA giornalistica potrebbe non aver capito subito l’obbligo di iscrizione all’INPGI 2, e quindi non paga i primi anni. Oppure, in passato, alcuni giornalisti pensionati credevano di non dover più contribuire sui nuovi redditi, mentre invece l’INPGI 2 prevede comunque un contributo (sia pure ridotto). Queste situazioni di mancata informazione non esonerano dal pagamento, ma in sede di opposizione possono essere valutate per ridurre sanzioni, se si dimostra ad esempio l’affidamento in una normativa confusa. Un esempio concreto: prima che fosse chiarito legislativamente, alcuni giornalisti che ricoprivano cariche pubbliche elettive (sindaci, assessori) non versavano contributi su indennità di carica, credendo non dovuti; successivamente l’INPGI ha chiarito (circolare n. 6/2019) che invece anche su quelle indennità scattano contributi figurativi e ha invitato le amministrazioni al versamento. Ne è derivato un potenziale debito per i Comuni/Regioni coinvolti, che hanno dovuto sanare per evitare danno erariale. Insomma, evoluzioni normative o interpretative possono far emergere ex post scoperture contributive prima non percepite come tali.
5. Combinazione con riscossione fiscale coattiva: Va menzionato che, se i contributi dovuti vengono iscritti a ruolo e non pagati, possono sommarsi aggravi da parte dell’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate – Riscossione). La cartella esattoriale include l’aggio di riscossione (circa 3%–6%) e diritti di notifica, che aumentano il debito. Inoltre, i costi di eventuali procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche) ricadono sul debitore. Pertanto, un debito iniziale di €5.000 in contributi omessi può lievitare a migliaia di euro in più tra interessi, sanzioni e costi di esecuzione se non gestito per tempo.
Riassumendo, le cause dei debiti contributivi possono essere involontarie (difficoltà economiche, disorganizzazione) o volontarie (scelta deliberata di non pagare, o di evitare l’INPGI qualificando diversamente il rapporto). In ogni caso, è fondamentale affrontare subito la questione, perché gli effetti dell’inadempimento peggiorano col passare del tempo.
Interessi, sanzioni civili e altre conseguenze finanziarie
Cosa succede a livello economico se non si pagano i contributi INPGI nei termini? Come altri enti previdenziali, l’INPGI applica interessi di mora e sanzioni civili sul ritardato od omesso pagamento. Il regime sanzionatorio dell’INPGI presenta alcune peculiarità:
- Interessi di mora: decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di pagamento fino al giorno del versamento effettivo. Il tasso applicato è tipicamente quello di interesse legale annuo (aggiornato annualmente; negli ultimi anni oscillante tra 0.01% e 5%, in aumento nel 2023-25 per effetto dell’inflazione). Dunque, il debito cresce con interessi modestamente (es.: su €1.000 omessi nel 2019, gli interessi al 5% annuo fino al 2025 potrebbero essere attorno a €300 cumulati).
- Sanzioni civili da ritardato pagamento: oltre agli interessi, l’INPGI 2 (gestione separata) prevede sanzioni forfettarie in misura percentuale sul capitale a seconda del ritardo. In particolare, se il pagamento avviene: entro 60 giorni dal termine, nessuna sanzione (solo interessi); dal 61° al 90° giorno, sanzione pari al 5% dei contributi dovuti; dal 91° al 120° giorno, sanzione 10%; oltre 120 giorni, sanzione 15%. Questa sanzione del 15% rappresenta il tetto massimo e non aumenta ulteriormente col tempo (clausola di salvaguardia: anche se il ritardo è di anni, resta 15%). Dunque, per i contributi non pagati entro 4 mesi, l’iscritto subisce un aggravio pari al 15% dell’importo, oltre agli interessi di mora giornalieri. Esempio: contributi 2019 non pagati di €1.200 ⇒ sanzione civile €180 (15%) + interessi legali annui (nel 2019-2021 lo 0,05-0,5%, trascurabile, poi 2022-2023 intorno al 1-5%). Se si salda dopo 3 anni, il debito sarà circa €1.200 + €180 + €50 di interessi = €1.430 (circa il 19% in più). Nota: Questo sistema, previsto dal Regolamento INPGI, si discosta da quello INPS: l’INPS impone “sanzioni civili” molto gravose (fino al 30% annuo il primo anno, poi 6% annuo oltre il 100% del dovuto) salvo riduzioni per buona fede o adempimento spontaneo (L. 388/2000). L’INPGI invece non applica la disciplina di L. 388/2000 art. 116 co.20 – che prevedeva sanzioni ridotte in caso di versamenti tardivi spontanei – in quanto ente privatizzato con proprie regole. La Cassazione ha escluso l’applicabilità di quelle norme INPS all’INPGI, ribadendo che valgono le sanzioni dettate dal regolamento dell’ente. Pertanto, un datore di lavoro che per errore ha versato i contributi ad un ente diverso (ad es. all’INPS invece che all’INPGI) non può invocare la buona fede per ottenere l’abbattimento delle sanzioni secondo l’art.116, co.20 L.388/00, se l’INPGI richiede poi i contributi: la Cassazione (sent. n. 23296/2010) ha cassato una sentenza di merito che aveva riconosciuto tale buona fede, sottolineando che l’azienda datrice aveva chiaramente impiegato il lavoratore in ruoli giornalistici e che comunque il periodo contestato era anteriore all’entrata in vigore della L.388/00. In altre parole, l’errore di versare ad un “creditore apparente” (ente previdenziale sbagliato) non evita il debito verso l’INPGI, salvo forse in rari casi di errore scusabile in buona fede, ma la giurisprudenza INPGI è molto rigorosa su questo punto. Lo stesso dicasi per eventuali transazioni tra datore di lavoro e lavoratore: se con un accordo economico privato si rinuncia a differenze retributive, ciò non libera dall’obbligo di versare i contributi sulle somme dovute; l’INPGI non è vincolato da tali transazioni e potrà pretendere i contributi come se l’accordo non esistesse.
- Sanzione per errato versamento ad altro ente (gestione separata): Nel regolamento INPGI 2 si prevede un caso specifico: se il ritardo nel pagamento è dovuto a versamenti indebiti fatti a un altro ente previdenziale (per errore del committente), la sanzione è particolare. Invece del 5-10-15%, si applica una sanzione pari alla rivalutazione del montante contributivo (cioè l’aggiornamento ISTAT) +1% sui contributi dovuti. Questa è una formula più vantaggiosa per chi paga all’ente sbagliato, perché in genere la rivalutazione è inferiore al 15%. Tuttavia, si tratta di ipotesi residuali e comunque l’ente sbagliato (es. INPS) poi dovrebbe restituire quanto indebitamente ricevuto o trasferirlo. In generale, conviene sempre segnalare all’INPGI subito se si scopre di aver versato contributi erroneamente ad altro fondo, per coordinare le compensazioni.
- Sanzioni per omessa dichiarazione reddituale (INPGI 2): Come accennato, la mancata comunicazione annuale dei redditi comporta una sanzione amministrativa (non aggiuntiva sul debito contributivo, ma pecuniaria) pari al 5% del contributo minimo se il modulo arriva entro 30 giorni di ritardo, 10% se entro 60 giorni, 15% entro 90 giorni, 20% oltre 90 giorni. Ad esempio, per un professionista oltre 5 anni di anzianità, il contributo minimo è €426: un invio in ritardo di oltre 3 mesi costerà una multa di circa €85. Queste sanzioni sono dovute “per il solo fatto” del ritardo, indipendentemente dal poi pagare i contributi. Inoltre, l’INPGI ha facoltà di stimare d’ufficio i contributi se non riceve la comunicazione, sulla base dell’ultimo reddito noto, con riserva di conguaglio. Insomma, non comunicare i redditi complica la posizione del debitore, perché l’ente potrebbe iscrivere a ruolo importi presumibilmente dovuti, invertendo l’onere su di te di dimostrare eventualmente che il reddito era inferiore.
- Blocco della posizione assicurativa e prestazioni: Finché i contributi sono solo in ritardo ma non prescritti, il giornalista mantiene il diritto alle prestazioni pensionistiche relative, anche se condizionato al poi saldare. Tuttavia, in caso di contributi non versati e poi prescritti, l’INPGI (come l’INPS) non li considera più ai fini pensionistici. Questo significa che il periodo scoperto non varrà per la pensione, a meno che il lavoratore stesso non si attivi per sanarlo volontariamente (vedi oltre la rendita vitalizia). Inoltre, l’INPGI può rifiutare di erogare alcune prestazioni (ad es. indennità di disoccupazione o maternità per free-lance) se il beneficiario risulta non in regola con i versamenti. Spesso concede un termine per regolarizzare, scaduto il quale la prestazione può essere sospesa. Dunque, la conseguenza più grave del non pagare i contributi è che si perde copertura previdenziale: meno anni di contributi e, in casi estremi, impossibilità di andare in pensione finché non si coprono gli ammanchi.
- Danno erariale e responsabilità patrimoniale: se il debitore è un ente pubblico o un suo funzionario, l’omissione contributiva può generare un’azione della Corte dei conti. Ad esempio, la mancata iscrizione di un dipendente all’INPGI e relativo mancato versamento può essere considerata un danno erariale se comporta per l’ente pubblico spese aggiuntive (ad es. cause legali o trasferimenti compensativi). In passato, la Corte dei conti – sezione controllo – ha evidenziato il fenomeno dei contributi non versati ai fondi sostitutivi come criticità, e le procure contabili potrebbero chiedere conto ai dirigenti responsabili. In sostanza, un amministratore pubblico rischia di dover risarcire di tasca propria il “danno” causato all’erario per sanzioni e interessi maturati a seguito di sue omissioni. Anche per aziende private, i soci o amministratori potrebbero essere chiamati a rispondere del debito contributivo se ad esempio hanno operato distrazioni patrimoniali: il credito INPGI è privilegiato e in caso di fallimento dell’azienda viene soddisfatto preferenzialmente; se però c’è insolvenza, può emergere responsabilità degli amministratori per mala gestio (questo rientra più nel diritto societario, ma è da tenere presente). In sintesi: ignorare i debiti contributivi può comportare responsabilità personali, oltre che patrimoniali dirette.
Riepilogo (tabella effetti finanziari del mancato pagamento):
| Voce | INPGI (Gestione Separata) – Regime sanzionatorio | INPGI (Gestione principale)** – Regime (fino al 2022) |
|---|---|---|
| Interessi di mora | Interesse legale annuo (dal giorno dopo scadenza al pagamento). Es: 5% annuo su contributo. | Interesse legale (simile, poiché anche l’INPGI 1 prevedeva interessi di mora; ora INPS applica tasso legale sui propri avvisi). |
| Sanzioni da ritardo (civili) | 5% del contributo se pagamento entro 90 gg dal termine; 10% entro 120 gg; 15% oltre 120 gg di ritardo. Max 15% una tantum. Se errore di ente: rivalutazione ISTAT +1%. | Sanzioni civili in passato calcolate come INPS? (In assenza di L.388/00). In pratica, l’INPGI 1 applicava sanzioni analoghe all’INPS ante 2001 (fino al 40-50% annuo). La Cassazione però non ha mai consentito riduzioni L.388/00. Ora INPS applica art. 116 L.388: 9% annuo su omessi spontanei, 30% annuo su omessi accertati, con max 60%. |
| Sanzione omessa dichiarazione redditi | 5% – 20% del contributo soggettivo minimo, in base ai giorni di ritardo. Es: >90 gg = 20% minimo (€85 circa). | Non prevista specifica, ma eventuali sanzioni per omessa denuncia periodica (nel lavoro dipendente, le denunce mensili omesse portavano a sanzioni INPGI e soprattutto problemi sulla regolarità contributiva azienda). |
| Altri aggravi | Aggio riscossione (Agenzia Riscossione): ~3-6% + spese notifica. Costi fissi per solleciti, fermi, ipoteche se attivati. | Idem (crediti INPGI 1 confluiti in ruoli Equitalia/AER con stessi aggi e spese). |
| Penale (omesso versamento) | Solo se contributi trattenuti e non versati > €10.000 annui (reato ex art. 2 DL 463/1983, oggi D.Lgs. 8/2016): reclusione fino 3 anni + multa fino €1.032. Estinzione del reato se si paga entro 3 mesi dalla contestazione. – (Vedi infra per dettagli) | Uguale: per i datori ex INPGI 1 vale stessa norma, essendo contributi obbligatori per dipendenti. |
(NB: la gestione principale INPGI 1 aveva norme proprie fino al 2022, ma seguiva prassi analoghe a INPS. In ogni caso oggi quei crediti sono in mano all’INPS, quindi le sanzioni seguiranno le regole INPS, salvo che per il periodo fino al 2022 maturato secondo le regole originarie. Il prospetto sopra è semplificato.)**
Come si vede, le somme dovute possono crescere significativamente col tempo, anche se l’INPGI 2 – con il tetto del 15% di sanzione – risulta meno oneroso di altre casse e dell’INPS in caso di lunghi ritardi. Ciò non deve però indurre in errore: non pagare i contributi rimane altamente sconsigliabile, sia per le possibili sanzioni, sia per il rischio di perdere anni contributivi e incorrere in azioni legali.
Impatto sui diritti pensionistici e rimedi in caso di contribuzioni omesse
Un punto cruciale per il giornalista debitore è capire come il debito incide sulla sua posizione previdenziale. In particolare: i contributi non versati possono essere recuperati ai fini pensionistici? e se cadono in prescrizione, c’è qualche rimedio? Vediamo.
Prescrizione dei contributi: I contributi previdenziali obbligatori, come regola generale, si prescrivono in 5 anni dal momento in cui avrebbero dovuto essere versati. Questo termine quinquennale è stato introdotto dalla riforma del 1995 (L. 335/1995, art. 3 co.9) e si applica anche all’INPGI. Significa che, trascorsi 5 anni senza che il credito contributivo sia stato reclamato in modo formale (con atti interruttivi), l’INPGI perde il diritto di pretenderne il pagamento. Attenzione però: per l’INPGI 2 la decorrenza dei 5 anni è particolare. Il Regolamento INPGI stabilisce che il termine decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi all’INPGI da parte dell’obbligato. In pratica, per i freelance la prescrizione inizia a conteggiarsi quando il giornalista comunica all’ente il proprio reddito per l’anno in questione. Se non comunica nulla, la prescrizione potrebbe non iniziare affatto finché l’INPGI non venga comunque a conoscenza del reddito (es. tramite Agenzia Entrate). Questa regola è stata confermata dalla Cassazione: la Suprema Corte ha esteso all’INPGI il principio che il termine di prescrizione comincia quando il diritto può essere fatto valere, e nel caso dei contributi da lavoro autonomo ciò coincide con la comunicazione reddituale su cui calcolarli.
Dunque, se un giornalista autonomo dichiara all’INPGI nel 2020 il reddito del 2019, i 5 anni decorrono dal 2020. Se però non dichiara nulla, l’INPGI potrebbe sostenere che la prescrizione non è ancora decorso (finché non ottiene i dati e iscrive d’ufficio i contributi). In ogni caso, una volta che l’INPGI ti notifica una richiesta (es. una diffida o una cartella), quel atto interrompe la prescrizione, facendola ripartire da capo per altri 5 anni. È frequente che l’INPGI invii lettere di sollecito entro 5 anni proprio per interrompere i termini.
Importante: durante la pandemia Covid, il legislatore ha disposto sospensioni dei termini di prescrizione per garantire agli enti più tempo. In particolare, tra il 2020 e 2021 vi è stata una sospensione straordinaria di 311 giorni (dal 23/2/2020 al 30/6/2021) per i termini di prescrizione dei contributi. Inoltre, per alcuni periodi sono stati aggiunti ulteriori 90 giorni di proroga. L’effetto pratico è stato di posticipare la scadenza di prescrizione dei contributi 2018 e 2019 di circa 10-12 mesi rispetto al normale. Ad esempio, i contributi dovuti per l’anno 2018, che in base alla scadenza ordinaria del 31/10/2019 si sarebbero prescritti il 31/10/2024, hanno il termine spostato a 5 settembre 2025. Quelli del 2019, con scadenza 31/10/2020, si prescrivono il 30 aprile 2026. (Queste date sono state ufficialmente comunicate dall’INPGI stesso nelle sue note agli iscritti e confermate da circolari: si veda la tabella riepilogativa sottostante.)
Ecco una tabella di esempio sulle scadenze di prescrizione dopo le sospensioni Covid, per dare un’idea concreta:
| Anno di competenza contributi | Data ordinaria scadenza versamento | Termine ordinario prescrizione (5 anni) | Sospensione Covid (giorni) | Nuovo termine di prescrizione |
|---|---|---|---|---|
| 2018 (autonomi) | 31/10/2019 | 31/10/2024 | +311 giorni | 05/09/2025 |
| 2019 | 31/10/2020 | 31/10/2025 | +182 giorni | 30/04/2026 |
| 2020 | 31/10/2021 | 31/10/2026 | (no ulteriori sospensioni) | 31/10/2026 |
| 2021 | 31/10/2022 | 31/10/2027 | (nessuna sospensione) | 31/10/2027 |
| 2022 | 31/10/2023 | 31/10/2028 | (non applicabile) | 31/10/2028 |
| 2023 | 31/10/2024 | 31/10/2029 | – | 31/10/2029 |
| Nota: per i dipendenti, il versamento era mensile; tuttavia ai fini prescrizionali si considera spesso l’anno solare o la data di denuncia contributiva annuale. La sospensione Covid è la stessa applicata all’INPS e ad altri enti. |
Come si vede, non è corretto pensare che “bastino 5 anni per farla franca”: l’INPGI ha beneficiato di proroghe legislative e comunque può interrompere il termine con atti. Inoltre, la regola della decorrenza dal momento della dichiarazione impedisce al furbetto di non dichiarare nulla sperando nella prescrizione breve: così facendo, anzi, rimane a rischio ben oltre 5 anni. La Cassazione ha espressamente negato la prescrizione in un caso in cui l’iscritto aveva omesso di iscriversi e dichiarare, ritenendo che in assenza di comunicazione il termine non fosse ancora decorso. Naturalmente, su questa materia c’è un dibattito: alcuni ritengono che la norma regolamentare non possa derogare alla legge (la legge dice 5 anni “dalla scadenza del versamento”). Tuttavia, finché la giurisprudenza conferma l’impostazione INPGI, conviene fare attenzione: un reddito non dichiarato potrebbe essere inseguito anche dopo 5 anni, finché l’INPGI ne viene a conoscenza.
Che accade ai fini pensionistici se i contributi si prescrivono? Una volta prescritto il credito, l’INPGI non può più esigerne il pagamento, ma neppure riconoscerà quei contributi per la pensione, non avendoli ricevuti. Il giornalista quindi perde l’accredito di quei periodi. Tuttavia, esiste un rimedio previsto dall’ordinamento generale: la possibilità di costituire una rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/1962, ossia un versamento volontario per coprire periodi non più recuperabili coattivamente dal fondo. In termini semplici: se i contributi sono prescritti, il lavoratore (o il suo datore) può scegliere di pagarli comunque, ottenendo in cambio l’accredito figurativo ai fini pensionistici, oppure può chiedere all’ex datore di lavoro di finanziare una rendita a suo favore equivalente al trattamento pensionistico perso. Questa norma era stata pensata per l’INPS, ma si applica in generale. Quindi, il giornalista dipendente che scopre che l’editore non gli ha versato contributi 10 anni fa ormai prescritti, può chiedere al giudice del lavoro la condanna del datore a versare all’INPGI una somma per costituire rendita (se il datore è ancora solvente). Se invece è il freelance stesso, può valutare di versare volontariamente il dovuto (senza sanzioni) per coprire quel buco: alcuni enti lo consentono tramite riscatto oneroso. L’INPGI 2, ad esempio, consente a chi non ha maturato 5 anni di contributi di chiedere la restituzione dei contributi versati (liquidazione una tantum); ma per i periodi prescritti credo permetta anche il pagamento volontario se l’interessato vuole comunque la copertura (questo andrebbe confermato caso per caso attraverso regolamenti interni e prassi – non semplice, ma l’opzione generale di cui sopra esiste).
Effetti su pensioni in corso: se un giornalista va in pensione e poi si scopre che mancano contributi di anni passati ormai prescritti, in teoria la pensione erogata potrebbe risultare più bassa (quei periodi non valgono). L’INPGI (ora INPS per la gestione principale) può ricalcolare l’assegno escludendoli. Viceversa, se erano stati contati erroneamente periodi non coperti, potrebbe chiedere restituzione indebiti (cosa rara e impopolare, ma legalmente possibile). Comunque, situazioni del genere sono estreme: di solito, prima della pensione, l’ente invita a regolarizzare eventuali scoperture (l’INPGI controlla gli ultimi 5 anni dichiarazioni, come da regolamento).
Prescrizione delle sanzioni e interessi: anche gli interessi e le sanzioni seguono la sorte del contributo: non appena il contributo è prescritto, decadono anche gli accessori. Se invece il contributo è stato pagato ma non le sanzioni, l’ente ha 5 anni per riscuotere queste ultime.
Riassumendo questa parte: il debitore può talvolta eccepire la prescrizione come difesa (lo vedremo nella sezione difese legali), ma deve valutare il contrappeso: ogni anno prescritta è un anno perso per la pensione. In genere, i giornalisti tengono molto all’anzianità contributiva: dunque, se c’è margine, può convenire pagare comunque il dovuto (magari aderendo a sanatorie agevolate) per non compromettere la propria futura pensione, specie se si è in fase avanzata di carriera. Al contempo, però, evitare di pagare contributi per attività occasionali minime potrebbe essere una scelta cosciente di chi ha già pensione assicurata altrove: in quei casi la prescrizione può “liberare” da un onere contributivo poco influente ai fini pensionistici ma fastidioso economicamente. Ad esempio, un avvocato prossimo alla pensione forense che aveva qualche collaborazione giornalistica minore negli anni passati potrebbe decidere di non inseguire quei versamenti INPGI se tanto inciderebbero marginalmente su una eventuale pensioncina INPGI separata. Si tratta di valutazioni personali, da fare con un consulente previdenziale. Questa guida, focalizzata sulla difesa del debitore, evidenzia la prescrizione come strumento di opposizione, ma non va dimenticato l’impatto previdenziale.
Come difendersi da una richiesta di pagamento dell’INPGI (strumenti e strategie)
Passiamo ora al cuore pratico della guida: cosa può fare un giornalista (o un’azienda) che si trova di fronte a una richiesta di pagamento dell’INPGI per contributi non versati? “Difendersi” può significare: contestare la legittimità o l’entità della pretesa (se ritenuta infondata o eccessiva) oppure cercare soluzioni per ridurre l’impatto del debito (rateizzazioni, sanatorie) evitando conseguenze peggiori. In questa sezione esploriamo entrambe le prospettive, ossia le azioni legali per opporsi e le misure amministrative per gestire il debito. Verranno affrontati i seguenti temi:
- Procedura di riscossione e termini: come e quando l’INPGI (o l’INPS per i crediti ex INPGI1) notifica le richieste, e quali sono i termini per reagire.
- Opposizione a cartelle esattoriali o avvisi di addebito: la causa davanti al giudice del lavoro per annullare o ridurre la pretesa.
- Eccezioni difensive comuni: prescrizione, difetto di obbligo contributivo, errori formali, pagamento già effettuato altrove, ecc.
- Strumenti deflativi: domande di rateizzazione del debito in sede amministrativa.
- Definizioni agevolate e condoni: opportunità straordinarie (es. rottamazione cartelle, saldo e stralcio) per chiudere il debito a condizioni favorevoli.
- Tutela in sede penale: cenni su come evitare o affrontare l’eventuale accusa penale per omesso versamento.
L’obiettivo è fornire un ventaglio di opzioni in mano al debitore, da valutare a seconda del caso concreto.
Atti di riscossione: avviso di addebito e cartella esattoriale
Prima di tutto, vediamo come l’INPGI formalizza la richiesta di pagamento. Nella maggior parte dei casi, la riscossione dei contributi omessi avviene tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER), l’ente pubblico deputato al recupero coattivo di crediti fiscali e previdenziali (ex Equitalia). L’INPGI predispone un ruolo contenente il debito del contribuente (dettagliato per anno, importo, sanzioni e interessi) e lo affida all’AER. Sulla base di tale ruolo, l’Agenzia emette la cartella di pagamento (detta volgarmente “cartella esattoriale”) che viene notificata al debitore. La cartella ha valore di titolo esecutivo: se non viene opposta entro i termini e non si paga, si può passare a esecuzione forzata.
Per i contributi più recenti (post 2011), l’INPGI potrebbe anche utilizzare l’istituto dell’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (analogo a quello introdotto per l’INPS). In pratica, invece di far emettere una cartella all’Agenzia, l’ente stesso notifica un avviso di addebito al debitore, che è immediatamente esecutivo trascorsi 60 giorni. Tuttavia, nel caso dell’INPGI la prassi consolidata è stata l’uso delle cartelle via Equitalia/AER. Ora che i crediti INPGI1 sono passati all’INPS, è probabile che per essi si utilizzeranno gli avvisi di addebito INPS. In ogni caso, sia la cartella sia l’avviso contengono le indicazioni del debito (ente creditore, causale “contributi previdenziali”, periodo, importi, ecc.) e recano l’ingiunzione a pagare entro 60 giorni.
Termini di notifica: non c’è un termine fisso per notificare una cartella per contributi, se non quello generale della prescrizione (5 anni). Ad esempio, l’INPGI potrebbe notificare nel 2025 cartelle relative a contributi 2019, e sarebbe ancora nei termini grazie alla sospensione Covid. Casi di cartelle per contributi molto risalenti (es. anni ’90) oggi non dovrebbero più vedersi, essendo prescritti; salvo situazioni di dolo (evasione contributiva occultata) in cui un tempo si applicava la prescrizione decennale, ma con la riforma 1995 questa distinzione è venuta meno. Dunque, se vi notificano nel 2025 una cartella per contributi 2010, quasi certamente è prescritta – o, più probabilmente, è frutto di un accertamento notificato entro il 2015 e poi trasformatosi in cartella (in tal caso dipende se ci sono stati atti interruttivi).
Solleciti bonari: spesso l’INPGI invia prima un sollecito o una comunicazione preventiva al contribuente. Ad esempio, come detto, a febbraio 2025 l’INPGI ha spedito lettere ai freelance per i redditi 2018-19 omessi, invitandoli a mettersi in regola prima di procedere al ruolo. Queste comunicazioni non sono atti esecutivi, ma è bene non ignorarle: offrono la chance di sistemare il dovuto (magari chiedendo subito una rateizzazione) ed eventualmente segnalare se si ritiene la pretesa errata (ad esempio, perché quell’anno non si è avuto reddito giornalistico). Se ignorate, si passerà alla cartella. Va detto che il sollecito informale non interrompe la prescrizione (non avendo forma legale rigorosa), mentre la successiva notifica della cartella sì. In caso di dubbi, è possibile contattare l’INPGI per chiarimenti già a seguito del sollecito: talvolta l’errore è banale (il giornalista ha inviato la comunicazione ma l’ente non l’ha registrata, ecc.) e si può risolvere senza contenzioso.
Termine per agire: dalla notifica della cartella esattoriale (o avviso esecutivo) decorrono 40 giorni per proporre opposizione giudiziaria. Questo termine è stabilito dall’art. 24 D.Lgs. 46/1999 per opposizioni a ruoli contributivi. È perentorio: significa che se non si fa ricorso entro 40 giorni, la pretesa diventa definitiva ed incontestabile (salvo pochi casi eccezionali). Attenzione: spesso la cartella contiene l’indicazione “entro 60 giorni pagare o presentare richiesta di rateazione”; quel “60 giorni” è riferito al pagamento prima di avviare l’esecuzione, ma non corrisponde al termine per l’opposizione giudiziaria, che resta 40 giorni. È un trabocchetto che ha tratto in inganno taluni: credendo di avere 2 mesi per ricorrere, si sono visti eccepire la tardività in giudizio. Dunque, se si intende contestare, è bene muoversi entro 40 giorni dalla data di notifica (verificare la relata o l’AR di consegna per calcolare esattamente la scadenza).
Giurisdizione competente: le controversie sui contributi previdenziali di giornalisti rientrano nella competenza del Giudice del Lavoro, sezione lavoro del Tribunale, analogamente alle cause previdenziali INPS. Si tratta infatti di obblighi previdenziali a carico di lavoratori o datori di lavoro. Quindi il ricorso andrà presentato al Tribunale in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente: di solito, il foro è quello del luogo di residenza del lavoratore per le cause previdenziali, oppure della sede del datore per questioni contributive datoriali. Nel dubbio, spesso si utilizza il foro del luogo dove ha sede l’INPGI o l’ufficio periferico che ha emesso l’atto (Roma, essendo l’INPGI un ente nazionale, ma l’INPGI si avvale anche dell’INPS per la riscossione locale? – Comunque, la maggior parte dei contenziosi INPGI si sono svolti presso Tribunale di Roma, data la presenza lì dell’ente, ma non è esclusiva). In ogni caso, non è il giudice tributario ad occuparsene (le Commissioni Tributarie non hanno giurisdizione su contributi previdenziali, pur se la cartella è emessa dall’Agenzia Entrate Riscossione).
Forma dell’azione: tecnicamente, l’impugnazione è un ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 46/99 (opposizione all’intimazione di pagamento per crediti previdenziali) oppure, se si contesta l’esistenza del rapporto di lavoro, un’opposizione ex art. 615 c.p.c. (profilo esecutivo). Ma senza entrare nel tecnico, per il debitore ciò significa assumere un avvocato (per legge le cause di lavoro in Tribunale richiedono assistenza legale, tranne rare eccezioni) e predisporre un ricorso spiegando i motivi di contestazione. Entro pochi mesi (dipende dal carico di ruolo) si terrà un’udienza. È possibile chiedere al giudice anche la sospensione dell’esecuzione nel frattempo, se c’è pericolo (pignoramenti in corso). Il giudice deciderà poi con sentenza di primo grado; appellabile in Corte d’Appello (se il valore sopra soglie modeste) e poi eventualmente in Cassazione. Come notato da alcuni osservatori, il contenzioso INPGI spesso è lungo: la durata media di una causa contributiva può arrivare a 10-15 anni fino alla Cassazione. Questo è un fattore di cui tener conto: fare causa ha senso se la somma è alta e le ragioni solide, altrimenti protrarre l’incertezza per anni potrebbe non convenire.
Vediamo ora le possibili difese di merito, ossia i motivi per cui il debitore può opporsi alla richiesta dell’INPGI.
Motivi di opposizione: come contestare la pretesa contributiva
Quando si presenta ricorso contro una cartella o un avviso dell’INPGI, occorre indicare i motivi specifici per cui si chiede l’annullamento o la riduzione del debito. I motivi tipici di opposizione (da adattare al caso concreto) comprendono:
1. Eccezione di prescrizione: Come già trattato, la prescrizione è una difesa potentemente risolutiva se applicabile. Se al momento della notifica della cartella erano già trascorsi più di 5 anni dall’ultimo atto interruttivo valido, si può eccepire che il credito è estinto per prescrizione. Ad esempio, supponiamo che l’INPGI non abbia mai inviato alcun sollecito per contributi 2016 e notifichi una cartella nel 2023: il contribuente può sostenere che il diritto alla riscossione si è prescritto il 31/12/2021 (5 anni da fine 2016, tenuto conto che la denuncia redditi 2016 fu trasmessa nel 2017). In giudizio, bisognerà verificare se l’INPGI produrrà eventualmente qualche lettera AR di interruzione. La prescrizione deve essere eccepita dal debitore – il giudice non la applica d’ufficio – e va preferibilmente indicata subito nel ricorso. Se provata, porta all’annullamento totale della pretesa per gli anni prescritti. È comune che i giudici del lavoro accolgano tali eccezioni, in presenza di evidenza (es. “nessun atto dal 2010 al 2018”). Bisogna però tenere presente le questioni sulla decorrenza: nel caso INPGI 2, l’ente spesso replica che “non c’è prescrizione perché il termine decorreva dal tal anno di conoscenza”. Ad esempio, se si eccepisce prescrizione per contributi 2015 perché oggi è 2025, l’INPGI potrebbe dire: sì ma noi lo abbiamo saputo nel 2020 con i dati fiscali, quindi 5 anni non sono trascorsi. Come verrà risolta? Dipende dal giudice: alcune pronunce potrebbero ritenere il regolamento INPGI non in contrasto con la legge e quindi dare ragione all’INPGI (contributi non prescritti); altre potrebbero invece aderire alla tesi che comunque i 5 anni vanno dal momento in cui il versamento andava fatto. C’è infatti una sentenza Cass. del 2005 (citata in dottrina) che affermava la prescrizione quinquennale senza interruzioni per contributi omessi prima della riforma 1995, facendo “pulizia” di posizioni vecchie. Tuttavia, la linea attuale (Cass. 2016) sembra più favorevole all’INPGI. Il debitore può comunque tentare l’eccezione, specie se l’INPGI è rimasto del tutto inerte oltre i 5 anni canonici. Il giudice valuterà se l’inerzia integra acquiescenza.
Va ricordato che eventuali periodi di sospensione vanno scomputati: nel nostro esempio, per contributi 2015 la prescrizione ordinaria scadeva nel 2020, ma con sospensione Covid potrebbe slittare metà 2021, ecc. Quindi i calcoli vanno fatti con precisione, magari presentando al giudice uno specchietto (come la tabella prima) delle scadenze. Se anche solo parte del credito è prescritta, si può chiedere l’annullamento parziale (il giudice potrebbe escludere gli anni lontani e confermare quelli più recenti ancora in termine).
**Attenzione:** se il debitore, prima della causa, ha **riconosciuto il debito** in qualche modo (ad es. chiedendo una dilazione all’INPGI), ciò **interrompe la prescrizione**. Ad esempio, se nel 2019 il giornalista aveva firmato un piano di rateazione per contributi 2013-2014, ha ammesso il dovuto e quindi i 5 anni ripartono da capo dal momento in cui poi è decaduto dal piano. In tal caso eccepire prescrizione potrebbe non reggere.
2. Contestazione dell’obbligo contributivo (natura del rapporto): Questo è un motivo centrale: il debitore può sostenere che l’attività svolta non rientrava tra quelle soggette all’INPGI. Per un’azienda, significa dire “quel lavoratore non era un giornalista assicurato INPGI”; per un freelance, dire “non ero tenuto a iscrivermi per quei redditi”. Esempi di argomentazioni:
- Il lavoratore non era iscritto all’Albo giornalisti: se non sussisteva il requisito professionale, l’INPGI non dovrebbe avere titolo. Ad esempio, una società contesta una cartella INPGI affermando che il dipendente per cui vengono chiesti i contributi era un comunicatore non iscritto all’Albo, e che l’Ordine ha respinto l’iscrizione. Questo può accadere, ma attenzione: potrebbe non bastare a evitare i contributi, perché la giurisprudenza potrebbe qualificare quell’attività come giornalismo svolto irregolarmente. In generale però, l’iscrizione all’Albo è requisito legale per l’obbligo INPGI: se davvero il soggetto non era iscritto né iscrivibile (magari perché privo dei titoli), l’ente non poteva iscriverlo d’ufficio all’INPGI. La difesa su questo punto deve essere argomentata con cautela, perché c’è il rischio di ammettere implicitamente un abuso (far esercitare a non iscritti).
- L’attività non era giornalistica: caso tipico, l’azienda sostiene che le mansioni erano di pubbliche relazioni o mera comunicazione istituzionale, non di informazione giornalistica. Questo confine è stato spesso dibattuto nei tribunali. Ad esempio, alcuni uffici stampa di enti pubblici producono comunicati “istituzionali” senza spirito critico, e i datori hanno provato a sostenere che non fosse vera attività giornalistica. Dopo le SU 2021, però, questa linea di difesa è quasi completamente preclusa se il soggetto era un addetto stampa con tessera: la Cassazione ha detto che quell’attività è comunque giornalistica per definizione di legge. Un margine può esserci se il lavoratore non redigeva testi pubblici ma faceva ad esempio sola organizzazione eventi o mansioni segretariali. In tal caso, sebbene avesse il tesserino, si può provare a dimostrare che di fatto non svolgeva compiti editoriali. Serviranno testimonianze e documenti.
- Attività giornalistica ma con contratto già coperto da altra previdenza: esempio, un collaboratore veniva pagato con un contratto Co.co.co. iscritto alla Gestione Separata INPS (perché magari si considerava non giornalistico il lavoro). Il debitore potrebbe dire: “Ho già pagato i contributi all’INPS per quell’attività, non devo pagare anche all’INPGI”. Questa difesa invoca il principio ne bis in idem contributivo. Purtroppo, se l’attività era effettivamente giornalistica, l’INPGI resta l’ente competente esclusivo, e i contributi versati altrove devono essere spostati o comunque non valgono come pagamento per l’INPGI. Come abbiamo visto, la buona fede di aver versato a INPS non esime dal pagare a INPGI. Però in giudizio, il debitore può chiedere quantomeno di scomputare dal dovuto le somme eventualmente trasferite dall’INPS all’INPGI (se è avvenuto) oppure di considerare quelle somme a riduzione del danno. Spesso, tuttavia, conviene fuori dal processo chiedere all’INPS la restituzione dei contributi indebitamente versati per poi destinarli all’INPGI. L’INPS, su richiesta del datore o del lavoratore, dovrebbe rimborsare i contributi non dovuti (entro termini di decadenza amministrativa). Questa strada è parallela: in tribunale intanto l’INPGI vorrà i suoi, e l’aver pagato a INPS erroneamente non è giuridicamente una causa di annullamento del debito INPGI (al più incide sulle sanzioni se c’era confusione).
- Il reddito non era imponibile INPGI: un freelance potrebbe eccepire che quel reddito non era da attività giornalistica. Ad es., un pubblicista può avere redditi da altre professioni (fotografo, docente, etc.). Se l’Agenzia Entrate fornisce all’INPGI solo il dato reddituale totale, l’INPGI potrebbe presumere contributi su importi non pertinenti. In giudizio il giornalista deve provare quali proventi erano estranei (es. con fatture, codici attività, contratti). L’INPGI tende ad assoggettare contributi a tutto ciò che un iscritto dichiara come lavoro autonomo, ma esistono casi di attività miste. Va fatto valere se ad esempio un pubblicista guadagna come addetto marketing: non è giornalismo, e quei compensi non dovrebbero contribuire (salvo borderline).
- Non c’era obbligo perché già pensionato prima 2017: citiamo per scrupolo un caso: quando fu istituita l’INPGI 2 (dal 1996) vigeva un’esenzione per chi era già pensionato e iscritto ad altro ente. Alcuni pubblicisti pensionati INPS hanno sostenuto di non dover pagare INPGI su compensi occasionali. In effetti, l’INPGI inizialmente esonerava i pensionati da contributo soggettivo, poi però ha introdotto un contributo di solidarietà ridotto (8%). Quindi questa difesa storica oggi è superata (il contributo anche per i pensionati esiste, benché minimo).
Riassumendo, contestare la natura giornalistica del rapporto è una difesa che punta a dire: “INPGI, non avevi diritto a questi contributi perché in realtà non ricadevamo sotto la tua competenza”. Se provata, annulla l’obbligo e quindi il debito. Va però considerato che la giurisprudenza recente è molto inclusiva nell’ambito INPGI (specie per i dipendenti addetti stampa, come visto). È più facile su posizioni autonome ibride convincere il giudice. Se ad esempio Tizio fatturava come “servizi di consulenza multimediale” ma l’INPGI gli chiede contributi ritenendoli articoli, Tizio può portare i contratti che definiscono quell’opera come non giornalistica. Sarà poi una valutazione tecnica (spesso si rifà alle definizioni di giornalista ex L. 69/63: creatività, periodicità, pubblicazione su media, etc.).
3. Errori o vizi formali dell’atto: Un altro fronte di difesa è individuare eventuali irregolarità formali nella cartella o nell’avviso che possano inficiarne la validità. Alcuni possibili vizi:
- Difetto di motivazione: la cartella deve indicare in modo chiaro la causale del debito, il periodo cui si riferisce, la base di calcolo e le norme applicate. Se la descrizione è troppo generica (es. “omessi contributi” senza specificare anno, o importo per anno), si può eccepire la nullità per carenza di motivazione. Tuttavia, spesso le cartelle INPGI sono abbastanza dettagliate (riportano l’anno o addirittura il protocollo della diffida originaria). Comunque, se il debitore non è messo in grado di comprendere l’origine del debito, può far valere tale vizio. Bisogna farlo subito: la giurisprudenza richiede che l’opponente precisi perché la motivazione è insufficiente (es: “non è indicato se trattasi di gestione principale o separata né l’anno d’imposta, quindi non ho potuto correlare l’importo a mie omissioni note”).
- Notifica invalida: se la cartella è stata notificata a un indirizzo errato, o tramite PEC non conforme, etc., si può eccepire la nullità della notifica (che in pratica sposterebbe in avanti i termini). Esempio, se la notifica è fatta a mezzo PEC ma a un indirizzo non risultante da registri pubblici, potrebbe essere nulla. Oppure se il destinatario è deceduto e notificano a lui invece che agli eredi. Questi aspetti però portano a ridiscutere la decorrenza dei termini più che il merito: l’INPGI potrebbe semplicemente rinotificare correttamente poi.
- Mancata previa intimazione (nel caso di avviso di addebito): per INPS è prassi emettere direttamente avvisi, ma per INPGI se mai usasse l’avviso esecutivo, ci si potrebbe chiedere se serviva un provvedimento amministrativo antecedente. Tuttavia, la legge consente di iscrivere a ruolo anche senza provvedimento formale, quindi questo argomento in genere non passa: la cartella stessa è il primo e ultimo atto.
- Errata intestazione soggetto passivo: ad esempio, l’INPGI potrebbe aver richiesto a una società i contributi di un co.co.co. che invece erano a carico di un’altra società (magari per confusione di denominazione). Se si prova che c’è uno scambio di persona giuridica, la cartella va annullata per difetto di titolarità passiva. Questo vale anche per persone fisiche (es: contributi attribuiti a Caio mentre erano di Tizio per omonimia). Non frequente ma da tenere presente.
- Violazione del diritto al contraddittorio (per contributi in accertamento): se l’INPGI ha basato l’accertamento su dati fiscali, potrebbe essere tenuto a invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di emettere il ruolo. Non c’è una norma chiara che lo imponga (non siamo in ambito tributario UE), però alcuni giudici potrebbero ritenere che, ad esempio, per importi notevoli l’ente avrebbe dovuto inviare una diffida prima della cartella. Se ciò non è avvenuto, il debitore può lamentare di non aver potuto far valere elementi esonerativi prima. Non sempre questo porta ad annullare la cartella, ma può indurre una riduzione di sanzioni per buona fede incolpevole.
In generale, i vizi formali sono un ottimo completamento delle difese, ma raramente un giudice annulla una cartella solo per un vizio formale sanabile, soprattutto se il debito appare fondato. Molto dipende dal vizio: se è radicale (prescrizione maturata, soggetto sbagliato, totale mancanza di motivi) allora sì; se è marginale, il giudice potrebbe dire che non c’è nullicità.
4. Importo errato o duplicazioni: Il debitore dovrebbe sempre ricontrollare i calcoli dell’INPGI. Potrebbero esserci errori aritmetici (rari, visto che i sistemi sono informatizzati). Oppure duplicazione di periodi (ad esempio, contributi già pagati ma che risultano scoperti per errata attribuzione). Se si riscontra che una parte del richiesto era stata già versata, si deve eccepire compensazione: allegando ricevute, F24, quietanze INPGI. L’INPGI potrebbe aver sbagliato a registrare un pagamento. La dimostrazione di ciò in giudizio porta a ridurre il debito. È importante allegare tutte le prove di versamenti fatti (anche se tardivi) perché il giudice non li può immaginare. Ad esempio, un freelance riceve cartella per €10.000 ma lui in passato aveva fatto due versamenti parziali per tot €4.000: se lo dimostra, il debito residuo è €6.000 e la cartella va corretta in tal senso.
5. Applicazione di esoneri o agevolazioni: In alcuni casi, il debitore può invocare particolari norme di esonero. Ad esempio, l’art. 3, co. 98, L. 244/2007 esonerava dal contributo minimo i titolari di altri redditi. Oppure un giornalista disabile ex art. 13 L.68/99 potrebbe avere esenzioni contributive. Se la cartella non li ha considerati, bisogna farlo presente. Ci sono stati anche condoni passati (es. condono 2004) che se il contribuente aveva aderito, l’INPGI non potrebbe ora chiedere quei contributi. Occorre in tal caso documentare l’adesione al condono e il pagamento dovuto per sanatoria.
6. Sospensione in pendenza di ricorso amministrativo: Questa è una difesa procedurale: se il contribuente aveva presentato un ricorso amministrativo interno all’INPGI (ad esempio al Comitato Amministratore) e quell’iter era ancora in corso, la riscossione dovrebbe essere sospesa. Non è comune ricorrere amministrativamente, ma nel dubbio se c’è stata una domanda di riesame pendente, va segnalato. Al giudice potrebbe non bastare, ma quantomeno fa capire che c’era contestazione in atto.
7. Difesa penale e riflessi sul procedimento contributivo: Se il datore viene parallelamente imputato penalmente per omesso versamento (importi >10k), potrebbe attendere l’esito penale prima di definire la somma, o viceversa. In verità, il processo penale non blocca la riscossione contributi: l’INPGI/INPS può procedere comunque. Però, il datore imputato ha interesse a pagare entro 3 mesi dalla contestazione per estinguere il reato. Dunque, in quel contesto la “difesa” migliore è il ravvedimento operoso: pagare subito e poi eventualmente discutere sul resto (sanzioni). In ogni caso, nel contenzioso contributivo, il giudice del lavoro non è influenzato dall’eventuale esito penale (che verte su dolo/colpa); può però sospendere se c’è pregiudizialità (rara).
Riassumendo: il giornalista o datore debitore, assistito dall’avvocato, deve costruire una linea difensiva combinando più motivi. Ad esempio, un ricorso tipo potrebbe dire: “La cartella X per contributi 2015-2018 è illegittima perché: a) prescritta per gli anni fino al 2016; b) il soggetto non doveva iscriversi all’INPGI per il 2015 (attività di natura non giornalistica); c) in ogni caso i calcoli contengono €500 di contributi già versati; d) le sanzioni applicate eccedono i limiti normativi”. Ognuno di questi punti, se accolto anche parzialmente, ridurrà l’importo da pagare. L’esito può essere quindi un’annullamento totale (se passa la tesi principale, es. nessun obbligo o tutta prescrizione) oppure un annullamento parziale (es. tolti due anni prescritti e 500€ doppi conteggiati). Il giudice potrebbe anche rideterminare le sanzioni se ravvisa errori (in genere no, prende atto di quelle regolate per legge).
Va detto che, se la pretesa è fondata (il giornalista non ha pagato e non ha scuse valide), andare in causa serve solo a guadagnare tempo e forse a ridurre sanzioni. Spesso in questi casi conviene esplorare soluzioni transattive o sanatorie.
Rateizzazione e piani di rientro del debito
Se il debito contributivo è confermato (per nulla o in parte) e il giornalista/debitore riconosce di dover pagare, ma magari non è in grado di saldare tutto subito, una via fondamentale è richiedere la rateizzazione. La rateazione amministrativa consente di diluire il pagamento nel tempo ed evitare misure esecutive (fermo restando che continueranno a maturare interessi, seppur ridotti).
INPGI 1 (gestione principale) – ora INPS: Dopo il passaggio all’INPS, tutte le richieste di rateazione per contributi dei giornalisti dipendenti (anche relativi a periodi pre-2022) devono essere presentate all’INPS. L’INPS ha esteso agli ex debiti INPGI le sue regole: in particolare applica il Regolamento INPS sulle dilazioni dei debiti in fase amministrativa anche ai debiti maturati verso INPGI fino al 30/6/2022. L’INPS, con messaggio n. 3922 del 31/10/2022, ha chiarito che le istanze di dilazione vanno presentate telematicamente all’INPS e devono includere tutti i debiti contributivi del richiedente eventualmente presenti in varie gestioni (compreso INPGI). Quindi, ad esempio, un’azienda editoriale che ha sia debiti INPS ordinari che debiti INPGI 1 li raggrupperà in un’unica domanda di rateazione. Il modulo da compilare è l’SC18, appositamente aggiornato per indicare anche posizioni INPGI. Le richieste inviate a vecchi uffici INPGI non sono più accettate: bisogna passare da INPS.
*Durata e condizioni:* di norma l’INPS concede fino a **24 rate mensili** (2 anni) per importi sotto certa soglia, estensibili a **36 o 60 rate** per importi rilevanti e comprovata difficoltà. Bisogna allegare documentazione sulla situazione economica se si chiedono piani lunghi. Sulle rate **decorrono interessi** (attualmente al tasso del 2% annuo per le definizioni agevolate, ma nelle rate ordinarie potrebbe essere il tasso di dilazione INPS, intorno al 6%). Il mancato pagamento di due rate fa decadere dal beneficio, e riparte la riscossione forzata. Nel caso INPGI pre-2022, l’INPS ha previsto che se qualcuno avesse già una rateazione attiva con INPGI, doveva subentrare l’INPS nella gestione, con le stesse condizioni.
INPGI 2 (gestione separata): L’INPGI continua a gestire direttamente le rateazioni per i free-lance. Il Regolamento per le rateazioni INPGI (in fase amministrativa) consente dilazioni solitamente fino a 36 mesi, con possibili eccezioni per casi gravissimi. Il soggetto interessato deve presentare domanda motivata all’INPGI (ora probabilmente via PEC o portale dedicato). In passato l’INPGI chiedeva come garanzia il pagamento di un piccolo acconto o la regolarità dei versamenti correnti. Oggi è presumibile segua prassi analoghe all’INPS.
Tuttavia, attenzione: se il debito è già stato iscritto a ruolo (quindi c’è cartella Equitalia/AER), la rateazione non la concede più l’INPGI direttamente, ma va chiesta all’Agenzia Entrate Riscossione. Infatti, dopo l’affidamento al concessionario, l’ente non può più riscuotere direttamente. In tal caso si può accedere alle rateazioni Equitalia: queste per legge permettono fino a 72 rate (6 anni) automaticamente per importi fino a €60.000, e fino a 120 rate (10 anni) in casi di comprovata grave difficoltà con importo elevato. Il tasso d’interesse sulle rateazioni AER è attualmente attorno al 3,5%. La domanda si fa online sul sito AER indicando le cartelle che si vogliono dilazionare.
Ad esempio, un freelance che riceve cartella da €10.000 può chiedere all’AER fino a 72 rate (~€140/mese). Ottenuta la dilazione, l’AER sospende le azioni esecutive purché si paghino puntualmente le rate. Se il debitore salta più di 5 rate, decade dal piano e il debito residuo torna esigibile immediatamente.
Effetti della rateazione: La concessione della rateazione blocca le procedure esecutive (pignoramenti, fermi) e consente al debitore di ottenere il DURC regolare (documento di regolarità contributiva), importante per poter lavorare con la PA o accedere a compensi di lavoro dipendente. L’art. 2, comma 11, DL 338/1989 (conv. L. 389/89) – richiamato anche dall’INPS per INPGI – prevede infatti che durante la dilazione in regola con i pagamenti il DURC sia positivo. Questo è cruciale: un giornalista free-lance con partita IVA che ha debiti contributivi aperti risulterebbe “non in regola” e potrebbe non poter essere pagato da enti pubblici finché non sistema. Con la rateazione, questo ostacolo viene rimosso (purché rispetti le scadenze rateali).
Cambia qualcosa con l’adesione alle sanatorie? Sì, se si è chiesto di aderire a una definizione agevolata (rottamazione), la presentazione dell’istanza sospende eventuali pignoramenti e fermi in corso fino all’esito. Ma su questo torneremo dopo.
In sintesi, la rateazione è lo strumento ordinario per chi ammette il debito ma vuole tempo. È generalmente consigliabile fare domanda di dilazione prima che la situazione degeneri (ossia prima che parta il pignoramento). Ad esempio, l’INPGI a fine 2022 ricordava che le domande dal 1/7/22 andavano fatte all’INPS e che quelle inviate all’INPGI sarebbero state respinte. Quindi, chi ha situazioni pendenti, meglio che si informi subito sull’ente competente e attivi il piano di rientro.
Definizioni agevolate, condoni e sanatorie: rottamazione, saldo e stralcio, ecc.
Negli ultimi anni, il legislatore ha varato varie misure di “tregua fiscale” che hanno riguardato anche i contributi previdenziali. In particolare, i giornalisti con debiti contributivi hanno potuto beneficiare – al pari di altri contribuenti – di provvedimenti come:
- Saldo e Stralcio 2019 (L. 145/2018) – una sanatoria per persone fisiche con ISEE basso, che consentiva di estinguere cartelle fino al 2017 pagando solo una percentuale ridotta del dovuto (16%, 20% o 35% a seconda dell’ISEE). Inizialmente era dubbio se valesse per le casse privatizzate, ma poi un decreto ha autorizzato anche queste ultime ad aderire. L’INPGI, con delibera del Comitato Amministratore n.10/2019 approvata dai Ministeri vigilanti, ha aderito al saldo e stralcio. Ciò ha permesso ai giornalisti in difficoltà economica di chiudere i debiti contributivi notificati dall’Agente della Riscossione pagando solo la quota capitale (o anche meno). La notizia fu data a ottobre 2019: per es. un iscritto con ISEE < €20.000 ha potuto definire il debito INPGI pagando il 16% dei contributi dovuti (senza sanzioni né interessi).
- Rottamazione-ter 2018-19: l’INPGI già nel 2018 rientrò nella cosiddetta definizione agevolata ter (L. 136/2018), dove chi aveva cartelle 2000-2017 poteva pagare integrale il contributo e azzerare sanzioni e interessi. Molti avranno aderito allora.
- Rottamazione-quater (2023) – L’ultima in ordine di tempo, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), estesa ai carichi affidati all’Agente Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. L’INPGI, con comunicazione di aprile 2023, ha confermato di aver aderito alla definizione agevolata 2023. Ciò significa che i giornalisti possono estinguere i debiti contributivi INPGI del periodo 2000-06/2022 versando solo il capitale e l’aggio, senza sanzioni né interessi di mora. È la cosiddetta “rottamazione-quater”. La domanda andava presentata all’Agenzia Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2023 (poi prorogato al 30 giugno 2023). Il contribuente inseriva le cartelle che voleva rottamare nel portale AER e otteneva il calcolo dei “sconti” (tutti interessi e sanzioni abbuonati). Il pagamento può essere fatto in un’unica soluzione (entro 31 luglio 2023) o in massimo 18 rate spalmate fino al 2027. In caso di rateizzazione, sono previsti interessi ridotti al 2% annuo sulle rate dal 2024 in poi. L’INPGI nella sua newsletter ha invitato gli iscritti con debiti a cogliere questa opportunità. Ad esempio, un giornalista che aveva €5.000 di contributi + €2.000 di sanzioni e €500 di interessi in una cartella, aderendo ha dovuto pagare circa €5.500 (capitale + aggio) risparmiando €2.500. Importante: la definizione agevolata copre i contributi dovuti fino a giugno 2022 perché dopo quelli confluiti in INPS (per i quali comunque la rottamazione 2023 vale analogamente, essendo carichi AER).
- Stralcio automatico mini-debiti: la L. 197/2022 prevedeva anche l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a €1.000 affidati entro 2015. Tuttavia, per i enti previdenziali privatizzati (come INPGI) tale stralcio non si applica automaticamente: ogni Cassa poteva decidere se aderire o meno. Nessuna Cassa privata ha aderito allo stralcio dei mini-debiti, e infatti l’INPGI ha escluso la cancellazione automatica delle sue cartelle sotto €1.000. Ciò perché temeva effetti negativi sulle posizioni pensionistiche degli iscritti (cancellare contributi anche piccoli può danneggiare il lavoratore stesso in futuro). Quindi, se avevate una cartella di €800 verso INPGI, non è stata annullata d’ufficio nel 2023 (a differenza di quelle fiscali). Bisogna comunque pagarla o rottamarla.
Come sapere se la propria Cassa aderisce? Nel maggio 2023, un articolo riportava l’elenco degli enti aderenti: tra questi, l’INPGI c’era, limitatamente alla definizione agevolata e non allo stralcio automatico. Dunque l’INPGI ha sempre scelto la linea: niente perdono totale, ma sì a far pagare solo il dovuto togliendo sanzioni. Questo è positivo per il debitore, perché vuol dire che quasi sempre c’è la chance di risparmiare su sanzioni e more.
Se vi siete persi la scadenza di aprile/giugno 2023? Al momento (luglio 2025) non c’è un nuovo provvedimento in vigore per rottamare ulteriormente. Potrebbe essercene un altro con la prossima manovra se la situazione lo permetterà, ma nulla di certo. Nel caso, l’INPGI presumibilmente aderirebbe di nuovo.
È possibile una transazione individuale col l’ente? Enti come INPS e INPGI non fanno transazioni ad personam sul dovuto (devono seguire le norme generali). Tuttavia esiste la “transazione fiscale e contributiva” nell’ambito di crisi d’impresa (art. 63 D.Lgs.14/2019): un’azienda in concordato può proporre di pagare parzialmente i debiti contributivi. Questo esula dal focus (vale per aziende in insolvenza). Per privati non c’è, salvo le procedure da sovraindebitamento che però difficilmente includerebbero contributi previdenziali se non con l’assenso dell’ente.
In generale, chiunque abbia un debito contributivo significativo dovrebbe tenersi informato sulle possibili definizioni agevolate. Ad esempio, la stampa specializzata prospetta a volte “rottamazione-quinqies”. Nel 2025 non è escluso che il Governo possa reintrodurre misure simili per aiutare i contribuenti in difficoltà (specie se persistono strascichi del Covid).
Riassumendo la sezione difensiva: il debitore deve valutare un mix di azioni. Un possibile percorso virtuoso è: verificare se il debito è effettivamente dovuto. Se no, opporsi legalmente (tenendo d’occhio termini). Se sì, vedere se c’è una sanatoria attivabile (es. rottamazione) e aderire in tempo. Al contempo, chiedere subito la rateazione per bloccare enforcement. E magari, se alcune parti sono prescritte, eccepirlo comunque per ridurre l’importo. È consigliabile farsi seguire da un legale esperto di diritto del lavoro/previdenza, e un consulente del lavoro per la parte contabile, così da non perdere opportunità (ad es. presentare la domanda rottamazione nei termini, etc.). Nei paragrafi conclusivi, sintetizzeremo queste mosse in forma di domande e risposte per fissare i concetti chiave.
Domande frequenti (FAQ) su debiti INPGI e tutela del debitore
Domanda: Non ho versato i contributi INPGI 2 su alcuni compensi degli anni scorsi. Cosa rischio concretamente?
Risposta: Rischi innanzitutto l’accumulo di interessi e sanzioni (15% sull’importo dopo 4 mesi, più interesse legale), nonché un’azione di recupero coattivo da parte dell’INPGI tramite cartella esattoriale. Inoltre, finché sei in difetto, l’INPGI potrebbe non rilasciarti il DURC regolare (quindi potresti avere problemi a lavorare con committenti pubblici). A lungo termine, se i contributi restano non versati e diventano prescritti (dopo 5 anni), non potrai più usarli per la pensione (perderai l’anzianità contributiva di quei periodi). Nei casi di omissione dolosa di contributi da datore di lavoro per importi rilevanti, c’è anche il profilo penale: se hai dipendenti o collaboratori e non versi le loro quote previdenziali oltre €10.000 annui, commetti reato con pena fino a 3 anni (evitabile pagando il dovuto entro 3 mesi dalla contestazione). Insomma: se non regolarizzi, il debito cresce e possono derivarne azioni legali e perdite di diritti pensionistici. Meglio attivarsi presto per sistemare (pagando, magari a rate, o verificando prescrizioni) piuttosto che attendere la cartella.
Domanda: Ho ricevuto una cartella di pagamento per contributi INPGI non versati. Cosa devo fare subito?
Risposta: Per prima cosa, controlla la data di notifica della cartella e segnatela: da quella decorrono 40 giorni per un’eventuale opposizione giudiziaria. Poi, analizza il contenuto: per quali anni e importi ti chiedono contributi? Verifica se corrispondono a periodi in cui effettivamente non hai pagato. Se ritieni che la pretesa sia errata o non dovuta, prepara con un legale un ricorso al Tribunale (sez. lavoro) entro 40 giorni, eccependo ad esempio prescrizione, errore sul soggetto, attività non giornalistica, ecc.. Se invece la pretesa è corretta e semplicemente non riesci a pagare subito, puoi chiedere rateizzazione: se la cartella è di AER, rivolgiti all’Agenzia Entrate-Riscossione per un piano fino a 72-120 rate (online è abbastanza semplice). La richiesta di rateazione sospende intanto azioni esecutive. Valuta anche se puoi aderire a qualche definizione agevolata (ad esempio, se la cartella era entro 30/6/22, c’era la rottamazione-quater nel 2023: verifica se hai fatto domanda; se no, al momento non c’è, ma tieni d’occhio future sanatorie). In parallelo, se la somma è grossa, potresti negoziare col l’INPGI (ora INPS per gestione principale) una dilazione in fase amministrativa, soprattutto se il ruolo non è ancora esecutivo. In sintesi: non ignorare la cartella. O fai ricorso in tribunale entro 40 giorni (se hai valide ragioni) o attivati per pagare – in unica soluzione entro 60 giorni o tramite rate, chiedendole formalmente. Se non fai nulla, dopo 60 giorni l’Agenzia potrà procedere con recuperi forzati (pignoramento conto, stipendio, ecc.).
Domanda: La cartella INPGI contiene contributi molto vecchi (di oltre 5 anni fa). Posso farli dichiarare prescritti?
Risposta: Sì, la prescrizione quinquennale dei contributi può essere eccepita in giudizio. Se ad esempio nel 2025 ti chiedono contributi del 2016 e non ci sono stati atti interruttivi dal 2016 ad oggi, quei crediti dovrebbero essere prescritti. Tieni conto però delle sospensioni Covid: per i contributi 2018 la prescrizione è stata prorogata al settembre 2025, per il 2019 ad aprile 2026. Quindi, nel calcolo, aggiungi i giorni di sospensione. Inoltre, se si tratta di INPGI 2, la prescrizione decorre dalla tua dichiarazione dei redditi all’INPGI: se non l’avevi mai presentata, l’INPGI potrebbe sostenere che il termine non è partito. Ciò complica le cose. Comunque, in sede di opposizione tu puoi eccepire la prescrizione e spetterà all’INPGI provare eventuali atti interruttivi o far valere la regola della comunicazione. Molti giudici del lavoro accolgono l’eccezione se effettivamente l’ente è stato silente per oltre 5 anni. In sintesi: l’eccezione di prescrizione va sempre sollevata per i periodi oltre i 5 anni (tenuto conto di sospensioni); potrebbe non passare al 100% per via delle particolarità INPGI, ma è una difesa fondamentale che può alleggerire o azzerare il debito se riconosciuta.
Domanda: L’INPGI mi chiede contributi per una collaborazione che secondo me non era attività giornalistica. Posso oppormi?
Risposta: Sì, puoi contestare che non era lavoro giornalistico soggetto a INPGI. Dovrai dimostrare la natura diversa dell’attività. Ad esempio, se hai scritto testi ma come content editor pubblicitario, potresti sostenere che non rientrano nel perimetro giornalistico. Se il tuo committente non era un’azienda editoriale e la prestazione era ad esempio una consulenza di comunicazione, evidenzia questi elementi contrattuali. La Cassazione ha affermato che conta la sostanza delle mansioni: se c’è la creatività e finalità informativa tipica del giornalismo, i contributi sono dovuti. Quindi la difesa funziona se effettivamente l’attività era diversa (es. relazioni pubbliche, formazione, traduzione di testi, ecc.). Nel tuo ricorso, descrivi in dettaglio il lavoro svolto, allega eventualmente il contratto o la corrispondenza col committente che chiarisce il ruolo. Se convinci il giudice che non eri in veste di giornalista, l’obbligo contributivo INPGI cade e la richiesta deve essere annullata. Attenzione però: se eri comunque iscritto all’Albo e scrivevi articoli seppur per pubblicazioni atipiche (es. blog aziendali), l’INPGI tenderà a qualificare quello come giornalismo. La linea di demarcazione può essere sottile. Ma hai diritto di far valere la tua diversa interpretazione. Nei dubbi interpretativi, spesso si decide a tuo sfavore se c’è iscrizione all’Albo e pubblicazione rivolta al pubblico. Quindi valuta con l’avvocato la sostenibilità delle prove. In sintesi, puoi opporre “attività non giornalistica = niente contributi INPGI”, ma preparati a sostenere l’affermazione con fatti concreti e magari testimoni.
Domanda: Sono una piccola casa editrice e l’INPGI pretende contributi per un collaboratore che avevo pagato con ritenuta, sostenendo fosse in realtà un co.co.co. giornalistico. Posso difendermi?
Risposta: Puoi provare a difenderti su più fronti. Primo, verifica se il collaboratore era iscritto all’Ordine: se no, evidenzia che non potevi trattarlo da giornalista per mancanza di titolo (anche se ciò non garantisce, è un punto da sollevare). Secondo, argomenta che la sua collaborazione non aveva i requisiti del co.co.co. giornalistico: ad esempio, era saltuaria, senza vincolo di continuità, oppure di natura tecnica (foto, video editing) più che redazionale. L’INPGI dopo il 2009 inquadra anche collaborazioni coordinate come rapporti da assicurare. Per essere escluso, dovresti dimostrare che era prestazione autonoma occasionale (senza coordinamento). Se magari quell’autore scriveva un solo pezzo al mese in autonomia, potresti dire che era lavoro autonomo puro, e i contributi sarebbero dovuti solo se lui li dichiara in gestione separata come libero professionista (non come tuo co.co.co.). La difesa qui è tecnica e dipende dai fatti: contratti firmati, pagamenti, email di istruzioni ecc. Se risulta che di fatto c’era una collaborazione costante con direzione da parte tua (tipo consegna articoli settimanali concordati), l’INPGI ha ragione e difficilmente si sfugge all’obbligo (magari potrai solo ottenere di scomputare eventuali contributi pagati altrove). Se invece l’attività era molto libera e saltuaria, hai migliori chances di convincere il giudice che non era soggetta a INPGI ma caso mai a semplice gestione separata INPS. Ricorda però: se i compensi venivano dati per attività giornalistica, l’iscrizione all’INPGI del collaboratore scatta anche per poco (Cass. 9633/2016). La differenza è se era giornalismo in senso proprio o no. In conclusione, sì puoi difenderti, ma il successo dipenderà dalla qualificazione concreta del rapporto: in udienza i giudici guarderanno molto la sostanza. Prepara documenti e magari qualche dichiarazione per sostenere la tua versione.
Domanda: Ho aderito alla rottamazione 2023 per i debiti INPGI: cosa succede ora e cosa devo fare?
Risposta: Se hai presentato domanda entro il termine (poi prorogato al 30 giugno 2023), l’Agenzia Entrate-Riscossione ti avrà inviato entro la fine di giugno 2023 una comunicazione delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata. In quella comunicazione, per ciascuna cartella, è indicato l’importo da pagare scontato (solo contributo residuo + spese/notifiche, senza sanzioni/interessi) e il piano di pagamento che hai scelto (unica soluzione o rate). Dovrai pagare secondo quelle scadenze: la prima rata era fissata al 31 luglio 2023, la seconda al 30 novembre 2023, e poi nel 2024-2027 4 rate annue (28 feb, 31 mag, 31 lug, 30 nov). È fondamentale non saltare i pagamenti: se non paghi la prima o ritardi oltre 5 giorni, la rottamazione salta e tornano dovuti interamente sanzioni e interessi (con ripresa della riscossione). Quindi, assicurati di rispettare le scadenze; puoi anche prevedere addebito automatico sul conto per sicurezza. Durante il piano, non dovrai pagare ulteriori somme oltre quelle nelle comunicazioni: l’INPGI/AER sospende ogni azione esecutiva finché rispetti il piano. Alla fine, quando avrai pagato tutte le rate, il debito sarà estinto definitivamente. Tieni le quietanze di pagamento. Se, invece, non hai aderito pur avendo potuto, ormai per quella rottamazione è tardi. Puoi però eventualmente chiedere ad AER la rateizzazione ordinaria del residuo (pagando anche sanzioni e interessi, purtroppo). Al momento non ci sono proroghe: chi non ha aderito deve pagare in via ordinaria. In sintesi: per chi ha aderito – pagare puntualmente le rate; per chi non ha aderito – valutare rateazione normale e sperare in un futuro nuovo provvedimento.
Domanda: Ho un grosso debito contributivo e davvero non posso pagarlo per intero neanche a rate: ci sono soluzioni di saldo e stralcio individuali?
Risposta: Al di fuori delle sanatorie legislative (che abbiamo detto), l’INPGI in sé non può concederti di pagare meno del dovuto, perché vincolato a norme pubbliche. Tuttavia, esistono procedure di composizione della crisi per le persone fisiche (Legge 3/2012, ora Codice della Crisi) in cui puoi proporre ai tuoi creditori – inclusi gli enti previdenziali – un piano di ristrutturazione. In tali procedure (OCC, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio) potresti offrire, ad esempio, di pagare il 50% dei debiti contributivi e farti esdebitare dal resto. L’INPGI/INPS non può accettare formalmente meno del dovuto salvo queste sedi giudiziali. Devi rivolgerti a un Organismo di Composizione della Crisi che valuta il tuo caso. Questo è un ambito molto specialistico e funziona solo se sei sovraindebitato in generale (non per il singolo debito). In alternativa, se sei un’impresa (es. una casa editrice in crisi), potresti accedere a un concordato preventivo e proporre una transazione sul contributi (pagandone una percentuale). Ma per un privato giornalista, la via resta quella delle procedure da sovraindebitamento. Fuori da ciò, l’unica è attendere eventuali futuri saldo e stralcio legislativi (come fu nel 2019). In conclusione: non ci sono condoni “privati” con l’INPGI, bisogna passare per procedure concorsuali o sperare in una nuova legge di saldo e stralcio.
Domanda: Ho scoperto che il mio ex datore di lavoro non mi ha versato i contributi INPGI e ora sono prescritti. Posso fare qualcosa per la mia pensione?
Risposta: Sì, hai un paio di possibilità. Primo, puoi richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno previdenziale: in pratica, ai sensi dell’art. 2116 c.c., se il datore non versa i contributi e questi vanno prescritti, tu hai diritto a una “rendita vitalizia” a carico del datore pari alla pensione che l’INPGI ti negherà per quei contributi mancanti. È un’azione da fare in tribunale (Corte d’Appello – sezione lavoro, entro 5 anni dal pensionamento). Non è semplicissima ma è prevista dalla legge. In alternativa, se il datore esiste ancora, potresti accordarti che lui versi comunque i contributi (anche se prescritti) all’INPGI per riconoscerteli: l’INPGI in teoria non potrebbe accettarli come “pagamento coatto”, ma può accettarli come costituzione di rendita ex L. 1338/62. Dovresti parlare con l’INPGI (ora INPS per ex INPGI1) e il tuo datore per trovare una soluzione tecnica. Se il datore non esiste più o si rifiuta, l’unica alternativa è che versi tu stesso volontariamente i contributi per coprire quel buco – questo di solito è possibile solo se la cassa lo consente come riscatto. L’INPGI consente il riscatto laurea e altri periodi, ma per periodi lavorati e prescritti non c’è norma esplicita tranne la rendita di cui sopra. In parole povere: non tutto è perduto. Rivolgiti a un avvocato del lavoro e valuta una causa per rendita vitalizia contro l’ex datore. Se vinci, lui dovrà pagarti una somma periodica aggiuntiva quando andrai in pensione, compensando il minore importo che l’INPGI ti darà (perché mancano i contributi). Questa è una tutela prevista per i lavoratori di tutti i settori in casi del genere. Il consiglio è di non aspettare troppo: queste cause conviene farle magari subito al momento della pensione, quando hai contezza di quanto ti hanno penalizzato. Nel frattempo, raccogli prove che il datore non versò nonostante le trattenute (buste paga, estratti conto). Se il datore ha agito con dolo (non versando trattenute), sappi che c’è stata anche condanna penale magari (ma se è tanto tempo fa, sarà andata prescritta pure quella). In conclusione, per tutelare la tua pensione: azione civile contro il datore o versamento volontario oneroso sono le vie possibili.
Domanda: Sono indagato per omesso versamento di ritenute INPGI: come posso difendermi sul penale?
Risposta: Innanzitutto, verifica di rientrare nella soglia penale: dal 2016 è reato solo se hai omesso più di €10.000 di contributi trattenuti in un anno. Se stai sotto, è illecito amministrativo (multa). Se stai sopra, la miglior difesa è pagare integralmente il dovuto entro 3 mesi dalla contestazione (di solito dalla chiusura indagini): così estingui il reato e il procedimento penale viene archiviato o chiuso per adempimento. Quindi, se possibile, trova le risorse e versa tutto (magari anche chiedendo un prestito), perché ne vale della fedina penale. Se non riesci proprio a pagare tutto, allora dovrai difenderti dimostrando che non avevi dolo o colpa grave: ad esempio, che non sapevi dell’obbligo (difficile se sei datore professionale), o che un caso di forza maggiore ti ha impedito (fallimento improvviso, frode subita, ecc.). Ma questa strada raramente evita la condanna, perché la giurisprudenza è severa: basta la colpa a volte. Un’altra linea è dimostrare che l’importo contestato è calcolato male e in realtà sotto 10.000€ (magari includendo cose non dovute). Se riesci a ricondurlo sotto soglia, il reato non sussiste. Un bravo penalista del lavoro può aiutarti a setacciare i conteggi. In parallelo, cura la difesa nel merito: spiega se hai dilapidato i soldi dei contributi per pagare stipendi (non giustifica ma fa capire assenza di arricchimento). E se sei seriamente senza colpa (es. bonifico fatto ma finito su IBAN sbagliato per errore dell’INPGI), porta prove. Comunque, la chiave resta – come dice la norma – pagare: la legge ti dà questa chance unica di estinguere il reato semplicemente versando quanto dovuto (entro tre mesi dalla contestazione ufficiale). Se proprio non puoi in quel termine breve, sappi che in alcuni casi la giurisprudenza ha ritenuto non punibile chi paga prima della sentenza (ma è discrezionale). Quindi concentrati per trovare i fondi. Infine, tieni presente che la pena massima è 3 anni (spesso convertibile in sospensione condizionale o pena pecuniaria se sei incensurato), ma meglio evitare la macchia. Dunque, difesa penale = affidarsi a un avvocato penalista esperto di reati tributari/previdenziali e, parallelamente, cercare di regolarizzare la posizione contributiva (anche un piano di rateazione accettato dall’INPS/INPGI può essere un attenuante, sebbene non estingua formalmente il reato).
Domanda: Cosa è successo all’INPGI nel 2022? Devo ancora pagare all’INPGI o ora all’INPS?
Risposta: Dal 1° luglio 2022 l’INPGI 1 (gestione lavoratori subordinati) è stato incorporato nell’INPS. Ciò significa che se sei un datore di lavoro che assume giornalisti dipendenti, da quella data paghi i contributi all’INPS (Fondo Lavoratori Dipendenti) e non più all’INPGI. Anche i contributi arretrati per periodi fino al 30/6/2022 li devi regolarizzare seguendo istruzioni INPS. Ad esempio, l’INPS ha emanato circolari (n. 82/2022, 92/2022) con le aliquote e le causali per giornalisti ex-INPGI. L’INPGI continua ad esistere solo per la Gestione Separata (INPGI 2) dei giornalisti autonomi. Quindi, se sei un giornalista freelance, continui a rapportarti con l’INPGI per dichiarare e pagare i contributi sui tuoi redditi autonomi. Se però eri un dipendente e hai debiti contributivi pregressi (o l’azienda li ha), ora quelle pratiche sono gestite dall’INPS. In pratica, l’INPS è subentrato in tutti i crediti e debiti della gestione ex INPGI1. Per te, come debitore, cambia l’interlocutore: ad esempio, per chiedere una rateazione o un DURC ora ti rivolgi all’INPS, e se avevi in corso un contenzioso legale contro l’INPGI1, è subentrato l’INPS. In sintesi: INPGI 1 confluito in INPS, INPGI 2 rimane autonomo. Il “nuovo INPGI” gestisce solo i freelance e certe prestazioni residuali (mutui, ecc.). Tutto questo è stato fatto per salvaguardare le pensioni future dei giornalisti dipendenti perché l’INPGI1 era in forte passivo. Dal tuo punto di vista di contribuente, devi solo adeguarti al nuovo canale contributivo: l’INPS ha attribuito nuove posizioni contributive alle aziende giornalistiche, e i giornalisti dipendenti seguono le regole INPS per pensione (tranne una salvaguardia per chi aveva requisiti a giugno 2022). Quindi, se hai dubbi su a chi pagare ora, la regola è: dipendenti -> INPS, autonomi -> INPGI.
Domanda: Dove posso trovare le norme e le sentenze citate per approfondire?
Risposta: Nella sezione Fonti qui sotto troverai tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali usati in questa guida, con link alle sentenze o articoli che li commentano. Ad esempio, potrai leggere la sentenza Cass. Sez. Unite 21764/2021 che chiarisce i contributi per addetti stampa P.A., o la Cass. 9633/2016 sull’obbligo degli autonomi e la prescrizione. Inoltre troverai riferimenti al Messaggio INPS 3922/2022 per le rateazioni, alle circolari sul passaggio INPGI-INPS, alle notizie ANSA e Edotto sui controlli INPGI 2018-19, e alle fonti sulle rottamazioni. Tutti utili per un approfondimento tecnico. Buono studio!
Fonti
- Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n. 21764/2021 (29 luglio 2021) – Contributi INPGI dovuti per dipendenti pubblici addetti stampa: “in presenza dello svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’INPGI ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro”.
- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 9633/2016 (11 maggio 2016) – Obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPGI per i pubblicisti autonomi e decorrenza della prescrizione quinquennale dalla comunicazione del reddito all’INPGI.
- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 23296/2010 (18 novembre 2010) – Regime sanzionatorio INPGI: inapplicabilità dell’art. 116, co.20, L.388/2000 (buona fede del datore che versa ad ente diverso non esime da sanzioni).
- Regolamento INPGI Gestione Separata (ultimo agg. 2022) – Articoli rilevanti: art. 8 (obbligo dichiarazione redditi); art. 9 (prescrizione 5 anni dalla comunicazione); art. 7 (sanzioni civili per ritardato pagamento: 5%-10%-15%); art. 7 co.4 (sanzione ridotta per versamenti a ente errato); art. 4 (contributo integrativo 4%).
- Messaggio INPS n. 3922 del 31/10/2022 – Gestione ex INPGI: tutte le richieste di rateazione dal 1/7/2022 in poi vanno presentate all’INPS, applicando il Regolamento INPS anche ai debiti maturati verso INPGI fino al 30/6/2022. Modulo SC18 aggiornato per indicare posizione INPGI. (Riassunto in Quotidianopiù, 02/11/2022)
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1, commi 103-118 – Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale dell’INPGI (gestione sostitutiva AGO) dal 1° luglio 2022. INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell’INPGI 1. I giornalisti dipendenti passano al FPLD INPS, restando all’INPGI solo la Gestione Separata (INPGI/2) per autonomi.
- INPS – Circolare n. 82 del 14/07/2022 – Obblighi contributivi dei giornalisti dipendenti dopo il 1° luglio 2022 (aliquote, minimali, nuovi codici). E Circolare n. 92 del 28/07/2022 – Adeguamento requisiti pensionistici post-confluenza. (Disponibili su sito INPS).
- Portale INPGI – Rassegna sentenze: una miniera di massime. In particolare:
- Tribunale di Roma 13/02/2014 n. 1723: “Inopponibilità all’INPGI delle transazioni fra datore e lavoratore” – l’INPGI può pretendere contributi anche su somme oggetto di transazione privata.
- Cassazione 14/04/2010 n. 8901: Erroneo pagamento ad ente diverso – esclusa buona fede per esonero sanzioni – il datore che versa contributi all’INPS anziché all’INPGI non può invocare art. 116 L.388/00 in mancanza di prova rigorosa di buona fede (v. anche Cass. 23296/2010 citata).
- Cassazione 29/05/2013 n. 13408: conferma principi su obbligo INPGI per direttore testata (subordinazione) – c’entra meno col debito, più con inquadramento.
- Cassazione 18/11/2010 n. 23296: (già citata sopra in Rassegna).
- Tribunale di Roma 07/06/2021 n. 5473: Transazione fra datore e lavoratore inopponibile all’ente previdenziale (persistente obbligo contributivo su somme originarie).
- Corte dei Conti – Sezione controllo Enti: Determinazione e relazione sul risultato del controllo INPGI esercizio 2021 (pubbl. 2022) – evidenzia che nel 2021, ultimo anno di gestione INPGI1 autonoma, i contributi obbligatori della gestione principale sono aumentati del 1,93% (da €345,7 a 352,4 mln) mentre quelli della gestione separata sono diminuiti del 7% a causa del calo occupati autonomi. Menção al contributo straordinario 1% 2020-2024 a carico attivi per risanare bilancio
Sei un giornalista e hai accumulato debiti contributivi con l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani)? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Sei un giornalista e hai accumulato debiti contributivi con l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani)?
Hai ricevuto avvisi di pagamento, cartelle esattoriali o minacce di pignoramento?
Molti professionisti dell’informazione si trovano in difficoltà quando non riescono a versare i contributi dovuti all’INPGI. Sanzioni e interessi fanno crescere rapidamente il debito, che può sommarsi a pendenze fiscali e finanziarie, mettendo a rischio il patrimonio personale e la continuità dell’attività. La legge, però, offre strumenti concreti per ridurre, rateizzare o persino cancellare i debiti, evitando azioni esecutive aggressive.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua posizione contributiva con INPGI e la situazione debitoria complessiva
📌 Verifica la legittimità delle somme richieste, delle sanzioni e degli interessi applicati
✍️ Predispone piani di ristrutturazione del debito o procedure di sovraindebitamento specifiche per giornalisti
⚖️ Ti assiste nei rapporti con INPGI, Agenzia delle Entrate, banche e società di recupero crediti
🔁 Richiede l’esdebitazione per liberarti definitivamente dai debiti non più sostenibili
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto nella difesa di professionisti iscritti a enti previdenziali di categoria
✔️ Specializzato in sovraindebitamento e contenzioso contributivo e fiscale
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Anche un giornalista con debiti contributivi INPGI può trovare una via d’uscita legale e tornare a lavorare con serenità.
Con una strategia mirata puoi ridurre i debiti, bloccare i creditori e proteggere il tuo futuro professionale.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro i debiti INPGI comincia da qui.