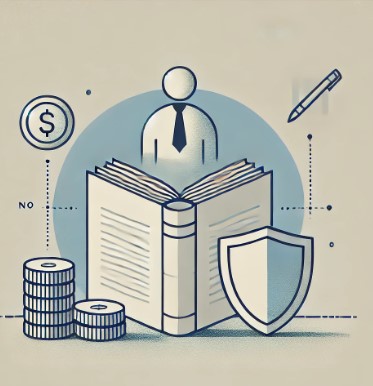Sei un ex socio di una casa editrice e ti ritrovi con debiti da pagare?
Anche dopo l’uscita dalla società, i creditori possono chiederti il pagamento di obbligazioni maturate durante il periodo in cui ne facevi parte. La responsabilità dipende dalla forma societaria, dagli accordi presi e dalle eventuali garanzie personali che hai prestato. Conoscere i tuoi diritti e le possibili strategie di difesa è fondamentale per proteggere il tuo patrimonio.
Quando un ex socio di casa editrice può essere chiamato a rispondere dei debiti
– Quando era socio di una società di persone (SNC o SAS) e risponde in solido per i debiti contratti durante la partecipazione
– Quando ha prestato fideiussioni o garanzie personali per finanziamenti, forniture, stampe o acquisti di materiale editoriale
– Quando la cessione delle quote o il recesso non sono stati formalizzati correttamente
– Quando restano in sospeso debiti fiscali o contributivi maturati prima dell’uscita
– Quando cause legali o vertenze contrattuali iniziate durante la sua partecipazione si concludono con condanne al pagamento
Cosa può accadere a un ex socio con debiti della casa editrice
– Pignoramento di conti correnti, stipendio o pensione
– Iscrizione di ipoteche su immobili personali
– Segnalazione come cattivo pagatore nelle banche dati creditizie
– Aumento del debito per interessi, sanzioni e spese legali
– Azioni esecutive anche anni dopo l’uscita, se relative a obbligazioni pregresse
Come difendersi legalmente
– Far verificare da un avvocato la reale entità della propria responsabilità e la legittimità della pretesa
– Dimostrare con documenti societari e contabili la data di uscita e la non imputabilità di debiti successivi
– Contestare fideiussioni o garanzie se nulle, prescritte o decadute
– Eccepire prescrizione o decadenza nei casi previsti dalla legge
– Negoziare con i creditori piani di rientro o accordi transattivi per ridurre l’importo dovuto
– Valutare, in caso di indebitamento grave, la procedura di sovraindebitamento per liberarsi dai debiti in modo legale
Cosa si può ottenere con la giusta assistenza legale
– L’esclusione dalla responsabilità per debiti sorti dopo l’uscita dalla società
– La riduzione consistente del debito complessivo
– La sospensione di pignoramenti e azioni esecutive
– La salvaguardia del patrimonio personale e familiare
– La chiusura definitiva delle posizioni debitorie contestate
Attenzione: uscire da una società non significa sempre essere automaticamente liberati da tutti i debiti. È fondamentale verificare la propria posizione, soprattutto in presenza di fideiussioni o garanzie personali.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti societari, tutela degli ex soci e difesa del patrimonio – ti spiega come difenderti se sei un ex socio di una casa editrice con debiti e quali passi intraprendere per proteggerti.
Hai ricevuto richieste di pagamento per debiti di una casa editrice da cui sei uscito?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua reale responsabilità, contesteremo le pretese indebite e studieremo una strategia per difenderti in modo efficace.
1. Introduzione
Diventare socio di una casa editrice – sia essa una piccola S.n.c. familiare o una S.r.l. strutturata – comporta impegni e responsabilità. Ma cosa accade se il socio esce dalla società e restano dei debiti insoluti? Questa guida affronta in dettaglio la posizione dell’ex socio debitore, con un taglio giuridico avanzato ma dal taglio divulgativo, aggiornato a luglio 2025. Verranno analizzate le differenze tra società di persone (ad esempio S.n.c., S.a.s.) e società di capitali (S.r.l., S.p.A.), evidenziando la normativa italiana e la giurisprudenza più recente. Dal punto di vista del debitore, spiegheremo come difendersi dalle pretese dei creditori (fornitori, banche, Fisco) e quali strumenti legali si possono utilizzare.
In particolare, approfondiremo: quali responsabilità continuano a gravare sull’ex socio dopo l’uscita; come rispondere a richieste di pagamento di debiti civili (mutui, fornitori, ecc.) e debiti tributari (imposte, tasse); gli effetti di procedure concorsuali come il fallimento (liquidazione giudiziale) e la possibilità di procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione per liberarsi dai debiti residui. Saranno inclusi esempi pratici, tabelle riepilogative schematiche e una sezione di Domande e Risposte per chiarire i dubbi più comuni. Le fonti normative e giurisprudenziali utilizzate (codici, leggi e sentenze) sono elencate in fondo alla guida per riferimento.
Scenario tipico: Immaginiamo una casa editrice costituita come S.n.c. in cui Tizio è socio al 50%. La società contrae debiti con fornitori e il fisco. Successivamente Tizio recede (esce) dalla società, che però rimane gravata da quei debiti. Tizio, ora ex socio, può essere chiamato a pagare quei debiti? Se sì, entro quali limiti e con quali difese? Questa guida risponderà a situazioni come questa, distinguendo a seconda del tipo di società e della natura del debito, per aiutare tanto gli avvocati quanto gli ex soci privati o imprenditori a orientarsi nelle possibili strategie difensive.
2. Quadro normativo: società di persone vs società di capitali
La responsabilità per i debiti sociali dell’ex socio dipende in modo cruciale dal tipo di società di cui faceva parte. L’ordinamento distingue tra:
- Società di persone (S.n.c., S.a.s., Società semplice, ecc.), nelle quali i soci (almeno quelli illimitatamente responsabili) rispondono personalmente e solidalmente dei debiti della società. In altre parole, i creditori possono chiedere il pagamento sia alla società sia direttamente ai soci con patrimonio personale. Questa responsabilità è illimitata, cioè non confinata al capitale investito, e solidalmente con gli altri soci e la società.
- Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a. per gli accomandanti, ecc.), dove vige il principio opposto: responsabilità limitata dei soci. L’art. 2462 c.c. sancisce che nella S.r.l. “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Similmente per la S.p.A. (art. 2325 c.c.). Ciò significa che i creditori sociali non possono di regola aggredire i beni personali dei soci per soddisfare i debiti della società.
Questa distinzione di base ha riflessi enormi sulla posizione dell’ex socio debitore. Nelle società di persone, il socio resta tradizionalmente visto come un co-obbligato verso i creditori, mentre nelle società di capitali il socio è separato dall’ente e protetto dal velo societario. Tuttavia, come vedremo, esistono eccezioni e condizioni: ad esempio, nella S.r.l. i soci possono diventare responsabili nei limiti di somme ricevute in sede di liquidazione.
Inoltre, la fase di uscita del socio è regolata da norme specifiche. Un aspetto chiave è la pubblicità della cessazione del rapporto sociale: l’uscita del socio va registrata (es. nel Registro delle Imprese) e portata a conoscenza dei terzi, altrimenti il socio uscente può continuare ad essere ritenuto responsabile da creditori che ignoravano in buona fede la sua uscita. Questo principio, sancito dall’art. 2290 c.c. per le società di persone, tutela l’affidamento dei terzi, ma implica per l’ex socio un onere di comunicazione per “tagliare” il cordone con le obbligazioni future.
Nei paragrafi seguenti analizzeremo separatamente la situazione dell’ex socio di società di persone e di società di capitali, per poi affrontare le peculiarità dei debiti tributari, le conseguenze di eventuale fallimento della società e le soluzioni di esdebitazione a favore dell’ex socio.
3. Responsabilità dell’ex socio nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.)
Nelle società di persone, la legge impone ai soci (illimitatamente responsabili) di farsi carico con il proprio patrimonio dei debiti sociali. Vediamo come questo principio si applica al caso dell’ex socio:
Responsabilità illimitata e solidale – L’art. 2291 c.c. stabilisce che in una S.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e qualsiasi patto contrario non ha effetto verso i terzi. Ciò significa che finché una persona è socio di una S.n.c., ogni debito contratto dalla società può essere richiesto anche a lui personalmente, per intero, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Lo stesso vale per i soci accomandatari della S.a.s. (art. 2313 c.c.) e per i soci di una società semplice.
Estensione agli ex soci: il momento di cessazione – Cosa accade se il socio esce dalla società? L’art. 2290 c.c. disciplina la responsabilità del socio uscente. In base a tale norma, il socio uscente (o i suoi eredi) resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. In altre parole, l’ex socio di S.n.c./S.a.s. continua ad essere garante dei debiti che esistevano (o che trovano causa) prima o durante il giorno della sua uscita. Non è invece responsabile dei debiti sociali sorti dopo la sua uscita, purché tale uscita sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Notifica ai terzi: La comunicazione dell’uscita del socio ai terzi è fondamentale. La legge richiede che lo scioglimento del rapporto sociale sia reso noto ai terzi con mezzi idonei (tipicamente, l’iscrizione della cessazione nel Registro delle Imprese). In mancanza di pubblicità, l’uscita non è opponibile ai terzi che ignoravano senza colpa il cambiamento. Dunque, un creditore che non sapeva della uscita potrebbe ancora considerare il soggetto come socio e pretenderne il pagamento. Sarà l’ex socio a dover provare di aver reso pubblica la propria cessazione.
Esempio: Mario era socio di una S.n.c. ed esce dalla società il 10 gennaio 2024 con regolare recesso, iscritto il 20 gennaio 2024 nel Registro Imprese. La società, però, aveva firmato un contratto di fornitura nel dicembre 2023 (quando Mario era socio) e non paga il fornitore a marzo 2024. Il fornitore, venuto a conoscenza che Mario era socio fino a gennaio, può chiedere a Mario il pagamento del debito, in quanto obbligazione sorta mentre Mario era socio. Viceversa, se la società contrae un nuovo debito a febbraio 2024, dopo l’uscita di Mario, Mario non ne risponderà purché il creditore fosse a conoscenza (o almeno informabile tramite il Registro) che Mario non era più socio. In caso contrario, se la notizia non è stata pubblicata, il creditore potrebbe coinvolgerlo in buona fede.
Debiti anteriori ma esigibili dopo – Un punto sottile riguarda le obbligazioni sorte prima ma divenute esigibili dopo l’uscita. Secondo una recente interpretazione, la responsabilità dell’ex socio copre i debiti contratti fino alla sua uscita purché l’obbligazione sia divenuta esigibile quando egli era ancora in carica. Se invece il debito matura interamente dopo, l’ex socio non avrebbe più possibilità di controllare l’adempimento e dunque non risponde. La Corte d’Appello di Roma nel 2025 ha chiarito che nell’art. 2290 c.c. il termine “obbligazioni sociali fino al giorno dello scioglimento” si riferisce non al momento di formazione del contratto, ma al momento in cui l’obbligazione diviene esigibile e resta inadempiuta. Ciò per tutelare l’affidamento dei terzi sulla permanenza del socio finché poteva influire sull’adempimento. Dunque, la responsabilità dell’ex socio si esclude per obbligazioni che sono rimaste inadempiute solo dopo la data di scioglimento del suo rapporto (ferma restando la necessità che i creditori fossero a conoscenza dell’uscita). In pratica: se la società aveva un debito “a termine” che veniva a scadenza dopo l’uscita, l’ex socio potrebbe sottrarsi, mentre per debiti già scaduti prima dell’uscita (anche se non ancora richiesti dal creditore) resta obbligato.
Beneficio di escussione – Un ex socio illimitatamente responsabile può invocare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale? Il cosiddetto beneficium excussionis è previsto dall’art. 2268 c.c. e dalla giurisprudenza come principio: il creditore sociale dovrebbe rivolgersi prima alla società e solo se i beni sociali non bastano può escutere i soci personali. Tuttavia, questo beneficio opera solo in sede esecutiva (pignoramento) e non in sede di cognizione. Ciò significa che un creditore può ottenere un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo) sia contro la società sia contro il socio indistintamente; ma quando passerà all’esecuzione forzata sui beni del socio, quest’ultimo potrà opporsi se il creditore non ha almeno tentato di escutere i beni della società. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità del socio è personale e diretta, sebbene sussidiaria rispetto al patrimonio sociale. Il socio non è considerato un “terzo” rispetto al debito, ma co-debitore al pari della società. Pertanto, in giudizio il socio non può eccepire di non essere parte del rapporto (non può sottrarsi al pagamento invocando la priorità della società), mentre in fase esecutiva potrà chiedere la preventiva escussione dei beni sociali (se ve ne sono).
Soci accomandanti (S.a.s.) – Un discorso a parte va fatto per gli accomandanti nella S.a.s., i quali per definizione rispondono solo nei limiti del conferimento (art. 2313 c.c.). Un socio accomandante non è illimitatamente responsabile dei debiti sociali, né prima né dopo l’uscita, salvo che abbia violato il divieto di immistione nell’amministrazione. Infatti, l’art. 2320 c.c. prevede che se l’accomandante ingerisce nella gestione o compie atti di amministrazione verso terzi, perde il beneficio della responsabilità limitata e diviene responsabile illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali. Dunque: l’ex socio accomandante che si è sempre comportato come tale (senza gestire) non risponderà con patrimonio personale nemmeno dei debiti anteriori, a meno che il creditore dimostri che in realtà ha agito come amministratore occulto. Se però l’accomandante ha violato le regole (ad esempio firmando contratti con terzi a nome della società), viene equiparato a un accomandatario anche per il passato, e quindi anche dopo l’uscita potrebbe essere chiamato a pagare i debiti sorti nel periodo in cui svolgeva di fatto attività gestionale.
Riassumendo – Ex socio di società di persone: egli rimane obbligato per i debiti contratti fino alla sua uscita (inclusi quelli sorti quando era socio e rimasti insoluti), salvo che la cessazione fosse nota ai creditori e l’obbligazione sia sorta/esigibile successivamente. La sua responsabilità è pari a quella dei soci attuali: illimitata e personale. Può però pretendere che, in sede di esecuzione, prima si escutano i beni sociali. È essenziale formalizzare e pubblicizzare la cessazione del rapporto sociale, consegnandone prova al bisogno.
4. Responsabilità dell’ex socio nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.)
Nelle società di capitali, il socio gode normalmente di piena protezione rispetto ai debiti sociali: il creditore sociale non può chiedergli il pagamento, potendosi soddisfare solo sul patrimonio della società. Questa regola vale durante la vita sociale e, in linea di massima, continua a valere dopo l’uscita del socio. Ci sono però importanti eccezioni e situazioni particolari da considerare, in cui anche un ex socio di S.r.l. o S.p.A. può essere chiamato a rispondere di debiti sociali, seppur entro limiti ben precisi.
Principio generale: nessuna responsabilità personale – Come già ricordato, l’art. 2462 c.c. afferma che nella S.r.l. risponde solo la società con il proprio patrimonio. Lo stesso principio è applicabile alle S.p.A. (art. 2325 c.c.) e, in generale, a tutte le società di capitali. Dunque un socio (o ex socio) non può essere costretto a pagare i debiti sociali solo in virtù della sua partecipazione societaria. Ad esempio, se una casa editrice costituita come S.r.l. accumula debiti con fornitori o banche e l’ex socio Caio viene contattato dal creditore, egli potrà eccepire che la sua responsabilità è esclusa per legge (a meno che non ricorra una delle eccezioni che ora vedremo).
Obblighi pendenti verso la società – Una prima ipotesi di coinvolgimento del socio riguarda gli eventuali obblighi interni non adempiuti. Ad esempio, se l’ex socio non aveva ancora liberato interamente il capitale sottoscritto (quote non completamente versate), la società o il curatore in caso di insolvenza potrebbero richiedere quei versamenti dovuti. Inoltre, in caso di S.r.l. unipersonale, la legge prevede cautele: se l’unico socio non adempie agli obblighi di conferimento o omette di depositare atti prescritti (es. non pubblicizza l’unipersonalità), può perdere la garanzia del capitale e diventare illimitatamente responsabile delle obbligazioni sorte nel periodo di irregolarità (art. 2462, comma 2 c.c.). Dunque un ex socio unico potrebbe essere chiamato a rispondere di debiti se, durante la sua titolarità esclusiva, non ha rispettato tali formalità e la società è poi insolvente (questa è una situazione peculiare prevista a tutela dei creditori contro abusi dell’unico socio).
Responsabilità post-liquidazione (art. 2495 c.c.) – L’eccezione più rilevante al principio di limitazione riguarda l’ipotesi di scioglimento e cancellazione della società. Quando una società di capitali viene liquidata e cancellata dal Registro delle Imprese, essa cessa di esistere come soggetto giuridico. Tuttavia, i debiti sociali insoddisfatti non si estinguono magicamente con la cancellazione. Per evitare che i creditori restino senza tutela, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i propri crediti nei confronti degli ex soci, entro il limite di quanto questi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. In pratica, si realizza una sorta di “successione” nei debiti: i soci, incassando l’attivo residuo, diventano debitori pro quota verso i creditori insoddisfatti, ma solo entro l’importo ricevuto. Se un socio non ha ricevuto nulla in liquidazione, in via di principio non dovrà pagare nulla di tasca propria. Se invece ha ricevuto 10.000 €, potrà essere chiamato a rispondere dei debiti sociali fino a 10.000 € (oltre interessi eventualmente maturati), ma non oltre.
Questo principio garantisce un equilibrio: i creditori possono ancora recuperare qualcosa a posteriori, ma il socio non rischia più di quanto effettivamente ha beneficiato dalla liquidazione. La norma aggiunge che i creditori possono agire anche contro i liquidatori se il mancato pagamento è colpa di questi (ad esempio, se hanno ripartito attivo ai soci lasciando debiti noti insoddisfatti). Per gli ex soci, invece, non si richiede colpa: la loro responsabilità deriva ex lege dal fatto di aver ricevuto risorse in luogo dei creditori.
Esempio pratico: La casa editrice Alfa S.r.l. si liquida nel 2025. Dopo aver venduto tutti i beni, restano debiti per 50.000 € verso fornitori; il liquidatore però ripartisce ai due soci un residuo attivo di 20.000 € (10.000 € ciascuno). A società cancellata, i fornitori rimasti a mani vuote potranno citare in giudizio i due ex soci, chiedendo a ciascuno fino a 10.000 €. Gli ex soci dovranno pagare (in proporzione al ricevuto) i creditori insoddisfatti. Se avessero ricevuto di più, la responsabilità comunque si ferma all’importo incassato. Se un socio non ha ricevuto nulla (attivo esaurito per pagare in parte i creditori), egli non è tenuto a versare nulla di aggiuntivo. Inoltre, i fornitori potrebbero anche agire contro il liquidatore se possono provare che ha distribuito attivo ai soci omettendo colpevolmente di pagare quei debiti.
Conoscenza e prova delle somme ricevute – Affinché i creditori possano far valere efficacemente tali pretese contro gli ex soci, occorre dimostrare quanto ogni socio ha percepito. La Cassazione ha chiarito che l’onere della prova in merito spetta ai creditori (o all’Amministrazione finanziaria, nel caso di imposte): se l’ex socio contesta di aver ricevuto utilità, è il creditore che deve provare la riscossione di somme da parte di quel socio. Per questo motivo, spesso l’azione contro gli ex soci si basa sul bilancio finale di liquidazione: se da esso risulta una ripartizione, quella è la prova dell’attivo percepito. In mancanza di evidenze (es. se il bilancio finale mostra zero residuo), sarà arduo per il creditore ottenere qualcosa, a meno di dimostrare che in realtà vi sono stati trasferimenti occulti ai soci. Su questo punto, la giurisprudenza ha mostrato rigore: nessuna responsabilità automatica degli ex soci, ma solo nei limiti del vantaggio economico concretamente ricevuto.
Da ultimo, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 3625/2025) sono intervenute per risolvere contrasti interpretativi proprio su quest’area (debiti tributari di società estinte, v. paragrafo successivo). Hanno confermato la linea “intermedia”: gli ex soci non diventano debitori illimitati, ma rispondono solo fino alla concorrenza dell’attivo percepito. Inoltre, hanno ribadito che per pretendere il pagamento dall’ex socio occorre notificargli un atto motivato specifico, non essendo sufficiente trascinare il socio nel procedimento già intentato contro la società. In sostanza, l’effettiva responsabilità patrimoniale del socio “esiste solo se si dimostra la percezione di somme” e il creditore deve attivarsi direttamente contro di lui per accertarlo. Nel frattempo, eventuali sanzioni amministrative (es. multe) a carico della società si estinguono con essa e non si trasferiscono ai soci – su questo torneremo parlando di debiti tributari.
Altre ipotesi di coinvolgimento del socio – Pur restando la regola dell’assenza di responsabilità personale, segnaliamo altre situazioni in cui un ex socio di società di capitali potrebbe trovarsi esposto:
- Garanzie personali: Spesso soci o amministratori rilasciano fideiussioni o garanzie personali a favore di banche e fornitori per ottenere credito alla società. Tali garanzie restano valide anche dopo l’uscita del socio (salvo diversa pattuizione). Quindi, se l’ex socio aveva firmato da garante, può essere escusso dal creditore in base al contratto di fideiussione, indipendentemente dalla responsabilità societaria limitata. In tal caso, tuttavia, il socio paga non “in quanto ex socio”, ma in forza di un’obbligazione contrattuale distinta. Le difese consisteranno nell’opporre eventuali vizi della fideiussione o benefìci previsti in quel contratto (ad es. beneficio di escussione se non rinunciato, eccezioni ex art. 1945 c.c., ecc.).
- Abuso della personalità giuridica – “piercing the veil”: In casi estremi, la giurisprudenza ha riconosciuto che quando i soci di S.r.l./S.p.A. usano la società come schermo per frodare i creditori, si possa “superare” il velo societario ritenendo i soci direttamente responsabili. Ad esempio, se un socio di controllo svuota la società trasferendo attività a sé stesso o a terzi compiacenti, oppure costituisce una società di fatto occulta dietro la facciata della S.r.l., i creditori possono provare l’abuso e ottenere dal giudice una estensione della responsabilità al socio per i danni causati. Questo non è previsto da una norma scritta specifica, ma è frutto di elaborazione giurisprudenziale (principio dell’“etero-integrazione dell’art. 2476 c.c.” o dell’impropria estensione del fallimento nelle società schermo). Resta comunque un rimedio eccezionale: il socio agiva di fatto come amministratore occulto o confondeva il patrimonio sociale col proprio. In simili situazioni (molto tecniche), l’ex socio può essere citato dai creditori per rispondere illimitatamente, ma i creditori hanno l’onere probatorio elevato di dimostrare l’abuso.
- Azione dei creditori sociali verso amministratori e soci influenti: Un ex socio che in passato abbia rivestito anche il ruolo di amministratore potrebbe essere citato in giudizio non come debitore dell’obbligazione sociale, ma per risarcimento danni verso i creditori sociali. L’art. 2476 c.c. (comma 6) consente ai creditori di agire contro amministratori se questi violando i loro doveri hanno leso il patrimonio sociale non sufficiente a soddisfare i crediti. In alcune interpretazioni (comma 7 previgente) si prospettava una responsabilità accessoria dei soci che abbiano deliberatamente autorizzato atti pregiudizievoli (es. un socio che approva distribuzioni illegittime di utili causando insolvenza). Pur trattandosi di fattispecie diverse dal far valere un debito sociale, conviene ricordare che un ex socio che abbia esercitato poteri gestori o di forte influenza potrebbe essere chiamato a rispondere di mala gestio (cattiva gestione) qualora abbia concorso a cagionare il dissesto della società. Ad esempio, se come socio di maggioranza ha imposto decisioni disastrose, il curatore fallimentare o i creditori potrebbero promuovere un’azione di responsabilità per ottenere dal suo patrimonio il risarcimento del deficit creato. Queste sono però azioni risarcitorie fondate su condotte illecite, non sul semplice status di ex socio.
Riassumendo – Ex socio di società di capitali: di regola non risponde dei debiti sociali con il proprio patrimonio. Fanno eccezione i casi in cui abbia ricevuto attivo dalla liquidazione della società (in tal caso risponde verso i creditori insoddisfatti entro il limite di quanto incassato), oppure ove abbia assunto volontariamente garanzie personali per i debiti, o ancora qualora sia provato un abuso della forma societaria o responsabilità per mala gestio. In ogni caso, non c’è responsabilità illimitata paragonabile a quella del socio di società di persone: i rischi sono circoscritti e condizionati a specifici presupposti.
5. Debiti tributari: posizione dell’ex socio verso il Fisco
I debiti tributari (imposte, IVA, tasse, contributi previdenziali assimilati) meritano un capitolo a parte perché soggetti a normative speciali e a prassi particolari. La posizione dell’ex socio di fronte al Fisco dipende anch’essa dal tipo di società, ma con alcune peculiarità: l’Amministrazione finanziaria, in virtù di norme specifiche, può tentare di recuperare i tributi non pagati direttamente dai soci in determinati casi. Vediamo le regole per società di persone e di capitali.
5.1 Società di persone: ex socio e debiti fiscali
Per le società di persone, non c’è una distinzione netta tra debiti “civili” e debiti “tributari”: le imposte dovute dalla società ricadono sui soci illimitatamente responsabili al pari di qualsiasi altro debito sociale. Ad esempio, se una S.n.c. non paga IVA o IRAP, l’Agenzia delle Entrate può legittimamente pretendere il pagamento dai singoli soci (anche mediante cartella di pagamento o accertamento a loro notificato). Il socio di una S.n.c. risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni fiscali sorte nel periodo in cui era socio, esattamente come per un debito verso fornitori. Quindi un ex socio di S.n.c. sarà responsabile verso il Fisco per le imposte (e relativi interessi) riferite a periodi fino alla sua uscita, mentre per i tributi maturati dopo non lo sarà, a condizione – come visto – che abbia reso pubblica la cessazione.
In tal senso, la Cassazione ha confermato che il socio risponde delle obbligazioni sociali tributarie sorte solo fino al momento in cui la cessione/recesso è iscritta in Registro Imprese, e non di quelle sorte successivamente. Ad esempio, se Caio era socio fino al 2019 e la società omette imposte nel 2018, l’Agenzia potrà esigere da Caio il pagamento (solidalmente col resto). Se invece la società nel 2020 (dopo la sua uscita formalizzata) non versa imposte, Caio non risponderà di queste, a meno che l’ufficio non provi che la sua uscita non era conoscibile (ipotesi rara, data la pubblicità legale). Resta dunque valido tutto quanto visto sopra: l’ex socio di S.n.c./S.a.s. ha l’onere di dimostrare il momento di uscita per sottrarsi a cartelle relative a periodi successivi.
Accertamento fiscale del reddito di partecipazione – Spesso per i soci di società di persone la questione tributaria si presenta sotto forma di accertamento sui redditi: il Fisco rettifica il reddito della società (trasparente) e quindi emette avvisi ai soci per maggiori imposte personali dovute su quel reddito. Anche qui, se l’anno accertato è precedente all’uscita del socio, l’ex socio verrà coinvolto a pieno titolo, a meno che dimostri di non essere più socio da prima (es. l’accertamento riguarda l’anno successivo all’uscita). Nella sentenza Cass. 7688/2013 (citata nel §3) la Corte ha annullato un avviso ad un’ex socia perché era risultato che il reddito accertato riguardava un periodo successivo al suo recesso già comunicato. Ciò conferma che anche per il fisco vale la regola: debiti tributari sorti dopo l’uscita non gravano sull’ex socio.
Sanzioni tributarie – Un aspetto importante: le sanzioni amministrative tributarie (ad es. le multe per omessi versamenti, violazioni fiscali) non si trasferiscono ai soci in caso di società di persone? In realtà, nelle società di persone la questione è meno rilevante perché la società stessa non ha personalità giuridica distinta ai fini fiscali (nelle S.n.c./S.a.s. vige la trasparenza fiscale per i redditi, mentre IVA e altre imposte sono riferite alla società come soggetto). Le sanzioni per violazioni commesse dalla società di persone in materia di IVA, ritenute, ecc., formalmente colpiscono la società; ma poiché i soci ne rispondono in solido come di un debito, l’Erario potrebbe tentare di riscuoterle dai soci. Tuttavia, la norma generale (art. 7 D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003 e art. 2 d.lgs. 472/97) afferma che le sanzioni tributarie sono personali e non si trasmettono agli eredi o ai successori salvo eccezioni – questo di solito riguarda la trasformazione o successione di enti. Per prudenza, e in analogia a quanto chiarito per le società di capitali (v. infra), si ritiene che le sanzioni pecuniarie non ricadano sui soci neppure di società di persone dopo la cessazione della società: i soci rispondono delle imposte evase, ma non delle multe collegate. Infatti, le Sezioni Unite 2025 hanno espressamente confermato che le sanzioni “muoiono” con la società estinta. Nel caso di società di persone estinta, l’Erario potrà comunque perseguire i soci per il tributo (imposta) evaso, ma non per la sanzione amministrativa correlata.
Contributi previdenziali (INPS) – I contributi previdenziali obbligatori (es. contributi dovuti per dipendenti o artigiani/commercianti) seguono regole analoghe alle imposte. L’INPS considera i soci di S.n.c. solidalmente responsabili per i contributi non versati dalla società, in quanto obbligazioni sociali. Pertanto, un ex socio di S.n.c. potrà essere chiamato dall’INPS a pagare contributi arretrati riferiti a periodi antecedenti o coincidenti con la sua partecipazione, ma non quelli successivi all’uscita debitamente comunicata. Anche qui le sanzioni civili (more e aggi) seguono la sorte dei contributi in linea di massima, quindi il discorso ricalca le imposte.
5.2 Società di capitali: ex socio e debiti tributari (art. 36 DPR 602/1973)
Per le società di capitali, come visto, i soci non rispondono dei debiti sociali salvo quanto previsto dall’art. 2495 c.c. dopo la liquidazione. Nel caso dei debiti tributari, però, esiste una disposizione specifica – l’art. 36 del DPR 602/1973 – che disciplina la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per le imposte non pagate dalla società in liquidazione. Questa norma è stata pensata per tutelare l’Erario nel caso di società che si sciolgono con debiti fiscali, evitando che i soci portino via attivi lasciando il Fisco insoddisfatto. Ecco i punti chiave:
- Ambito temporale: Art. 36 prevede che i soci che nei due anni precedenti la messa in liquidazione o durante la liquidazione abbiano ricevuto assegnazione di somme o beni sociali, rispondono dei debiti tributari della società entro il limite del valore di quanto ricevuto. Si estende così l’arco di osservazione: non solo ciò che il socio riceve al termine (bilancio finale), ma anche eventuali distribuzioni anticipate nei due esercizi prima dello scioglimento (es. dividendi, rimborsi di finanziamenti soci, restituzioni di capitale) vengono considerate. Lo scopo è evitare che i soci “svuotino” la società prima della liquidazione per sfuggire al Fisco. Ad esempio, se la S.r.l. ha distribuito un dividendo nel 2024 e poi si scioglie nel 2025 con debiti fiscali, quell’importo 2024 percepito dai soci può essere computato tra le somme di cui rispondono verso l’Erario.
- Limite quantitativo: Il socio risponde entro il limite del valore dei beni ricevuti (sommandovi tanto le assegnazioni pre-liquidazione negli ultimi due anni, quanto quelle risultanti dal bilancio finale). Non c’è dunque responsabilità oltre quanto incassato complessivamente. Se Tizio ha ricevuto 5.000 € di utili nel biennio e 10.000 € a liquidazione, risponderà al massimo di 15.000 €. Se non ha ricevuto nulla né prima né durante la liquidazione, non può essergli imputato alcunché.
- Natura della responsabilità: La giurisprudenza ha chiarito che questa responsabilità ex art. 36 non è “tributaria” in senso stretto, ma civilistica – ossia deriva da un obbligo legale proprio del socio di restituire quelle somme ai fini di pagare i debiti sociali. Non si tratta di una coobbligazione solidale nel tributo, bensì di un’obbligazione nuova che sorge in capo al socio (o liquidatore) per legge, avente causa nel pregiudizio ai creditori. Questo significa ad esempio che, per attivarla, l’Agenzia Entrate deve seguirne le relative procedure (non basta dire “il socio è obbligato”, ma va emesso un atto ad hoc), e che il socio può opporre tutte le eccezioni relative a tale posizione (ad esempio contestare di aver ricevuto effettivamente somme, contestare la quantificazione, ecc.).
- Procedura di accertamento: L’art. 36, comma 5, DPR 602/73 stabilisce che la pretesa nei confronti di liquidatori e soci deve essere formalizzata con un atto motivato, notificato agli interessati, contro cui è ammesso ricorso secondo le norme sul contenzioso tributario. Non è quindi possibile per l’Erario limitarsi a iscrivere a ruolo (emissione di cartella) il socio senza prima avergli notificato un avviso che gli contesti esplicitamente la responsabilità. Le Sezioni Unite 2025 hanno ribadito ciò come principio di diritto: l’accertamento della responsabilità degli ex soci va fatto tramite autonomo avviso di accertamento specificamente rivolto a loro, per evitare coinvoliementi automatici nel processo della società. In altre parole, se una S.r.l. viene accertata per imposte evase, non è possibile che lo stesso avviso emesso alla società valga anche per i soci: serve un atto ulteriore che – una volta definito l’importo rimasto insoluto dopo la liquidazione – richiami la responsabilità del socio nei limiti dovuti.
- Onere della prova: Analogamente a quanto visto per l’art. 2495 c.c., anche per l’art. 36 DPR 602/73 la Cassazione (specie con SU 3625/2025) ha chiarito che la ricezione di somme da parte del socio è un presupposto essenziale. Se il socio contesta di aver ricevuto attivo, spetta al Fisco provare il contrario, ad esempio producendo il bilancio finale di liquidazione da cui risulti la distribuzione o evidenziando gli atti di assegnazione nei due anni antecedenti. La semplice esistenza del debito fiscale e della qualità di socio non bastano. Inoltre, le SU hanno aggiunto che l’interesse ad agire dell’Erario contro i soci può sussistere anche se il bilancio finale non mostra distribuzioni, qualora vi siano altre evenienze che indicano utilità trasferite ai soci (es. beni non risultanti formalmente ma di fatto incamerati dai soci, oppure escussione di garanzie prestate dai soci che hanno pagato al posto della società). Ma queste situazioni vanno provate e non si presumono.
- Presunzioni di “beneficio occulto”: Prima delle SU 2025, alcune pronunce (Cass. ord. n. 20840/2023) avevano ammesso che in casi di S.r.l. a ristretta base familiare, la presenza di utili extrabilancio (evasione fiscale) potesse far presumere un vantaggio anche in assenza di distribuzioni formali: in pratica, se la società ha nascosto ricavi, si può presumere che siano finiti nelle tasche dei soci, rendendoli chiamabili a rispondere dei debiti tributari anche senza un bilancio finale attivo. In tali casi, l’onere probatorio si invertirebbe, richiedendo al socio di dimostrare di non aver fruito di quei proventi non dichiarati. Tuttavia, le SU 2025 hanno riportato la regola generale: serve dimostrare l’effettivo incasso perché il socio paghi, evitando automatismi punitivi. Dunque, queste presunzioni restano utilizzabili solo in presenza di gravi indizi concreti di distrazione di utili verso i soci; ma in mancanza, vige la tutela del socio, che non paga se non si prova il contrario.
Sanzioni tributarie nella società di capitali estinta – Come anticipato, un elemento di favore per gli ex soci è l’esclusione delle sanzioni. Le sanzioni amministrative fiscali comminate alla società (es. per infedele dichiarazione) non seguono il passaggio ai soci: muoiono con la società. Le Sezioni Unite hanno confermato che i soci rispondono solo di imposte e interessi, non delle pene pecuniarie. Ciò significa che se una società aveva 100.000 € di imposte evase e 40.000 € di sanzioni, il Fisco potrà chiedere ai soci al massimo i 100.000 (pro quota sui loro incassi) più gli interessi dovuti, ma non quei 40.000 € di sanzioni, che rimangono definitivamente a carico della società ormai estinta e dunque irrecuperabili. Questa scelta legislativa si spiega col carattere personale-punitivo della sanzione, che non può essere trasferito a chi non ha commesso direttamente la violazione (il socio potrebbe essere all’oscuro delle decisioni fiscali).
Procedura di riscossione – In concreto, quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione intende escutere ex soci di S.r.l. per tributi non pagati, procede di solito così: verifica se la società è cessata; controlla il bilancio finale e gli atti degli ultimi anni; emette eventualmente un avviso di accertamento art.36 DPR 602/73 indirizzato al socio, indicandogli l’importo delle imposte rimaste insolute e la quota per cui lo ritiene responsabile (limitata al valore dei beni/denaro ricevuti). L’ex socio può difendersi presentando ricorso in Commissione Tributaria, contestando ad esempio di non aver percepito importi, o che il calcolo è errato, o che la pretesa fiscale originaria verso la società era infondata/non definitiva. Se l’avviso diventa definitivo, verrà iscritta a ruolo la somma dovuta e notificata la cartella di pagamento al socio. È importante notare che l’avviso non può essere notificato oltre i termini di decadenza dell’accertamento fiscale originario (di regola, entro il quinto anno successivo per omessi versamenti, o entro termini dell’art. 43 DPR 600/73 per imposte dirette). Inoltre, l’azione nei confronti dei soci ha comunque un limite fisiologico: passato troppo tempo dalla cancellazione, far valere queste pretese potrebbe incontrare ostacoli di prescrizione (secondo alcuni, la prescrizione per far valere il 2495 c.c. è 5 anni, analogamente per l’azione ex art.36; secondo altri 10 anni come azione ordinaria). In ogni caso, il D.Lgs. 175/2014 ha introdotto all’art. 28, co.4, che “l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni” a fini fiscali: significa che l’Agenzia può considerare la società ancora esistente fino a 5 anni dopo la cancellazione per completare accertamenti, ma dopo 5 anni la società è definitivamente estinta anche per il Fisco e i soci non possono più essere coinvolti se non hanno già ricevuto atti. Questo dettaglio tecnico è da tenere presente per contenziosi tributari protratti.
Riassumendo – Debiti tributari ex socio di S.r.l.: l’ex socio risponde verso il Fisco solo nei limiti delle somme o beni di cui ha beneficiato dalla società nei due anni antecedenti lo scioglimento o in sede di liquidazione. L’Erario deve notificargli un atto specifico e provare tali benefici. In difetto, l’ex socio non può essere tenuto a pagare. Le multe fiscali non si trasmettono. Quindi, se non ha tratto profitto dalla società, il socio è protetto; se invece ha ricevuto denaro a scapito dei creditori pubblici, dovrà restituirlo (in tutto o in parte) per saldare quelle imposte rimaste.
6. Fallimento della società ed effetti sugli ex soci
Quando i debiti sono particolarmente gravi, si può arrivare alle procedure concorsuali (fallimento, oggi detta liquidazione giudiziale, o altre procedure di insolvenza). In questo contesto emergono ulteriori differenze tra società di persone e di capitali, soprattutto riguardo alla possibilità che anche l’ex socio sia dichiarato fallito (o coinvolto nella procedura). Approfondiamo questi aspetti dal punto di vista del socio debitore.
6.1 Società di persone e fallimento (liquidazione giudiziale)
Le società di persone possono essere dichiarate fallite (ora assoggettate a liquidazione giudiziale) se svolgono attività d’impresa commerciale e ricorrono i presupposti di insolvenza previsti dalla legge. Un punto cardine della vecchia Legge Fallimentare (R.D. 267/1942, art. 147) e confermato nel nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019, art. 256) è che il fallimento della società di persone si estende ai soci illimitatamente responsabili. In altre parole, quando un Tribunale dichiara il fallimento di una S.n.c. o di una S.a.s., contestualmente (o successivamente su richiesta) può essere dichiarato il fallimento personale di ciascun socio illimitatamente responsabile. I patrimoni personali dei soci entrano così a far parte della massa attiva liquidabile per soddisfare i creditori sociali.
Ex socio e estensione del fallimento – L’estensione ai soci include anche i soggetti che erano soci al tempo in cui sono sorti i debiti poi sfociati in insolvenza? La regola è che vengono dichiarati falliti i soci attuali al momento dell’apertura della procedura. Tuttavia, l’art. 147 L.F. (ora art. 256 CCII) prevedeva un limite temporale per coinvolgere gli ex soci: non si può dichiarare il fallimento di un socio decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale. Ciò significa che se un socio ha lasciato la società più di un anno prima della sentenza di fallimento, egli è “fuori portata” e il suo fallimento personale non può più essere dichiarato. Viceversa, se l’uscita è avvenuta in un tempo più recente (meno di un anno prima), l’ex socio può essere dichiarato fallito in estensione, perché la legge presume che i creditori abbiano fatto affidamento sulla sua presenza fino a un anno dopo. Ad esempio, Tizio recede da una S.n.c. nel gennaio 2024; se la società viene dichiarata fallita a dicembre 2024 (meno di 12 mesi dopo), anche Tizio rischia la declaratoria di fallimento personale. Se invece il fallimento della società avviene nel 2026, oltre l’anno, Tizio non può più essere dichiarato fallito per quelle obbligazioni. Questo termine annuale è perentorio e rappresenta un bilanciamento tra tutela dei creditori e certezza per chi esce da una società.
Va notato che il termine si conta dallo scioglimento del rapporto sociale (quindi dalla data di recesso, esclusione o cessione quota formalizzata): di nuovo diventa cruciale la tempestiva registrazione dell’evento. Se l’ex socio non formalizza l’uscita e la società fallisce, potrebbe essere considerato ancora socio e fallire con essa, a meno di provare che l’uscita era di fatto avvenuta anteriormente di oltre un anno (ma senza registrazione, è difficile).
Diritto di difesa dell’ex socio nella procedura – In passato, il fallimento dei soci avveniva d’ufficio contestualmente a quello della società, spesso senza neppure sentire il socio (bastava la qualità di socio illimitatamente responsabile). Oggi, grazie anche a interventi della Corte Costituzionale, i soci devono essere convocati prima di dichiararne il fallimento, e hanno diritto di contestare la loro qualità di soci o far valere il decorso dell’anno. La Corte Cost. n. 87/2025 ha chiarito che i soci palesi di società semplice/commerciale devono essere chiamati nel procedimento di fallimento della società se ne consegue anche la loro possibile insolvenza, altrimenti la dichiarazione di fallimento nei loro confronti successiva potrebbe non essere loro opponibile. In pratica, si sta rafforzando la garanzia processuale per i soci, che ora hanno la possibilità di difendersi: possono eccepire di non essere soci (ad esempio, se contestano la propria responsabilità illimitata o dicono di essere accomandanti o terzi estranei) oppure di essere usciti da oltre un anno.
Se tutte le difese falliscono e l’ex socio viene dichiarato fallito, la sua situazione diviene simile a quella di un imprenditore individuale in procedura: il suo patrimonio personale sarà gestito dal curatore e liquidato per pagare i debiti sociali (ed eventualmente debiti personali se ce ne sono, concorsualmente). Tuttavia, se l’uscita era anteriore, l’ex socio potrebbe trovarsi in posizione peculiare: non avendo più partecipato alla gestione recente, potrebbe non avere debiti “nuovi” ma essere chiamato per quelli storici.
Conclusione per ex socio di società di persone: se la società entra in procedura concorsuale, l’ex socio rischia il fallimento personale solo entro l’anno dalla sua uscita. Se quella soglia è superata, i creditori potranno sì perseguirlo individualmente (come visto nei paragrafi precedenti), ma non attraverso la procedura concorsuale. Questo significa che l’ex socio, pur non fallendo formalmente, rimane comunque esposto ad azioni esecutive individuali per i debiti sociali pregressi. Egli dovrà difendersi caso per caso, potendo però beneficiare del fatto che, essendo la società ormai fallita, la maggior parte del debito sarà trattata nel fallimento stesso. I creditori eventualmente insoddisfatti dopo la chiusura del fallimento potrebbero ancora agire contro l’ex socio (entro i limiti di legge). Si noti che se la società di persone opta per altre procedure (es. un concordato preventivo o ristrutturazione del debito), il socio illimitatamente responsabile non è automaticamente liberato dal residuo non pagato in quella procedura, a meno che i creditori rinuncino espressamente anche nei suoi confronti: infatti il concordato della società vincola i creditori verso l’ente, ma non verso i coobbligati solidali. Dunque, se una S.n.c. chiude i debiti con un concordato pagando il 50%, i creditori, salvo patto contrario, potrebbero pretendere dagli ex soci il restante 50% (questa situazione è delicata e si risolve spesso in fase di accordo con creditori che estendono l’efficacia remissoria anche ai soci, ma non è automatica per legge).
Infine, va detto che qualora l’ex socio di società di persone non venga dichiarato fallito (perché uscito oltre l’anno o perché la società sceglie altre vie), egli può eventualmente valutare di accedere volontariamente alle procedure di sovraindebitamento previste per i non fallibili, come vedremo oltre, per gestire i suoi debiti personali derivanti da quella situazione.
6.2 Società di capitali e procedure concorsuali
Per le società di capitali, il fallimento (liquidazione giudiziale) della società non coinvolge i soci. Se una S.r.l. fallisce, i suoi soci non falliscono e non subiscono alcuna restrizione patrimoniale diretta dalla procedura – semplicemente perderanno il valore delle loro quote (ormai azzerato dall’insolvenza), ma i curatori/creditori non possono toccare i beni personali dei soci in virtù di quel fallimento. Eccezione: come già evidenziato, se un socio ha prestato garanzie personali, i creditori (ad es. la banca) durante la procedura fallimentare potranno escutere la garanzia a suo carico al di fuori del fallimento, oppure insinuarsi in prededuzione per escutere eventuali pegni dati dal socio. Ma questo deriva dal contratto di garanzia, non dallo status di socio.
Dunque un ex socio di S.r.l./S.p.A. non rischia il fallimento personale solo perché la società fallisce. Non esiste un meccanismo legale di estensione analogo a quello delle società di persone. Ciò non toglie che l’insolvenza della società possa indirettamente interessarlo: ad esempio, se era socio-amministratore e ci sono state condotte di mala gestio, il curatore potrebbe promuovere contro di lui un’azione di responsabilità (ma ciò rientra nel campo delle azioni risarcitorie, non del fallimento del socio). Oppure, i creditori potrebbero – come visto – agire ai sensi dell’art. 2495 c.c. o art.36 DPR 602/73 per ottenere dai soci (anche ex) il dovuto nei limiti delle somme percepite. Ma queste sono iniziative esterne al fallimento della società: i creditori sociali insoddisfatti potrebbero, dopo la chiusura della procedura e per la parte non pagata, intraprendere cause civili contro i soci in base al 2495 c.c. (se attivo distribuito) o cause tributarie ex art.36 (per imposte residue). Queste azioni spesso avvengono dopo la chiusura del fallimento, quando si vede quanto è rimasto non pagato. Il socio può trovarsi quindi, a distanza di tempo, a fronteggiare queste pretese, ma non come “fallito”. Sarà un debitore civile e potrà difendersi come tale (ad esempio eccependo termini decadenziali, prescrizioni, mancanza di utili percepiti, ecc., come visto nei capitoli precedenti).
Procedura di liquidazione coatta o amministrativa – Se la società di capitali segue altre procedure concorsuali (es. liquidazione coatta amministrativa per editori soggetti a vigilanza, o amministrazione straordinaria per grandi imprese, ecc.), analogamente i soci non subiscono conseguenze dirette sui propri beni.
Impatto sui soci garanti – Un aspetto pratico: quando una società di capitali fallisce, molto spesso le banche o altri creditori, se muniti di fideiussione del socio, si rivalgono su quest’ultimo. Il socio garante non ha le tutele del fallimento (che sospende le azioni contro la società ma non contro i terzi garanti), per cui può vedersi subito richieste di pagamento. In quel caso, può opporre eventuali eccezioni previste nel contratto di garanzia o tentare di accordarsi (spesso la banca chiede al garante di onorare una parte del debito). Una volta pagato, il socio-garante ha diritto di surroga nelle posizioni creditorie verso la società e può insinuarsi al passivo del fallimento della società come creditore (surrogandosi alla banca) per cercare di recuperare qualcosa. Ma se la società è priva di attivo sufficiente, la surroga avrà scarso effetto pratico.
Conclusione per ex socio di società di capitali: il fallimento o altra procedura concorsuale della società non lo coinvolge direttamente come parte del procedimento (non diventa insolvente “persona fisica” per ciò). Resterà però esposto alle eventuali azioni successorie sui debiti residui (2495 c.c. o art.36 DPR 602/73), e può subire escussioni di garanzie personali. In caso abbia problemi a soddisfare quei debiti con il proprio patrimonio, potrà considerare le procedure di sovraindebitamento o fallimento personale, di cui parliamo nel prossimo paragrafo.
7. Sovraindebitamento ed esdebitazione: soluzioni per l’ex socio debitore
Un ex socio che si ritrovi gravato da ingenti debiti – derivanti magari dal tracollo della società o dall’escussione da parte di creditori sociali – può domandarsi quali strumenti legali esistano per ottenere un alleggerimento o cancellazione dei debiti. Il nostro ordinamento, specie dopo la riforma introdotta dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), offre varie procedure di composizione della crisi anche al debitore civile o ex imprenditore, volte alla regolazione del sovraindebitamento e all’esdebitazione (cioè la liberazione dai debiti residui). Di seguito presentiamo le opzioni principali dal punto di vista di un ex socio debitore, distinguendo se egli è soggetto fallibile o meno, e le opportunità previste.
7.1 Fallimento personale ed esdebitazione del fallito
Se l’ex socio di società di persone viene dichiarato fallito in estensione, o se comunque era un imprenditore fallibile (ad esempio socio accomandatario di S.a.p.a. o società di fatto) ed è coinvolto in un fallimento, potrà ricorrere all’esdebitazione del fallito al termine della procedura. L’esdebitazione in questo caso è il meccanismo per cui, una volta liquidati tutti i beni del fallito e soddisfatti i creditori per quanto possibile, il Tribunale dichiara inesigibili i debiti residui e il debitore viene liberato. Nella vecchia legge fallimentare l’esdebitazione (introdotta nel 2006) richiedeva un’istanza del fallito a fine procedura (art. 142 L.F.) e la verifica di alcune condizioni (aver cooperato, non aver frodato, non condannato per bancarotta, ecc.). Con il nuovo Codice della Crisi, tale istituto è confermato e integrato: oggi, conclusa la liquidazione giudiziale (nuovo nome del fallimento) di una persona fisica, il giudice può dichiarare l’esdebitazione del debitore onesto e meritevole anche d’ufficio. In pratica, l’ex socio fallito che abbia subito la liquidazione di tutti i suoi beni potrà essere discolpato dai debiti rimasti e tornare economicamente “pulito”. Questa è una tutela importante per chi, ad esempio, ha visto andare all’asta la casa e gli altri beni per pagare i debiti sociali: ciò che non è stato pagato con il ricavato viene cancellato, permettendogli di ripartire.
Le condizioni per l’esdebitazione post-fallimento includono: la cooperazione con gli organi della procedura, l’assenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi che hanno causato il dissesto, e di solito il non aver già ottenuto esdebitazioni in passato per abusi. L’esdebitazione può essere negata se emergono frodi. Ma per l’ex socio “sfortunato” che ha dovuto fallire solo per la responsabilità illimitata, è uno sbocco provvidenziale: superata la procedura, non rimarrà inseguito a vita dai debiti residui.
7.2 Procedure di sovraindebitamento (Codice della Crisi)
Se l’ex socio debitore non è fallibile (ad esempio perché la società era una S.r.l., o perché la società di persone non è stata dichiarata fallita e lui come persona fisica non ha un’attività commerciale individuale rilevante), allora rientra nella categoria dei debitori civili sovraindebitati disciplinati dalla legge n. 3/2012 (ora trasfusa nel CCII). Queste procedure sono state create per dare una via d’uscita a soggetti non fallibili – consumatori, piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, start-up innovative, soci di società cessate etc. – che si trovano incapaci di pagare i propri debiti. Un ex socio con debiti personali ingenti rientra perfettamente nella casistica di “sovraindebitamento”: ha più obbligazioni di quante possa ragionevolmente adempiere.
Le principali procedure oggi si chiamano: Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore e Liquidazione controllata del sovraindebitato, oltre a uno strumento speciale di Esdebitazione del debitore incapiente. Vediamoli brevemente in rapporto all’ex socio.
- Piano di ristrutturazione del consumatore: riservato a persone fisiche che hanno contratto debiti principalmente fuori dall’attività d’impresa (ad esempio fideiussioni, debiti fiscali come privato, ecc.). Se l’ex socio era di fatto un consumatore (cioè non un imprenditore professionale) e i suoi debiti derivano da garanzie o da tasse personali, potrebbe accedere a questa procedura. Essa prevede la presentazione al giudice di un piano di pagamento parziale dei debiti, sostenibile con il suo reddito e patrimonio, senza bisogno del voto dei creditori (è sufficiente che il giudice valuti il piano fattibile e che il debitore sia meritevole). Ad esempio, Caio ex socio di S.r.l. con 100.000 € di debiti tributari e poche risorse potrebbe proporre di pagarne il 30% in 5 anni utilizzando il suo stipendio, ottenendo l’esdebitazione del resto a fine piano. Questo strumento è molto utile se il debitore ha un reddito o patrimonio modesto ma sufficiente a offrire qualcosa ai creditori, e soprattutto se il sovraindebitamento non deriva da attività d’impresa propria (la qualifica di consumatore richiede che i debiti non siano prevalentemente di natura professionale).
- Concordato minore: è l’equivalente del piano ma per imprenditori minori e professionisti. Sostituisce il vecchio “accordo di composizione” della legge 3/2012. Un ex socio che fosse considerabile un piccolo imprenditore (ad es. un socio di S.n.c. artigiana che non ha superato le soglie fallimentari) potrebbe accedere al concordato minore, presentando anche qui una proposta di pagamento parziale ai creditori. A differenza del piano del consumatore, il concordato minore prevede il voto dei creditori (serve una maggioranza di consensi) e si applica tipicamente a chi ha debiti per attività economica. Nel caso di un ex socio, se i debiti derivano dal fallimento di un’impresa e lui stesso era un imprenditore piccolo, questo è l’istituto adatto. Consente di trattare con creditori (compresi fiscali) e ottenere anche qui, con l’omologazione, l’esdebitazione finale previa esecuzione di quanto promesso. Ad esempio, un ex accomandatario con debiti per 200.000 €, qualche bene da liquidare e un lavoro autonomo potrebbe proporre di pagare in concordato minore una percentuale del dovuto (magari vendendo un immobile e dilazionando il resto), e una volta adempiuto ottiene la liberazione dai debiti residui.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: questa procedura è analoga al fallimento ma su base volontaria (o su istanza di creditori limitatamente) per i soggetti non fallibili. L’ex socio disperatamente indebitato, senza capacità di proporre un piano, può chiedere al tribunale di aprire una liquidazione controllata dei suoi beni. Verrà nominato un liquidatore (simile a un curatore), che venderà il patrimonio disponibile del debitore e ripartirà il ricavato tra i creditori. Dura al massimo 3 anni (salvo proroghe per vendite di immobili). Al termine, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione residua in maniera quasi automatica (a differenza del vecchio fallimento, qui il codice prevede che l’esdebitazione non richiede una specifica domanda se la liquidazione si conclude regolarmente). Questa è la via consigliabile se l’ex socio ha beni da far liquidare ma i debiti superano di molto le sue risorse – in pratica mette tutto ciò che ha in un calderone per i creditori e ottiene di ripartire da zero libero dai debiti insoddisfatti.
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta di recente (prima nella L.3/2012 art. 14-quaterdecies, ora art. 283 CCII) per i casi più estremi, ossia il debitore persona fisica totalmente privo di beni o redditi utilmente aggredibili. Se l’ex socio non possiede nulla e non può offrire nulla ai creditori, può chiedere ugualmente al tribunale di essere esdebitato “a costo zero”. È un beneficio eccezionale e concesso solo una volta nella vita, riservato al debitore “meritevole” (cioè che si trova insolvibile senza colpa grave, e ha tenuto un comportamento onesto) e incapiente non solo attualmente ma anche prevedibilmente (nessuna prospettiva di poter pagare nemmeno in futuro). Se concesso, il provvedimento cancella tutti i debiti (eccetto quelli eventualmente esclusi per legge, come forse debiti da risarcimento danni per fatti illeciti o mantenimenti, che però non sono solitamente in questo scenario). Ci sono cautele: per 4 anni dopo l’esdebitazione, il debitore ha l’obbligo di comunicare ai creditori e versare eventuali utilità sopravvenute (eredità, vincite, incrementi reddituali rilevanti), fino a concorrenza di quanto non pagato, a beneficio dei vecchi creditori. Passati i 4 anni di “quarantena”, ogni sopravvenienza fortunata resterà al debitore. Questa procedura è stata pensata per chi vive situazioni drammatiche (nullatenenti oppressi da debiti, spesso per aver fatto da garanti o per fallimenti altrui). Ad esempio, un ex socio che ha perso tutto e ha addosso cartelle esattoriali per 300.000 € e nessun stipendio né beni, potrebbe optare per l’esdebitazione incapiente: con l’aiuto di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) prepara la domanda, e il giudice – verificati i requisiti – cancella i debiti dandogli un “fresh start”. I creditori rimangono insoddisfatti ma è un sacrificio giustificato dalla evidente irrecuperabilità ed esigenza di reinserimento sociale del debitore.
Meritevolezza e esclusioni: Va evidenziato che tutte queste procedure prevedono un vaglio di meritevolezza: il debitore non deve aver colpe gravi o frodi. Per l’ex socio ciò significa, ad esempio, non aver provocato dolosamente il sovraindebitamento (se fosse un ex amministratore fraudolento, potrebbe essergli negato l’accesso). In più, alcuni debiti potrebbero non essere esdebitabili (tradizionalmente, le obbligazioni alimentari, le multe penali e amministrative per sanzione, e i risarcimenti per danni da illecito extracontrattuale con dolo sono esclusi). I debiti tributari sono falcidiabili ed esdebitabili invece, comprese le cartelle, purché si segua la procedura corretta e salvo che riguardino IVA o ritenute non versate (che però dal 2021 sono anch’esse trattabili nelle procedure).
Perché considerare il sovraindebitamento: Per un ex socio fortemente indebitato, avviare una di queste procedure può essere l’alternativa alla clandestinità economica. Invece di rimanere a tempo indeterminato esposto a pignoramenti e interessi che crescono, il debitore affronta in modo trasparente la situazione davanti a un giudice, offrendo ciò che può, e ottiene la cancellazione del resto. È un percorso complesso (serve l’ausilio di professionisti e OCC, e c’è un procedimento giudiziale), ma porta a una soluzione definitiva. Ad esempio, se Tizio ex socio ha 20 creditori tra banche e Fisco, può con un concordato minore o piano consumatore ristrutturare l’intero debito con un provvedimento unico del tribunale, più efficace che trattare con ognuno separatamente.
Esempio pratico di esdebitazione incapiente: Luigi era socio di una piccola casa editrice S.r.l., ha personalmente garantito debiti bancari e ora, fallita la società, gli sono rimaste addosso fideiussioni escusse e debiti verso fornitori per 150.000 € complessivi. Luigi non ha proprietà (vive in affitto) e ha solo un modesto stipendio da dipendente, che basta appena alle esigenze familiari. In questa situazione, Luigi potrebbe chiedere l’esdebitazione da incapiente. Se il giudice accerta che Luigi è meritevole (cioè non ha dissipato beni volontariamente o aggravato la sua insolvenza con malafede, etc.) e davvero non ha nulla da offrire, emetterà decreto di esdebitazione immediata. Da quel momento, tutti i creditori (banche, fornitori, Agenzia Entrate per eventuali tributi) non potranno più pretendere nulla da Luigi. Se però entro 4 anni Luigi dovesse ricevere, ad esempio, un’eredità di 50.000 €, dovrà comunicarlo e quella somma potrebbe essere ripartita tra i vecchi creditori riabilitati in proporzione. Passati i 4 anni, Luigi sarà libero definitivamente. Questa soluzione “a costo zero” è stata introdotta proprio per casi come questo, in cui diversamente il debitore resterebbe ostaggio di debiti impagabili vita natural durante.
Conclusione: l’ex socio debitore ha oggi a disposizione strumenti di “fresh start” molto più avanzati che in passato. Se soggetto a fallimento, ha la chance dell’esdebitazione al termine. Se non fallibile ma oppresso dai debiti, può valutare un piano del consumatore o concordato minore per pagare quanto possibile e farsi esdebitare il resto, oppure una liquidazione controllata cedendo tutto il suo patrimonio ai creditori in cambio della liberazione. Se addirittura privo di risorse, la legge gli consente una sola volta la grazia dell’esdebitazione da incapiente. Tutte queste procedure richiedono consulenza specializzata (coinvolgono avvocati, commercialisti, OCC, e l’autorità del Tribunale), ma rappresentano una via d’uscita legale dal tunnel del debito, permettendo all’ex socio onesto ma sfortunato di tornare a una vita normale, pur avendo fatto fronte, per quanto possibile, alle proprie obbligazioni.
8. Strategie di difesa e prevenzione per l’ex socio debitore
Dopo aver esaminato il quadro normativo, è utile riassumere alcune strategie pratiche che un ex socio con debiti (o a rischio di doverne pagare) può adottare per difendere i propri interessi e limitare le proprie responsabilità.
1. Formalizzare e pubblicizzare l’uscita dalla società: Se un socio decide di lasciare la società (per recesso, cessione di quote, esclusione, ecc.), è fondamentale assicurarsi che tale evento sia registrato tempestivamente presso il Registro delle Imprese e comunicato ai principali creditori. Questa diligenza è il primo scudo: in caso di contestazioni, l’ex socio potrà opporre la data di scioglimento del rapporto e sostenere la non responsabilità per debiti successivi. Ad esempio, inviare comunicazioni ai fornitori abituali e alla banca depositaria informandoli del cambiamento societario può prevenire pretese indebite su debiti futuri. È l’ex socio che deve poter provare di aver reso noto ai terzi il proprio disimpegno, altrimenti rischia di restare agganciato alle obbligazioni contratte dalla società successivamente alla sua uscita.
2. Mappare i debiti “potenziali” e valutare l’impatto prima di uscire: Prima di lasciare la società, un socio saggio farà una ricognizione dei debiti sociali esistenti e potenziali (ad esempio: contenziosi in corso, debiti fuori bilancio, debiti fiscali non ancora accertati). In questo modo può stimare a quali esposizioni potrebbe essere chiamato in futuro. Se i debiti sono ingenti, potrebbe valutare di trovare un accordo transattivo con gli altri soci o con creditori prima di uscire, come condizione per il suo recesso, in modo da ottenere liberatorie. Ad esempio, nel cedere la propria quota, potrebbe negoziare che la società (o i nuovi soci) si facciano carico di taluni debiti e manlevino l’uscente – certo, ciò non vincola i terzi creditori, ma crea un diritto di regresso o risarcimento interno se poi l’ex socio dovesse pagare.
3. Beneficio di escussione in pratica: Abbiamo visto che, se un creditore agisce legalmente contro l’ex socio (soprattutto parliamo di ex soci illimitatamente responsabili), questi in sede di causa di merito non può rifiutare il pagamento adducendo la priorità del patrimonio sociale. Tuttavia, in via stragiudiziale l’ex socio può e deve far presente al creditore che prima esiga il dovuto dalla società o dagli altri coobbligati e solo se insoddisfatto venga da lui. Questa argomentazione spesso funziona in fase di trattativa: il socio può guadagnare tempo e magari nel frattempo la società paga o si trova un accordo. In fase di esecuzione forzata, poi, il socio potrà formalmente opporre il beneficium excussionis se il creditore tenta subito il pignoramento di un suo bene senza aver tentato sulla società. Pertanto, una strategia difensiva è: qualora arrivi un decreto ingiuntivo o atto di precetto, intimare al creditore di escutere prima i beni sociali noti (se ve ne sono: es. magazzino, crediti della società, ecc.), pena opposizione al giudice dell’esecuzione. Questo potrebbe scoraggiare il creditore dall’insistere sul patrimonio personale se intravede possibilità sulla società. Ovviamente, se la società è palesemente insolvente o ormai priva di beni, il beneficio di escussione è solo formale e non eviterà l’azione sul socio – ma va comunque fatto valere per seguire la corretta procedura (il creditore potrebbe doversi almeno costituire un titolo esecutivo contro la società prima di aggredire il socio, a seconda dei casi).
4. Contestare la legittimazione passiva se non dovuta: Nel caso di ex socio di società di capitali che venga chiamato a pagare un debito sociale senza base legale (ad esempio, un fornitore ottiene una sentenza solo contro la S.r.l. e poi notifica precetto anche al socio senza titolo), l’ex socio deve prontamente opporsi, eccependo che egli non è parte obbligata. A volte i creditori, per pressione, provano ad aggredire i soci di S.r.l. pur sapendo che non c’è un titolo contro di loro: in tal caso, un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ferma il pignoramento sul nascere, evidenziando che manca un titolo esecutivo contro il socio e che la legge esclude la sua responsabilità personale. Questo strumento processuale è cruciale per evitare pignoramenti ingiusti. Similmente, se viene notificata una cartella esattoriale intestata impropriamente al socio (ad esempio per debiti di una S.r.l. senza un avviso art.36), l’ex socio deve fare ricorso nei 60 giorni eccependo il difetto di legittimazione: la cartella è nulla in mancanza di un previo accertamento specifico. Non bisogna mai subire passivamente richieste di pagamento se non si è convinti dell’obbligo: il codice di procedura e le commissioni tributarie offrono rimedi per far valere l’estraneità del soggetto.
5. Verificare la correttezza formale degli atti del Fisco e degli altri creditori: Molte pretese contro ex soci si basano su atti amministrativi o giudiziari. È buona difesa farli vagliare da un esperto per cogliere eventuali vizi. Esempi: un avviso di accertamento ex art.36 DPR 602/73 deve contenere la motivazione sulla responsabilità del socio e la quantificazione di quanto ricevuto – se manca, è annullabile. Oppure, se un creditore notifica un decreto ingiuntivo all’ex socio senza menzionare che è in qualità di socio illimitatamente responsabile, potrebbe esserci un vizio di legittimazione (la Cassazione diceva che se il socio è convenuto “in proprio” e non come socio, manca la legittimazione passiva). Queste finezze giuridiche possono far ottenere l’annullamento dell’atto o almeno guadagnare tempo prezioso. Dunque, mai dare per scontato che “tanto devo pagare”: far analizzare l’atto potrebbe rivelare errori di controparte su cui costruire la difesa.
6. Transigere e dilazionare dove possibile: Spesso la strada migliore per il debitore è negoziare. Un ex socio che rischia di dover pagare integralmente un debito potrebbe provare a raggiungere un accordo transattivo col creditore: ad esempio, offrire il pagamento immediato del 50% a saldo e stralcio, oppure chiedere un piano di rientro rateale. Dal punto di vista del creditore, se il patrimonio sociale è inaccessibile e l’alternativa è una lunga causa o un’esecuzione incerta sul socio, una proposta concreta di pagamento parziale può risultare conveniente. Il socio deve ovviamente valutare la propria sostenibilità finanziaria e, preferibilmente, negoziare prima che la situazione degeneri in decreti ingiuntivi o pignoramenti (quando le posizioni tendono a irrigidirsi). Ad esempio, se un fornitore contatta l’ex socio per un debito di 20.000 €, il socio può subito evidenziare che la società è inadempiente e magari proporre: “Vi pago 10.000 € in sei mesi e chiudiamo la questione liberandomi da ogni obbligo ulteriore”. Formalizzando poi l’accordo per iscritto con quietanza liberatoria, si mette al riparo da ulteriori azioni per quel credito. Anche col Fisco esistono margini: l’Agenzia Entrate spesso è meno incline a transigere, ma l’ex socio potrebbe ad esempio chiedere una rateizzazione delle cartelle (fino a 72 o 120 rate in certi casi) per diluire l’impatto, oppure aderire se possibile a istituti come il saldo e stralcio o rottamazione delle cartelle se la normativa lo consente (attualmente riservati a persone fisiche con ISEE basso in alcuni casi, o a tutti per sanzioni/interest). Tener d’occhio le eventuali definizioni agevolate può far risparmiare sulle sanzioni e interessi e pagare solo l’imposta. In generale, mostrarsi collaborativi e di buona fede può persuadere i creditori a concordare soluzioni invece di azioni aggressive.
7. Proteggere il patrimonio personale legalmente: Prima che i creditori agiscano, l’ex socio potrebbe adottare misure lecite di protezione dei propri beni. Ad esempio, valutare di costituire un fondo patrimoniale (per tutelare l’abitazione familiare dai crediti non attinenti ai bisogni familiari), o una polizza vita impignorabile come forma di risparmio. Attenzione: tali mosse devono essere fatte quando ancora non c’è insolvenza conclamata e soprattutto non in frode ai creditori. Se l’ex socio trasferisce tutti i suoi beni a parenti o li svende dopo che i debiti sono già maturi, rischia azioni revocatorie o, peggio, denunce per sottrazione fraudolenta se in prossimità di procedure concorsuali. Però, ad esempio, destinare la casa a fondo patrimoniale prima che emergano problemi può offrire una difesa ulteriore (i crediti commerciali o fiscali sortile dopo potrebbero essere considerati estranei ai bisogni familiari e quindi non attaccabili sulla casa, salvo contestare la revocatoria entro 5 anni se c’è malafede). Anche intestare beni al coniuge o ai figli: va valutato con estrema prudenza e onestà, perché potrebbe configurare frode. In ogni caso, qualunque pianificazione dev’essere fatta in tempi non sospetti e seguendo i consigli di un legale, considerando i possibili effetti (ad es., alcuni crediti erariali sono comunque esclusi dal fondo patrimoniale se usati a beneficio famigliare – c’è giurisprudenza fluttuante).
8. Valutare le procedure di cui al §7: Se il peso del debito è insostenibile, l’ex socio dovrebbe informarsi sulle procedure di sovraindebitamento. Pianificare un piano del consumatore o concordato minore può mettere ordine nel caos, fermare gli interessi e bloccare le azioni esecutive (che vengono sospese una volta ammessa la procedura). È un processo che richiede buona volontà e trasparenza (dev’essere dichiarato tutto l’attivo e impegnare tutto il possibile ai creditori), ma conduce a una soluzione definitiva. Procrastinare inerte consente ai debiti di lievitare e ai creditori di agire sparpagliati; entrare in procedura consente invece di congelare la situazione e risolverla in modo organico. La scelta della procedura dipende dal profilo del debitore (consumatore o no), dal tipo di debiti e dalla presenza di risorse da offrire o meno. Un buon professionista saprà consigliare. Importante: la meritevolezza. Se l’ex socio ha distratto beni o ha comportamenti scorretti in passato, conviene regolarizzare e “ripulire” la condotta prima di presentarsi in tribunale per una procedura di sovraindebitamento, perché quei fattori potrebbero causare rigetto. Ad esempio, se ha ancora intestato a sé un bene ma lo di fatto lo ha ceduto al figlio senza formalità, è meglio chiarire la situazione prima di entrare in una procedura concorsuale minore.
9. Coordinarsi con gli altri soci o garanti: Un ex socio spesso non è l’unico nel mirino dei creditori. Se vi sono altri ex soci o garanti solidali (ad esempio più soci che hanno garantito una banca), è opportuno coordinare la difesa. Presentare un fronte unito può portare a un accordo globale con il creditore (es. due soci garantiscono insieme di pagare una certa somma ciascuno). Oppure, nel caso di debiti tributari, tutti i soci ex di una SRL potrebbero concertare un’unica strategia in sede di contenzioso (magari facendo riferimento alla medesima pronuncia SU che li tutela). Dividersi e fare ciascuno di testa propria può invece indebolire la posizione (il Fisco potrebbe ottenere sentenze diverse contro l’uno e l’altro se non ben coordinate). A volte, agire insieme consente anche di condividere costi di difesa (es. incaricare un unico avvocato per tutti gli ex soci su questioni comuni). Naturalmente, se tra ex soci vi è conflitto (ad es. uno era amministratore e gli altri lo accusano del dissesto), ognuno dovrà curare i propri interessi separatamente.
10. Tenere traccia documentale di tutto: Il fardello probatorio spesso cade sull’ex socio in certe circostanze (es. dimostrare di aver lasciato la società, provare di non aver percepito somme). È essenziale conservare tutti i documenti rilevanti: visure camerali storiche attestanti la cessazione, bilanci di liquidazione, verbali assembleari, quietanze che mostrano chi ha ricevuto cosa, lettere di accollo di debiti da parte di terzi, ecc. Avere un dossier ordinato permette di reagire prontamente a qualsiasi richiesta con le prove alla mano. Se arriva una cartella su un ex socio per IRAP 2025 e lui può esibire la visura che mostra recesso nel 2023, risolve subito la questione. Se un creditore afferma che il socio ha preso soldi in liquidazione, e lui ha copia del bilancio finale a zero e del piano di riparto dove risulta che non ha incassato nulla, potrà immediatamente contestare la pretesa con fondamento. Dunque, mai buttare via i documenti sociali e contabili, anche anni dopo la fine della società: potrebbero salvarvi da un decreto ingiuntivo o far vincere un ricorso. Inoltre, se del caso, farsi rilasciare dichiarazioni dai liquidatori o dagli altri soci su chi ha ricevuto attivo (o che l’attivo è andato tutto a pagare creditori) potrà essere utile in giudizio.
In conclusione, la difesa dell’ex socio debitore si basa su un mix di prevenzione, conoscenza dei propri diritti e utilizzo accorto degli strumenti legali. Non esiste una formula magica valida per tutti: ogni situazione va analizzata nei dettagli. Tuttavia, applicando i principi sopra esposti – pubblicità dell’uscita, contestazione tempestiva delle pretese illegittime, negoziazione ove possibile e ricorso a procedure concorsuali minori se necessario – l’ex socio può limitare i danni e, spesso, evitare di essere travolto completamente dai debiti della sua (ex) società. La legge italiana, pur severa nel chiedere responsabilità ai soci di persone, offre comunque vie di uscita e tutele procedurali che un ex socio ben assistito può e deve attivare a proprio favore.
9. Simulazioni pratiche di casi tipici
In questa sezione proponiamo alcune simulazioni di casi pratici tipici che coinvolgono ex soci con debiti. Ogni caso esemplifica situazioni diverse (società di persone vs di capitali, debiti civili vs tributari, ecc.) e mostra come, in pratica, si applichino le norme e le tutele descritte nella guida.
Caso 1 – Ex socio di S.n.c. con debito verso fornitore:
Scenario: La società Beta S.n.c. (società in nome collettivo) operante nell’editoria ha due soci, Alice e Bruno. Nel 2023 Bruno recede dalla società, che continua con Alice come impresa individuale. Nel frattempo la S.n.c. aveva ordinato una grossa partita di carta per stampe nel 2022, non ancora pagata (€50.000 di debito verso il fornitore Cartiera X). Nel 2024 Cartiera X, non essendo stata pagata, fa causa sia alla società Beta (nel frattempo trasformata in ditta individuale di Alice) sia a Bruno come ex socio, per ottenere il pagamento. Domanda: Bruno può essere ritenuto responsabile? Come può difendersi?
Soluzione: Bruno, in quanto ex socio illimitatamente responsabile, risponde del debito contratto dalla S.n.c. quando egli era ancora socio (2022). La circostanza che la società prosegua come ditta individuale non lo libera dalle obbligazioni sorte prima del suo recesso. Tuttavia Bruno potrà far valere alcune difese: anzitutto, se il suo recesso è stato iscritto nel Registro Imprese e comunicato, non sarà responsabile per eventuali forniture ordinate dopo (non è questo il caso, poiché il debito è del 2022). In giudizio, Bruno non potrà eccepire di non essere tenuto a pagare affatto, ma potrà chiedere che il giudice disponga che il patrimonio della società (ora di Alice) sia escusso per primo (beneficio di escussione in sede esecutiva). Se ad esempio la ditta individuale Beta di Alice ha beni pignorabili (macchinari, conti, ecc.), Bruno potrà chiedere di aggredire prima quelli. Inoltre, Bruno dovrebbe controllare l’importo: se parte del debito è maturata dopo il suo recesso (ad esempio interessi di mora oltre la data di uscita, o nuove forniture), egli non ne risponderà per la quota successiva all’uscita. In definitiva, Bruno molto probabilmente dovrà pagare Cartiera X se Alice non paga (essendo obbligato solidale), ma potrà eventualmente rivalersi su Alice per la parte di debito che eccede la sua quota interna di competenza. Se Bruno paga l’intero €50.000, avrà diritto di regresso su Alice per la quota che internamente spettava a lei (tipicamente 50%, salvo diversi accordi sociali). Per tutelarsi, Bruno dovrebbe partecipare al giudizio dimostrando la data del suo recesso (per circoscrivere il periodo di responsabilità) e invocando formalmente il beneficio d’escussione nella fase di esecuzione forzata, così da tentare di soddisfare il creditore prima sui beni sociali.
Caso 2 – Ex socio accomandante di S.a.s. con debito fiscale:
Scenario: Casa Editrice Gamma S.a.s. ha un accomandatario (Luca) e un accomandante (Marco). Marco non ha mai amministrato né il suo nome figura verso terzi. La società non versa IVA per l’anno 2022 per €30.000. Nel 2023 Marco cede la sua quota ed esce dalla società. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate notifica a Luca (socio accomandatario) e a Marco un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA 2022. Domanda: Marco, in qualità di ex accomandante, deve pagare?
Soluzione: L’accomandante risponde limitatamente alla sua quota conferita, e non essendo amministratore non ha responsabilità illimitata (art. 2313 c.c.). Dunque, in teoria, Marco non dovrebbe rispondere personalmente dei debiti sociali, né civili né fiscali, oltre la perdita della sua quota. L’Agenzia delle Entrate però ha incluso anche lui nell’accertamento. Marco dovrà far valere che la sua posizione era di semplice socio finanziatore, senza poteri gestori, e che pertanto egli non era obbligato solidalmente per l’IVA dovuta dalla società. Se l’Ufficio insiste ritenendo magari che Marco abbia in qualche modo ingerito nella gestione (ad esempio c’è stata una verifica e Marco firmò qualche documento gestionale), allora vorrebbe dire che secondo il Fisco Marco ha violato il divieto di immistione ed è divenuto di fatto illimitatamente responsabile. Marco dovrà difendersi dimostrando di non aver mai compiuto atti di amministrazione: se ci riesce, l’avviso a suo carico è illegittimo. Inoltre, Marco può far rilevare che nel 2022 la sua quota di accomandante era tot (es. 20%) e aveva già versato per intero il conferimento: il suo rischio massimo era quello. La cessione della quota nel 2023, se registrata, lo mette al riparo da pretese su debiti successivi (ma qui si tratta di debito 2022, quando era socio). In conclusione, Marco non dovrà pagare perché la sua qualità di accomandante lo tutela, a meno che l’Agenzia provi un suo ruolo attivo nella gestione (ipotesi in cui sarebbe trattato come accomandatario e quindi illimitatamente responsabile anche lui). Probabilmente il coinvolgimento di Marco è un errore o eccesso di zelo: sarà annullato in autotutela o in Commissione Tributaria presentando il ricorso con la visura camerale e l’atto costitutivo che attestano il suo ruolo di accomandante non amministratore.
Caso 3 – Ex socio di S.r.l. con liquidazione e debiti verso lo Stato:
Scenario: La società Delta S.r.l. (casa editrice) viene liquidata volontariamente nel 2024. Al momento della liquidazione ha un debito verso l’Agenzia delle Entrate di €40.000 (IVA non versata) e verso una banca €60.000 (prestito garantito dai soci). Il patrimonio sociale è di €50.000, che il liquidatore utilizza in parte per pagare €30.000 alla banca (che liberano in quel limite la garanzia dei soci) e il resto €20.000 viene distribuito ai due soci in parti uguali (€10.000 ciascuno) nel bilancio finale. In sostanza, la società paga parzialmente la banca e nulla al Fisco, dopodiché viene cancellata. Domanda: Cosa rischiano i due ex soci, Paolo e Chiara, per i debiti residui (€10.000 verso banca e €40.000 verso Fisco)?
Soluzione: Per il debito verso la banca residuo (€30.000 rimasti dopo aver ricevuto €30.000), la banca essendo munita di fideiussione escuterà i soci garanti. Supponiamo che entrambi avessero garantito l’intero importo in solido: la banca può richiedere a uno solo o ad entrambi il pagamento di €30.000 (più interessi). I soci dovranno adempiere secondo il contratto di garanzia. Successivamente, essi potranno ripartire tra loro il peso secondo gli accordi interni (es. 50/50, quindi €15.000 ciascuno in definitiva) e surrogarsi nel credito verso la società (ormai inutile, essendo estinta). In parallelo, per il debito fiscale di €40.000, l’Agenzia Entrate procederà ai sensi dell’art. 36 DPR 602/73: i soci hanno ricevuto €10.000 a testa in liquidazione, quindi l’Erario può chiedere a ciascuno fino a €10.000. Essendo rimasto €40.000 di imposta non pagata, la somma complessiva ottenibile dai soci è €20.000 (10k+10k). Lo Stato dovrà assorbire la perdita del rimanente €20.000 a meno che non rilevi colpa grave del liquidatore (che però ha pagato prima la banca garantita, scelta discutibile forse, ma i soci come garanti avevano interesse). Dunque, verosimilmente, l’Agenzia invierà a Paolo e Chiara un avviso di accertamento per responsabilità ex socio indicando che la Delta S.r.l. è estinta con €40.000 di imposte non pagate, e che ogni socio è chiamato per €10.000 (limite del bilancio finale percepito). Paolo e Chiara potranno difendersi? In questo scenario, la norma è chiara: i creditori sociali (Erario incluso) possono far valere i crediti verso i soci fino a concorrenza di quanto riscosso. Non c’è margine per contestare la sussistenza della responsabilità, perché i soci effettivamente hanno avuto quell’attivo. Potrebbero solo verificare la correttezza formale dell’avviso: se, ad esempio, l’Agenzia notificasse direttamente una cartella senza avviso motivato, potrebbero ricorrere per nullità (mancato rispetto art.36). Ma supponiamo che l’Agenzia faccia tutto in regola. A quel punto, Paolo e Chiara dovranno pagare €10.000 a testa. Potrebbero considerare se l’art. 36 include anche i €30.000 pagati alla banca come “assegnazione ai soci negli ultimi due anni”: in realtà no, quei 30k sono andati alla banca, non ai soci; i soci però hanno beneficiato indirettamente perché la garanzia si è ridotta. Ma l’art.36 guarda alle assegnazioni ai soci, e qui formalmente ai soci sono andati solo €20.000 totali. Quindi la pretesa per €20.000 complessivi è legittima. Paolo e Chiara pagheranno e si toglieranno il pensiero col Fisco, evitando sanzioni e interessi futuri (le sanzioni, come detto, non sono dovute oltre l’imposta base). Se uno dei due non paga, l’Agenzia potrebbe perseguire l’altro per la sua parte? No, la responsabilità di ciascun socio è limitata alla sua quota di attivo percepito, non c’è solidarietà tra soci in questo caso (ognuno risponde pro quota). Quindi l’Agenzia eventualmente iscriverà a ruolo separatamente i €10k a carico di ciascuno. Quanto alla banca, se uno dei due soci pagasse tutto (€30k) in forza della fideiussione in solido, questi avrebbe pieno diritto di rivalsa per la metà sull’altro (in assenza di patti diversi). Una strategia per i soci potrebbe essere: anticipare l’Agenzia offrendo spontaneamente €10k ciascuno per definire subito il debito fiscale, magari chiedendo una piccola riduzione su interessi o sanzioni. Data la limpidezza della norma, probabilmente conviene pagare senza ricorsi (evitando spese legali). Invece, con la banca, potrebbero trattare: essendoci stata parziale escussione, la banca vorrà il resto; i soci potrebbero proporre di chiudere a €25k subito invece di €30k tardi. Dipende dal potere contrattuale. In conclusione, in questo caso i soci sono effettivamente responsabili nei limiti di €10k caduno verso il Fisco e verso la banca come garanti per l’importo residuo (slegato dal 2495 c.c., ma per contratto di fideiussione). Non essendo insostenibile l’esborso, non occorre per loro attivare procedure di sovraindebitamento; risolvono adempiendo tali somme.
Caso 4 – Ex socio sovraindebitato e soluzione con piano del consumatore:
Scenario: Francesca era socia al 30% di una casa editrice in forma di S.r.l. La società è fallita nel 2021 con molti debiti. Francesca non era garante di nulla, ma ha ricevuto €20.000 di dividendi nei due anni precedenti il fallimento. Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate le notifica un avviso chiedendole €15.000 per IVA e IRES non pagati dalla società (sulla base di art.36, limitatamente ai 20k ricevuti). Inoltre, alcuni fornitori non pagati per circa €50.000 le hanno fatto causa ai sensi dell’art.2495 c.c., sostenendo che deve restituire i €20.000 percepiti per pagare in parte quei debiti. Francesca attualmente è una lavoratrice dipendente con stipendio medio e ha una casa di proprietà su cui grava però un mutuo pesante; con questi debiti extra, si trova nell’impossibilità di far fronte a tutto (ha già arretrati sul mutuo e spese ordinarie). Domanda: Come può Francesca uscire da questa situazione di sovraindebitamento?
Soluzione: Francesca si trova a dover pagare circa €35.000 (15k al Fisco e ipotizziamo 20k transattivi ai fornitori, per evitare cause). Valutando il suo bilancio familiare, vede che non ha liquidità per saldare queste somme in un colpo; inoltre il mutuo assorbe molto del suo reddito. Francesca può ricorrere alla procedura di piano del consumatore, poiché i suoi debiti derivano in gran parte da obbligazioni assunte non per un’attività imprenditoriale personale ma come conseguenza indiretta (la responsabilità da ex socio è riconducibile al suo ruolo, ma lei non era imprenditrice individuale; inoltre i debiti verso fornitori in capo a lei sorgono ex lege, non per sua attività produttiva). Dunque, può qualificarsi come consumatore sovraindebitato. Attraverso un OCC e un avvocato, Francesca può presentare un piano dove, ad esempio, propone di pagare €300 al mese per 5 anni, destinando ai creditori la parte di stipendio residua al netto di mutuo e mantenimento familiare. Supponendo €300×60 mesi = €18.000. Nel piano, i creditori (Agenzia Entrate e fornitori) verrebbero soddisfatti parzialmente (circa il 50% del loro credito totale di 35k, salvo vedere come suddividerlo: tipicamente l’Erario ha privilegio su parte del credito e quindi prenderebbe una quota maggiore). Il piano del consumatore non richiede l’accordo dei creditori: se il giudice lo trova fattibile e verifica che Francesca è meritevole (non ha colpe gravi, la situazione deriva dal fallimento della società, non da sue frodi), potrà omologarlo anche senza il consenso dell’Agenzia o dei fornitori. A quel punto, Francesca verserà i €300 al mese al trustee nominato e, dopo 5 anni di sacrificio, otterrà l’esdebitazione completa: il residuo debito non pagato verrà cancellato. Otterrà così di non dover più nulla né al Fisco né ai fornitori. Il mutuo ovviamente dovrà continuare a pagarlo per tenersi la casa (i creditori nel piano in genere non toccano il mutuo se la casa è già gravata e se conviene lasciarla al debitore perché è prima casa e magari di modesto valore, oppure Francesca potrebbe decidere di venderla e soddisfare tutti subito, ma pare che tenga a conservarla). Grazie al piano, nessun creditore potrà agire esecutivamente contro Francesca finché rispetta i pagamenti. Se la sua situazione dovesse peggiorare ulteriormente (perde il lavoro, ecc.), potrà chiedere modifiche al piano o, in estremo, potrebbe convertire in liquidazione. In sintesi, Francesca può liberarsi dei debiti da ex socia mediante il piano del consumatore, pagando solo una parte del dovuto in maniera sostenibile e ottenendo lo stralcio del resto. Questa è una tipica via d’uscita per ex soci onesti travolti da importi per loro impagabili: invece di essere inseguiti per decenni, in pochi anni chiudono i conti e ripartono.
Ogni caso pratico può ovviamente presentare ulteriori complicazioni, ma le simulazioni mostrano: (i) come la natura della società condizioni profondamente gli obblighi dell’ex socio; (ii) l’importanza delle azioni correttive (pagamenti, accordi, procedure concorsuali) per risolvere la situazione; (iii) che esistono rimedi legali efficaci, sia difensivi (opposizioni, eccezioni) sia proattivi (piani, accordi), che l’ex socio debitore può mettere in campo per difendersi e uscire dall’impasse debitoria.
10. Tabelle riepilogative delle responsabilità
Di seguito proponiamo alcune tabelle riepilogative per avere a colpo d’occhio le principali differenze di responsabilità tra tipi di società, nonché un riassunto delle procedure di esdebitazione disponibili. Queste tabelle aiutano a sintetizzare i concetti trattati nella guida.
Tabella 1 – Responsabilità dell’ex socio per i debiti sociali (civili e fiscali)
| Tipo di società | Responsabilità ex socio per debiti civili | Responsabilità ex socio per debiti tributari | Note aggiuntive |
|---|---|---|---|
| Società di persone (S.n.c., S.a.s. – socio accomandatario) | Illimitata e solidale per i debiti sorti fino alla data di uscita (se comunicata). Può opporre l’uscita per escludere debiti successivi. Può chiedere escussione preventiva del patrimonio sociale in esecuzione. | Illimitata e solidale per imposte e contributi del periodo in cui era socio (equiparate a debiti sociali). Sanzioni tributarie in teoria trasmissibili come debito sociale, ma orientamento a non trasferirle per personalità. Uscita comunicata esclude tributi successivi. | Socio accomandante: risponde solo nei limiti del conferimento, nessuna responsabilità personale ulteriore salvo immistione. Se accomandante ha agito da amministratore, trattato come accomandatario (illimitatamente responsabile). |
| Società di capitali (S.r.l., S.p.A.) | Nessuna responsabilità personale per debiti sociali durante la vita della società. Dopo la liquidazione, ex soci responsabili verso i creditori sociali solo entro le somme ricevute in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.). Se non ricevono nulla, non pagano nulla. Nessuna responsabilità solidale tra soci (ciascuno per la propria quota di attivo ricevuto). | Nessuna responsabilità durante la vita sociale (il Fisco agisce solo sulla società). Dopo la liquidazione: art. 36 DPR 602/73 – ex soci responsabili per imposte non pagate nei limiti dei beni ricevuti nei 2 anni precedenti lo scioglimento o durante la liquidazione. Necessario avviso di accertamento specifico. Sanzioni tributarie non trasferite ai soci (si estinguono con la società). | Se socio ha prestato fideiussioni o garanzie personali, ne risponde per contratto (anche post-uscita). Sole shareholder (socio unico): se non rispetta obblighi (conferimenti, pubblicità), può perdere limitazione responsabilità per debiti contratti in quel periodo. Abuso di forma societaria/piercing: in caso di frode, possibile azione per far dichiarare i soci illimitatamente responsabili (caso eccezionale, onere a creditori). |
| Entro quando può essere chiesto il pagamento all’ex socio? | Illimitatamente nel tempo per debiti sorti fino all’uscita (salvo prescrizione del singolo credito). Fallimento estensibile entro 1 anno dall’uscita. Dopo 1 anno, niente fallimento ma resta l’obbligo civile diretto. | Entro termini di decadenza tributaria (normalmente l’ex socio viene coinvolto entro 5 anni dalla dichiarazione omessa/non pagata). La cancellazione società è considerata efficace dopo 5 anni a fini fiscali, oltre i quali difficilmente si attivano pretese verso soci. | Prescrizione ordinaria: un credito sociale civile verso soci prescrive tipicamente in 10 anni (se contrattuale), uno tributario accertato in 10 anni (dalla notifica cartella) ecc. Quindi ex socio può essere chiamato in quei limiti. Attenzione: termine annuale di art.2495 c.c. per notifica atti presso sede società (atto entro 1 anno può notificarsi alla vecchia sede). |
Tabella 2 – Procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione (opzioni per l’ex socio debitore)
| Procedura | A chi si rivolge | Cosa prevede | Esdebitazione (liberazione debiti) | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Liquidazione giudiziale (fallimento) + esdebitazione | Imprenditori commerciali fallibili (inclusi soci illimitati falliti in estensione). | Liquidazione di tutto il patrimonio da parte del curatore; soddisfazione creditori secondo prelazioni. | Esdebitazione dei debiti residui a fine procedura su ordine del tribunale, se il debitore è meritevole (non ha frodato, cooperato etc.). | Art. 256 CCII (estensione soci); Artt. 278-279 CCII (esdebitazione del fallito). Prima: art. 142-144 L.Fall. |
| Concordato minore (ex accordo composizione) | Debitori non fallibili che esercitano attività economica (piccoli imprenditori, professionisti, soci di società cessate con debiti d’impresa). | Proposta di accordo con i creditori per pagamento parziale dei debiti, con eventuale cessione beni o pagamento dilazionato. Richiede voto favorevole di >= 60% crediti (maggioranza). Omologato dal tribunale. | Se il debitore adempie al concordato come da omologa, viene liberato dai debiti residui non soddisfatti (effetto esdebitazione al termine). | Artt. 74-83 CCII. (Sostituisce Accordo L.3/2012). |
| Piano di ristrutturazione del consumatore (ex piano del consumatore) | Persona fisica consumatore sovraindebitata (debiti da fideiussioni, tasse personali, credito al consumo, ecc., non da attività d’impresa). | Piano di pagamento (anche parziale) dei debiti in un periodo determinato, basato su reddito e patrimonio del consumatore, senza coinvolgere i creditori (niente voto). Valutato e omologato dal tribunale con giudizio di fattibilità e meritevolezza (no colpa grave del debitore). | Una volta eseguito il piano secondo l’omologazione, il giudice dichiara inesigibili tutti i debiti residui. Durante il piano, il debitore è protetto da azioni esecutive (automatic stay). | Artt. 67-73 CCII. (Sostituisce Piano del consumatore L.3/2012). |
| Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione patrimonio) | Qualsiasi debitore civile o piccolo imprenditore sovraindebitato. Anche creditori possono chiedere apertura in taluni casi. | Liquidazione giudiziale semplificata: un liquidatore nominato dal tribunale vende tutti i beni non necessari alla vita del debitore e ripartisce il ricavato ai creditori. Durata massima 3 anni per liquidare redditi futuri (oltre ai beni). | Al termine, il debitore persona fisica è automaticamente esdebitato dai debiti non soddisfatti (salvo revoca esdebitazione per dolo). Non serve richiesta specifica salvo opposizioni. (Per società e enti, invece, la chiusura li estingue senza esdebitazione perché non persone fisiche). | Artt. 268-277 CCII (procedura); art. 278 CCII (esdebitazione). |
| Esdebitazione del debitore incapiente (“fresh start a zero”) | Persona fisica meritevole priva di beni e di reddito aggredibile, che non può offrire alcuna utilità ai creditori nemmeno in futuro. Tipicamente ex soggetti falliti senza attivo residuo, o sovraindebitati nullatenenti. Una sola volta. | Procedura semplificata: istanza al tribunale per ottenere la cancellazione dei debiti senza liquidazione, attestando l’incapienza totale. Il tribunale sente i creditori e valuta la meritevolezza (assenza di atti in frode, ecc.). Se accordata, non c’è pagamento (o, talvolta, si offre simbolicamente il poco che si ha). | I debiti sono cancellati immediatamente col decreto di omologa. Obbligo 4 anni: se il debitore ha miglioramenti di reddito/sostanze significativi entro 4 anni, deve comunicarli e destinare ai vecchi creditori quanto ricevuto in più (oltre una certa soglia). Dopo 4 anni di buona condotta, ogni sopravvenienza resta al debitore e l’esdebitazione diventa definitiva. | Art. 283-284 CCII. (Introdotto in L.3/2012 con art. 14-quaterdecies, ora confluito nel Codice). |
11. Domande frequenti (FAQ)
D. Un ex socio di S.n.c. può essere costretto a pagare i debiti della società dopo che ne è uscito?
R. Sì, un ex socio di S.n.c. rimane responsabile per i debiti contratti dalla società fino al giorno in cui era ancora socio. L’uscita non lo libera retroattivamente dalle obbligazioni già sorte. Egli invece non risponde dei debiti sorti dopo la sua uscita, a condizione che questa sia stata resa nota ai terzi (es. con iscrizione al Registro Imprese). In sostanza: se il debito è stato contratto quando era socio, il creditore può chiedergli il pagamento anche dopo anni; se il debito nasce dopo, l’ex socio può opporre che non faceva più parte della compagine sociale. È fondamentale per l’ex socio provare la data della propria uscita (ad esib. visura camerale).
D. Ci sono limiti di importo o di tempo per la responsabilità di un ex socio di S.n.c.?
R. La responsabilità è illimitata nell’importo (può essere chiamato a pagare anche tutto il debito sociale) e solidale (il creditore può scegliere di escutere lui per l’intero). Quanto al tempo, il codice civile non fissa un termine di “decadenza” generale per agire contro l’ex socio (salvo la regola del fallimento entro 1 anno). Quindi, il credito segue la sua prescrizione ordinaria: ad esempio, se era un debito contrattuale, prescrive in 10 anni; se era una cambiale, in 3 anni, ecc. Decorso tale termine senza richieste, l’ex socio può opporre la prescrizione. Un aspetto importante: se la società viene dichiarata fallita, l’ex socio può essere dichiarato fallito a sua volta solo se l’uscita è avvenuta da meno di un anno. Passato un anno, non rischia più la procedura fallimentare personale, anche se resta civilmente obbligato verso i creditori (che però a quel punto di solito avranno fatto valere i loro crediti nel fallimento della società, riducendo la parte eventualmente reclamabile al socio).
D. Un ex socio accomandante (S.a.s.) rischia di dover pagare i debiti sociali?
R. In linea di principio no, il socio accomandante ha responsabilità limitata alla quota conferita e una volta che l’ha interamente versata non deve nulla di più. Questo vale anche dopo la sua uscita: i creditori sociali non possono pretendere altro dal suo patrimonio personale. Eccezione: se l’accomandante ha violato il divieto di immistione negli affari sociali (cioè ha di fatto agito da amministratore), perde la responsabilità limitata. In tal caso straordinario, egli verrebbe trattato alla stregua di un socio accomandatario, quindi illimitatamente responsabile per i debiti sorti nel periodo in cui si è immischiato. Dunque, un ex accomandante che sia sempre rimasto nei ranghi non paga debiti sociali (né civili né fiscali) oltre il capitale eventualmente non ancora versato; mentre un accomandante “di fatto” potrebbe essere chiamato se i creditori dimostrano la sua ingerenza.
D. Ero socio al 20% di una S.r.l. fallita. Ora alcuni creditori mi chiedono soldi. È legale?
R. Dipende: di base, i soci di S.r.l. non rispondono personalmente dei debiti sociali. I creditori sociali non possono farle causa in virtù del solo fatto che era socio. Ci sono però due situazioni in cui possono avanzare richieste: (1) dopo la liquidazione della società, se Lei ha ricevuto somme o beni in riparto. In tal caso, gli eventuali creditori rimasti insoddisfatti possono chiederLe indietro quanto ha ricevuto (art. 2495 c.c.). Se la società è fallita, tuttavia, di norma i soci non ricevono nulla (perché in fallimento i creditori hanno priorità). Quindi se era fallimento, la regola di 2495 c.c. raramente si applica (i soci di solito perdono il capitale e basta, non ottengono distribuzioni di attivo). (2) Responsabilità fiscale ex art.36 DPR 602/73: se la S.r.l. aveva debiti fiscali e Lei, nei 2 anni prima dello scioglimento o durante la liquidazione, ha ricevuto soldi (es. dividendi, rimborsi) dalla società, il Fisco può chiederLe di pagare le imposte dovute, nei limiti di quanto incassato. Nel Suo caso, società fallita, bisogna vedere: ha ricevuto utili prima del fallimento? Se sì, l’Agenzia Entrate potrebbe (previo atto motivato) domandarle il pagamento di parte delle imposte non versate, fino alla concorrenza di quell’importo. I creditori privati invece (fornitori, banche) non hanno uno strumento analogo all’art.36, ma se la società è stata cancellata al termine del fallimento con qualche attivo residuo distribuito (ipotesi rara), potrebbero tentare di applicare analogicamente l’art.2495. In pratica, se Lei non ha ricevuto nulla, ogni pretesa è infondata. Se ha ricevuto, ad esempio, €10.000 di dividendi un anno prima del fallimento, l’Agenzia può chiederLe fino a €10.000 per tasse non pagate. Un fornitore, invece, può solo agire eventualmente contro i liquidatori se reputa che abbiano chiuso male la società, ma non contro i soci se non c’è attivo distribuito a essi. Quindi, valuti le richieste: se sono di creditori privati e Lei non ha percepito attivo, opponga con decisione che non è legittimato a pagare (responsabilità limitata); se è il Fisco, verifichi se effettivamente c’è una base (un avviso art.36 che giustifica la richiesta). In mancanza, anche col Fisco può fare ricorso.
D. Ho garantito con fideiussione un mutuo bancario della mia ex società (S.r.l.). Ora la società è insolvente e la banca viene da me, posso evitare di pagare invocando la responsabilità limitata?
R. Purtroppo no. La responsabilità limitata si riferisce ai debiti sociali in capo alla società. Nel momento in cui Lei ha firmato una fideiussione, ha assunto un’obbligazione personale verso la banca, distinta da quella della società. La banca può quindi legalmente pretendere il pagamento da Lei, a termini di contratto, indipendentemente dal fatto che la società sia una S.r.l. e indipendentemente dalla Sua uscita dalla compagine. È una situazione frequente: i soci di società a responsabilità limitata spesso offrono garanzie personali per ottenere credito, e se l’azienda fallisce, i garanti ne rispondono con patrimonio proprio. Tuttavia, Lei ha comunque qualche tutela: può verificare se la fideiussione rispetta i requisiti di legge, se la banca ha escusso correttamente (in alcune fideiussioni c’è il “beneficio di escussione” o la preventiva escussione dei beni ipotecati, se c’erano, prima di aggredire il garante). Può anche controllare se la fideiussione è nulla in parte, ad esempio quelle omnibus bancarie a volte incorporano clausole riconosciute nulle dall’Antitrust (clausole ABI standard) – un legale potrebbe analizzarla per ridurre l’importo garantito o eliminare alcune voci. Ma in generale, se la garanzia è valida, la banca può agire. Una volta che Lei paga (o un pignoramento avviene sul Suo conto), avrà diritto di regresso verso la società per ciò che ha pagato al posto suo. Se però la società è insolvente o fallita, questo diritto rischia di essere insoddisfatto nei fatti. L’unica via per “uscire” dal debito di garanzia, se Le è oneroso, potrebbe essere negoziare con la banca un saldo e stralcio o una dilazione (spesso più efficaci delle eccezioni legali, specie se la banca preferisce evitare lungaggini). In estrema ipotesi, se l’importo è insostenibile, consideri le procedure di sovraindebitamento: un debito da fideiussione rientra tipicamente in un piano del consumatore, per ridurlo o diluirlo come spiegato nella guida.
D. La società (S.n.c.) di cui ero socio è fallita. Io non sono stato dichiarato fallito perché ero uscito 2 anni prima. Alcuni creditori ora mi chiedono il pagamento dei debiti rimasti scoperti dal fallimento. Possono farlo nonostante il fallimento (della società) sia chiuso?
R. Sì, possono. Il fallimento della società non cancella le obbligazioni dei coobbligati (soci) verso i creditori per la parte non soddisfatta. Nel Suo caso, essendo Lei uscito da oltre un anno, non è stato coinvolto nella procedura concorsuale; i creditori sociali però, terminato il fallimento della società, se non hanno ottenuto l’integrale pagamento, possono rivolgersi agli ex soci illimitatamente responsabili per il residuo. Si tratta di azioni individuali post-fallimentari. Facciamo un esempio: la società aveva debito 100, in fallimento i creditori hanno preso 30, ne restano 70 insoddisfatti; costoro possono chiedere al socio (coobbligato solidale) quel 70 residuo, ovviamente detraendo quanto eventualmente già percepito. Il fallimento infatti non libera i soci (a differenza di un concordato che vincola anche i chirografari per la parte eccedente la percentuale concordataria? Ma per i soci no, solo per la società). Dovrà quindi esaminare ogni richiesta e verificare se il credito era effettivamente sorto prima della Sua uscita e se è rimasto insoddisfatto. Se Sì, Lei purtroppo ne risponde per intero (salvo rivalersi sugli altri soci eventualmente). Tuttavia, c’è una buona notizia: se Lei dovesse pagare quei residui 70, ha diritto di vedersi riconoscere l’esdebitazione come fosse un fallito anche Lei, grazie a una recente interpretazione estensiva. In pratica, la giurisprudenza ha ammesso che il socio non fallito, pagati i debiti sociali residui fuori procedura, possa chiedere al tribunale di dichiararlo esdebitato per evitare eventuali strascichi (questo in analogia con art. 282 CCII, ma è materia complessa). Al netto di ciò, la difesa concreta potrebbe essere: negoziare con questi creditori per chiudere a saldo e stralcio (spesso dopo un fallimento, i creditori sono disposti ad accettare meno del 100% pur di non iniziare un’altra battaglia legale contro il socio). E soprattutto, verificare se tali creditori non abbiano già sottoscritto una quietanza tacita accettando i riparti fallimentari come soddisfacimento finale (in rari casi si intende come rinuncia al resto, ma di norma no, rimane dovuto). In sintesi, la richiesta è legittima se Lei era obbligato e il debito è rimasto. Per risolvere definitivamente, consideri eventualmente una procedura di sovraindebitamento (ad es. un concordato minore) includendo tutti quei residui, così da pagarne magari una percentuale e ottenere esdebitazione.
D. Un ex socio nullatenente con molti debiti può davvero azzerarli senza pagare nulla? Non è troppo bello per essere vero?
R. È comprensibile la perplessità, ma sì, in casi eccezionali la legge oggi lo consente, con la cosiddetta esdebitazione del debitore incapiente. Ovviamente il tribunale verifica attentamente che il debitore sia in bona fide. Se l’ex socio nullatenente ha accumulato debiti per sua colpa grave o frodi, non gli concederanno il beneficio. Ma se, ad esempio, i debiti derivano da sventure (fallimento dell’azienda, fideiussione escussa, malattia, perdita del lavoro) e davvero questo ex socio non ha più nulla da dare ai creditori, la legge preferisce dargli una seconda chance anziché condannarlo a restare per sempre nell’economia sommersa. È un provvedimento con diverse cautele: solo una volta nella vita, revocabile se mente sulla sua situazione, e con quel vincolo di 4 anni a comunicare eventuali arricchimenti. Non è un percorso facile né automatico – serve coinvolgere un OCC e un giudice – ma è reale. Nel recente correttivo 2022 e sentenze 2023-2024, è stato applicato con successo in vari tribunali a persone sommerse dai debiti senza colpa. Quindi, se Lei (ex socio o qualunque debitore) è davvero privo di risorse e i Suoi debiti la schiacciano, vale la pena informarsi su questa opportunità. È un po’ come una “grazia” civile mirata ai casi umani più critici.
D. Come incide la recente sentenza delle Sezioni Unite 3625/2025 sulla responsabilità degli ex soci per debiti fiscali?
R. La pronuncia a Sezioni Unite del febbraio 2025 è molto importante: ha fatto chiarezza sul regime dell’art. 36 DPR 602/73, delineando i confini della responsabilità dei soci per i debiti tributari di società estinte. In particolare ha stabilito tre punti chiave: (1) il fatto che i soci abbiano ricevuto somme dalla liquidazione è non solo un limite quantitativo ma un vero presupposto per agire contro di loro. Se non hanno ricevuto nulla, l’azione del Fisco non ha interesse ad agire (salvo casi particolari di asset occulti). (2) Tale presupposto, se contestato, dev’essere provato dal Fisco tramite atto motivato notificato al socio. Dunque i soci vanno coinvolti con un avviso ad hoc; non si può semplicemente continuare contro di loro la pretesa fatta alla società. (3) Le sanzioni non si trasmettono e più in generale non c’è automatismo: la responsabilità non è solidale illimitata ma circoscritta ai vantaggi ricevuti. La sentenza quindi conferma un orientamento garantista per gli ex soci: chiudendo dibattiti su necessità o meno di un atto impositivo nuovo (ora confermata la necessità dell’atto nuovo) e su eventuali obblighi a carico del socio anche senza aver riscosso attivo (negati, salvo prova di utilità indirette). In pratica, per gli ex soci ciò significa maggiore tutela: se l’Agenzia Entrate vuole i soldi, deve fare un processo/accertamento apposito e dimostrare il perché e il quanto, dandovi modo di difendervi. Non possono “saltarvi addosso” con una cartella così, né chiedervi più di quanto avete incamerato. È una sentenza che bilancia l’esigenza erariale con i diritti di difesa dei soci. Dunque, se siete ex soci alle prese con cartelle del Fisco, questa sentenza è il vostro scudo: fate verificare che l’iter sia stato corretto e, se non lo fosse, impugnatelo richiamando i principi delle SU. Ad esempio, se vi mandano la cartella senza avviso motivato, potrete farla annullare perché contrastante con quanto deciso dalle Sezioni Unite.
D. Cosa può fare un ex socio per prevenire i rischi di dover pagare debiti sociali?
R. Riassumiamo i consigli pratici già discussi: a) curare la formalità dell’uscita (atto di recesso/cessione, iscrizione Camera Commercio, comunicazioni a clienti/fornitori chiave) – questo protegge da debiti successivi; b) durante la vita sociale, evitare di firmare garanzie personali se possibile, oppure limitarle nell’importo – ogni fideiussione può ritorcersi contro di voi; c) se prevedete che la società avrà problemi, valutate di uscire con un accordo: ad esempio pretendendo dai soci subentranti un patto di manleva per eventuali debiti passati (anche se il patto non vincola i creditori, avrete diritto di rivalsa verso chi rileva la vostra quota); d) assicuratevi che in fase di liquidazione i debiti vengano pagati prima di distribuire utili: se siete ancora soci, consigliate al liquidatore di accantonare somme per imposte e creditori, così da ridurre il rischio di azioni contro di voi poi – meglio ricevere poco o nulla in liquidazione che ricevere qualcosa e doverlo restituire anni dopo con magari contenziosi; e) conservate tutta la documentazione relativa alla società, soprattutto bilanci finali, certificati di cancellazione, quietanze di pagamento ai creditori, ecc., perché in futuro potrebbero servire come prove liberatorie; f) fatevi seguire da un consulente nelle operazioni straordinarie: spesso piccole negligenze (es. non depositare la dichiarazione di scioglimento, non pubblicare un annuncio) poi complicano la posizione dell’ex socio. Insomma, prevenire è meglio che curare: un’uscita pulita e trasparente, magari concordata con i partner e con i creditori principali, riduce significativamente la probabilità che anni dopo vi bussi un creditore.
D. Perché i soci di società di persone sono trattati così diversamente dai soci di società di capitali?
R. È una scelta di politica legislativa storica: nelle società di persone vige la fiducia personale tra soci e la responsabilità illimitata è il corollario che dà fiducia ai terzi. I creditori trattano con una S.n.c. sapendo che possono rifarsi sui soci se qualcosa va storto, quindi concedono credito anche senza grandi garanzie patrimoniali della società. Nelle società di capitali, invece, lo Stato ha voluto incentivare l’attività d’impresa a scapito della sicurezza dei creditori: il capitale sociale è un “tetto” alla responsabilità. Ciò però può esporre i creditori a rischi maggiori (società che falliscono e lasciano debiti non pagati). Per mitigare questo, il legislatore ha introdotto regole come l’art. 2495 c.c. e l’art. 36 DPR 602/73: in pratica, se i soci prendono qualcosa dalla società in liquidazione, devono prima soddisfare i creditori. È un modo per impedire che i soci si arricchiscano a danno dei creditori grazie alla responsabilità limitata. In sintesi: i soci di S.n.c. sono co-imprenditori e quindi co-debitori a tutti gli effetti (massima tutela creditori, minore incentivo a investitori esterni); i soci di S.r.l./S.p.A. sono investitori con rischio limitato, salvo abuso (massimo incentivo a investire capitale, rischio creditori mitigato dal capitale minimo e altre norme anti-abuso). Dal punto di vista dell’ex socio, questo significa che se eri in una società di persone hai meno scappatoie: la legge presume che ti fossi “messo in gioco” con tutto il patrimonio. Nelle società di capitali invece puoi separar meglio la tua sfera personale da quella dell’impresa – a patto di non confonderle tu stesso (perché se fai pagamenti ai soci impropri, torni ad esser chiamato in causa).
D. Se l’ex socio muore, i creditori possono perseguitare gli eredi?
R. Sì, i debiti di cui l’ex socio era responsabile entrano nella sua eredità come qualunque debito. Quindi, se un ex socio di S.n.c. muore con in sospeso obbligazioni sociali, i creditori possono chiedere agli eredi di pagare con il patrimonio ereditato. Attenzione: l’art. 2290 c.c. prevede anche il caso degli eredi del socio uscente (ad esempio se il socio muore, i suoi eredi sono responsabili per i debiti fino al giorno della morte). Tuttavia, gli eredi hanno la facoltà di fare la rinuncia all’eredità o di accettarla con beneficio d’inventario. Se rinunciano, non pagano i debiti (ma perdono anche i beni eventualmente lasciati). Se accettano con beneficio d’inventario, risponderanno dei debiti del de cuius (inclusi questi sociali) solo nei limiti dell’attivo ereditario. Perciò, se un ex socio molto indebitato muore, i suoi figli farebbero bene a valutare la rinuncia per non essere poi tormentati dai suoi creditori (a meno che l’attivo ereditario non sia sufficiente a coprire i debiti e resti qualcosa). Nel caso di debiti verso il Fisco ex art.36, sono debiti per obbligazione propria del socio defunto? La giurisprudenza dice che hanno natura civile ex lege, quindi dovrebbero seguire la regola generale: passano agli eredi (perché non sono sanzioni personali, sono debiti patrimoniali). Dunque sì, eredi potenzialmente attaccabili, ma con gli strumenti protettivi del diritto ereditario.
D. Cosa succede se l’ex socio paga un debito della società? Può rivalersi su qualcuno?
R. Sì. Se l’ex socio paga un debito sociale di cui era coobbligato, egli subentra nei diritti del creditore verso la società e eventualmente verso gli altri soci. In termini giuridici, c’è la surrogazione o quanto meno il regresso. Ad esempio, ex socio Tizio paga €10.000 al fornitore, che era debito della società: ora Tizio può chiedere alla società (se ancora esiste, o se ha continuato con altri soci) di restituirgli €10.000. Se la società è sciolta, può agire contro i soci rimasti o subentrati secondo gli accordi interni: tipicamente i soci di S.n.c. hanno diritto di ripartirsi tra loro i debiti in base alle percentuali di partecipazione (art. 1299 c.c. analogicamente). Quindi Tizio potrà chiedere agli altri ex soci di contribuire pro quota. Se questi non pagano spontaneamente, può fare causa e ottenere un rimborso della parte eccedente la sua. Naturalmente, se la società è insolvente o gli altri soci nullatenenti, questa rivalsa sarà più teorica che pratica. In caso di procedure concorsuali, il socio che paga un debito si surroga e può insinuarsi al passivo del fallimento della società per cercare di recuperare (ma di solito il fallimento chiude senza soddisfare soci surrogati). Quindi, il diritto c’è ma l’utilità dipende dalla solvibilità di società/altri soci. C’è un caso particolare: se un socio illimitato paga un debito fiscale della società, può rivalersi? Sì, sempre surrogazione nei diritti del Fisco verso la società; però le imposte hanno privilegio sui beni sociali che forse in liquidazione controllata potrebbe fargli ottenere qualcosa, ma realisticamente no se la società è a pezzi. In definitiva, l’ex socio pagatore è come un garante di fatto: può rifarsi sugli altri obbligati ma il suo rimborso non è garantito. Ecco perché è importante, nel momento di uscire, avere accordi di indennizzo: se i soci rimasti promettono di tenerti indenne e magari prestano garanzie (es. pegno su qualcosa a tuo favore), sarai più tutelato nel regresso. Altrimenti, rimane un credito chirografario verso soggetti spesso insolventi anch’essi.
D. In caso di accordo stragiudiziale con i creditori, è utile farsi rilasciare liberatorie?
R. Assolutamente sì. Se riuscite a fare un saldo e stralcio con un creditore, fatevi mettere per iscritto che accetta quella somma “a saldo stralcio di ogni maggior pretesa” e vi dichiara espressamente liberi dall’obbligazione. Ciò vi tutela da eventuali ripensamenti o cessioni del credito a terzi speculatori. Per esempio, se una banca vi libera da una fideiussione dopo aver incassato il 50%, fatevi dare una liberatoria formale (spesso hanno moduli standard). Così, se mai arrivasse un’altra richiesta per quel debito, potrete opporre la quietanza finale. Anche con il Fisco, se aderite a una definizione agevolata, conservate i certificati di regolarità al termine. Insomma, qualsiasi accordo di esenzione di un ex socio da debiti dev’essere documentato chiaramente.
Con questa carrellata di domande e risposte, speriamo di aver chiarito i dubbi più ricorrenti. La materia è complessa, ma le regole essenziali da ricordare sono: conoscere il proprio tipo di società e le relative responsabilità, comunicare sempre la propria uscita, non farsi trovare impreparati su cartelle e atti – reagire subito legalmente, e sapere che esistono vie legali per uscire dai debiti, dalle transazioni fino alle procedure di esdebitazione. Ogni caso concreto va valutato nella sua particolarità, possibilmente con l’assistenza di un professionista legale esperto in diritto societario e fallimentare, che potrà cucire la strategia difensiva sulle specifiche esigenze dell’ex socio debitore.
12. Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice Civile: artt. 2290-2291 c.c. (responsabilità socio uscente e soci di S.n.c.); art. 2313 c.c. (responsabilità accomandatari illimitata, accomandanti limitata); art. 2320 c.c. (divieto di immistione accomandanti, perdita limitazione in caso di violazione); art. 2462 c.c. (responsabilità limitata soci S.r.l., eccezione socio unico); art. 2476 c.c. (azione creditori sociali verso amministratori, richiamo responsabilità soci influenti); art. 2495 c.c. (cancellazione società di capitali ed esercizio dei crediti verso soci nei limiti delle somme riscosse).
- Legge Fallimentare (R.D. 267/42): art. 147 L.F. (estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, entro 1 anno dallo scioglimento del rapporto). Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019): art. 256 CCII (liquidazione giudiziale delle società con soci illimitatamente responsabili, conferma estensione e termini); art. 283 CCII (esdebitazione del debitore incapiente, requisiti e condizioni); artt. 65-83 CCII (procedure di composizione sovraindebitamento: piano consumatore, concordato minore); artt. 268-277 CCII (liquidazione controllata del sovraindebitato); art. 278 CCII (esdebitazione successiva alla liquidazione controllata); artt. 279-282 CCII (esdebitazione fallito e condizioni).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 36 (responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per il mancato pagamento di imposte sui redditi da parte di società liquidate) – disciplina richiamata per debiti tributari: il socio risponde entro il valore dei beni ricevuti negli ultimi due esercizi o in liquidazione; atto motivato da notificare al socio ex comma 5.
- Cassazione Civile – numerose sentenze:
- Cass. civ. Sez. I, 27-03-2013, n. 7688: in tema di ex socio S.n.c., conferma che il socio risponde delle obbligazioni sociali sorte solo fino all’iscrizione della cessazione in Registro Imprese; nel caso concreto ha accolto il ricorso di una contribuente ex socia, esclusa da obblighi su redditi societari successivi.
- Cass. civ. Sez. I, 11-05-2012, n. 7327: (richiamata da dottrina) – afferma la natura ex lege civilistica della responsabilità ex art.36 DPR 602/73: non c’è successione né coobbligazione tributaria, ma obbligo proprio per organi e soci, con necessità di atto motivato e facoltà di ricorso.
- Cass. civ. Sez. Unite, 12-02-2025, n. 3625: decisione fondamentale sui debiti tributari dei soci di società estinte. Principi di diritto: il fatto che i soci abbiano percepito somme dal bilancio finale (art.2495 c.c.) costituisce presupposto sostanziale e limite massimo della loro responsabilità; l’onere di provare tale presupposto spetta al Fisco, che deve agire con avviso di accertamento ex art.36 co.5 DPR 602/73 notificato ai soci; la responsabilità non è esclusa dal solo fatto che nulla risulti dal bilancio finale, se emergono altre utilità trasferite ai soci (es. beni non formalmente liquidati, garanzie escusse a loro favore); tuttavia resta necessaria un’accertamento ad hoc nei confronti dei soci, non potendo tale verifica aver luogo nel giudizio contro la società ormai estinta. Le SU ribadiscono inoltre che i soci subentrano processualmente alla società estinta (legittimazione in continuità) ma la loro responsabilità patrimoniale è limitata a quanto ricevuto, e che le sanzioni tributarie non si trasferiscono ai soci (si estinguono con la società). (Fonte: Maurizio Villani – M. Zizzari, nota a Cass. SU 3625/2025).
- Cass. civ. Sez. III, 20-07-2020, n. 15378: (ordinanza) – ribadisce la natura dell’azione ex art.36 DPR 602/73 come autonoma e la necessità dell’atto di accertamento motivato; richiamata da dottrina per confermare che i soci rispondono in via sussidiaria e limitata, con onere all’Erario di dimostrare le condizioni (Cass. nn. 7327/2012, 29969/2019, 17020/2019 conf.).
- Cass. civ. Sez. V, 04-06-2024, n. 15580: (ordinanza) – caso di responsabilità del liquidatore per debiti IVA; richiama i principi consolidati su art.36 DPR 602/73, tra cui che l’azione verso liquidatore/amministratori/soci ha natura civilistica ex lege e non crea coobbligazione tributaria; conferma necessità atto motivato e prova di iscrizione a ruolo dei tributi insoddisfatti. (Fonte: Studio Cerbone – commento a Cass. 15580/2024).
- Corte Appello di Roma, Sez. I, 09-04-2025, n. 2249: ha affrontato il tema del beneficium excussionis e responsabilità ex socio S.n.c. Principi: il beneficio d’escussione opera solo nella fase esecutiva – il creditore può agire in giudizio direttamente contro il socio illimitatamente responsabile, purché in esecuzione tenti prima sui beni sociali. Inoltre, riguardo all’art.2290 c.c., la Corte ha chiarito che la responsabilità del socio uscente copre le obbligazioni contratte anteriormente finché dura il rapporto sociale; il termine “fino al giorno dello scioglimento” si riferisce alle obbligazioni divenute esigibili e non adempiute prima della sua uscita. Dopo lo scioglimento, il socio non può più controllare l’adempimento, quindi non risponde delle inadempienze successive, a condizione che lo scioglimento sia stato reso conoscibile ai terzi ignari senza colpa. (Fonte: Avv. A. Sugamele, sintesi Corte App. Roma 2249/2025).
- Corte Costituzionale, 26-06-2025, n. 87: ha esaminato l’art.147 L.F. (ora art.256 CCII) sulla estensione del fallimento ai soci illimitati, in particolare per soci di società semplice di fatto commerciale. Ha dichiarato non fondate le questioni, ma con interpretazione conforme: ha statuito che i soci palesi hanno diritto di essere convocati nel giudizio di fallimento della società, e se ciò non avviene, l’accertamento dei requisiti di fallibilità dell’ente non è loro opponibile nel successivo giudizio di estensione. Inoltre, ha ribadito che il fallimento dei soci non può essere dichiarato dopo 1 anno dallo scioglimento del rapporto sociale (richiamando l’art.147, comma 3 L.F.). Questa sentenza rafforza il diritto di difesa dei soci nelle procedure, imponendo la loro chiamata prima di estenderne il fallimento (pena poter contestare dopo). (Fonte: Corte Costituzionale n.87/2025).
Sei un ex socio di una casa editrice e ti ritrovi a dover affrontare debiti fiscali, contributivi o verso fornitori e banche? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Sei un ex socio di una casa editrice e ti ritrovi a dover affrontare debiti fiscali, contributivi o verso fornitori e banche?
Hai ricevuto richieste di pagamento, cartelle esattoriali o sei stato coinvolto in azioni legali per debiti contratti dalla società?
Molti ex soci non sanno che, anche dopo l’uscita dalla società, possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni contratte dall’azienda, soprattutto se hanno firmato garanzie personali, prestato fideiussioni o se la forma societaria prevedeva responsabilità illimitata. La legge, però, offre strumenti concreti per contestare richieste ingiustificate, ridurre gli importi dovuti e tutelare il proprio patrimonio personale.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua posizione giuridica e la reale entità della responsabilità sui debiti della casa editrice
📌 Verifica la legittimità delle richieste di pagamento e individua eventuali vizi nelle procedure esecutive
✍️ Predispone ricorsi e opposizioni contro pignoramenti, decreti ingiuntivi o atti di precetto non dovuti
⚖️ Ti assiste nelle trattative con creditori, banche, fornitori e Agenzia delle Entrate
🔁 Valuta procedure di sovraindebitamento o piani di ristrutturazione del debito per alleggerire o azzerare l’esposizione residua
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto nella difesa di ex soci e amministratori coinvolti in crisi aziendali
✔️ Specializzato in contenzioso commerciale, fiscale e bancario
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Anche un ex socio di una casa editrice con debiti può difendersi e salvaguardare il proprio futuro.
Con una strategia legale mirata puoi ridurre i debiti, bloccare le azioni esecutive e proteggere i tuoi beni personali.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa legale comincia da qui.