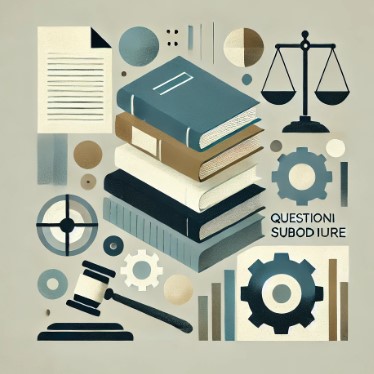Hai sentito parlare di questioni subordinate nel processo tributario, ma non sai cosa significano?
Se stai affrontando un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate o vuoi presentare ricorso contro un atto fiscale, è importante capire cosa sono le questioni subordinate, quando si sollevano e perché sono utili per rafforzare la tua difesa.
Cosa si intende per “questioni subordinate” nel processo tributario?
Le questioni subordinate sono argomentazioni difensive che il contribuente solleva in via subordinata, cioè solo nel caso in cui il giudice non accolga le questioni principali. In pratica, il contribuente dice:
“Se non mi date ragione per il motivo principale, allora valutatemi almeno questo altro aspetto.”
Si tratta quindi di una strategia processuale di riserva, che consente di ottenere comunque un risultato parziale favorevole, anche se il giudice rigetta la contestazione principale.
Esempi tipici di questioni subordinate sono:
– Se il contribuente impugna un avviso di accertamento e contesta la legittimità della notifica (questione principale), ma in via subordinata chiede almeno la riduzione delle sanzioni
– Se si contesta l’inesistenza del debito fiscale, ma in subordine si chiede di riconoscere un costo deducibile non considerato dall’Agenzia
– Se si eccepisce la nullità dell’atto per vizio di motivazione, ma in subordine si chiede la rideterminazione del reddito sulla base di criteri più equi
A cosa servono le questioni subordinate?
– A rafforzare la difesa, offrendo al giudice una seconda via per accogliere, almeno in parte, il ricorso
– A ottenere una decisione favorevole anche se la tesi principale non viene condivisa
– A dimostrare la buona fede del contribuente, che coopera e propone soluzioni alternative
– A contenere il danno, riducendo il carico fiscale o le sanzioni in caso di parziale soccombenza
Come si presentano correttamente le questioni subordinate?
– All’interno del ricorso introduttivo, indicando chiaramente che si tratta di motivi subordinati
– Usando formule tipo: “In via principale si eccepisce…, in subordine si chiede che…”
– Con l’assistenza di un professionista esperto, che sappia coordinare correttamente i diversi livelli di difesa
– In modo coerente e logico: le questioni subordinate non devono contraddire la difesa principale, ma integrarla
Cosa puoi ottenere con una buona strategia difensiva subordinata?
– Il parziale annullamento dell’atto, anche se la contestazione principale viene rigettata
– La riduzione dell’imposta accertata o delle sanzioni applicate
– Il rinvio alla fase di ricalcolo, se il giudice accoglie solo in parte le tue richieste
– Una sentenza più favorevole, utile anche in vista di un eventuale appello
– La possibilità di non pagare l’intero importo richiesto, limitando il danno economico
Attenzione: nel processo tributario non esiste l’obbligo di sollevare questioni subordinate, ma farlo può fare la differenza tra perdere tutto o salvare almeno una parte della tua posizione. Una difesa articolata, con tesi principali e subordinate, è segno di intelligenza processuale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario, ricorsi fiscali e difesa strategica del contribuente ti spiega cosa sono le questioni subordinate, quando usarle e come possono aiutarti a ottenere un risultato utile anche in caso di soccombenza parziale.
Hai ricevuto un atto fiscale e vuoi costruire una difesa efficace e completa?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a impostare correttamente il ricorso, sollevare le giuste questioni (principali e subordinate) e difenderti nel modo più intelligente e sicuro.
Introduzione
Nel processo tributario le questioni subordinate sono quegli argomenti o domande formulate in via alternativa o condizionata rispetto a una questione principale. In pratica, il contribuente (debitore) imposta una gerarchia di motivi nel ricorso: prima si solleva la questione principale (ad esempio un vizio formale che potrebbe annullare interamente l’atto fiscale), e poi si aggiungono questioni subordinate da esaminare solo se la principale non viene accolta. Questo approccio consente al giudice di affrontare il contenzioso in modo progressivo e ragionato: si decide prima sulla questione principale e, solo in caso di rigetto (o parziale accoglimento) di questa, si passa ad esaminare le questioni subordinate. Se invece la questione principale viene accolta pienamente, le questioni subordinate restano assorbite (cioè non vengono esaminate poiché divenute irrilevanti ai fini della decisione).
Le questioni subordinate rivestono un ruolo cruciale nella strategia difensiva del contribuente (debitore fiscale). Dal punto di vista del debitore, infatti, è fondamentale prevedere tutte le possibili linee difensive: in caso di insuccesso sull’argomento principale, una questione subordinata ben formulata può ancora portare a una decisione parzialmente favorevole (ad esempio riducendo la pretesa tributaria o eliminando le sanzioni). Viceversa, omettere di proporre questioni subordinate significa rischiare di perdere completamente la causa se la doglianza principale non viene accolta.
Di seguito, forniremo un quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato (luglio 2025) sulle questioni subordinate nel processo tributario, con approfondimenti avanzati ma esposti in modo chiaro. Verranno esaminati i riferimenti normativi italiani (incluse le ultime novità), le pronunce più recenti delle corti (Cassazione, Corti di giustizia tributaria), e saranno proposti esempi pratici e simulazioni di atti difensivi. Troverete inoltre domande e risposte frequenti sul tema, tabelle riepilogative e modelli di formulazione delle domande subordinate, il tutto dal punto di vista del contribuente/debitore, per guidare sia i professionisti (avvocati, commercialisti) sia i privati e imprenditori che si trovino coinvolti in un contenzioso tributario.
Quadro normativo e principi generali
Principio del contraddittorio “per gradi” e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Nel processo tributario vige – al pari del processo civile – il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), secondo cui il giudice deve decidere nei limiti di quanto richiesto dalle parti. Ciò significa che il giudice tributario non può annullare o modificare un atto fiscale per motivi diversi da quelli sollevati dal ricorrente, né può accordare un beneficio non richiesto. Questo principio impone al contribuente di articolare tutte le domande e le eccezioni sin dal ricorso introduttivo, includendo eventualmente richieste in via subordinata, affinché il giudice abbia titolarità di pronunciarsi su di esse.
Corollario di tale principio è che una corretta gestione delle questioni subordinate permette di coprire tutte le possibili decisioni del giudice senza uscire dal perimetro delle richieste di parte. Il giudice adotterà un approccio graduale: se accoglie un motivo assorbente (ad esempio un vizio procedurale che invalida l’atto impugnato), non esaminerà le altre questioni; se invece lo rigetta, passerà ad esaminare i motivi ulteriori (subordinati). Il rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato garantisce quindi che ogni decisione trovi fondamento in una domanda espressamente formulata dalla parte.
Definizione di “domanda” e “motivo” subordinato
È opportuno distinguere tra domande e motivi (o eccezioni) subordinati, poiché in ambito tributario questi concetti possono sovrapporsi. La domanda si riferisce al petitum, ossia al risultato concreto chiesto al giudice (es. annullamento di un avviso di accertamento, rimborso di un tributo, annullamento di una sanzione). Un esempio tipico di domanda subordinata è chiedere, se non viene accolto l’annullamento totale di un atto, l’annullamento parziale o la riduzione dell’imposta accertata. Il motivo (o censura), invece, è la singola ragione di diritto o di fatto posta a fondamento della domanda. Ad esempio, un ricorrente può dedurre vari motivi di illegittimità di un avviso (vizio di notifica, errore di calcolo, difetto di motivazione, ecc.): ciascuno di questi è un motivo di ricorso. Anche i motivi possono essere formulati in via subordinata l’uno rispetto all’altro (ad es. si deduce prima un vizio radicale che annullerebbe l’intero atto, e subordinatamente un vizio minore che porterebbe solo a ridurre la pretesa).
In pratica, la distinzione non è sempre netta: spesso un motivo subordinato sottende anche una domanda subordinata di portata più limitata. Ad esempio, il motivo con cui si contesta l’errata quantificazione di un reddito contiene implicitamente la domanda subordinata di ridurre l’imponibile qualora il ricorso non venga accolto in toto. Nel processo tributario, la norma fa riferimento genericamente a “questioni” ed “eccezioni” non accolte (art. 56 D.lgs. 546/1992), terminologia ampia che ricomprende sia le domande condizionate sia le ragioni giuridiche a sostegno delle stesse. Ciò riflette l’esigenza di far riproporre in appello qualsiasi profilo non accolto in primo grado, senza formalismi eccessivi sulla natura di “domanda” o “motivo”.
Riferimenti normativi principali
Le questioni subordinate trovano il loro fondamento normativo principalmente nelle regole sul giudizio di appello nel processo tributario, in particolare:
- Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Questioni ed eccezioni non riproposte. Questa norma codifica l’onere di riproposizione in appello delle questioni subordinate non decise in primo grado. Testualmente: “Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate”. Questo significa che se una parte era risultata vittoriosa in primo grado su un motivo (che ha reso assorbiti gli altri) o comunque non ha visto accolti tutti i propri motivi, ha l’onere di ripresentare in appello quelli rimasti inevasi, altrimenti si considerano abbandonati. L’art. 56 ricalca l’analogo art. 346 c.p.c. vigente nel processo civile, adattandolo al processo tributario (dove infatti si parla di “questioni” in senso ampio e non solo di “domande”). Come vedremo, dalla mancata riproposizione discende un effetto paragonabile a un giudicato interno sul punto non più trattato.
- Art. 57 del D.Lgs. 546/1992 – Divieto di domande nuove in appello. Stabilisce il principio dello “ius novorum” limitato in appello: “Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio”. Inoltre, la stessa norma prevede che non sono ammesse nuove eccezioni se non quelle rilevabili d’ufficio (ad esempio eccezioni di nullità insanabili) e fa salvo soltanto il potere di chiedere gli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado. In sostanza, l’appello tributario ha carattere chiuso: il suo scopo è riesaminare quanto già dedotto in primo grado, non introdurre contestazioni completamente nuove. Ciò significa che il contribuente non può, in appello, inserire nuove questioni che non siano state almeno implicitamente trattate nel ricorso originario. Le questioni subordinate, quindi, devono essere proposte sin dall’atto introduttivo o comunque essere già parte del giudizio di primo grado (per esempio come eccezioni non esaminate): diversamente, proporle ex novo in appello significherebbe formulare una “domanda nuova” vietata.
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Applicabile anche nel processo tributario in virtù del rinvio generale al codice di procedura civile (art. 1, c. 2 D.Lgs. 546/92), sancisce che il giudice non può pronunciarsi su ciò che non è stato domandato. Questo principio, come anticipato, obbliga il contribuente a esplicitare chiaramente tutte le sue richieste (principali e subordinate) negli atti processuali, pena la preclusione di una decisione su di esse. Una pronuncia del giudice su una questione non richiesta configurerebbe infatti ultrapetizione, mentre non decidere su una domanda ritualmente proposta configurerebbe omissione di pronuncia. Le questioni subordinate, se correttamente introdotte, mettono al riparo da rischi di omissione: il giudice sarà tenuto a valutarle qualora divengano rilevanti (cioè se la principale non risolve interamente la lite).
- Art. 8 D.Lgs. 546/1992 – Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. È una norma specifica ma importante: consente al giudice di non applicare le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione discende da un’incertezza oggettiva sulla portata della norma tributaria. Questa disposizione costituisce, di fatto, la base per una tipica domanda subordinata in materia sanzionatoria (il contribuente può chiedere “in via subordinata” la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa, qualora non venga annullato il merito dell’imposta). Ne parleremo nel dettaglio più avanti, trattando delle sanzioni.
Novità 2025: Va segnalato che la disciplina del processo tributario è oggetto di riordino: in attuazione della legge delega di riforma fiscale, è stato emanato il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 – “Testo Unico della giustizia tributaria” (pubblicato in G.U. 28/11/2024). Tale Testo Unico entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 e comporterà la riorganizzazione (in gran parte formale) di molte norme. In particolare, l’art. 56 del D.Lgs. 546/92 sarà abrogato dal 2026 e il suo contenuto trasfuso nel nuovo art. 110 del T.U. giustizia tributaria. Allo stato (luglio 2025) la disciplina è invariata e i principi restano gli stessi; tuttavia, gli operatori dovranno fare attenzione, nel futuro prossimo, ai nuovi riferimenti normativi. È presumibile che il nuovo art. 110 confermerà l’onere di riproposizione delle questioni assorbite in appello, in continuità col previgente art. 56.
Effetto devolutivo dell’appello e onere di riproposizione
Il giudizio di appello nel processo tributario, analogamente al processo civile, ha carattere di “revisio prioris instantiae”: ciò significa che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riesamina la causa nei limiti di quanto devoluto con i motivi di appello. L’effetto devolutivo implica che passano al giudice d’appello tutte le questioni decise o da decidere in primo grado che siano oggetto di contestazione.
Tuttavia, proprio l’art. 56 citato sopra pone un limite all’effetto devolutivo automatico: alcune questioni, pur originariamente sollevate, potrebbero non essere automaticamente riesaminate in appello se la parte interessata non le ripropone. In particolare parliamo delle questioni subordinate rimaste assorbite. Si pensi a un ricorrente che in primo grado abbia dedotto più motivi: il giudice di prime cure accoglie il primo motivo (ad es. vizio di notifica) e annulla l’atto impugnato, dichiarando assorbiti gli altri motivi (merito, sanzioni ecc.). In tal caso, in assenza di impugnazione dell’ente, il contribuente ha vinto e la sentenza non tratta gli altri temi; ma se l’ente impositivo propone appello, quelle questioni precedentemente assorbite tornano rilevanti. Chi ha vinto in primo grado (in questo esempio il contribuente) deve però attivarsi per farle rientrare nel dibattito d’appello: il codice tributario (art. 56) prevede infatti che le questioni assorbite devono essere specificamente riproposte dall’appellato, altrimenti si presumono rinunciate.
Questa regola responsabilizza la parte vittoriosa di primo grado: è onere dell’appellato indicare chiaramente quali ulteriori questioni, già sollevate in primo grado ma non decise, egli intende far valere in appello. La ratio è evitare che in appello si discutano questioni su cui la parte vittoriosa magari non ha più interesse (presumendo, in difetto di iniziativa, una sua volontà di abbandonarle). Allo stesso tempo, la norma tutela la parte vittoriosa consentendole, con una semplice riproposizione, di tenere “vive” tutte le sue tesi difensive per il caso in cui la decisione di primo grado venga ribaltata.
Dal punto di vista pratico, come si ripropongono tali questioni? La legge non prescrive formule sacramentali, ma richiede espressamente una riproposizione “specifica” (art. 56 usa l’avverbio “specificamente”, analogo a “espressamente” dell’art. 346 c.p.c.). Ciò significa che non basta un generico riferimento “a tutti i motivi del ricorso di primo grado”: frasi di stile come “si intendono riproposte tutte le eccezioni e i motivi non accolti o assorbiti” sono state giudicate insufficienti. Invece, l’appellato deve indicare in modo chiaro e univoco ciascuna questione su cui mantiene interesse in appello, anche senza dover riscrivere per intero le argomentazioni (è sufficiente richiamare il motivo o l’eccezione per titoli o sintesi, purché sia identificabile). Importante: questa riproposizione avviene nell’atto di controdeduzioni dell’appellato, da depositare entro il termine di costituzione in secondo grado (30 giorni dalla notifica dell’appello). In altre parole, la parte vittoriosa espone nel proprio “atto di appello incidentale non formalizzato” – chiamiamolo così – le questioni che vuole tenere aperte, entro la prima udienza di trattazione al massimo.
Giova ribadire che non occorre proporre un appello incidentale formale (ossia un’impugnazione autonoma della sentenza) per le questioni assorbite o non accolte in quanto non esaminate. L’appello incidentale è richiesto, semmai, quando la parte vittoriosa voglia censurare capi della sentenza che l’hanno vista soccombente, cioè questioni che il primo giudice ha esaminato e rigettato a suo sfavore. Ad esempio, se il contribuente ha ottenuto solo un annullamento parziale dell’accertamento in primo grado, e vuole ottenere di più in appello, deve proporre appello incidentale su ciò che è stato deciso negativamente (ad es. sui motivi respinti). Ma se una questione non è stata affrontata perché assorbita da altra statuizione a lui favorevole, la parte può limitarsi a riprogrammarla (riproporla) nelle controdeduzioni, senza bisogno di impugnare la sentenza. La Cassazione ha chiarito questo concetto: la parte vittoriosa non ha l’onere di appello incidentale in relazione a questioni non esaminate, dovendo unicamente manifestare in modo espresso la volontà di riproporle. Reintrodurre tali questioni non costituisce domanda nuova, poiché si tratta di temi già dedotti nel giudizio di primo grado e che non ampliano l’oggetto del processo d’appello. In altre parole, la riproposizione serve proprio a confermare che su quei punti la parte mantiene interesse alla decisione, senza introdurre nulla di estraneo al thema decidendum originario.
Infine, va sottolineato che la mancata riproposizione di una questione assorbita comporta la decadenza definitiva dalla possibilità di farla valere. La presunzione di rinuncia sancita dall’art. 56 è infatti considerata dalla giurisprudenza un meccanismo che produce un giudicato interno sul punto. Quindi, se il contribuente dimentica di riproporre in appello un motivo non esaminato dal primo giudice, non potrà poi riprenderlo né in Cassazione (dove sarebbe considerato nuovo) né in un eventuale nuovo giudizio successivo. Ad esempio, se in primo grado era stata proposta sia l’eccezione di decadenza dell’azione accertatrice sia, subordinatamente, quella di prescrizione, ma il giudice ha accolto la decadenza assorbendo la prescrizione, il contribuente appellato dovrà riproporre l’eccezione di prescrizione in appello. Se non lo fa, e poi la sentenza di primo grado viene riformata sulla decadenza, egli non potrà più ottenere esame sulla prescrizione, essendosi cristallizzata la rinuncia tacita su tale eccezione.
Schema riassuntivo: tipi di questioni non accolte e sorte in appello
Per chiarire le differenze tra le varie situazioni in cui una questione sollevata in primo grado non venga accolta (o esaminata) e come va gestita in appello, si propone la seguente tabella riepilogativa:
| Situazione in primo grado | Esempio | Azione richiesta in appello | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Questione respinta dal giudice (esplicitamente o implicitamente rigettata) | Il giudice di primo grado rigetta l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente (decidendola e negandola) | Appello (principale o incidentale) sulla statuizione sfavorevole. La parte soccombente su quel punto deve impugnare la sentenza chiedendone la riforma. | Art. 57 D.Lgs. 546/92 (divieto nuove domande); Art. 343 c.p.c. (appello incidentale) |
| Questione non esaminata perché assorbita (la parte era vittoriosa su altro) | Il giudice annulla l’accertamento per difetto di notifica e dichiara assorbiti gli altri motivi (es. prescrizione, vizi di merito, sanzioni) | Riproposizione specifica nelle controdeduzioni dall’appellato vittorioso. Non serve appello incidentale, ma occorre indicare chiaramente in appello i motivi/eccezioni assorbiti che si vogliono mantenere. | Art. 56 D.Lgs. 546/92 (presunzione di rinuncia se non riproposti); Art. 346 c.p.c. (analogo nel civile). |
| Nuova questione mai dedotta in primo grado (non trattata perché non sollevata) | In appello, il contribuente vorrebbe aggiungere un nuovo motivo di nullità non indicato nel ricorso originario | Inammissibile: il giudice d’appello non può conoscerla (ius novorum vietato). Eccezione solo per questioni rilevabili d’ufficio (es. nullità insanabili) o elementi sopravvenuti (esclusi i nuovi motivi, salvo fatti nuovi per i quali la legge lo consenta). | Art. 57 D.Lgs. 546/92 (domande nuove inammissibili; eccezioni nuove ammesse solo se officiose). |
Come si evince dalla tabella, il nodo principale da sciogliere in appello è distinguere ciò che è nuovo (e dunque vietato) da ciò che è già nel processo e va solo mantenuto in discussione. Le questioni subordinate, se introdotte in primo grado, non sono mai “nuove” in senso tecnico, neppure quando vengono fatte valere per la prima volta in grado di appello a seguito di assorbimento: esse, infatti, “rientrano già nell’oggetto della prova e della decisione perché non introducono nel giudizio pendente nuovi diritti o fatti”. Questo passaggio delle Sezioni Unite ribadisce che riproporre un motivo assorbito non amplia il thema decidendum, ma manifesta soltanto l’interesse alla decisione su punti già dedotti.
Formulazione delle questioni subordinate nel ricorso introduttivo
Importanza di sollevare tutte le questioni sin dall’inizio
Dal punto di vista del contribuente, la fase introduttiva del ricorso è cruciale per impostare correttamente sia le questioni principali che quelle subordinate. La regola generale è: tutte le possibili censure e domande vanno formulate nel ricorso di primo grado, per evitare preclusioni future. In particolare, se si intende chiedere qualcosa in via subordinata, occorre dichiararlo espressamente nell’atto introduttivo.
Ad esempio, nel caso tipico di impugnazione di un avviso di accertamento, il contribuente chiederà innanzitutto l’annullamento totale dell’atto (domanda principale). Tuttavia, può essere prudente aggiungere che, ove il giudice non ritenga di accogliere pienamente il ricorso, si chiede in subordine un annullamento parziale o una riduzione della pretesa fiscale (ad esempio rideterminando l’imponibile accertato o eliminando/riducendo le sanzioni). Allo stesso modo, se si contestano più profili (motivazione, calcoli, violazioni di legge, ecc.), si può indicare espressamente che alcuni motivi sono subordinati ad altri – ad esempio dicendo “in via gradata” oppure con formule del tipo “in via principale si deduce X; in via subordinata si deduce Y”.
Formulare correttamente le questioni subordinate richiede chiarezza e ordine espositivo. È buona prassi dedicare una sezione finale del ricorso alle “conclusioni” in cui si riassumono le richieste al giudice, evidenziando le subordinazioni. Ciò agevola il giudice nella comprensione delle domande e del loro ordine logico.
Modello di atto: come indicare richieste subordinate
Per rendere concreto il concetto, ecco uno schema di conclusioni tratto da un ricorso introduttivo reale (aggiornato alla terminologia della riforma, dove le Commissioni Tributarie sono ora “Corti di Giustizia Tributaria di primo grado”):
Richiesta (estratto dal ricorso): in via principale, il ricorrente chiede l’annullamento totale dell’avviso di accertamento impugnato, per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese. In subordine, ove non accolto integralmente il ricorso, chiede la riduzione dell’imponibile e delle sanzioni secondo equità della Corte.
Come si nota, la formula è chiara: prima viene richiesta l’intera soddisfazione (annullamento totale), poi si prevede l’alternativa subordinata (accoglimento parziale – riduzione delle somme dovute). Nel corpo del ricorso, naturalmente, saranno stati sviluppati i motivi corrispondenti: ad esempio, i Motivi di ricorso potrebbero essere: 1) Vizio di notifica dell’atto (che se accolto fa cadere l’intero accertamento); 2) Errori di calcolo sul reddito imponibile (motivo da valutare solo se l’atto non è annullato per il motivo 1); 3) Illegittimità delle sanzioni (anche questo subordinato all’ipotesi in cui l’atto principale resti valido, poiché se il motivo 1 annulla tutto, le sanzioni decadono automaticamente). Ciascuno di questi motivi può essere presentato come subordinato al precedente, esplicitamente o implicitamente.
È importante sottolineare che “meno è più”: la scrittura deve essere esplicita ma sintetica. Non servono lunghe formule arzigogolate, basta indicare chiaramente il carattere subordinato di un motivo o di una domanda. Ad esempio: “in via subordinata, si chiede – qualora l’avviso non venisse annullato in toto – di rideterminare il maggior reddito in misura non superiore a € XXX, con corrispondente riduzione dell’imposta e delle sanzioni”. Questa frase segnala al giudice cosa fare se la richiesta principale non fosse accolta interamente.
Gli esperti consigliano anche di numerare o elencare le conclusioni in modo gerarchico (come fatto nell’esempio). In tal modo, nella sentenza il giudice potrà agevolmente richiamare “la domanda subordinata di riduzione” sapendo che è stata formulata, ed evitare eccezioni di ultrapetizione. Infatti, se il giudice accogliesse solo parzialmente il ricorso senza che nulla fosse chiesto in subordine, teoricamente potrebbe incorrere nel vizio di extra o ultra petizione se riducesse la pretesa nonostante il ricorrente avesse chiesto solo l’annullamento totale. In realtà la giurisprudenza ritiene che l’annullamento parziale sia sempre possibile nel processo tributario, perché il giudice, accogliendo anche solo in parte i motivi, può annullare l’atto “nei limiti” della fondatezza senza eccedere (dare qualcosa in meno non è dare qualcosa di diverso). Ad ogni modo, dal punto di vista pratico, dichiarare la subordinazione mette al riparo da qualsiasi contestazione e rende palese la volontà del ricorrente.
Indicazione espressa e conseguenze di omissioni
La normativa non prevede formule rigide, ma la giurisprudenza ha insistito sulla necessità di un’indicazione espressa delle subordinate. In particolare, come visto, in appello l’art. 56 impone la riproposizione “specifica” delle questioni non accolte. Analogamente, già in primo grado, per evitare equivoci interpretativi, conviene esplicitare ogni domanda subordinata. Se, ad esempio, il ricorso mira anche solo implicitamente a un risultato alternativo (es. ridurre l’imposta invece che annullarla del tutto), meglio dichiararlo: “in ogni caso, nei limiti in cui fosse riconosciuta fondata solo parte della pretesa fiscale, si richiede la corrispondente riduzione dell’ammontare dovuto”.
Un’omissione nel formulare subordinate può avere ripercussioni:
- Se non si deduce un certo vizio o argomento in primo grado, non lo si potrà introdurre dopo (art. 57 vieta questioni nuove). Ad esempio, se ci si “dimentica” di chiedere la disapplicazione di una sanzione per incertezza normativa in primo grado, non la si potrà pretendere in appello come nuova domanda.
- Se non si formula una domanda alternativa che pure poteva essere pertinente, il giudice potrebbe ritenere di non poter accordare un beneficio non richiesto. Ad esempio, se contesto un avviso da €100.000 chiedendone solo l’annullamento totale, e il giudice ritiene illegittimi €60.000 ma legittimi €40.000, in generale pronuncerà l’annullamento parziale per 60k e il resto dovuto. Ciò non è ultra petita (sto ottenendo parzialmente ciò che chiedevo, cioè l’annullamento, anche se non totale). Tuttavia, immaginiamo un caso diverso: impugno un diniego di rimborso IVA chiedendo solo il rimborso integrale di €50.000, ma in via istruttoria emerge che avevo diritto a €30.000. Se non ho chiesto “in subordine il rimborso nella misura minore ritenuta di giustizia”, il giudice potrebbe essere in dubbio se condannare l’ufficio a rimborsare €30.000 (risultato parziale) oppure no. La Cassazione ha affermato che in simili casi il giudice deve riconoscere il rimborso parziale se accerta un diritto parziale, perché il contribuente, chiedendo il totale, implicitamente accetta anche il minore (principio del “qui dicit de imo, dicit de medio”). Tuttavia, per scrupolo, conviene sempre chiarire le possibili soluzioni subordinate.
In sintesi, dal punto di vista pratico del difensore: elencate tutte le possibili vie di uscita per il vostro cliente. La domanda principale rappresenta il vostro scenario ideale (vittoria completa); le subordinate sono reti di sicurezza che possono salvare l’esito in caso la prima linea difensiva ceda. Fate in modo che nessun esito potenzialmente favorevole rimanga precluso per difetto di domanda.
Questioni subordinate nell’impugnazione di avvisi di accertamento
Gli avvisi di accertamento sono tra gli atti più frequentemente impugnati dai contribuenti, e costituiscono un terreno tipico per l’uso di questioni subordinate. Un avviso di accertamento fiscale di norma contiene sia la pretesa principale (imposte e interessi) sia le sanzioni collegate. Il contribuente che lo impugna ha quindi interesse a contestare qualsiasi profilo di illegittimità, potendo ottenere un annullamento totale oppure parziale.
Tipologie di questioni principali e subordinate negli accertamenti
In un ricorso contro un avviso, in genere si formulano motivi di nullità “pregiudiziale” e motivi di merito. Esempi di motivi di natura pregiudiziale (o preliminare) che spesso vengono posti in via principale:
- Vizi di notifica dell’avviso (notifica nulla o inesistente).
- Vizi procedimentali: ad esempio, violazione del contraddittorio endoprocedimentale (mancato invito a comparire ex art. 5-ter DLgs 218/1997, o ex art. 12, c.7 L. 212/2000 se applicabile) – dopo le riforme recenti il contraddittorio è divenuto obbligatorio per molte materie.
- Difetto di motivazione dell’atto impositivo (motivazione assente o insufficiente).
- Decadenza del potere accertativo (atto notificato oltre i termini decadenziali previsti per legge).
- Incompetenza dell’ufficio (casi particolari).
Questi motivi, se fondati, comportano l’annullamento integrale dell’atto, e per loro natura vengono valutati prima degli altri (spesso il giudice, se li accoglie, dichiara assorbiti i restanti motivi di merito).
Accanto a questi, il ricorso tipicamente sviluppa motivi di merito (da esaminare cioè sul contenuto dell’accertamento):
- Errata applicazione della legge tributaria nel merito (es. un reddito imponibile calcolato su basi imponibili non previste dalla norma, o un’aliquota errata).
- Errori di fatto nel calcolo del tributo (es. doppia conteggiatura di ricavi, erronea ricostruzione di volumi d’affari, ecc.).
- Infondatezza delle presunzioni utilizzate dall’ufficio (mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza).
- Illegittimità delle sanzioni irrogate in quanto sproporzionate o non dovute (su quest’ultimo punto si tornerà nella sezione sulle sanzioni).
La questione principale posta dal contribuente in questi casi è la richiesta di annullare l’avviso. Tuttavia, è fondamentale prevedere espressamente le questioni/subdomande subordinate. Ad esempio:
- Subordinata sul quantum: qualora l’atto non fosse annullato in toto, chiedere la rideterminazione dell’imponibile o dell’imposta in misura minore. Ciò può basarsi su un motivo di merito specifico: es. “se anche fossero dovute imposte, il loro importo andrebbe calcolato al netto di € X per spese deducibili non considerate; quindi, in via subordinata si chiede ridurre il maggiore reddito accertato di € X”.
- Subordinata sulle sanzioni: chiedere, se l’accertamento in sé non viene annullato, almeno l’annullamento o la riduzione delle sanzioni (magari invocando cause di non punibilità come l’assenza di colpa, buona fede, obiettiva incertezza normativa, ecc.).
- Subordinata su aspetti procedurali minori: ad esempio, se non viene riconosciuto nullo l’avviso per difetto assoluto di motivazione, in subordine si può chiedere di dichiarare quantomeno illegittimo l’atto per non aver risposto ai rilievi del contribuente in sede di contraddittorio (violazione dell’art. 12, c.7 Statuto Contribuente, se applicabile).
In pratica, ogni motivo di ricorso dovrebbe concludersi con una richiesta specifica, e laddove alcune richieste siano condizionate, va detto espressamente. Un possibile schema di conclusioni per un accertamento complesso potrebbe essere:
- in via principale: annullare integralmente l’avviso per i motivi esposti (es. nullità della notifica oppure infondatezza totale del recupero a tassazione);
- in via subordinata: ove non si annulli totalmente, annullare almeno i capi relativi alle riprese infondate e ridurre il maggior imponibile accertato secondo giustizia (ad esempio accogliendo solo parzialmente la pretesa fiscale);
- in via ancora subordinata: in ogni caso (qualora qualche maggior imposta risultasse dovuta) eliminare o ridurre le sanzioni, in quanto non dovute per ragioni di merito o da disapplicare per incertezza normativa.
Nella pratica, il giudice tributario ha il potere di accogliere parzialmente il ricorso: “quando ravvisa l’infondatezza parziale della pretesa, non deve né può limitarsi ad annullare l’atto impositivo per intero”, ma è tenuto a mantenerne valida la parte non viziata. Questo significa che, anche in assenza di un’esplicita domanda subordinata di riduzione, il giudice può decidere per un annullamento parziale. Tuttavia, la domanda subordinata rafforza la posizione del contribuente, perché manifesta la sua volontà di ottenere comunque il risultato alternativo. Inoltre orienta il giudice sulle esatte aspettative: ad esempio, se il contribuente chiede in subordine la rideterminazione di un reddito da €100k a €50k, sta suggerendo che qualora non si annulli tutto, almeno si riconosca quel limite. Il giudice non è vincolato a quella cifra, ma capisce la linea di confine delle richieste di parte.
Esempio pratico
Caso: Tizio riceve un avviso di accertamento per IRPEF con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il suo reddito, aggiungendo €50.000 di imponibile non dichiarato, e applica una sanzione del 100% sull’imposta corrispondente. Tizio presenta ricorso.
- Motivi del ricorso:
- Violazione del diritto al contraddittorio: l’avviso è nullo perché emesso senza invito a comparire obbligatorio (si cita la normativa sul contraddittorio preventivo, ad es. art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 o art. 12 L.212/2000, a seconda del caso).
- Erronea ricostruzione del reddito: l’ufficio ha incluso €30.000 che in realtà erano somme già tassate l’anno precedente (doppia imposizione).
- Sanzioni non dovute: la sanzione del 100% è illegittima perché l’errore deriva da incertezza su norme fiscali (ad esempio differenze interpretative su quando dichiarare certe somme).
- Domande:
- In via principale: annullare totalmente l’avviso per violazione del contraddittorio (motivo 1), con conseguente annullamento di ogni somma pretesa.
- In via subordinata: qualora il vizio del contraddittorio non fosse accolto, annullare parzialmente l’accertamento riducendo l’imponibile di €30.000 (motivo 2 accolto), con ricalcolo dell’imposta dovuta su €20.000 (in luogo di 50.000).
- In via ulteriormente subordinata: anche se dovesse essere confermato qualche maggior imponibile, disapplicare le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, o comunque ridurle al minimo di legge (motivo 3).
In primo grado, il giudice potrebbe avere diversi esiti. Ipotizziamo che la Corte tributaria di primo grado accolga il motivo 1 (vizio di contraddittorio) e quindi annulli l’intero avviso; dichiarerà assorbiti i motivi 2 e 3. Il contribuente vince completamente, ma l’Agenzia impugna in appello sostenendo la legittimità del procedimento. Ora Tizio, che è appellato, deve riproporre in appello i motivi 2 e 3 (che erano assorbiti) per evitare che, se l’appello dell’ufficio venisse accolto sul punto 1, la causa venga decisa senza esaminare gli altri motivi. Tizio nelle sue controdeduzioni di appello elencherà esplicitamente: “il contribuente, odierno appellato, ripropone ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 546/92 i motivi di ricorso non esaminati in primo grado, ed in particolare: – l’erronea ricostruzione del reddito per €30.000; – l’assenza di colpevolezza e l’obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori”. Così facendo, assicura che la Corte d’appello, se reputerà valido l’atto sul contraddittorio, dovrà esaminare questi due motivi e potrà eventualmente annullare almeno parzialmente l’accertamento.
Se invece Tizio dimenticasse di riproporli, e la Corte di appello gli desse torto sul contraddittorio, l’avviso risulterebbe valido per intero, perché i motivi su merito e sanzioni non essendo stati riproposti sarebbero considerati abbandonati (il giudice d’appello non potrebbe sollevarli d’ufficio né esaminarli, pena ultrapetizione). Questo esempio mostra bene l’importanza delle questioni subordinate e del loro corretto rilancio in appello.
Questioni subordinate nelle controversie su sanzioni tributarie
Le sanzioni tributarie meritano un discorso a parte, in quanto spesso costituiscono l’aspetto “subordinato” per eccellenza. Salvo rari casi in cui il contribuente impugna solo un atto di irrogazione sanzioni (ad esempio un provvedimento sanzionatorio autonomo, non legato a una maggiore imposta), nella maggior parte delle controversie fiscali le sanzioni sono accessorie a un tributo. Ciò implica che se il tributo viene eliminato, anche la sanzione normalmente cade (principio di accessorietà della sanzione). Tuttavia, se il tributo viene confermato (in tutto o in parte), il contribuente può aver interesse a discutere comunque della sanzione, per farla eliminare o ridurre. Ecco perché, tipicamente, le questioni relative alle sanzioni sono poste in via subordinata rispetto alle questioni sul merito del tributo.
Contestazione congiunta di imposta e sanzioni
Nel ricorso contro un avviso di accertamento che comprende sanzioni, il contribuente di solito formula un motivo dedicato alle sanzioni, ma sapendo che esso sarà esaminato solo se non viene annullato l’intero atto per altri motivi. Ad esempio: “Violazione di legge in punto sanzioni: l’atto è illegittimo anche nella parte in cui irroga le sanzioni, poiché… (motivi). Si chiede comunque l’annullamento delle sanzioni in via subordinata, ove fosse ritenuta fondata in tutto o in parte la pretesa principale”. Questo riconosce che se il motivo principale annulla l’imposta, la sanzione viene meno automaticamente (non occorrerà una specifica pronuncia, perché la sanzione accessoria cade insieme al tributo). Viceversa, se il tributo rimane dovuto, allora il giudice dovrà valutare il motivo sulle sanzioni.
Un esempio pratico: impugno un avviso IVA da €100.000 con sanzione 120%. Nel ricorso sostengo:
- (motivo principale) che non era dovuta IVA perché l’operazione è non imponibile.
- (motivo subordinato) in ogni caso, la sanzione 120% è impropria perché l’errore era scusabile o comunque sarebbe applicabile la sanzione fissa minima.
Se il giudice accoglie il motivo sull’IVA (non imponibilità), annulla tutto l’atto; non si pronuncia sulle sanzioni (assorbite). Se invece ritiene dovuta l’IVA, allora dovrà decidere sulla sanzione, e potrebbe ad esempio accogliere il motivo subordinato e annullare o ridurre la sanzione (ad es. applicandone una minore).
Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza e altre esimenti
La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa è forse la questione subordinata più ricorrente in materia di sanzioni. Si fonda sull’art. 8 del D.Lgs. 546/92 (richiamato anche dall’art. 6, c.2 D.Lgs. 472/1997 e dall’art. 10, c.3 L.212/2000): se la norma violata era così poco chiara da indurre in errore inevitabile il contribuente, le sanzioni non si applicano. Questa è una valutazione che spetta al giudice tributario, il quale verifica se vi fosse un’oggettiva incertezza normativa tale che neppure l’Amministrazione potesse pretenderne una interpretazione univoca. La Cassazione ha precisato che l’“incertezza normativa oggettiva” va intesa in senso rigoroso: deve trattarsi di una situazione di ambiguità normativa grave e inevitabile, comprovata da prassi divergenti o difficoltà interpretative riconosciute, tale da rendere non esigibile una condotta diversa del contribuente. In termini concreti, però, l’esimente di incertezza normativa viene spesso invocata dai contribuenti ogniqualvolta la questione fiscale sia complessa o vi siano state evoluzioni giurisprudenziali: non sempre i giudici la accolgono, ma è importante allegarla come questione subordinata.
Oltre all’incertezza normativa, altre possibili esimenti o cause di riduzione delle sanzioni che il contribuente può far valere (tipicamente in via subordinata) includono:
- Buona fede o errore scusabile: se l’infrazione è dovuta a un errore non addebitabile a negligenza del contribuente (es. si è affidato a indicazioni fuorvianti dell’ufficio stesso, o a interpretazioni poi mutate), le sanzioni potrebbero non applicarsi. Questa fattispecie è in parte sovrapponibile all’incertezza normativa, ma può essere più ampiamente intesa.
- Non punibilità per particolare tenuità o ravvedimento: ad esempio, se il contribuente prima dell’accertamento ha effettuato un ravvedimento operoso, o se l’ammontare dell’imposta evasa è sotto soglie di punibilità, etc. (questioni tecniche che però devono essere sollevate se pertinenti).
- Applicazione del cumulo giuridico: se ci sono più violazioni formali o periodi d’imposta coinvolti, chiedere in subordine che sia applicata la sanzione unica per cumulo (ex art. 12 D.Lgs. 472/97) invece di cumulare aritmeticamente le sanzioni.
- Riduzione per adesione o definizioni agevolate: talvolta, se l’atto viene definito o se il contribuente ha fatto istanze in sede amministrativa, può spettare la riduzione delle sanzioni (p.es. 1/3 in caso di acquiescenza, 40% in caso di mediazione tributaria, 1/18 in caso di conciliazione, a seconda della normativa). In giudizio può essere invocato che comunque, in esito alla sentenza, le sanzioni non dovrebbero eccedere quanto sarebbe spettato con definizione agevolata.
Tutte queste sono questioni tipicamente subordinate perché entrano in gioco solo se il contribuente risulta, almeno in parte, soccombente sul merito della pretesa tributaria principale. Dal punto di vista strategico, un ricorso ben congegnato in materia di sanzioni dovrebbe:
- Attaccare in via principale la legittimità della sanzione alla radice (es. “non dovuta perché il fatto non costituisce violazione” – ad es. nessuna evasione, quindi sanzione ingiustificata).
- In subordine, invocare l’incertezza normativa o altre esimenti per escludere comunque la punibilità.
- Ancora subordinatamente, chiedere la riduzione quantitativa della sanzione alla misura minima o a quella risultante dall’applicazione del cumulo o di attenuanti.
Esempio di formulazione graduata sulle sanzioni
In una causa riguardante sanzioni, le conclusioni del ricorso potrebbero essere articolate così:
- in via principale: annullare la sanzione impugnata perché il contribuente non ha commesso alcuna violazione (o perché il presupposto della sanzione è venuto meno, ad esempio se si annulla l’imposta principale);
- in via subordinata: dichiarare non dovute le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza della normativa applicabile, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 546/1992;
- in via ulteriormente subordinata: ridurre la sanzione, applicando il minimo edittale o la sanzione in misura fissa prevista dall’ordinamento in casi di lieve entità (ad esempio, applicare la sanzione pari al 30% dell’imposta, ex art. 13, c.1 D.Lgs. 471/97, in luogo del 100% applicato).
Dal testo sopra (liberamente ispirato a conclusioni tratte da una sentenza reale) si vede come si possano graduare più livelli: prima si afferma che proprio non c’è stata violazione (illegittima irrogazione di sanzioni, presumibilmente perché la maggiore imposta non è dovuta o per altri motivi di nullità); poi si chiede in ogni caso di disapplicare la sanzione per incertezza normativa; infine, ancor più in subordine, di applicare la sanzione minima se proprio una violazione deve essere contestata.
Questioni subordinate in appello riguardo alle sanzioni
Un caso comune: il contribuente impugna insieme l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione sanzioni (quando quest’ultimo è separato, come in alcuni tributi locali o in casi in cui la sanzione formale viene irrogata con provvedimento a parte). Se in primo grado l’accertamento viene annullato, la domanda sulle sanzioni resta assorbita e va riproposta in appello. Come notato nel commentario, “affinché la commissione tributaria regionale possa pronunciarsi sul punto, il contribuente che abbia impugnato l’avviso di accertamento unitamente all’atto di irrogazione delle sanzioni, ed abbia ottenuto l’annullamento dell’atto impositivo, dovrà specificamente riproporre in appello la domanda assorbita relativa alle sanzioni”. Ciò perché, se l’ufficio appella e il tributo resuscita, il giudice d’appello dovrà decidere anche sulla sanzione, ma solo se il contribuente glielo chiede di nuovo. Dunque, mai dare per scontato che la questione sanzionatoria “sia automatica”: è vero che se cade il tributo cadono anche le sanzioni (in silenzio); ma non è vero il contrario – se il tributo risorge, le sanzioni non “risorgono” da sole nel dibattito, bisogna farle esaminare riproponendole.
In conclusione, per il debitore l’obiettivo è evitare di pagare sanzioni anche qualora una parte del tributo risultasse dovuto. Le questioni subordinate sulle sanzioni sono lo strumento per ottenere questo risultato. La giurisprudenza più recente conferma che le Commissioni (Corti) tributarie possono e devono disapplicare le sanzioni in presenza di incertezza normativa oggettiva, ma richiedono prova rigorosa di tale incertezza. Ad esempio, la Cassazione nel 2025 ha ribadito che l’incertezza deve essere tale da rendere oggettivamente impossibile al contribuente discernere il comportamento dovuto, al punto che lo stesso fisco in passato abbia avuto dubbi o posizioni ondivaghe. Ciò implica che il contribuente, nel sollevare questa questione, dovrebbe documentare eventuali prassi discordanti, difformi interpretazioni o lagune normative che hanno generato confusione. Sul piano processuale, comunque, basta dedurre l’incertezza e chiedere la disapplicazione: sarà poi il giudice a valutare se è il caso di riconoscerla.
Questioni subordinate nei procedimenti di riscossione e esecuzione tributaria
Nel contenzioso tributario rientrano anche le impugnazioni relative alla riscossione coattiva dei tributi (cartelle di pagamento, avvisi di addebito, intimazioni di pagamento, fermi amministrativi, ipoteche esattoriali, ecc.). Questi procedimenti presentano peculiarità, poiché spesso il contribuente contesta vizi formali dell’atto della riscossione oppure fatti sopravvenuti (come pagamenti già avvenuti, prescrizione, sgravio ottenuto ma non registrato, ecc.). Anche in tali controversie troviamo sovente questioni subordinate.
Impugnazione della cartella di pagamento: questioni tipiche
Prendiamo il caso emblematico dell’impugnazione di una cartella di pagamento. Le cartelle sono atti con cui l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) richiede il pagamento di somme risultanti da atti impositivi precedenti (accertamenti, liquidazioni, ecc.) divenuti definitivi, oppure da controlli automatizzati.
Le possibili contestazioni del contribuente possono riguardare:
- Vizi propri della cartella: ad esempio, omessa notifica della cartella (mai ricevuta, ma magari il contribuente lo scopre tramite un estratto di ruolo), difetto di motivazione (mancata indicazione dell’atto a monte), errata intestazione, importi sbagliati.
- Vizi dell’atto presupposto: ad esempio, l’accertamento sottostante non fu mai notificato, oppure è stato annullato da una sentenza passata in giudicato, oppure ancora vi è decadenza dall’iscrizione a ruolo.
Per regola generale, se il contribuente non ha impugnato a suo tempo l’atto presupposto, non può rimetterne in discussione il merito tramite la cartella, a meno che non alleghi vizi “che gli impedivano di conoscere l’atto” (come la mancata notifica). Quindi lo scenario classico è: “contesto la cartella perché il precedente avviso non mi fu notificato, ergo il debito non è esigibile”.
In una situazione del genere, la questione principale è spesso un vizio formale risolutivo: la nullità della notifica dell’atto presupposto, che renderebbe nulla anche la cartella (poiché fondata su un titolo inesistente o non divenuto definitivo regolarmente). Tuttavia, il contribuente accorto solleverà in via subordinata anche altre questioni, per evitare che basti rigettare la doglianza principale per farlo perdere del tutto. Esempi:
- In via principale: annullamento della cartella perché l’accertamento presupposto non fu notificato regolarmente (dunque il ruolo è invalido).
- In via subordinata: annullamento o sospensione della cartella perché il credito è comunque prescritto (magari l’accertamento era del 2015 e la cartella è arrivata nel 2022, oltre i termini di prescrizione del tributo).
- In via ulteriormente subordinata: riduzione degli importi pretesi perché errato il calcolo degli interessi o degli aggi di riscossione (oppure perché nel frattempo il contribuente ha pagato una parte e la cartella non ne ha tenuto conto).
Facciamo un esempio concreto per capire le subordinazioni in campo riscossione.
Caso: Caio riceve una cartella di pagamento per €50.000 (IRPEF) relativa a un avviso di accertamento 2017 che, a suo dire, non ha mai ricevuto. Inoltre, nota che la cartella include €10.000 di interessi moratori che gli sembrano eccessivi. Caio propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
- Motivo 1 (principale): Nullità della cartella per omessa notifica dell’atto presupposto (l’avviso 2017). Caio allega che di quell’avviso non ha traccia, e che l’Agente della riscossione non ha prodotto prova di notifica valida. Chiede quindi l’annullamento integrale della cartella perché emessa in assenza di un titolo esecutivo definitivo.
- Motivo 2 (subordinato): In ogni caso, intervenuta prescrizione del credito tributario. Caio deduce che, anche ammesso che l’avviso 2017 fosse stato notificato, dal 2017 al 2023 (data cartella) sono trascorsi più di 5 anni senza altri atti interruttivi, quindi il diritto alla riscossione si è prescritto (per IRPEF il termine di prescrizione – se applicabile, poiché la natura è dibattuta – potrebbe essere decennale, ma Caio invoca il più breve termine quinquennale di diritto comune; è un argomento che il giudice valuterà).
- Motivo 3 (ulteriore subordinato): Errori di calcolo negli interessi di mora. Caio sostiene che gli interessi addebitati (10k su 50k) sono eccessivi perché calcolati su base errata o oltre il tasso legale. Chiede dunque, se proprio la cartella fosse valida, di ricalcolare correttamente gli interessi dovuti e annullare l’importo eccedente.
In primo grado, la Corte tributaria potrebbe:
- Accogliere il motivo 1, annullando la cartella perché l’atto presupposto non risulta notificato. A quel punto gli altri motivi sarebbero assorbiti e Caio vincerebbe pienamente. (L’ente potrebbe poi ri-notificare l’atto presupposto, ma intanto quella cartella è nulla).
- Oppure, se ritenesse che l’atto presupposto invece fu notificato (l’ente produce una ricevuta di raccomandata che Caio contesta, ecc.), potrebbe rigettare il motivo 1 e passare a esaminare il motivo 2:
- Se accoglie il motivo 2 (prescrizione), annulla la cartella perché il credito è ormai inesigibile; a quel punto il motivo 3 diventa irrilevante (assorbito).
- Se rigetta anche il motivo 2 (ritenendo ad es. che la prescrizione sia decennale e non ancora maturata, o che vi fossero stati atti interruttivi), valuterà il motivo 3.
- Sul motivo 3, se Caio ha ragione (ad es. l’ente ha calcolato interessi fino a una data errata, o a un tasso troppo alto), il giudice potrebbe disporre l’annullamento parziale della cartella limitatamente agli interessi non dovuti, rideterminando l’importo totale. Se invece trova regolari anche i calcoli, respingerà pure l’ultimo motivo.
Si vede bene la cascata logica: ogni motivo subordinato diventa rilevante solo se fallisce quello che lo precede. Per Caio, inserire i motivi 2 e 3 è stato determinante: se non li avesse messi e il giudice avesse ritenuto valida la notifica dell’avviso, la cartella sarebbe stata confermata per l’intero importo di €60.000, senza ulteriore scampo. Invece, avendo eccepito la prescrizione e gli errori di calcolo, Caio ha aperto la strada almeno a una riduzione o annullamento parziale.
Altri procedimenti di riscossione: intimazioni, fermi, ipoteche
Le intimazioni di pagamento (avvisi con cui si intima il pagamento entro 5 giorni sotto pena di esecuzione), così come i provvedimenti di fermo amministrativo di veicoli o le iscrizioni ipotecarie, sono atti della riscossione che presuppongono anch’essi una cartella o un titolo precedente. In tali casi, il contribuente può contestare sia vizi propri dell’atto (es. un’intimazione viziata perché la cartella sottostante è nulla o non notificata; un fermo sproporzionato o senza preavviso) sia questioni legate al merito (se ancora discutibile) o alla regolarità della pretesa.
Ad esempio, impugnando un fermo amministrativo, si potrebbe chiedere:
- in via principale, la sospensione e l’annullamento del fermo perché la cartella sottostante non è mai stata notificata (o il debito è stato pagato, ecc.);
- in via subordinata, la conversione del fermo in un provvedimento meno gravoso (ad esempio, limitare il fermo a un solo veicolo se ne hanno bloccati più, proporzionalità);
- in via ulteriormente subordinata, la rateazione del debito con conseguente revoca del fermo (anche se la rateazione di solito è amministrativa, il giudice potrebbe prendere atto di una sopravvenuta dilazione e dichiarare cessata la materia del contendere sul fermo).
Nel caso di ipoteca, similmente:
- principale: annullare l’ipoteca per vizi formali (mancato avviso al contribuente, credito inferiore a soglia di legge, ecc.);
- subordinato: ridurre l’importo garantito o limitare l’ipoteca se il debito effettivo è minore di quello iscritto (es. se parte del debito è prescritto o sgravato);
- subordinato ulteriore: sospendere gli effetti in attesa di giudizio sul merito del debito, ecc.
Questi esempi mostrano come, anche nelle fasi esecutive, il contribuente deve pensare a più livelli. Nelle controversie esecutive c’è un’ulteriore complessità: a volte competono i giudici tributari, altre il giudice dell’esecuzione (ordinario), a seconda che si discuta della legittimità della pretesa tributaria o di atti successivi (pignoramenti, ecc.). Ma rimanendo nell’alveo del processo tributario, il concetto è lo stesso: predisporre nel ricorso tutte le doglianze rilevanti, ordinandole dalla più efficace (capace se accolta di far cadere tutto) a quella meno risolutiva ma utile per mitigare le conseguenze.
Ruolo delle questioni subordinate dal punto di vista del debitore
In ambito riscossione, dal punto di vista del debitore l’obiettivo primario è liberarsi del carico o guadagnare tempo/sollievo. Le questioni subordinate servono a evitare che, fallita la linea di difesa principale, il contribuente resti senza argomenti. Ad esempio:
- Se il contribuente chiede solo l’annullamento della cartella per vizio di notifica e non menziona la prescrizione, e il giudice ritiene valida la notifica, la cartella è confermata e il contribuente dovrà pagare tutto.
- Se invece aveva eccepito la prescrizione in subordine, potrebbe ancora vincere su quella e non pagare nulla.
- Se neanche la prescrizione viene accolta ma aveva contestato il calcolo degli interessi, potrebbe almeno ottenere uno sgravio parziale (pagherà meno interessi).
Per questo il debitore dovrebbe, con l’aiuto del proprio difensore, passare in rassegna tutte le possibili irregolarità o spunti riguardanti la sua situazione debitoria e inserirli nel ricorso. Anche aspetti apparentemente marginali (come spese di notifica addebitate due volte, errori di denominazione, ecc.) possono trovare spazio magari come ultime censure subordinate: male non fa, e talvolta possono portare a esiti positivi inaspettati (ad esempio, una cartella per molti aspetti regolare potrebbe tuttavia essere annullata dal giudice se si scopre che era stata notificata solo per estratto di ruolo non impugnabile, in violazione di legge: caso estremo ma realmente accaduto, Cass. n. 19704/2015).
In sintesi, nei procedimenti di riscossione:
- Questione principale tipica: vizi radicali (nullità notifica, difetto titolo, ecc.) → mirano a caducare interamente l’atto di riscossione.
- Subordinate: questioni su importi e tempi (prescrizione, decadenza dalla riscossione, calcoli interessi, doppi addebiti, ecc.) → mirano a ridurre o azzerare il debito residuo anche se l’atto rimane formalmente valido.
- Ulteriori subordinate: eventualmente questioni di equità o di opportunità (sospensione, rateazione, riduzione di garanzie reali, ecc.) → non sempre competono al giudice tributario decidere su queste (ad es. la concessione di rate non è potere del giudice se non nei limiti di prendere atto di dilazioni già concesse dall’ente), ma possono inserirsi richieste di sospensione cautelare o simili.
Il debitore deve adoperare tutti gli strumenti a sua disposizione: le questioni subordinate sono parte integrante di questa strategia “a strati”, volta a ottenere il miglior risultato possibile date le circostanze.
Riepilogo esempi subordinate nei diversi contesti
Per ricapitolare come le questioni subordinate trovino applicazione nei vari ambiti del processo tributario, si consideri la seguente tabella riassuntiva:
| Contesto | Domanda/Motivo principale | Domanda/Motivo subordinato |
|---|---|---|
| Accertamento fiscale | Annullamento totale dell’avviso per vizi radicali (es. nullità di notifica, difetto di motivazione, decadenza termini) | – In subordine: annullamento parziale o riduzione della pretesa (eliminare le riprese infondate, rideterminare l’imponibile inferiore) – Ulteriormente: eliminazione o riduzione delle sanzioni collegate (se l’imposta dovesse restare in parte dovuta) |
| Sanzioni tributarie | Annullamento della sanzione perché il fatto non costituisce violazione o la sanzione è stata irrogata in violazione di legge (es. mancata contestazione, errore di persona, ecc.) | – In subordine: disapplicazione della sanzione per incertezza normativa oggettiva o per buona fede del contribuente– Ulteriormente: applicazione della sanzione minima prevista (o del cumulo giuridico, se applicabile), in luogo della sanzione piena |
| Riscossione (Cartella, ecc.) | Annullamento dell’atto di riscossione per vizi propri o del presupposto (es. cartella nulla perché l’atto precedente non notificato o già annullato) | – In subordine: dichiarazione di inesigibilità del debito per intervenuta prescrizione o decadenza della riscossione– Ulteriormente: riduzione importi per errori nel calcolo di interessi, aggi, spese, o altre irregolarità minori; sospensione della riscossione in attesa di giudizio sul merito (se non già ottenuta cautelarmente) |
Questa tabella evidenzia come il filo conduttore delle questioni subordinate sia comune: offrire al giudice un ventaglio di soluzioni graduate, dal tutto al parte, e al contempo assicurarsi che il contribuente non esca dal processo a mani vuote se il primo obiettivo non viene centrato.
Domande frequenti (FAQ) sulle questioni subordinate
Di seguito rispondiamo ad alcuni quesiti comuni per chiarire gli ultimi dubbi sul tema delle questioni subordinate nel processo tributario.
D: Cosa si intende esattamente per “questione subordinata” nel processo tributario?
R: Si intende un’argomentazione o una domanda proposta in via condizionata, cioè da esaminare solo se una diversa questione (detta principale, o pregiudiziale) non viene accolta. In altre parole, è un motivo alternativo o un rimedio alternativo che il contribuente richiede qualora il giudice non dia ragione alla richiesta principale. Ad esempio, chiedere in via subordinata la riduzione di una pretesa fiscale qualora non venga annullata in toto significa proporre al giudice un esito “di riserva” al quale ricorrere se il ricorrente non ottiene la vittoria piena.
D: Le questioni subordinate sono la stessa cosa delle questioni pregiudiziali?
R: No, anche se a volte i termini possono confondersi. Una questione pregiudiziale è una questione che va affrontata prima delle altre perché potenzialmente decisiva (ad esempio, la giurisdizione, la decadenza, la nullità dell’atto per vizio di forma). Spesso la questione pregiudiziale costituisce proprio la “questione principale” del processo: se accolta, chiude la causa. Le questioni subordinate sono invece quelle poste in subordine, quindi dopo la principale. Possono ben essere questioni di merito o secondarie. In sintesi, “pregiudiziale” indica una priorità logico-giuridica, “subordinata” indica una condizionalità (viene dopo un’altra). Ad esempio: il difetto di notifica è pregiudiziale (il giudice lo valuta prima di tutto); la richiesta di ridurre le sanzioni è subordinata (il giudice la considera solo se non annulla tutto per un altro motivo).
D: Perché è importante inserire questioni subordinate nel ricorso?
R: Perché offrono una tutela aggiuntiva. Il processo è aleatorio: il motivo principale potrebbe non convincere il giudice. Avere questioni subordinate significa poter ottenere comunque un risultato parziale favorevole (ad esempio una riduzione dell’importo dovuto, o l’eliminazione delle sanzioni) anche se la pretesa principale dell’ufficio viene confermata in parte. In assenza di subordinate, un ricorso rischia di essere “monco”: se cade l’unico motivo, il contribuente perde del tutto. Con le subordinate, si prepara una sorta di “piano B” (o C, etc.), il che spesso fa la differenza tra una sconfitta totale e una vittoria parziale o un compromesso. Inoltre, la presenza di subordinate può anche indurre l’Ufficio a essere più cauto: se vede che il contribuente ha eccezioni forti su più fronti, potrebbe valutare soluzioni alternative (es. una conciliazione).
D: Formulare motivi subordinati non rischia di confondere il giudice o di indebolire la posizione principale?
R: Se fatto correttamente, no. È importante che dal ricorso emerga chiaramente qual è il motivo principale e quali quelli subordinati: questa gerarchia logica guiderà anche il giudice. Un buon ricorso espone i motivi in ordine e magari lo dichiara espressamente (“si deduce in via principale… in via subordinata…”). Ciò non toglie forza al motivo principale, semplicemente mostra al giudice che esistono ulteriori profili da considerare. I giudici sono abituati a questa struttura “in via gradata” e anzi la apprezzano perché consente loro di scrivere sentenze più complete (decidendo in via principale e, “assorbite le altre” oppure – se rigettano il primo motivo – esaminando gli altri). Dunque, non c’è rischio di confusione se si redige in modo ordinato. Chiaramente, non bisogna nemmeno esagerare con valanghe di motivi: il ricorso deve mantenere focalizzazione. Le subordinate vanno inserite dove servono, non create artificiosamente. In sintesi: meglio avere due-tre buoni motivi (di cui uno principale e gli altri subordinati) ben chiari, che uno solo e mettere tutte le uova in quel paniere.
D: È possibile proporre una domanda nuova in appello come subordinata? Ad esempio, se in primo grado ho dimenticato un motivo, posso introdurlo in appello come subordinato?
R: No, purtroppo. Il divieto di nuove domande e nuovi motivi in appello (art. 57 D.Lgs. 546/92) è tassativo. Ciò che non è stato dedotto in primo grado non può essere introdotto in secondo grado neanche travestendolo da “subordinato”. Le uniche cose nuove ammesse in appello sono le eccezioni che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio (ad esempio, la nullità della sentenza di primo grado per un vizio processuale) e la richiesta degli interessi maturati dopo. Quindi, se in primo grado non ho contestato un particolare vizio dell’atto, non posso farlo esordire in appello. L’unica eccezione è se il motivo “nuovo” si basa su un fatto sopravvenuto dopo la sentenza (ma in tal caso più che subordinato è semplicemente un fatto nuovo, ad esempio: dopo la sentenza è intervenuto un condono, ecc., situazioni rare e disciplinate a parte). In generale, tutte le questioni vanno sollevate subito in primo grado, altrimenti sono perse.
D: Se in primo grado alcune mie questioni non sono state esaminate (perché assorbite), devo riproporle in appello anche se sono ovvie?
R: Sì. Anche se può sembrare superfluo, la legge impone la riproposizione esplicita. Ad esempio, se il giudice di primo grado ha annullato l’accertamento per difetto di firma del funzionario, non ha affrontato il motivo (subordinato) sulla prescrizione. In appello l’Ufficio impugna dicendo che la firma in realtà c’era. Tu contribuente, appellato, sei convinto che comunque il fatto che siano passati 5 anni rende tutto prescritto: è “ovvio”, ma devi lo stesso scriverlo nelle controdeduzioni. La Cassazione ha chiarito che senza riproposizione la questione si intende rinunciata, punto. Non importa se era “evidente” o se “faceva già parte del processo”: bisogna manifestare che si ha ancora interesse a farla decidere. Quindi sì, vanno riproposte tutte, per sicurezza. Farlo non costa nulla (basta qualche riga) e mette al riparo da decadenze.
D: In appello devo proporre appello incidentale o basta riproporre i motivi assorbiti?
R: Dipende dal tipo di questione:
- Se la sentenza di primo grado ti ha dato torto su un motivo (cioè lo ha rigettato, magari uno dei tuoi motivi di ricorso), allora sei soccombente su quel punto e devi proporre appello incidentale per chiedere alla CTR di ribaltare la decisione sfavorevole su quel motivo. Questo succede spesso quando, ad esempio, il ricorrente ottiene un annullamento parziale ma non totale e vuole contestare la parte non annullata. L’appello incidentale va notificato entro 30 giorni dalla notifica dell’appello principale (o entro la prima udienza se l’appellante principale tarda a costituirsi).
- Se la sentenza di primo grado non si è pronunciata su un tuo motivo perché ti ha dato ragione su altro (quindi quel motivo è rimasto assorbito, né accolto né rigettato esplicitamente), allora non sei “soccombente” su quel motivo (semplicemente non è stato trattato). In tal caso non serve appello incidentale, ma come detto devi riproporlo espressamente nelle controdeduzioni. La legge e la giurisprudenza dicono che la parte vittoriosa “non ha l’onere di proporre appello incidentale” su questioni non esaminate, ma solo di richiamarle in appello.
- Fai attenzione: se c’è dubbio se una questione sia stata implicitamente rigettata o assorbita, meglio agire con prudenza. A volte le sentenze di primo grado sono ambigue: es. dichiarano assorbiti alcuni motivi ma poi in realtà nelle motivazioni li trattano e li giudicano infondati “in ogni caso”. In situazioni così, conviene sia riproporre il motivo nelle controdeduzioni, sia eventualmente proporre appello incidentale condizionato. È un tecnicismo, ma giusto per coprire tutte le evenienze. Nella maggior parte dei casi, comunque, la distinzione è chiara: respinto = appello incidentale, non esaminato = riproposizione.
D: Se il giudice di appello riforma la sentenza di primo grado, che fine fanno le questioni subordinate non esaminate prima?
R: Se le hai riproposte correttamente, il giudice di appello dovrà decidere anche su di esse. Ad esempio, primo grado ti aveva dato ragione sul vizio di notifica (assorbendo merito e sanzioni); appello ti dà torto sulla notifica: a quel punto la Corte d’appello deve pronunciarsi sul merito e sulle sanzioni (i tuoi motivi subordinati), altrimenti la sentenza d’appello sarebbe essa stessa viziata per omessa pronuncia. Infatti, la Cassazione ha più volte cassato sentenze di secondo grado che, dopo aver ribaltato l’esito sul motivo principale, si erano dimenticate dei motivi subordinati riproposti dalle parti. Dunque, se tutto è fatto correttamente, in appello avrai una decisione su ogni questione rilevante. Se invece non le avevi riproposte, come spiegato, si intendono rinunciate: il giudice d’appello non ne parlerà e ciò farà stato (non potrai più sollevarle).
D: Il giudice tributario può accogliere una domanda in misura minore di quella richiesta? Serve indicarlo?
R: Sì, il giudice può accogliere anche parzialmente. Non è necessario che il contribuente scriva “in via subordinata accogli anche solo in parte”, perché in generale l’accoglimento parziale rientra nel potere del giudice. Ad esempio, se chiedo l’annullamento di un avviso da €100k e il giudice ritiene illegittimo solo €60k, normalmente pronuncerà l’annullamento parziale per 60k e la conferma per 40k, anche se io non avevo espressamente detto “annulla almeno 60k”. Questo non è considerato ultrapetizione (il giudice non sta andando oltre la domanda, mi sta dando meno di quanto chiesto, il che è lecito). Tuttavia, indicare le subordinate (ad esempio chiedere espressamente la riduzione) è comunque consigliabile perché orienta il giudice e formalizza la richiesta. In alcune situazioni più particolari (come i rimborsi parziali, vedi sopra), l’assenza di una domanda subordinata potrebbe creare incertezze. Quindi, pur non essendo strettamente obbligatorio per legge chiedere “anche il meno”, farlo esplicitamente con una subordinata è buona prassi. In ogni caso, se la domanda principale è generica tipo “annullare o ridurre come di giustizia”, il giudice ha mano libera di accogliere in parte. Ma meglio specificare con subordinata quale parte, se lo sai (es: “ridurre almeno le sanzioni al minimo”).
D: Che differenza c’è tra questioni subordinate e motivi aggiunti?
R: Nel processo tributario non esiste la figura dei “motivi aggiunti” dopo il ricorso, a differenza del processo amministrativo. Tutto ciò che intendi far valere deve stare nel ricorso originario (o al massimo, entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, in un ricorso integrativo se emergono nuovi motivi in quel lasso di tempo, ma questa è una finezza poco usata e valida solo in casi di atti sopravvenuti). Le questioni subordinate sono semplicemente motivi inseriti nel ricorso stesso con carattere condizionato. Quindi non vanno confuse con eventuali motivi nuovi introdotti successivamente (che, ripetiamo, in appello non sono ammessi e in primo grado possono al più essere presentati con atto integrativo nei limiti di legge). In sintesi: motivo aggiunto implica aggiungere qualcosa dopo; motivo subordinato implica averlo già scritto dentro il ricorso ma come eventuale.
D: Posso graduare anche le richieste sulle spese di giudizio?
R: Questo è un tema curioso: teoricamente sì, nulla vieta di chiedere in via principale la condanna integrale alle spese della controparte e in via subordinata la compensazione in caso di soccombenza reciproca. Però, in pratica, sulle spese decide il giudice con discrezionalità in base alla soccombenza prevalente e al comportamento delle parti. Non è consuetudine formulare conclusioni subordinate sulle spese, anche perché sono accessorie. Puoi certo argomentare che se vinci su un punto e perdi su un altro si dovrebbero compensare le spese, ma non è proprio una “questione subordinata” in senso stretto, è più una richiesta eventuale. Ad ogni modo, questo esula un po’ dal concetto classico di questioni subordinate, che riguarda il merito della causa.
D: Le questioni subordinate riguardano anche il giudizio di Cassazione?
R: In Cassazione il discorso è diverso. La Cassazione giudica solo di legittimità, su motivi tassativi (violazione di legge, vizio motivazione, etc.). Non si parla propriamente di questioni subordinate in Cassazione, perché non si introducono nuove domande ma si contestano errori della sentenza d’appello. Tuttavia può capitare di proporre motivi di ricorso per Cassazione in via subordinata l’uno rispetto all’altro. Ad esempio, in Cassazione spesso si formulano motivi condizionati: prima magari si eccepisce una nullità processuale (se accolta casserebbe la sentenza senza rinvio), e subordinatamente si deduce un errore di diritto sul merito (nel caso la nullità non venga ritenuta decisiva, si vuole comunque che la Corte valuti l’altro errore). Questa è una tecnica argomentativa che la Cassazione ammette. Ma attenzione: in Cassazione non si possono introdurre nuovi temi di merito, quindi le “questioni subordinate” in senso di questioni di fatto o di diritto nuove non esistono. Si può solo graduare i motivi di impugnazione della sentenza. Per concludere: il concetto di questione subordinata è soprattutto proprio del giudizio di merito (primo grado e appello), mentre in Cassazione assume la forma di motivi di ricorso graduati per economizzare l’analisi della Corte.
D: Ci sono casi in cui il giudice decide questioni che nessuno aveva posto (es. rileva d’ufficio qualcosa). Questo come si concilia con le questioni subordinate?
R: Il giudice tributario può rilevare d’ufficio solo questioni molto limitate, ad esempio quelle attinenti alla nullità insanabile dell’atto per difetto di motivazione solo se l’atto è talmente carente da non contenere neanche l’indicazione dell’imposta (situazione rara), oppure la questione di costituzionalità di una norma, o la giurisdizione. In tali casi si esula dal tema delle questioni subordinate perché non dipende dalle richieste di parte. Ad esempio, se il giudice accorgendosi di un vizio radicale non dedotto annulla l’atto, lo fa in base al suo potere-dovere ex officio; le altre questioni le dichiarerà assorbite. Ciò non riguarda le questioni subordinate del contribuente, se non per dire: anche se il contribuente non aveva posto quella questione, il giudice l’ha risolta d’ufficio. Ma sono eccezioni. In generale, la regola resta che “il giudice decide sul chiesto”. Dunque, le questioni subordinate attengono a ciò che la parte chiede e non a ciò che il giudice solleva autonomamente.
D: Se il contribuente non ripropone una questione assorbita in appello e quindi si forma giudicato interno, può in un nuovo giudizio autonomo farla valere?
R: No. Questo è un punto cruciale: quando diciamo che si forma giudicato interno, significa che all’interno di quella controversia quella questione non potrà più essere discussa. Se l’appello finisce male per il contribuente e lui aveva “perso” quella questione per mancata riproposizione, non può intentare un nuovo processo per farla valere perché sarebbe bloccato dal principio del ne bis in idem (non si può ridiscutere in un nuovo giudizio ciò che attiene allo stesso rapporto d’imposta già definito). Ad esempio, se non ripropone l’eccezione di prescrizione e perde in appello sulla decadenza, non è che poi può pagare e fare causa di rimborso sostenendo la prescrizione: sarebbe lo stesso rapporto tributario, ormai coperto da giudicato sulla debenza dell’imposta. Quindi purtroppo, una volta persa la chance in appello, la questione è persa del tutto. Questo conferma l’importanza di non dimenticare nulla per strada.
D: Ci sono strumenti alternativi al sollevare questioni subordinate?
R: L’unica alternativa è convincere il giudice con la questione principale! Scherzi a parte, non esistono strumenti processuali alternativi per inserire dopo le questioni non sollevate: non si può fare un secondo ricorso su un atto già impugnato (verrebbe riunito o dichiarato inammissibile), non si possono presentare memorie integrative per aggiungere nuovi motivi salvo il caso dei “motivi aggiunti” nel primo grado ma entro 60 giorni dalla notifica se l’atto è stato prodotto incompleto dall’ente (istituto raro). Quindi l’alternativa vera è cercare una soluzione in via amministrativa: per esempio, se ti accorgi tardi di aver trascurato qualcosa, puoi provare a transigere col fisco (conciliazione, mediazione se ancora ammessa, definizione agevolata se c’è qualche norma speciale, ecc.). In sede contenziosa, però, no: devi giocare tutte le carte dall’inizio. Quindi più che alternative ex post, serve prevenzione ex ante: studio accurato del caso e presentazione di un ricorso completo.
D: Sollevare molte questioni può avere controindicazioni (ad esempio far irritare la Commissione, o dare impressione di “buttarla in caciara”)?
R: Se le questioni sono tutte pertinenti e non pretestuose, no. I giudici tributari sanno che l’Agenzia delle Entrate fa spesso atti con più possibili vizi, e che il difensore li deve evidenziare tutti. Certo, presentare dieci motivi di cui magari nove di scarsa consistenza e uno buono, potrebbe far diluire l’attenzione. È compito dell’avvocato dare il giusto risalto a ciò che conta davvero, magari distinguendo i motivi principali dai subordinati in modo chiaro e dedicando più approfondimento a quelli più incisivi. Un ricorso prolisso e pieno di eccezioni fantasiose può nuocere alla credibilità della difesa. Quindi, equilibrio: sollevare tutto ciò che serve, ma solo ciò che serve. Non inventare questioni subordinate artificiose solo per allungare il brodo: il giudice se ne accorge. Al contrario, ogni buon motivo deve trovare posto nel ricorso. Il professionista tributarista sa che un accertamento può essere attaccato da varie angolazioni e spesso le cause si vincono per motivi diversi da quelli su cui si puntava all’inizio. Dunque, meglio avere più frecce al proprio arco. Le Commissioni non si “irritano” per questo, fa parte del gioco processuale. Si irritano magari per ricorsi confusi o eccessivamente lunghi senza costrutto. Ma se ogni motivo è nitido e centrato su un aspetto, anche fossero sei o sette, verranno valutati serenamente.
D: In fase di appello, se l’appellante principale ritira l’appello o questo viene dichiarato inammissibile, cosa succede delle questioni subordinate dell’appellato?
R: Se l’appello principale viene meno (per rinuncia, per improcedibilità, ecc.), la sentenza di primo grado passa in giudicato così com’era. Le questioni subordinate che l’appellato poteva aver riproposto restano semplicemente assorbite dal fatto che la pronuncia di primo grado non è stata modificata. Ad esempio, se avevi vinto su un vizio e l’ufficio rinuncia all’appello, non ci sarà mai bisogno di decidere i tuoi motivi subordinati: la sentenza di primo grado che ha annullato tutto resta definitiva, fine. Quindi in tal caso la riproposizione era una cautela ma non verrà esaminata. Diverso se tu avevi proposto appello incidentale su parti in cui eri soccombente: se l’appello principale si estingue, l’incidentale (se tempestivo autonomo) potrebbe proseguire. Ma restiamo sulle subordinate: in sostanza decadono con l’appello principale perché non c’è più un processo in cui discuterle.
D: Come reperire la giurisprudenza più rilevante sulle questioni subordinate?
R: Alcune pronunce chiave sono:
- Cass., Sez. Unite, 21 marzo 2019 n. 7940: ha sancito chiaramente l’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e la non necessità di appello incidentale per i motivi assorbiti.
- Cass., Sez. V, 27 novembre 2015 n. 24267: già richiamata in altre sentenze, sul fatto che un generico richiamo a “tutti i motivi” non basta, servono richiami specifici.
- Cass., Sez. V, 7 marzo 2023 nn. 6774 e 6790: confermano il principio (in ambito tributario) che la riproposizione dev’essere specifica e che l’omissione comporta rinuncia (queste due del 2023 sono citate nell’ordinanza 25239/2024).
- Cass., Sez. Trib., ord. 25239 del 19/09/2024: molto importante, già citata, perché spiega dettagliatamente l’onere di riproposizione e il concetto di presunzione di rinuncia.
- Cass., Sez. I, ord. 2670 del 04/02/2025: richiama gli stessi principi delle Sezioni Unite 2019, ribadendo che la parte vittoriosa non ha onere di appello incidentale ma deve espressamente riproporre le questioni assorbite (massima riportata in vari commenti).
- Cass., Sez. V, ord. 34798 del 29/12/2024: ha ribadito che la riproposizione in appello di questioni già prospettate in primo grado non costituisce domanda nuova vietata dall’art. 57, rientrando quindi nel perimetro del lecito.
- Cass., Sez. V, sent. 1312 del 20/01/2025: in tema di sanzioni, ha definito stringenti criteri per l’obiettiva incertezza normativa (utile da consultare quando si imposta quel tipo di questione subordinata).
Conoscere queste pronunce aiuta il difensore ad avere la certezza del diritto sulla correttezza della propria strategia processuale riguardo alle questioni subordinate.
Conclusione: le questioni subordinate, se ben padroneggiate, sono un elemento fondamentale di ogni difesa tributaria efficace. Permettono di costruire un ricorso “a prova di sconfitta”, offrendo al giudice soluzioni graduali e assicurando che i diritti del contribuente siano valutati sotto ogni profilo rilevante. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale conferma l’importanza di tali strumenti: il legislatore esige chiarezza (riproposizione specifica) e la Cassazione vigila affinché nessuna questione dedotta venga trascurata se ritualmente introdotta. Per il contribuente-debitore, questo si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti che sappiano individuare tutte le possibili censure e proporle nel modo giusto e al momento giusto. In tal modo, anche di fronte alla complessità del sistema fiscale e delle sue procedure, il contribuente può far valere pienamente le proprie ragioni e ottenere giustizia, totale o parziale che sia.
Fonti (normative, giurisprudenziali e dottrinali)
- Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – Art. 56 (Questioni ed eccezioni non riproposte) e Art. 57 (Domande ed eccezioni nuove).
- Codice di procedura civile, Art. 112 (Corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e Art. 346 (Riproposizione domande ed eccezioni non accolte in primo grado).
- D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 – Testo Unico della Giustizia Tributaria (in vigore dal 2026): prevede il riordino delle norme del processo tributario, tra cui la trasposizione dell’art. 56 D.Lgs. 546/92 nel nuovo art. 110 T.U..
- Cassazione Civile, Sez. Unite, sent. 21 marzo 2019 n. 7940 – Principio di diritto sull’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c.: la parte vittoriosa deve riproporre in appello i motivi assorbiti, senza necessità di appello incidentale, entro la prima difesa.
- Cassazione Civile, Sez. V, ord. 27 novembre 2015 n. 24267 – Sancisce che il generico richiamo a tutti i motivi di primo grado non basta a evitare la presunzione di rinuncia; servono indicazioni specifiche.
- Cassazione Civile, Sez. V, ord. 7 marzo 2023 nn. 6774 e 6790 – Confermano la necessità di riproposizione specifica delle questioni assorbite e la formazione del giudicato interno in caso di omissione.
- Cassazione Civile, Sez. V, ord. 19 settembre 2024 n. 25239 – Importante pronuncia recente: chiarisce che la devoluzione in appello delle questioni assorbite è subordinata a iniziativa della parte vittoriosa, altrimenti scatta presunzione di rinuncia. Sottolinea l’obbligo di specificità nella riproposizione.
- Cassazione Civile, Sez. I, ord. 4 febbraio 2025 n. 2670 – Ribadisce che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha onere di appello incidentale per questioni non esaminate, ma deve manifestare espressamente la volontà di riproporle in appello (principio conforme a SU 7940/2019).
- Cassazione Civile, Sez. V, ord. 29 dicembre 2024 n. 34798 – In tema di divieto di nuove domande (art. 57), afferma che non costituisce domanda nuova la riproposizione in appello di questioni originariamente sollevate in primo grado (conferma dunque che tali riproposizioni sono ammissibili).
- Cassazione Civile, Sez. V, sent. 20 gennaio 2025 n. 1312 – In materia di sanzioni tributarie, delinea i criteri rigorosi per l’“obiettiva incertezza normativa” come causa di non punibilità, richiedendo che l’incertezza sia oggettiva e inevitabile, accertata dal giudice caso per caso.
- Cassazione Civile, Sez. V, ord. 26 giugno 2024 n. 17641 – (Richiamata da dottrina, contenuto simile a Cass. 1312/2025) sul tema sanzioni: conferma la necessità di provare l’impossibilità oggettiva di individuare la corretta interpretazione della norma per invocare l’esimente di incertezza.
- Commissione Tributaria (Corte Giust. Trib.) di Civitavecchia, sent. 22/11/2018 n. 1837 – Esempio di applicazione dell’art. 8 D.Lgs. 546/92: la CTR ha disapplicato sanzioni per obiettiva incertezza, ribadendo che va dedotta dalla parte appellata e valutata in concreto.
Hai avviato un ricorso contro un avviso di accertamento, una cartella o un atto fiscale e ti hanno parlato di questioni subordinate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai avviato un ricorso contro un avviso di accertamento, una cartella o un atto fiscale e ti hanno parlato di questioni subordinate? Ti stai chiedendo cosa siano e quale ruolo abbiano nel processo?
Nel processo tributario, le questioni subordinate sono quelle che il giudice esamina solo se ha rigettato le questioni principali. In pratica, si tratta di argomenti difensivi alternativi o secondari, da sollevare nel caso in cui il giudice non accolga la tesi principale della difesa.
🔍 Esempi di questioni subordinate
- Se l’accertamento è legittimo (questione principale), si chiede comunque la riduzione della sanzione (questione subordinata)
- Se il ricorso principale mira all’annullamento dell’atto per vizio formale, la questione subordinata può riguardare la non debenza dell’importo o un errore di calcolo
- In caso di rigetto della tesi sull’incompetenza dell’ufficio, si chiede in via subordinata l’applicazione di un’agevolazione fiscale non considerata
Le questioni subordinate servono a garantire più livelli di difesa: se la tesi principale non viene accolta, il giudice può comunque pronunciarsi su un profilo secondario a vantaggio del contribuente.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza in profondità l’atto impugnato e il tuo caso fiscale
- 📌 Costruisce una strategia difensiva completa, con questioni principali e subordinate ben articolate
- ✍️ Redige ricorsi tecnici, fondati su argomentazioni alternative che rafforzano la tua posizione
- ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in primo grado e in appello
- 🔁 Ti assiste anche in eventuali accordi conciliativi, dove le questioni subordinate possono diventare decisive
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale strategico
- ✔️ Specializzato nella difesa multilivello, con attenzione alle questioni principali, subordinate e incidentali
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Nel processo tributario, le questioni subordinate sono uno strumento prezioso: ti permettono di difenderti anche quando la linea principale non viene accolta, offrendo al giudice ulteriori motivi per ridurre o annullare le pretese del Fisco.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa si costruisce su più livelli.