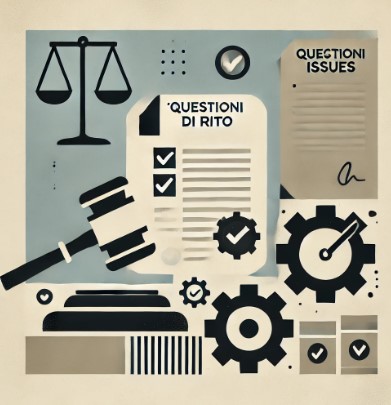Hai sentito parlare di questioni di rito nel processo tributario, ma non sai esattamente cosa significano?
Se stai affrontando un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate o hai intenzione di presentare ricorso contro un avviso di accertamento o una cartella esattoriale, è fondamentale capire cosa sono le questioni di rito, quando si sollevano e perché possono essere decisive per vincere una causa fiscale.
Cosa si intende per “questioni di rito” nel processo tributario?
Le questioni di rito riguardano la validità formale del processo e degli atti, cioè l’insieme delle regole procedurali che devono essere rispettate affinché il giudizio tributario sia valido. Non riguardano il merito del debito (cioè se l’imposta è dovuta o meno), ma aspetti tecnici e preliminari che, se violati, possono portare all’annullamento dell’atto impugnato anche senza esaminare il contenuto.
Esempi tipici di questioni di rito sono:
– Notifica irregolare o inesistente dell’atto (accertamento, cartella, intimazione, pignoramento)
– Mancanza di motivazione nell’atto impugnato
– Violazione del termine per impugnare o per notificare l’atto
– Incompetenza dell’ufficio che ha emesso l’atto
– Mancata sottoscrizione dell’atto da parte di un funzionario legittimato
– Vizio della procura alle liti o del mandato al difensore
– Inammissibilità del ricorso per carenza di motivi o perché proposto fuori termine
Perché le questioni di rito sono importanti?
– Perché se accolte, portano all’annullamento dell’atto per vizio formale, senza bisogno di affrontare il merito
– Perché permettono di bloccare accertamenti o riscossioni viziati anche se il debito è sostanzialmente fondato
– Perché sono spesso più rapide da far valere rispetto alle questioni di merito
– Perché in molti casi l’Agenzia delle Entrate commette errori procedurali che, se individuati, possono ribaltare l’intero procedimento
Come si sollevano le questioni di rito nel processo tributario?
– All’interno del ricorso introduttivo, dove il contribuente deve indicare chiaramente i vizi procedurali dell’atto impugnato
– Con l’assistenza di un avvocato o difensore abilitato, che conosce la normativa processuale tributaria
– In alcuni casi, anche in via preliminare all’udienza, mediante istanza di inammissibilità o nullità dell’atto
– In fase d’appello, se il vizio non era rilevabile in primo grado
Cosa puoi ottenere con una corretta impostazione difensiva sulle questioni di rito?
– L’annullamento totale dell’accertamento, della cartella o dell’atto impugnato
– La chiusura del contenzioso fiscale in tempi più brevi
– L’evitamento di sanzioni e interessi, se l’atto è dichiarato invalido
– La possibilità di non dover entrare nel merito del debito, quando il vizio formale è decisivo
– Il recupero delle spese legali, se la Commissione tributaria accoglie il ricorso per vizi di rito
Attenzione: le questioni di rito sono tecniche, ma fondamentali. Spesso rappresentano la via più rapida ed efficace per annullare un atto fiscale, specialmente se l’Agenzia ha commesso errori nei tempi, nella notifica o nella forma. Ignorarle significa rinunciare a una potente arma difensiva.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario, ricorsi fiscali e difesa del contribuente ti spiega cosa sono le questioni di rito, quando rilevarle e come usarle per bloccare accertamenti e cartelle viziate.
Hai ricevuto un atto fiscale e vuoi sapere se è impugnabile per vizi di rito?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a esaminare l’atto, individuare eventuali errori procedurali e costruire la difesa più efficace per annullarlo.
Introduzione
Nel processo tributario, prima di affrontare il merito di una controversia fiscale è fondamentale verificare la regolarità del rito, ossia il rispetto di tutte le regole procedurali previste dalla legge. Le questioni di rito sono quegli aspetti formali e preliminari che il giudice tributario deve esaminare per assicurarsi che il giudizio possa svolgersi correttamente. Solo se il rito è regolare il giudice potrà poi valutare le questioni di merito (cioè la fondatezza della pretesa tributaria contestata). In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile o il processo verrà estinto, senza entrare nel merito delle ragioni fiscali.
Le questioni di rito comprendono, ad esempio, la competenza del giudice, la tempestività e correttezza dell’impugnazione, la legittimazione delle parti, il rispetto delle formalità di notificazione e deposito degli atti, nonché l’osservanza di eventuali condizioni di procedibilità (come, fino a tempi recenti, la mediazione tributaria obbligatoria). Dal punto di vista del contribuente (in particolare del debitore d’imposta che impugna un atto fiscale), sollevare efficacemente le questioni di rito più comuni può significare ottenere l’annullamento dell’atto impositivo o il rigetto del ricorso dell’ente impositore per motivi procedurali, senza neppure affrontare il merito della pretesa fiscale.
In questa guida avanzata, aggiornata a luglio 2025, esamineremo in dettaglio le principali questioni di rito nel processo tributario italiano, con un linguaggio giuridico ma chiaro, adatto sia a professionisti (avvocati, commercialisti) sia a contribuenti esperti o imprenditori interessati a comprendere i propri diritti processuali. Verranno fornite spiegazioni normative, riferimenti a sentenze recenti delle giurisdizioni superiori, tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte. Tutto dal punto di vista del contribuente, ossia della parte che contesta una pretesa tributaria, con attenzione anche ai casi che coinvolgono tributi locali (IMU, TARI, ecc.) e gli enti impositori locali.
Definizione e inquadramento delle questioni di rito
Che cosa si intende per “questioni di rito”? In generale, nel diritto processuale si distinguono le questioni di rito da quelle di merito. Le questioni di rito sono quelle che attengono al corretto svolgimento processuale: riguardano la forma degli atti, le tempistiche, la competenza del giudice, la legittimazione delle parti e in generale tutte le condizioni che permettono al giudizio di esistere validamente. Se una questione di rito non è rispettata (ad esempio il ricorso è tardivo, o notificato in modo irregolare), il giudice non può entrare nel merito della controversia e deve fermarsi a quel livello, dichiarando il ricorso inammissibile o adottando altro provvedimento processuale che chiude il giudizio. Le questioni di merito, invece, riguardano la fondatezza sostanziale della pretesa fiscale contestata (ad esempio, se l’imposta è dovuta, se la base imponibile è stata calcolata correttamente, ecc.) e vengono esaminate solo se il processo ha superato il vaglio delle questioni di rito.
Va sottolineato che nel processo tributario (così come negli altri processi) vige il principio per cui le questioni pregiudiziali di rito hanno priorità logica: il giudice deve esaminarle prima di ogni altra cosa. Infatti, l’art. 276, co. 2 c.p.c. (applicabile anche al processo tributario in virtù del rinvio generale alle norme del processo civile) stabilisce che “il giudice, ove ritenga di dover definire il giudizio su una questione pregiudiziale di rito, assume a tal fine la decisione relativa”. In altre parole, se emerge un vizio procedurale che impedisce di esaminare il merito, il giudice deciderà la causa su quel punto e non affronterà le ulteriori questioni. Ad esempio, se un ricorso è stato presentato oltre i termini previsti, verrà dichiarato inammissibile per tardività senza analizzare se l’accertamento fiscale sia giusto o sbagliato nel merito.
Differenza con le questioni preliminari di merito: accanto alle questioni di rito (pregiudiziali in senso stretto) esistono anche le questioni preliminari di merito. Si pensi al caso in cui il contribuente eccepisca la prescrizione del credito tributario oppure la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento: si tratta di questioni che non riguardano la procedura in sé, bensì un fatto estintivo o limitativo della pretesa fiscale, che possono definire il giudizio prima di esaminare altri motivi di merito. La giurisprudenza più recente ha chiarito che il cosiddetto criterio della “ragione più liquida” – che consente al giudice di scegliere la soluzione più rapida decidendo una causa sulla base del motivo di più agevole definizione – opera solo tra più questioni di merito, ma non consente di sorvolare su una questione di rito pregiudiziale. In altri termini, un vizio procedurale non può essere ignorato in favore del merito: se c’è una ragione di rito assorbente, il giudice tributario deve decidere su quella (ad es. dichiarare il ricorso inammissibile) e non può preferire di risolvere il caso su un aspetto di merito, anche se quest’ultimo fosse più semplice da valutare.
Riassumendo, le questioni di rito nel processo tributario riguardano il se e il come possiamo discutere di un certo avviso o atto fiscale davanti al giudice. Dal punto di vista pratico, per il contribuente sollevare tempestivamente queste eccezioni procedurali è spesso il primo passo di una strategia difensiva efficace: un vizio di forma o un errore procedurale dell’ente impositore (o del contribuente stesso nella proposizione del ricorso) può infatti portare all’annullamento dell’atto o al rigetto del ricorso, indipendentemente dal merito.
Quadro normativo del processo tributario (profili generali)
Il processo tributario è disciplinato principalmente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (spesso chiamato “Codice del processo tributario”), più volte modificato nel corso degli anni. Tale decreto legislativo – integrato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice di procedura civile – stabilisce le regole fondamentali per introdurre e svolgere il ricorso contro atti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti locali. Negli ultimi anni il processo tributario ha subito una riforma significativa con la Legge 31 agosto 2022, n. 130, volta a potenziarne l’imparzialità ed efficienza, e con successivi decreti attuativi come il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (entrato in vigore a gennaio 2024). Tra le novità rilevanti vi sono il cambio di denominazione delle Commissioni Tributarie in Corti di giustizia tributaria (di primo e secondo grado), l’introduzione (seppur limitata) della prova testimoniale, l’ampliamento delle possibilità di conciliazione e – per quanto qui interessa – l’eliminazione dell’istituto del reclamo-mediazione obbligatoria a partire dal 2024 (di cui diremo più avanti).
Nonostante le innovazioni, i pilastri procedurali del contenzioso tributario sono rimasti invariati. Il giudizio si articola su due gradi di merito: il primo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale, CTP) e l’appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già Commissione Tributaria Regionale, CTR). È poi ammesso il ricorso per Cassazione quale giudizio di legittimità (terzo grado) limitatamente a motivi di diritto. Il contributo unificato è dovuto per proporre ricorso (dal 2011 ha sostituito l’imposta di bollo) e il suo importo dipende dal valore della lite. La tutela tecnica da parte di un difensore abilitato è obbligatoria salvo eccezioni (per le controversie minori, come dettaglieremo). Gli atti introduttivi viaggiano ormai su canale telematico (notifica via PEC e deposito sul sistema informatico della giustizia tributaria), con rarissimi residui cartacei.
È importante ricordare alcune scadenze e termini processuali che influenzano le questioni di rito: il termine per ricorrere è generalmente di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato in primo grado (30 giorni per l’appello), con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno (ai sensi dell’art. 1 L. 742/1969 modificato). Inoltre, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando l’originale o la copia dell’atto introduttivo presso la segreteria della Commissione adita. L’inosservanza di questi termini è sanzionata con la decadenza dal diritto di impugnazione, quindi con l’inammissibilità del ricorso.
Nei paragrafi che seguono esamineremo una ad una le principali questioni di rito che tipicamente si presentano nel processo tributario, evidenziando per ciascuna la normativa di riferimento, gli orientamenti giurisprudenziali più aggiornati e le conseguenze pratiche per il contribuente. Una tabella riassuntiva al termine di questa sezione elenca in modo sintetico le cause più comuni di inammissibilità del ricorso tributario, con i relativi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Principali questioni di rito nel processo tributario
1. Difetto di giurisdizione del giudice tributario
La prima questione di rito, di carattere assoluto, riguarda la giurisdizione: il giudice adito ha il potere di decidere quella controversia? In materia tributaria la risposta è generalmente sì quando si tratta di tributi, ma vi sono zone di confine in cui occorre verificare se la controversia spetti al giudice tributario, a quello ordinario (civile) o eventualmente ad altri (giudice amministrativo o contabile). L’art. 2 del D.Lgs. 546/1992 attribuisce alle Commissioni (ora Corti) tributarie la giurisdizione su “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati”, fatta eccezione solo per le materie espressamente escluse (ad esempio, restano fuori i tributi doganali per cui è previsto il ricorso alle Commissioni unificate delle dogane, alcune materie catastali in sede di volontaria giurisdizione, ecc.). Dal 2002 (riforma operata con L. 448/2001) rientrano nella giurisdizione tributaria anche le controversie sui tributi locali (IMU, TARI, imposta di pubblicità, tosap/cosap, bollo auto regionale, ecc.), per le quali prima sussistevano incertezze. Dunque, se un contribuente impugna un avviso di accertamento comunale (ad es. per l’IMU) o una cartella relativa a un tributo locale, la causa va proposta al giudice tributario e non al TAR o al giudice civile.
Confini con la giurisdizione civile (ordinaria): il principale terreno di confine tra giudice tributario e giudice ordinario riguarda la riscossione coattiva delle imposte. In generale, tutti gli atti antecedenti e fino alla notifica della cartella di pagamento (o di un atto equivalente di intimazione) rientrano nella giurisdizione tributaria, mentre gli atti successivi, tipicamente quelli dell’esecuzione forzata (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi in quanto atti esecutivi), attengono alla giurisdizione del giudice ordinario dell’esecuzione. Questo principio è stato affermato autorevolmente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche sulla scorta di un intervento della Corte Costituzionale. In particolare la Corte Cost. n. 114/2018 ha tracciato la linea di demarcazione: “fino a [alla cartella di pagamento o all’intimazione ad adempiere] la cognizione degli atti dell’amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell’esecuzione”. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 8465/2022 (e precedenti conformi, tra cui SU nn. 7822/2020 e 4846/2021) hanno così enunciato il seguente principio di diritto: rientra sempre nella giurisdizione tributaria ogni contestazione che incide sulla pretesa tributaria (sia sotto il profilo formale dell’atto impositivo, sia sotto il profilo sostanziale del fondamento del tributo) insorta fino alla notificazione della cartella (o, se questa manchi o sia nulla, fino al primo atto esecutivo utile); restano invece riservate alla giurisdizione ordinaria le questioni che attengono esclusivamente alla legittimità formale dell’atto dell’esecuzione forzata in sé, nonché i fatti incidenti sul rapporto esecutivo sopravvenuti dopo la notifica della cartella.
In applicazione di tale principio, ad esempio, una eccezione di prescrizione del debito tributario maturata prima della notifica della cartella esattoriale (o derivante da una cartella mai notificata) dovrà essere decisa dal giudice tributario, mentre un vizio formale del pignoramento (es. errore nel precetto contenuto nell’atto di pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73) sarà di competenza del giudice ordinario dell’esecuzione. Le controversie su atti come il pignoramento esattoriale diretto – ove il contribuente contesti sia la mancata notifica delle cartelle che la prescrizione del credito – possono presentare difficoltà di inquadramento, ma la Cassazione ha chiarito nel 2025 che occorre guardare al petitum sostanziale: se la contestazione investe la pretesa tributaria in sé (es. si nega il debito perché il credito è prescritto o perché la cartella non è mai stata notificata), la giurisdizione è tributaria; se invece si contesta solo la regolarità formale dell’atto esecutivo, la giurisdizione è ordinaria. In altre parole, “è la natura della domanda a determinare quale giudice sia competente”: contestare il fondamento del credito tributario (per ragioni sostanziali o vizi notificatori a monte) spetta al giudice tributario, mentre questioni meramente esecutive spettano al giudice civile.
Oltre al confine con l’ambito esecutivo, altre situazioni di difetto di giurisdizione possono sorgere quando la controversia non ha natura tributaria. Ad esempio, se per errore si propone davanti al giudice tributario un ricorso riguardante una sanzione amministrativa non tributaria (come una multa stradale) o un provvedimento tipicamente di competenza del giudice amministrativo (come una delibera comunale su tariffe non qualificabili come tributo), il giudice tributario dichiarerà il difetto di giurisdizione, in quanto l’oggetto non rientra tra quelli a lui affidati. Similmente, questioni attinenti a entrate patrimoniali dello Stato o degli enti pubblici (che non siano tributi in senso tecnico) non possono essere trattate dal giudice tributario; un esempio classico è il contributo previdenziale: i contributi INPS non sono “tributi” e le relative controversie appartengono al giudice ordinario (sebbene esistano casi limite, ad es. il contributo unificato stesso è un tributo ma è disciplinato in sede propria). Il contribuente deve dunque fare attenzione ad individuare il giudice giusto: se la causa è promossa innanzi a un giudice privo di giurisdizione, il processo si chiuderà senza decisione di merito.
Tecnicamente, il difetto di giurisdizione può essere rilevato in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio (art. 3, co. 1, D.Lgs. 546/92). Se il giudice tributario si accorge di non avere giurisdizione, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. In taluni casi le parti possono attivare lo strumento del regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) davanti alla Cassazione per far dirimere il dubbio prima che il merito venga affrontato. Ad esempio, quando vi è conflitto tra giudici (es. sia il giudice civile che quello tributario si sono dichiarati incompetenti, come nel caso deciso dalle SU n. 2098/2025 che ha risolto un conflitto negativo di giurisdizione tra CTP e Giudice di Pace in tema di pignoramento esattoriale). È bene evidenziare che, qualora il ricorso tributario sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, il contribuente potrà riproporre l’azione davanti al giudice competente (se non precluso da termini decadenziali nel frattempo maturati).
Enti locali: le questioni di giurisdizione coinvolgono anche i tributi locali. Dal 2002, come detto, tutti i tributi locali rientrano nella giurisdizione tributaria, quindi non va adita la giustizia amministrativa neppure quando si impugnano regolamenti comunali di natura tributaria o atti di accertamento emessi dal Comune. Un esempio interessante riguarda l’ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 639/1910: è uno strumento di riscossione coattiva alternativo alla cartella esattoriale che alcuni enti locali utilizzano per i tributi di propria competenza (soprattutto prima della piena operatività di Agenzia Entrate-Riscossione). La giurisprudenza considera l’ingiunzione fiscale un atto impugnabile davanti al giudice tributario, in quanto equiparabile, per effetti, alla cartella di pagamento. Di conseguenza, se un Comune notifica un’ingiunzione per TARI o IMU, il contribuente dovrà impugnarla in Commissione Tributaria, non dal giudice ordinario, e potrà far valere sia vizi formali dell’ingiunzione sia questioni sostanziali sul tributo sottostante. Anche in questi casi vale il discrimine sopra illustrato: una contestazione sul quantum o sull’an debeatur del tributo rientra nella giurisdizione tributaria; una eventuale contestazione sui soli atti esecutivi successivi (es. pignoramento presso terzi iniziato dal Comune sulla base di quell’ingiunzione) spetterà al giudice ordinario.
2. Incompetenza territoriale o funzionale (sede del giudice)
Accertata la giurisdizione, il secondo profilo pregiudiziale riguarda la competenza del giudice tributario adito. In campo tributario la competenza è principalmente territoriale (legata al luogo dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato o al domicilio fiscale del contribuente, a seconda dei casi). Fino al 2022 era l’art. 4 del D.Lgs. 546/92 a fissare i criteri di riparto territoriale, ma tale articolo è stato abrogato dalla riforma del 2022; attualmente la regola generale è che il ricorso di primo grado si propone davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per il territorio in cui ha sede l’ente impositore che ha emanato l’atto (o altro criterio previsto da norme speciali). In pratica, corrisponde quasi sempre alla Commissione Tributaria Provinciale del luogo dell’ufficio finanziario o del concessionario della riscossione interessato. Per l’appello, la competenza è fissata dalla legge nel senso che l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado va proposta alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (ex CTR) nella cui circoscrizione rientra la Commissione di primo grado.
L’eventuale errore sul giudice competente può dar luogo a una dichiarazione di inammissibilità oppure a una semplice translatio del giudizio, a seconda delle situazioni. Il D.Lgs. 546/92, all’art. 5, prevede che l’incompetenza territoriale debba essere eccepita o rilevata non oltre la prima udienza; in caso contrario, il giudice “errato” resta competente (c.d. proroga della competenza). Tuttavia, se il ricorso viene presentato alla Commissione sbagliata (ad esempio, ricorso indirizzato alla CTP di Milano quando era competente la CTP di Roma), la prassi è che quel giudice dichiari il ricorso inammissibile per incompetenza. Alcune pronunce, però, ammettono che il fascicolo possa essere trasmesso d’ufficio al giudice territorialmente competente in alternativa alla declaratoria d’inammissibilità, nell’ottica di favorire la trattazione nel merito. Una recente ordinanza della Cassazione (Cass. trib. n. 6864/2024) ha statuito che un ricorso inviato a una CTP territorialmente incompetente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, salvo che quel giudice avesse disposto il trasferimento alla sede competente. In sostanza, l’errore di competenza territoriale è un vizio di costituzione del rapporto processuale: teoricamente sanabile con il trasferimento, ma in concreto spesso risolto con l’inammissibilità se l’errore è colto tardivamente.
Altra ipotesi è l’incompetenza per valore: nel processo tributario non esiste un riparto di competenza per valore della causa – a differenza delle cause civili dove esistono giudici diversi (Giudice di Pace, Tribunale) in base al valore economico. Qui il valore serve solo per altre finalità (ad esempio per stabilire se era obbligatorio il tentativo di mediazione, o per determinare l’importo del contributo unificato). Dunque il contribuente non deve preoccuparsi di questo profilo: qualsiasi importo sia in contestazione, la competenza rimane delle Commissioni tributarie.
Da ricordare anche la competenza per materia all’interno delle Commissioni: di regola tutte le controversie tributarie seguono il rito ordinario, ma vi sono collegi specializzati per determinate materie (ad es. commissioni di primo grado con competenza sulle sole controversie catastali in alcune regioni). Questi aspetti interni raramente coinvolgono il contribuente, in quanto è l’ufficio di segreteria della Commissione che eventualmente assegna al collegio competente per materia.
In pratica, per evitare problemi: il ricorso va sempre indirizzato e notificato alla Commissione indicata nell’atto impugnato stesso. Infatti, ogni atto fiscale impugnabile deve per legge contenere l’indicazione del giudice competente e del termine per impugnare (art. 19, co. 2 D.Lgs. 546/92). Se il contribuente segue queste indicazioni, non incorrerà in errori di competenza. Un eventuale errore nell’indicazione del giudice da parte dell’ente nell’atto impugnato non dovrebbe pregiudicare il diritto di difesa: in tal caso, il ricorso proposto al giudice erroneamente indicato andrebbe poi riassunto davanti a quello corretto senza decadere (principio del legittimo affidamento). Ad ogni modo, l’art. 6, co. 2, D.Lgs. 546/92 prevede che le Commissioni tributarie provinciali possano dichiarare d’ufficio la propria incompetenza e indicare il giudice competente: le parti hanno 60 giorni per riassumere la causa innanzi a quest’ultimo, conservando gli effetti della domanda iniziale.
3. Atti impugnabili e interesse ad agire (oggetto del giudizio)
Una questione cruciale di rito è quella relativa all’oggetto del ricorso tributario, ossia quali atti e provvedimenti possono essere impugnati davanti al giudice tributario. Il legislatore ha stabilito un principio di “tipicità” degli atti impugnabili: l’art. 19 D.Lgs. 546/92 elenca tassativamente quali sono gli atti contro cui è ammesso il ricorso. Atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente (art. 19, co. 3). Inoltre, ciascun atto impugnabile può essere contestato “solo per vizi propri” – il che significa che, se si intende far valere un vizio di un atto precedente non più impugnabile, occorre impugnare l’atto successivo lamentando il vizio riflesso (es: impugnando la cartella si può eccepire la nullità dell’atto presupposto non notificato).
Ecco un elenco sintetico dei principali atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/92:
- Avviso di accertamento del tributo (art. 19, co.1, lett. a): l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate o altro ente impositore accerta un maggior tributo o una violazione fiscale, tipicamente notificando al contribuente un’imposta non dichiarata o una rettifica alla dichiarazione.
- Avviso di liquidazione (lett. b): atto con cui si liquida un tributo già dichiarato o dovuto (es. imposte di registro, successione, dove l’ufficio ricalcola l’imposta).
- Provvedimento di irrogazione sanzioni (lett. c): atto con cui si comminano sanzioni amministrative tributarie (es. atto di contestazione divenuto definitivo, ordinanza-ingiunzione tributaria).
- Ruolo e cartella di pagamento (lett. d): la cartella esattoriale emessa dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) a seguito dell’iscrizione a ruolo, con cui si richiede il pagamento coattivo di imposte, sanzioni e interessi. È l’atto esecutivo per eccellenza in materia tributaria.
- Avviso di mora (lett. e): la comunicazione (oggi sempre più rara in quanto sostituita dall’intimazione) con cui si ingiunge il pagamento di somme iscritte a ruolo già scadute, maggiorate di interessi di mora.
- Iscrizione di ipoteca (lett. e-bis): il provvedimento con cui l’Agente della Riscossione iscrive ipoteca sui beni immobili del debitore ai sensi dell’art. 77 DPR 602/73, a garanzia di crediti tributari.
- Fermo amministrativo di beni mobili registrati (lett. e-ter): il c.d. fermo auto, ossia il provvedimento ex art. 86 DPR 602/73 con cui si blocca la circolazione di un veicolo del debitore finché non paga il dovuto.
- Provvedimenti catastali (lett. f): es. atti di attribuzione o modifica di rendita catastale, riclassamenti, determinazioni di classi e categorie di immobili, ecc., emessi dall’Agenzia del Territorio (ora incorporata in Agenzia Entrate).
- Rifiuto di restituzione di tributi o accessori (lett. g): il diniego espresso o tacito di rimborso di un tributo indebitamente pagato, oppure il rigetto di istanze di sgravio. (Esempio: diniego di rimborso IVA, silenzio-rifiuto sull’istanza di restituzione di un’imposta dichiarata non dovuta, ecc.).
- Diniego o revoca di agevolazioni (lett. h): provvedimenti che negano benefici fiscali (es. esenzioni, crediti d’imposta) o la decadenza da essi, nonché il rigetto di istanze di definizione agevolata (ad es. diniego di condono o di rottamazione cartelle).
- Rigetto di istanza di accordo preventivo o procedura amichevole internazionale (lett. h-bis): atti che negano il raggiungimento di accordi preventivi in materia di doppia imposizione o transfer pricing, introdotti nel novero dei provvedimenti impugnabili di recente per adeguarsi al diritto UE.
- Ogni altro atto impugnabile per legge (lett. i): una clausola di chiusura, per cui se una norma di legge prevede espressamente l’impugnabilità autonoma di un atto in sede tributaria, tale atto rientra nella giurisdizione tributaria. (Ad esempio: l’ingiunzione fiscale locale può considerarsi ricompresa qui per interpretazione; un altro caso è la cartella di pagamento per contributi previdenziali affidata erroneamente all’Agente Riscossione – la Cassazione ha ritenuto impugnabile la cartella anche per la parte di crediti non tributari se vengono fatti valere vizi formali unitari).
Di converso, non sono impugnabili atti diversi da quelli sopra elencati, come ad esempio: semplici comunicazioni o avvisi bonari che non contengono una pretesa tributaria definita, lettere di compliance o inviti al pagamento non aventi natura provvedimentale, atti interni all’amministrazione (minuti, relazioni, ecc.), ruoli non ancora resi esecutivi, provvedimenti che incidono su diritti non tributari (ad es. il rifiuto di rateazione di una cartella in sé non è considerato atto impugnabile, poiché non incide sull’an o sul quantum del tributo ma solo sulle modalità di pagamento). In generale, il ricorso è ammissibile solo se c’è un atto impositivo lesivo in senso diretto: il principio di lesività implica che non si può ricorrere per questioni teoriche o contro meri atti preparatori. Ad esempio, un avviso bonario (comunicazione di irregolarità) non è impugnabile perché è solo un invito a pagare con sanzioni ridotte, non un provvedimento definitivo; allo stesso modo, un sollecito di pagamento o un estratto di ruolo (semplice elenco di cartelle dal database) non sarebbero atti autonomamente impugnabili. Tuttavia, la giurisprudenza ha ammesso in via di fatto che quando il contribuente viene a conoscenza di una cartella mai notificata attraverso l’estratto di ruolo, possa impugnare quest’ultimo al fine di far valere la nullità della cartella non notificata. Ciò per evitare che l’assenza di notifica precluda ogni tutela (SU n. 19704/2015 e succ.). In tali casi particolari si considera l’estratto come strumento per far valere i vizi propri dell’atto impositivo sottostante.
Oltre alla tipologia di atto, è necessario anche un interesse concreto e attuale ad agire (art. 100 c.p.c., in quanto compatibile). Il ricorso non può essere utilizzato per questioni astratte o ipotetiche: occorre che l’atto impugnato abbia prodotto o stia per produrre una lesione nei confronti del ricorrente. Ad esempio, se l’ufficio inviasse per errore un avviso intestato a un soggetto estraneo che non c’entra nulla, tale soggetto non avrebbe interesse ad impugnare (potrebbe limitarsi a segnalare l’errore all’ufficio). Se il ricorso è meramente teorico, o manca una lesione attuale, il giudice lo dichiarerà inammissibile per carenza di interesse ad agire. Questa evenienza è rara nei fatti, perché di solito l’atto fiscale comporta sempre una pretesa patrimoniale. Può però capitare, ad esempio, in caso di atto annullato in autotutela dall’ente impositore dopo che il contribuente ha presentato ricorso: a quel punto la materia del contendere è cessata e non vi è più interesse a proseguire il giudizio (si dichiara l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, più che inammissibilità, ma il concetto di fondo è il medesimo: senza interesse non c’è processo). Un altro caso: ricorso contro un atto non definitivo (es. un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che per legge non è direttamente impugnabile) può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, dato che quell’atto non ha ancora prodotto effetti lesivi diretti. In sintesi, non tutto ciò che l’Amministrazione finanziaria invia è impugnabile in giudizio: se non rientra nell’elenco di legge o non lede immediatamente il contribuente, un ricorso sarebbe prematuro e verrà respinto.
Dal punto di vista pratico per il contribuente, è fondamentale assicurarsi che l’oggetto del ricorso rientri tra gli atti impugnabili. Se si ha dubbio, è bene consultare un esperto o verificare la base normativa. Proporre un ricorso contro un atto non impugnabile comporta solo perdita di tempo e denaro, poiché l’ente eccepirà l’inammissibilità e il giudice la confermerà. Ad esempio, contestare un mero sollecito di pagamento anziché attendere la cartella esattoriale formale non porterà risultato, se non forse ritardare di poco la procedura. Meglio, in quel caso, attendere l’atto successivo impugnabile (la cartella o l’intimazione) e poi ricorrere. L’unica eccezione è, come accennato, quando l’atto successivo non è mai stato notificato: in tal caso, scoprendone l’esistenza tramite altri documenti, il contribuente deve poter agire subito (come confermato da Cass. SU 19704/2015 e seguenti sulla impugnabilità del ruolo o estratto di ruolo come escamotage per far valere la mancata notifica della cartella).
4. Termini di impugnazione e decadenza dal ricorso
La tempestività del ricorso è un aspetto procedurale fondamentale: il contribuente deve rispettare precisi termini per proporre impugnazione, pena la decadenza dal diritto di far valere le proprie ragioni. In materia tributaria i termini sono perentori e relativamente brevi, stabiliti dall’art. 21 del D.Lgs. 546/92. Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnabile. Ciò vale per la stragrande maggioranza dei casi: ad esempio, avviso di accertamento notificato il 1° febbraio, il ricorso va notificato entro (e non oltre) il 2 aprile dello stesso anno (salvo sospensione feriale ad agosto, che allungherebbe il termine di 31 giorni se il periodo cade in mezzo). Un giorno di ritardo rende il ricorso irrimediabilmente tardivo. La Cassazione ha ripetutamente affermato che il termine di 60 giorni è perentorio e va applicato con rigore assoluto, senza possibilità di estensioni analogiche oltre i casi previsti dalla legge. Ad esempio, se un contribuente presenta il ricorso il 61° giorno, questo sarà dichiarato inammissibile d’ufficio dal giudice, a nulla rilevando che magari il ritardo sia stato minimo o che le motivazioni nel merito sarebbero state fondate.
L’art. 21 prevede anche alcune situazioni particolari: per il rifiuto tacito di rimborso di tributi (quando il silenzio dell’ufficio su un’istanza di rimborso si protrae per 90 giorni, formando un silenzio-rifiuto) il contribuente ha 90 giorni di tempo per impugnare il silenzio, decorrenti dalla scadenza del periodo di inerzia dell’ufficio. Altre fattispecie speciali possono prevedere termini diversi, ma sono eccezioni (ad esempio, alcuni atti in materia doganale). Per l’appello la legge indica un termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Se la sentenza di CTP viene notificata il 1° ottobre, l’appello va notificato entro il 31 ottobre. Anche qui vale la sospensione feriale se il termine cade in agosto. In assenza di notifica della sentenza, invece, il termine “lungo” è di sei mesi (art. 327 c.p.c. come modificato).
A completare il quadro, vi è il termine per la costituzione in giudizio: entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il ricorrente deve depositare il fascicolo presso la segreteria della Commissione adita (oggi tramite upload telematico). Questo adempimento è condizione perché il giudizio prosegua: se manca, il ricorso pur notificato non risulta perfezionato nel processo. L’art. 22 del D.Lgs. 546/92 parla di “il ricorso si intende rinunciato” se non viene depositato entro 30 giorni, ma la giurisprudenza lo assimila a un vizio che comporta inammissibilità o improcedibilità. In sostanza: notifica + deposito sono entrambi necessari. Se uno dei due manca (o è oltre il termine), il giudice dichiarerà il ricorso inammissibile per difetto di costituzione. Ad esempio, la CTP di Cuneo ha dichiarato inammissibile un ricorso perché la parte, pur avendo notificato il ricorso contro un silenzio-rifiuto, non lo aveva poi depositato entro i 30 giorni. La Cassazione conferma che si tratta di un onere perentorio.
Ci sono però situazioni che possono sospendere o prorogare i termini: la già citata sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno (durante la quale i termini processuali sono congelati); inoltre, lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) all’art. 6, co. 3 prevede che se un atto impositivo è notificato nei 60 giorni precedenti il 15 agosto, i termini per ricorrere sono sospesi dal 1° al 31 agosto (di fatto è lo stesso concetto generale). L’art. 6, co. 1 prevede anche che gli adempimenti tributari e processuali che scadono di sabato o domenica slittano al primo giorno feriale successivo. Inoltre, l’art. 4, co. 2, L. 212/2000 stabilisce che “in caso di eventi eccezionali individuati dalla legge” (forza maggiore, calamità naturali, ecc.) possono essere sospesi i termini di impugnazione: ad esempio, durante l’emergenza Covid nel 2020 vi fu la sospensione dei termini processuali per alcune settimane. Ma al di là di queste ipotesi straordinarie, in circostanze normali la regola è: 60 giorni secchi (o 30 in appello) dal giorno dopo la notifica dell’atto.
Una prassi operativa importante: per provare il rispetto del termine, il contribuente deve conservare la prova della data di notifica dell’atto impugnato (es. la busta raccomandata o la relata di notifica della cartella) e ovviamente la prova della data di invio del ricorso (se via PEC, la ricevuta di accettazione e consegna; se cartaceo, la ricevuta postale). Il termine decorre dalla data in cui l’atto è stato ricevuto dal contribuente, non dalla data dell’atto stesso. Se l’atto non viene notificato (o la notifica è nulla), in teoria il termine non inizia a decorre – ciò consente al contribuente di impugnarlo senza limiti di tempo appena ne venga a conoscenza (cfr. supra sul caso di cartella mai notificata scoperta dopo anni: la si può contestare perché la notifica nulla non ha fatto decorrere termini).
Ricordiamo inoltre che, con la digitalizzazione, la data valida è quella di consegna nella casella PEC: se ad esempio un avviso di accertamento viene notificato via PEC il 10 gennaio, i 60 giorni decorrono dal 11 gennaio. Se il contribuente non legge la PEC o la casella risulta piena, la notifica può comunque perfezionarsi per compiuta giacenza, e il termine decorrerà lo stesso. Quindi è fondamentale controllare regolarmente la PEC e mantenere attiva la casella.
Conseguenze della tardività: un ricorso presentato oltre il termine è colpito da inammissibilità insanabile. Il giudice lo rileva anche d’ufficio (non è richiesta eccezione di parte) e lo dichiara con sentenza. Il contribuente perde così la possibilità di far valere quella impugnazione. Potrà eventualmente richiedere un rimedio straordinario come la remissione in termini solo in casi eccezionali (ma nel processo tributario non è espressamente prevista) oppure confidare nell’autotutela dell’ente (che raramente interverrà se sa che il ricorso è tardivo). Di norma, quindi, è essenziale rispettare i 60 giorni. In caso di dubbio sulla scadenza, meglio depositare qualche giorno in anticipo piuttosto che rischiare oltre il termine.
Una nota: se un contribuente ha comunque presentato ricorso tardivo, non gli conviene desistere spontaneamente; può attendere la decisione di inammissibilità e poi eventualmente proporre opposizione per revocazione o impugnare per Cassazione solo se vi fossero errori scusabili (sono ipotesi estreme, come cause di forza maggiore non considerate, ecc.). Ma realisticamente, la tardività è difficilmente sanabile. La Cassazione ha affermato che “un ricorso notificato anche di un solo giorno oltre la scadenza va dichiarato inammissibile d’ufficio”, ribadendo il carattere perentorio del termine.
Nella Tabella 2 più avanti sono riepilogati i termini di impugnazione del processo tributario per i vari gradi.
5. Modalità di notifica del ricorso e costituzione in giudizio
Un’altra questione formale fondamentale è la corretta notificazione del ricorso al resistente (ente impositore o concessionario della riscossione) e la successiva costituzione del ricorrente presso la Commissione. Questi passaggi, pur essendo successivi al perfezionamento del ricorso, rientrano tra le condizioni di procedibilità: errori nella notifica o nella costituzione possono condurre all’inammissibilità.
Dal 2018 il processo tributario telematico è divenuto la regola generale. L’art. 16-bis del D.Lgs. 546/92, introdotto dal D.L. 119/2018, impone che la notifica degli atti processuali tributari avvenga esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) per i soggetti obbligati a stare in giudizio con difensore tecnico. In pratica: se il contribuente deve farsi assistere da un avvocato o altro difensore abilitato (vedi oltre il capitolo sull’assistenza tecnica), la notifica deve essere fatta via PEC dall’indirizzo del difensore a un indirizzo PEC dell’ufficio destinatario tratto dagli appositi registri pubblici. La notifica in formato cartaceo a mezzo Ufficiale giudiziario o raccomandata A/R non è più ammessa in questi casi e, se effettuata, è considerata inesistente o nulla insanabile. La Cassazione ha confermato questo orientamento: con l’ordinanza n. 4815/2025 ha ribadito che un ricorso notificato in forma cartacea, anziché via PEC come richiesto dalla legge, è invalido e privo di effetti, quindi da dichiarare inammissibile anche se di fatto è arrivato a destinazione. Il principio è che la normativa sul PTT (Processo Tributario Telematico) non prevede alcuna sanatoria per la notifica effettuata con modalità diverse dalla PEC: l’atto resta come “mai notificato”.
Fino al 2023 resisteva un’eccezione: se la controversia aveva valore fino a €3.000 e il contribuente si difendeva personalmente (senza difensore tecnico, cosa consentita entro tale limite, come vedremo), era ammessa la notifica cartacea. Anche l’art. 16-bis prevedeva inizialmente questa eccezione. Tuttavia, con la riforma del 2022-2023, l’obbligo del digitale è generalizzato: dal 1° settembre 2024 tutti devono notificare e depositare telematicamente, senza eccezioni di valore. Pertanto, pure il piccolo contribuente senza difensore dovrà munirsi di PEC per notificare, o incaricare un difensore per farlo. Questo uniforma il rito e presumibilmente elimina gli ultimi dubbi sulla validità delle notifiche non telematiche.
Quanto alla costituzione in giudizio, l’art. 22 D.Lgs. 546/92 impone al ricorrente di costituirsi entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, depositando copia del ricorso notificato (con prova delle avvenute notifiche) presso la segreteria della Commissione competente. Con il processo telematico, tale deposito avviene tramite upload sulla piattaforma informatica (SIGIT). La norma prevede espressamente che il deposito può avvenire anche contestualmente alla notifica (nel PTT di solito avviene così: si notifica via PEC e subito dopo si deposita telematicamente il ricorso con marca temporale). Se però il deposito avviene oltre 30 giorni dalla notifica, il ricorso si intende rinunciato (art. 22, co. 1). La giurisprudenza equipara questa situazione all’inammissibilità del ricorso per mancata costituzione. Dunque, notificare e non depositare equivale a non aver proposto validamente il ricorso. Parimenti, depositare ma senza aver notificato sarebbe un atto inesistente (non c’è contraddittorio): un ricorso del genere verrà dichiarato inammissibile per difetto di instaurazione del contraddittorio, come violazione dell’art. 16-bis e 20 D.Lgs. 546/92.
Da segnalare una sottile distinzione: se la notifica è avvenuta ma con qualche vizio (ad esempio invio PEC all’indirizzo sbagliato, o PEC non andata a buon fine), il vizio di notifica potrebbe essere sanato dalla costituzione della controparte (ente impositore) che si presenta in giudizio senza eccepirlo. In base ai principi generali, la costituzione del convenuto sana i vizi di notificazione dell’atto introduttivo, tranne i casi di notificazione inesistente. La Cassazione di recente (ord. n. 585/2025) ha precisato che una notifica via PEC non perfezionata correttamente andrebbe considerata nulla ma sanabile se l’ufficio intimato si è comunque costituito in giudizio, dimostrando di aver avuto conoscenza dell’atto. Quindi, se l’ente riceve magari per conoscenza il ricorso cartaceo e si costituisce senza contestare, potrebbe in teoria sanare il vizio. Ma attenzione: questa possibilità di sanatoria non si applica se la notifica è considerata inesistente (completamente mancante o assolutamente fuori dalle forme previste). Nel dubbio, è sempre rischioso confidare nella costituzione avversaria: il contribuente deve fare il possibile per notificare regolarmente. Se proprio commette un errore (es. invia alla PEC sbagliata), conviene rifare una rinnovazione della notifica entro i termini, in modo da non lasciare il contenzioso su basi incerte.
Ricordiamo poi che la notifica deve avvenire entro i 60 giorni di decadenza: notificare oltre il termine rende il ricorso tardivo (la data di perfezionamento per il notificante – PEC inviata – fa fede). Inoltre, è opportuno notificare con congruo anticipo, perché se la consegna PEC fallisce e il contribuente scopre il mancato recapito oltre i termini, non potrà più rimediare. Nel PTT la ricevuta di avvenuta consegna è l’elemento essenziale: se manca quella, la notifica non è compiuta. Ad esempio, se l’avvocato invia la PEC il sessantesimo giorno ma poi riceve un avviso di mancata consegna per casella piena dell’ufficio, si troverà fuori termine senza colpa ma senza notifica valida. Cassazione e CTR sono state severe: hanno ritenuto che “non esiste sanatoria per una notifica irregolare del ricorso”, e se la notifica non è provata il ricorso è come non presentato. L’unico spiraglio in queste situazioni è se l’ufficio convenuto si costituisce ugualmente: allora, come detto, può considerarsi sanato il vizio (purché la notifica non fosse del tutto inesistente).
In sintesi, gli adempimenti chiave per introdurre correttamente il giudizio tributario sono: notifica valida del ricorso (preferibilmente tramite PEC, salvo i rarissimi casi residui di esonero) e deposito tempestivo presso la Commissione. Se entrambi sono rispettati, il processo è regolarmente instaurato. Qualsiasi errore in uno di essi genera una questione di rito su cui il giudice potrà chiudere il caso senza esaminarne il merito (inammissibilità del ricorso).
6. Contenuto obbligatorio del ricorso introduttivo
Il ricorso tributario, al pari di qualsiasi atto processuale, deve contenere alcuni requisiti formali essenziali previsti dalla legge. L’art. 18, comma 2, D.Lgs. 546/92 elenca in particolare:
a) l’indicazione della Corte di giustizia tributaria (Commissione) competente;
b) le generalità del ricorrente e del suo eventuale difensore, con i rispettivi codici fiscali e l’indirizzo PEC (questi ultimi due dati, per espressa previsione di legge, non sono più causa di inammissibilità in caso di omissione, essendo richiesti ma non essenziali);
c) l’indicazione dell’ufficio o ente contro cui si ricorre (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di …, Comune di … settore tributi, Agenzia Entrate-Riscossione ufficio territoriale di …, ecc.);
d) l’atto impugnato e l’oggetto della domanda (ossia che cosa si chiede al giudice: ad es. l’annullamento totale o parziale dell’atto, o altra pronuncia);
e) i motivi del ricorso, cioè le circostanze di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda la contestazione;
f) la sottoscrizione del ricorrente o del difensore che lo rappresenta.
La mancanza (o l’assoluta incertezza) di anche uno solo di questi elementi essenziali comporta, per legge, la inammissibilità del ricorso. Vediamo qualche dettaglio:
- Se manca l’indicazione del giudice (lett. a), ad esempio un ricorso che non precisi quale Commissione è adita, si rischia l’inammissibilità. Nella pratica, però, questo vizio è raro e spesso superabile: se dal contesto si capisce qual è il giudice (es. dal fatto che il ricorso è stato depositato presso quella Commissione), l’omissione può essere considerata sanata di fatto. Ma è buona norma indicare sempre con precisione la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di [Provincia] nell’epigrafe.
- Per quanto riguarda le parti in causa (lett. b e c), è fondamentale identificare chiaramente il ricorrente (nome, cognome/denominazione, codice fiscale) e il soggetto convenuto (esattamente l’ufficio che ha emanato l’atto: ad esempio “Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano”, oppure “Comune di Roma – Dipartimento Risorse Economiche – Ufficio Tributi”, o “Agenzia delle Entrate-Riscossione, sportello di Napoli” a seconda di chi ha emesso l’atto impugnato). Se il ricorso è rivolto a un ufficio completamente sbagliato (es. impugnare contro Agenzia Entrate un atto che in realtà proviene dal Comune, o viceversa), allora c’è un difetto di contraddittorio che può condurre all’inammissibilità. Anche l’omessa indicazione del codice fiscale e dell’indirizzo PEC del difensore non genera più inammissibilità per espressa previsione normativa (art. 18, co. 4), ma resta un’irregolarità da correggere. Se invece manca proprio il nome del ricorrente o del convenuto, il ricorso è praticamente inenarrabile e verrà dichiarato nullo/inammissibile perché “permane incertezza assoluta sulle parti”. Per fortuna, tali errori grossolani sono poco comuni quando si usa un modello standard.
- L’indicazione dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda (lett. d) è forse il punto più critico. Il ricorso deve specificare con esattezza quale atto si intende far annullare (es: “Avviso di Accertamento n. TX12345 notificato il 10/01/2025 dall’Agenzia Entrate ufficio X, relativo a IRPEF 2020”) e cosa si chiede (generalmente l’annullamento integrale, o l’annullamento parziale se si contesta solo un aspetto). Se su questo punto c’è confusione, il giudice potrebbe non capire cosa esattamente contestate e dichiarare il ricorso inammissibile per incertezza sull’oggetto. Cassazione e corti di merito hanno affermato che il ricorso è inammissibile “allorché sussista incertezza assoluta sull’oggetto della domanda”. Ad esempio, un ricorso che si limiti a dire “impugno il provvedimento impositivo perché illegittimo” senza neanche specificare quale provvedimento, oppure senza chiarire se si chiede annullamento o altra tutela, sarà considerato carente. È importante essere chiari: indicare gli estremi dell’atto (numero, data, tipo di tributo, importo, ecc.) e formulare una domanda precisa (“chiedo l’annullamento dell’avviso di accertamento”, eventualmente con specificazione delle parti illegittime se non si contesta tutto).
- I motivi del ricorso (lett. e) devono emergere dal testo: non è necessario scrivere un trattato, ma occorre fornire “i motivi di fatto e di diritto” alla base del ricorso. Anche qui, una totale mancanza di motivazione rende il ricorso inammissibile, perché si associa all’incertezza sull’oggetto. Ad esempio, presentare un ricorso che si limita a depositare l’atto impugnato senza alcuna spiegazione o con frasi generiche (“è ingiusto e illegittimo”) equivale a non indicare motivi. Il giudice non può integrarle d’ufficio, dunque dichiarerà l’inammissibilità. Va però detto che non è richiesta una particolare forma: “il ricorso non va pre-motivato” in modo formale come gli atti del processo civile, è ammessa una certa sinteticità. Ma un minimo di spiegazione va data: es. “Motivi: 1) Violazione dell’art. X, per difetto di motivazione dell’atto; 2) Erronea applicazione dell’aliquota IVA, doveva essere del 4% invece del 10%”, ecc. Anche semplicemente allegare l’istanza di accertamento con adesione presentata (che contiene le ragioni del contribuente) è stato ritenuto sufficiente come motivazione in alcuni casi. Tuttavia, è meglio esporre in modo chiaro e intellegibile ciò che si contesta e perché. Un ricorso con motivi estremamente vaghi o del tutto assenti sarà rigettato in limine.
- Sottoscrizione del ricorso: è un requisito formale essenziale (art. 18, co. 3 e 4). Il ricorso va firmato a) dal difensore abilitato che lo propone, se il contribuente deve stare in giudizio con difensore; oppure b) dal contribuente stesso, se si tratta di causa di modesto valore in cui è ammessa l’autodifesa (v. oltre). La mancanza della firma digitale (in caso di deposito telematico) o autografa (in caso cartaceo) del soggetto che doveva sottoscrivere rende l’atto nullo. In particolare, la norma dice che “il ricorso non sottoscritto […] non è valido”, quindi è un caso di nullità insanabile immediata. La giurisprudenza conferma che, diversamente dalla procura alle liti (dove c’è tolleranza, come si dirà), la mancanza della firma in calce al ricorso è causa di inammissibilità non emendabile. Ad esempio, un avvocato che predispone il ricorso ma omette di firmarlo digitalmente prima dell’invio PEC compie un errore fatale: quel ricorso è come inesistente. La Commissione lo dichiarerà inammissibile, senza possibilità di aggiustarlo dopo. Lo stesso se un contribuente in proprio invia un ricorso senza la propria firma. Anche qui la tecnologia può trarre in inganno: caricare su SIGIT un PDF non firmato digitalmente equivale a non aver sottoscritto l’atto.
In sintesi: un buon ricorso deve avere tutti i dati identificativi richiesti, un oggetto chiaro, motivi enunciati e la firma regolare. La maggior parte di questi requisiti è di buon senso, ma vale la pena fare un controllo accurato prima della notifica. Se il giudice riscontra uno di questi vizi essenziali, dichiarerà il ricorso inammissibile “senza esaminarlo nel merito”.
Da notare che alcuni vizi formali del ricorso possono essere sanati se non pregiudicano la comprensione dell’atto. Ad esempio, la mancata indicazione del codice fiscale o della PEC non comporta inammissibilità per disposizione di legge, e il giudice inviterà eventualmente a integrare quei dati. Anche l’errata indicazione del resistente (es. nominare un ufficio in luogo di un altro) potrebbe essere sanata se l’ufficio effettivamente competente si costituisce in giudizio senza contestare (così da correggere l’errore di destinatario). Ma in generale, è pericoloso contare sulle sanatorie: conviene “blindare” il ricorso in modo che sia completo in ogni sua parte dall’inizio.
7. Assistenza tecnica obbligatoria e procura alle liti
Il diritto di difesa nel processo tributario può essere esercitato personalmente dal contribuente solo nelle controversie di piccolo valore; diversamente, vi è l’obbligo di farsi assistere da un difensore tecnico abilitato (art. 12 D.Lgs. 546/92). Questa regola rientra nelle questioni di rito perché la mancanza di assistenza tecnica quando necessaria comporta un vizio potenzialmente inficiante il processo. Vediamo i dettagli:
L’art. 12, comma 1 stabilisce che il contribuente può stare in giudizio senza difensore solo per le cause di valore fino a €3.000 (valore calcolato al netto di interessi e sanzioni). In tal caso può firmare e presentare il ricorso da solo. Per cause di valore superiore, invece, “il ricorrente, diverso dagli enti impositori, […] deve essere assistito da un difensore abilitato”. I difensori abilitati sono, a termini di legge: avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro (per materie di loro competenza), e altri soggetti indicati (funzionari di CAF, ufficiali militari per tributi militari, ecc.), purché iscritti in appositi elenchi tenuti presso le Corti di giustizia tributaria.
La procura alle liti è il documento con cui il contribuente nomina formalmente il difensore, conferendogli il potere di rappresentarlo in giudizio. Nel processo tributario la procura può essere rilasciata in calce o a margine del ricorso, oppure su foglio separato da allegare, e va sottoscritta dal contribuente a pena di inammissibilità (così recitava l’art. 12, co. 3). Dunque, due piani: a) presenza del difensore abilitato quando necessario; b) regolarità formale della procura.
Secondo la lettera della legge, se un ricorso sopra soglia è presentato senza difensore, esso sarebbe inammissibile immediatamente (art. 12, co. 5). Tuttavia, la giurisprudenza – anche costituzionale – ha mitigato questo rigore. La Corte Costituzionale, già con sentenza n. 189/2000, ha dichiarato l’illegittimità parziale di norme che impedivano una sanatoria ex post dell’assenza di difensore. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 12059/2010) hanno affermato che l’assistenza tecnica integra una condizione dell’instaurazione del contraddittorio e che la sua mancanza può essere sanata attraverso la nomina successiva di un difensore entro un termine perentorio disposto dal giudice. In altri termini, se un contribuente presenta personalmente un ricorso che in realtà richiederebbe l’avvocato, il giudice non dovrebbe cestinarlo subito, ma dovrebbe sollecitare il contribuente a munirsi di difensore entro un certo termine (pena l’inammissibilità se non si adegua). Questo orientamento mira a salvaguardare l’accesso alla giustizia evitando che un errore formale privi il contribuente del tutto del giudizio. Ad esempio, la CTR Palermo 2834/2017 ha seguito questa linea ordinando la regolarizzazione di una procura invece di dichiarare inammissibile il ricorso.
In pratica oggi, se arriva un ricorso fai-da-te sopra €3.000, molte Commissioni invitano il contribuente a nominare un difensore e depositare una regolare procura. Se il contribuente adempie, il vizio è sanato e il processo prosegue. L’unico caso dove la sanatoria è esclusa è se la causa viene decisa senza che il difetto sia stato rilevato: in Cassazione, una sentenza resa su ricorso invalido per difetto di difensore sarebbe nulla (ma in genere, appunto, lo si rileva prima).
Passando alla procura alle liti in senso stretto: l’art. 18, co. 3 menziona come causa di inammissibilità la mancata sottoscrizione da parte del contribuente della procura. Letteralmente: “il difensore […] deve essere munito di procura alle liti rilasciata dal contribuente, a pena di inammissibilità del ricorso”. Nonostante questa formulazione drastica, la giurisprudenza tributaria ha ritenuto che la mancanza o irregolarità della procura alle liti comporti una nullità sanabile, non una inammissibilità automatica. In pratica, se il difensore deposita il ricorso senza procura o con procura non firmata, il giudice di regola assegna un termine per produrre la procura regolare (magari ex art. 182 c.p.c.), invece di rigettare subito. La Cassazione SU 22601/2004 conferma che la procura mancante può essere successivamente integrata senza determinare la nullità del ricorso. Così pure Cass. 15029/2014 ha chiarito che perfino l’assenza iniziale del difensore (dove richiesto) non preclude una regolarizzazione successiva, inquadrandola come vizio del contraddittorio suscettibile di rimedio.
In sostanza:
- Se manca del tutto il difensore obbligatorio: il giudice invita a nominarlo (e depositare procura) anziché dichiarare immediatamente inammissibile. Se l’invito non viene ottemperato, allora dichiarerà inammissibile.
- Se il difensore c’è ma la procura è nulla o mancante: il giudice chiede di regolarizzarla (depositandone copia autentica, o procura integrativa firmata) prima di decidere. Solo se la parte non adempie, il ricorso potrà essere invalidato.
Un caso di scuola: un avvocato notifica il ricorso ma si dimentica di far firmare la procura al cliente. La CTP accortasi dell’assenza non dovrebbe subito definire il giudizio, ma può sollecitare l’avvocato a produrre la procura (magari già firmata dal cliente con data antecedente alla notifica, per rispettare il principio che la procura va rilasciata prima o contestualmente all’atto). Se ciò avviene, il vizio è sanato e il ricorso considerato valido fin dall’inizio. Il ragionamento giuridico dietro questa tolleranza è che la procura attiene alla rappresentanza processuale, e la sua mancanza iniziale non incide sui diritti sostanziali se viene successivamente confermata dal rappresentato.
Resta fermo però un punto: se un ricorso è presentato da un soggetto non abilitato (es: un commercialista che difende su materia non ammessa, o un soggetto qualsiasi privo di titoli), quello è un difetto radicale. Anche qui il giudice potrebbe invitare a nominare un difensore idoneo, ma se nulla accade il ricorso non può proseguire.
In conclusione, dal punto di vista del contribuente: assicurarsi di rispettare le regole di rappresentanza tecnica. Se la causa supera €3.000, bisogna incaricare un difensore abilitato e rilasciargli regolare procura alle liti (firmata in originale se su carta, o con firma digitale se elettronica, e datata preferibilmente in data non successiva alla notifica del ricorso). In caso contrario si rischia una contestazione di rito. Fortunatamente, oggi la maggior parte dei giudici tributari adottano un approccio di salvaguardia, offrendo la chance di rimediare ai difetti di procura piuttosto che far decadere immediatamente il ricorrente.
NB: la regolarità della procura è importante anche per l’ente impositore resistente. Se l’Agenzia delle Entrate si costituisce con un funzionario non autorizzato o senza la delega prevista, potrebbe a sua volta incorrere in vizi (ma in genere anche in quel caso la sanatoria è concessa). Tuttavia, dal lato contribuente è raro dover eccepire inammissibilità dell’ente per difetto di rappresentanza, poiché gli uffici sono ben organizzati su questo.
8. Mancato pagamento del contributo unificato
Ogni ricorso tributario richiede il pagamento del contributo unificato (C.U.), previsto dal Testo Unico Spese di Giustizia (DPR 115/2002, art. 13) ed esteso al processo tributario dal 2011. L’importo varia a scaglioni in base al valore della lite: ad esempio €30 per liti fino a €2.582, €120 fino a €5.000, €250 fino a €25.000, €500 fino a €75.000, €1.500 oltre €200.000 (sono gli importi attuali). Il pagamento va effettuato al momento del deposito del ricorso (o poco prima) tramite modello F23 o F24 con apposito codice tributo (il 171T per processi tributari). Sul ricorso occorre indicare il valore della controversia e l’avvenuto pagamento del contributo unificato.
Cosa succede se il contribuente non paga il contributo unificato? Formalmente, il DPR 115/2002 prevede che il contributo è “dovuto” e in caso di omissione l’amministrazione finanziaria iscrive a ruolo il suo recupero con sovrattassa. Nel processo civile, la giurisprudenza ha a lungo discusso se il mancato pagamento comporti l’improcedibilità del ricorso; nel processo tributario, pur mancando una norma ad hoc, si è ritenuto di applicare per analogia la sanzione dell’inammissibilità del ricorso se il contributo non è versato. Infatti, Cassazione e prassi Agenzia Entrate concordano che la prova del pagamento del contributo unificato debba essere fornita, e in mancanza il ricorso è inammissibile (o quantomeno improcedibile). Alcune Commissioni in passato concedevano un termine per regolarizzare il pagamento del C.U. qualora il difetto emergesse in udienza (sul modello dell’art. 182 c.p.c. per le spese), ma non è una prassi codificata.
Una novità introdotta dal 2023 è che nel ricorso telematico il sistema SIGIT richiede di inserire gli estremi del pagamento del contributo unificato prima di consentire il deposito: questo dovrebbe prevenire molte omissioni. Tuttavia, restano casi di errore (es: contribuente che indica valore errato e versa un importo insufficiente).
Va ricordato che la legge impone di indicare espressamente il valore della controversia nel ricorso (art. 14, comma 3-bis DPR 115/2002, come modificato nel 2014), a pena di dover pagare il contributo massimo. Se il ricorso non riporta il valore, si presume oltre €200.000 e quindi contributo di €1.500 dovuto. In tal caso, se il contribuente non aveva pagato nulla o aveva pagato meno, l’amministrazione chiederà la differenza. Ma più nell’immediato, l’ufficio si attiverà probabilmente eccependo la mancata prova del pagamento, chiedendo al giudice di dichiarare inammissibile il ricorso.
La Cassazione (vedi ord. n. 4815/2025 citata prima) sembra avallare la linea dura: se non risulta il pagamento del C.U., il ricorso va considerato inammissibile. La ratio è che il contributo unificato nel processo tributario è considerato una “condizione di adempimento fiscale-processuale” che il ricorrente deve soddisfare; analogamente alla giurisdizione amministrativa (dove il mancato pagamento del contributo unificato comporta l’irricevibilità del ricorso TAR, sanabile solo con pagamento entro termine perentorio), anche nel tributario la tendenza è di non accettare la pendenza del giudizio senza pagamento.
Tuttavia, va detto che in passato molte Commissioni, in sede di costituzione, quando rilevavano l’assenza del pagamento invitavano informalmente il ricorrente a provvedere entro l’udienza. Alcune segreterie, inoltre, al momento del deposito controllavano e sollecitavano subito l’integrazione. Con il deposito telematico, questo controllo è demandato all’informatica e all’ufficio impositore (che in costituzione segnalerà se manca).
Il consiglio pratico è semplice: pagare sempre il contributo unificato dovuto e allegare la relativa ricevuta al momento del deposito. Se per dimenticanza non lo si è fatto, è bene provvedere prima possibile, preferibilmente prima che l’ente sollevi la questione o prima dell’udienza di trattazione, depositando la ricevuta tardiva (sperando nella clemenza del collegio nel considerarla sanante).
Riassumendo la posizione giurisprudenziale attuale: il mancato pagamento del contributo unificato è considerato un elemento che pregiudica la valida instaurazione del processo tributario; la sua mancanza comporta l’inammissibilità, salvo che venga sanato entro termini concessi (se concessi) dal giudice. In ogni caso la sanzione amministrativa rimane: se anche il giudizio proseguisse, l’ufficio potrebbe iscrivere a ruolo il contributo dovuto più una maggiorazione del 50% (DPR 115/2002, art. 16).
Nella pratica attuale (luglio 2025), a regime telematico completo, la situazione è la seguente: il sistema informatico obbliga a inserire i dati del pagamento C.U. per concludere il deposito; quindi l’ipotesi di un ricorso depositato senza contributo è divenuta residua (potrebbe avvenire se uno simula un valore causa sotto €3.000 dove il contributo non è dovuto, ma in realtà il valore era superiore; in tal caso emergerebbe il difetto in seguito e si applicherebbe la sanzione).
9. Reclamo e mediazione tributaria (fino al 2024)
Una peculiare questione di rito in ambito tributario, valida per le liti di modesto importo sino a tempi recenti, era rappresentata dall’istituto del reclamo e mediazione obbligatoria. Introdotto nel 2011 (D.L. 98/2011) e modificato più volte, prevedeva che per le controversie di valore non eccedente un certo limite (prima €20.000, poi €50.000) il contribuente dovesse, prima di instaurare il processo, presentare un’istanza di reclamo all’ente impositore, la quale valeva anche come proposta di mediazione. In sostanza, il ricorso stesso veniva inizialmente trasmesso all’ente come reclamo: l’ufficio poteva accoglierlo, proporre una mediazione riducendo la pretesa, oppure respingerlo; trascorsi 90 giorni, in mancanza di accordo, il reclamo si convertiva in ricorso e la causa proseguiva in Commissione.
Questa procedura era concepita come misura deflattiva per evitare cause di piccolo importo, ma ha avuto efficacia limitata (solo il ~30% dei reclami si concludeva con accordo). Inoltre fu oggetto di censura costituzionale: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 98/2014, dichiarò illegittima la sanzione di inammissibilità del ricorso in caso di mancato reclamo, perché costituiva un ostacolo all’accesso alla giustizia (art. 24 Cost.). Il legislatore corse ai ripari modificando il meccanismo: dal 2016 in poi, il reclamo-mediazione fu considerato condizione di procedibilità, non più di ammissibilità. Ciò significava che se il contribuente saltava la fase di reclamo, il giudice non doveva rigettare subito il ricorso, ma disporre la sospensione del processo per consentire la mediazione.
La disciplina negli ultimi anni era la seguente: per controversie fino a €50.000 relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate, di Agenzia Entrate-Riscossione o di enti locali, il ricorso doveva contenere anche una specifica richiesta di mediazione rivolta all’ente (art. 17-bis D.Lgs. 546/92). Il deposito del ricorso fungeva anche da istanza di reclamo. Dal 2023 questa fase è stata eliminata. Infatti il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha abrogato l’art. 17-bis con effetto sui ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 (anche se con regole transitorie complesse). In base alle indicazioni del MEF, per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 in poi la mediazione non è più obbligatoria e la relativa omissione non ha conseguenze; per quelli notificati prima di tale data, continua ad applicarsi la normativa previgente. Dunque, questa questione di rito è ormai storica, ma può ancora rilevare per ricorsi pendenti di anni scorsi.
Nella vigenza della mediazione obbligatoria, la mancata presentazione del reclamo o l’avvio del giudizio senza attendere i 90 giorni comportava una sanzione processuale. Prima del 2014 si parlava di inammissibilità; dopo, la norma parlava di improcedibilità. In concreto, se il contribuente depositava un ricorso soggetto a reclamo senza aver atteso la fase, la Commissione di primo grado in genere sospendeva il giudizio fino al decorso dei 90 giorni dalla notifica del ricorso, dopodiché il processo riprendeva regolarmente. Solo se il contribuente non aveva proprio presentato il reclamo all’ente, la giurisprudenza riteneva che il ricorso andasse dichiarato nullo/inammissibile per mancanza di una condizione di procedibilità. Di solito la nullità poteva essere sanata con la riassunzione dopo aver esperito la mediazione tardiva.
Facciamo un esempio tipico pre-2024: Tizio riceve un avviso di accertamento di €30.000 il 1° marzo 2023. Invece di presentare il reclamo all’Agenzia, notifica direttamente il ricorso alla CTP il 15 aprile 2023 e deposita immediatamente. La Commissione in udienza rileva che non sono passati 90 giorni e sospende la trattazione fino a fine giugno (90 gg dal 15 aprile). Nel frattempo l’Agenzia esamina il reclamo implicito: se fa una proposta, Tizio può accettare e chiudere la lite; se rigetta, trascorsi i 90 giorni Tizio deve semplicemente attivarsi per far proseguire il processo (in pratica il ricorso depositato è valido e dopo 90 giorni la causa va a sentenza). Se però Tizio non avesse proprio presentato reclamo, magari perché ignorava l’obbligo e avesse atteso oltre 90 giorni ugualmente, alcuni giudici avrebbero dichiarato nullo il processo. Ma la giurisprudenza più recente tendeva comunque a trovare modi per non annullare tutto: si poteva convertire il ricorso in reclamo e poi rimettere in termini.
Ora, dal punto di vista attuale (2025), la questione è superata: non è più necessario alcun reclamo preventivo per le nuove liti. Quindi non costituisce più motivo di inammissibilità. Tuttavia, per completezza e per i casi residui, ricordiamo che: i ricorsi notificati prima del 4 gennaio 2024 sotto soglia €50.000 dovevano rispettare l’art. 17-bis, e se non lo hanno fatto l’ente potrebbe aver eccepito la nullità di quei ricorsi. Tali eccezioni saranno decise caso per caso, tenendo conto che la norma è stata abrogata (ma con effetto non retroattivo).
In definitiva, oggi il contribuente non deve più presentare istanza di reclamo/mediazione prima di ricorrere. La fase eventuale di trattativa è demandata alla possibilità di conciliazione in corso di causa (istituto potenziato dalla riforma, ma facoltativo). Quindi una vecchia insidia procedurale – l’omesso reclamo – è stata rimossa. Chi aveva presentato ricorsi negli anni scorsi dovrebbe comunque aver già esaurito la fase di mediazione o essere stato richiamato a integrarla, quindi difficilmente nel 2025 avremo ancora pronunce di inammissibilità per questo motivo. Se vi fossero, sarebbero legate a ricorsi notificati prima del 2024 e sfuggiti a sanatoria.
10. Litispendenza e giudicato (doppie impugnazioni e ne bis in idem)
Altre questioni di rito che possono presentarsi riguardano il duplicarsi di azioni giudiziarie sullo stesso oggetto, o la violazione del principio del ne bis in idem quando si tenta di contestare nuovamente qualcosa di già deciso con sentenza passata in giudicato.
Litispendenza: si ha quando due giudizi pendenti coinvolgono le stesse parti e il medesimo oggetto. In campo tributario potrebbe accadere ad esempio che il contribuente presenti due volte ricorso contro lo stesso atto (magari per errore, o uno a seguito di iscrizione a ruolo provvisorio e uno a seguito di iscrizione definitiva, ecc.). Oppure, ipotesi non rara, che impugni separatamente due atti strettamente connessi invece di cumularli: se però l’oggetto è identico si configurerà litispendenza. La soluzione in questi casi è che uno dei due giudici dichiari l’inammissibilità per litispendenza, proseguendo solo il giudizio che è stato iscritto per primo. Ad esempio, se Caio impugna in CTP di Roma una cartella e, temendo un disguido, impugna la stessa cartella anche in CTP di Milano, avremo due ricorsi identici. Uno dei due tribunali (quello successivamente adito, generalmente) dovrà eliminare il duplicato per litispendenza. Tale eccezione può essere sollevata dall’ente o rilevata d’ufficio se nota al giudice.
Giudicato esterno: si tratta del caso in cui una questione sia già stata definita con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti. In base ai principi generali, un secondo ricorso sul medesimo oggetto è inammissibile, perché coperto da giudicato. Ad esempio, se Tizio ha già ottenuto in un precedente giudizio l’annullamento di un certo avviso di accertamento (sentenza definitiva), non può in altro giudizio richiedere ancora l’annullamento dello stesso avviso: il secondo ricorso sarà dichiarato inammissibile per cosa giudicata. Oppure, se Tizio aveva due vie per contestare una pretesa e ne ha percorsa una ottenendo una pronuncia di merito, non può in separato giudizio tentare un diverso angolo di attacco sullo stesso tributo (il giudicato copre il dedotto e il deducibile relativo a quell’oggetto).
Nel processo tributario capita, ad esempio, che un contribuente proponga ricorso contro un silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, perdendolo, e poi riproponga un nuovo ricorso tentando di far valere un motivo diverso per lo stesso rimborso: il secondo sarà inammissibile per giudicato esterno. Una recente ordinanza della Cassazione (n. 20322/2023) ha ricordato che l’inammissibilità per litispendenza o giudicato può essere dichiarata anche in sede di appello, se il giudice rileva che in primo grado magari nessuno se ne era accorto.
Un caso particolare è quando due giudizi paralleli riguardano annate diverse ma connesse: lì non c’è litispendenza perché gli oggetti (anni d’imposta) sono diversi, però potrebbe entrare in gioco il giudicato interno implicito. Ad esempio, se per IVA 2018 una certa questione (es. qualifica di esente un’operazione) è stata definita in un modo passato in giudicato, quella decisione potrebbe fare stato per IVA 2019 sul medesimo punto. Ma qui entriamo più nel merito che nel rito, e riguarda piuttosto l’efficacia del giudicato.
Ai fini procedurali, al contribuente conviene evitare doppioni: se ha già un ricorso pendente, non ne introduca un altro uguale; se per errore dovesse succedere (ad esempio due avvocati depositano due ricorsi per lo stesso atto), sarà opportuno rinunciare ad uno dei due, per non incorrere in condanna alle spese. E se ha già ottenuto una sentenza definitiva su una materia, non insistere con nuove cause sullo stesso tributo, perché saranno dichiarate inammissibili.
Esempio tipico: il contribuente propone ricorso avverso silenzio-rifiuto su rimborso IRPEF in due momenti diversi, notificandoli entrambi all’ufficio finanziario. L’ufficio potrebbe non accorgersene subito, ma se lo fa eccepirà litispendenza e uno dei due andrà eliminato. Oppure, come successo in un caso affrontato dalla Cassazione (ord. 29/08/2024, n. 23346), il contribuente impugna alcune cartelle in un primo ricorso e altre in un secondo, cercando di eccepire vizi di notifica su quelle già non impugnate: la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo tentativo, sostenendo che non aver impugnato le prime cartelle nei termini le rende definitive, e non possono essere rimesse in discussione indirettamente.
11. Altre cause di estinzione del processo
Oltre all’inammissibilità – che è la sanzione tipica per i vizi di rito – vi sono altre situazioni in cui il processo si chiude anticipatamente senza decisione di merito. Le citiamo brevemente per completezza, pur non essendo “questioni di rito” contestabili, ma piuttosto eventi:
- Cessata materia del contendere: se l’ente impositore, in tutto o in parte, annulla in autotutela l’atto impugnato o riconosce le ragioni del contribuente prima della sentenza, viene meno l’oggetto del ricorso. Il giudice, su comunicazione delle parti, dichiara cessata la materia del contendere (che di fatto è un’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse). Dal punto di vista del contribuente, questo è un successo (ha ottenuto soddisfazione amministrativamente). In genere il giudice in questi casi liquida le spese a carico dell’ente che ha dato causa al processo, a meno che l’annullamento sia avvenuto proprio grazie alle osservazioni del ricorrente in sede di reclamo (in tal caso possono compensare).
- Conciliazione: le parti (contribuente ed ente impositore) possono accordarsi in corso di causa per definire la lite in maniera parziale o totale (riduzione del tributo, sanzioni ad un terzo del minimo, pagamento rateale, etc., secondo l’art. 48 D.Lgs. 546/92 e succ. mod.). Se si concilia, il processo termina con un verbale di conciliazione giudiziale che ha gli effetti di una sentenza. Non è una pronuncia di merito del giudice, ma un accordo tra le parti. In pratica è una forma di definizione alternativa della controversia. Non la approfondiamo qui perché esula dalle questioni patologiche (è volontaria e pattizia), ma il risultato è analogo: il giudizio non arriva a una decisione sul merito in senso proprio.
- Rinuncia al ricorso: il ricorrente può sempre decidere di desistere dal ricorso (art. 44 D.Lgs. 546/92). Se la controparte aderisce, il processo si estingue per rinuncia. Ciò può avvenire, ad esempio, se l’ufficio emette un atto sostitutivo più favorevole e il contribuente, soddisfatto, ritira la causa. L’estinzione per rinuncia chiude il processo senza statuizione sul merito; normalmente comporta la condanna alle spese del rinunciante (salvo accordi diversi). Non è propriamente una “questione di rito”, ma un atto dispositivo delle parti.
- Interruzione ed estinzione: se durante il processo intervengono fatti come la morte o perdita di capacità di una parte, o la cessazione dell’ente parte in causa (es. muore il contribuente, o una società si estingue, o l’ente viene soppresso), il processo può subire un’interruzione. Va riassunto dalle parti interessate entro 6 mesi, altrimenti si estingue (artt. 40 e 43 D.Lgs. 546/92 richiamano le norme civili). Questa è una vicenda processuale che attiene in parte al rito. Per esempio, se il contribuente muore e gli eredi non proseguono la causa, dopo 6 mesi il giudizio si estingue. Ciò ovviamente incide sul risultato: se era ricorrente il contribuente, l’atto originario resta efficace (salvo che gli eredi lo impugnino in altro modo); se era appellante l’ufficio, la sentenza favorevole al contribuente diventa definitiva per mancata prosecuzione dell’appello.
In questa sede, le ultime situazioni non vengono esaminate in dettaglio in quanto non sono eccezioni di rito che una parte solleva, bensì eventi o facoltà che portano a definire anzitempo il processo. Tuttavia completano il quadro delle possibili definizioni “anticipate” del contenzioso tributario.
Di seguito presentiamo alcune tabelle riassuntive che schematizzano le principali cause di inammissibilità del ricorso tributario (questioni di rito) e i principali termini processuali, oltre a una sintesi delle competenze dei giudici tributari.
Tabella 1 – Cause principali di inammissibilità del ricorso tributario
| Causa di inammissibilità | Riferimenti normativi/giurisprudenziali | Note |
|---|---|---|
| Ricorso tardivo (decadenza dai termini) | Art. 21 D.Lgs. 546/92; Cass. civ. ord. 4815/2025 – Termini perentori | Presentazione oltre 60 gg (primo grado) o 30 gg (appello) dalla notifica atto impugnato → inammissibilità d’ufficio. |
| Ricorso notificato o depositato fuori termine | Art. 22 D.Lgs. 546/92; Cass. civ. sez. V, ord. 20322/2023 – Costituzione tardiva | Notifica del ricorso oltre termine di legge, oppure deposito in Commissione oltre 30 gg dalla notifica → ricorso inefficace (inammissibile/improcedibile). |
| Atto non impugnabile o carenza di interesse | Art. 19 D.Lgs. 546/92, co. 3; Cass. civ. sez. V, 21850/2013 – Lesività diretta | Ricorso contro atti non inclusi nell’elenco di legge (es. avvisi bonari, atti interni) → inammissibile per difetto di oggetto impugnabile. Ricorso “teorico” senza lesione attuale → inammissibile per carenza interesse. |
| Difetto di giurisdizione | Art. 2 D.Lgs. 546/92; Cass. SU 8465/2022; Cass. SU 2098/2025 – Petitum sostanziale | Controversia estranea alla giurisdizione tributaria (es. materia non tributaria, oppure atto esecutivo puro) → ricorso inammissibile. |
| Incompetenza territoriale (non sanata) | Art. 5 D.Lgs. 546/92; Cass. civ. ord. 6864/2024 – Sede errata | Ricorso proposto alla Commissione sbagliata → inammissibile salvo trasferimento ufficioso. Se trasferito nei termini, prosegue. |
| Mancata indicazione di elementi essenziali (art. 18) | Art. 18, co. 2 D.Lgs. 546/92; Cass. civ. ord. 2843/2020 – Oggetto/motivi incerti | Omessa/assoluta incertezza su: giudice adito, parti, atto impugnato, petitum, motivi → ricorso inammissibile. Es: petitum non chiaro o motivi del tutto assenti. (Codice fiscale e PEC difensore esclusi dall’art.18, co.4) |
| Vizi di sottoscrizione e procura alle liti | Art. 18, co. 3-4 e art. 12 D.Lgs. 546/92; Cass. SU 22601/2004; Cass. 7/3/2024 n. 6864 (CTR Lazio) | – Mancata firma del difensore/ricorrente sul ricorso: inammissibile insanabile. – Difensore mancante ove obbligatorio: vizio regolarizzabile (invito a nomina). – Procura alle liti mancante/nulla: nullità sanabile (termine per depositarla). |
| Notifica irregolare del ricorso | Art. 16-bis D.Lgs. 546/92; Cass. civ. ord. 4815/2025 – Obbligo PEC | Ricorso notificato con modalità non consentite (es. cartaceo anziché PEC, PEC a indirizzo errato) → notifica nulla/inesistente = ricorso inammissibile. Sanabile solo se l’ente si costituisce senza eccepire (nullità relativa). |
| Mancata costituzione in giudizio | Art. 22 D.Lgs. 546/92; Cass. civ. sez. V, ord. 20322/2023 | Omesso deposito del ricorso notificato entro 30 gg → ricorso considerato come non proposto (inammissibile). |
| Mancato pagamento contributo unificato | DPR 115/2002 art.13; Cass. civ. ord. 4815/2025 – Oneri fiscali | Omissione del pagamento C.U. dovuto → ricorso improcedibile/inammissibile (prassi Agenzia Entrate e giurisprudenza civile). Possibile integrazione se rilevata tempestivamente. |
| Omesso reclamo-mediazione (fino al 2023) | Art. 17-bis D.Lgs. 546/92 (abrogato da D.Lgs. 220/2023) | Per ricorsi ≤ €50.000 notificati prima del 4/1/24: mancata presentazione istanza reclamo-mediazione → inammissibilità/nullità del ricorso. (Dal 2024 non richiesto). |
| Nuove domande o motivi in appello | Art. 57 D.Lgs. 546/92; Cass. civ. ord. 13317/2020 | Introduzione in appello di richieste o eccezioni nuove, estranee al thema decidendum di primo grado → inammissibilità d’ufficio. |
| Litispendenza/Giudicato | Principio generale (art. 39 c.p.c. analogico) | Doppio ricorso stesso oggetto (litispendenza) o causa già decisa con giudicato esterno → secondo ricorso inammissibile. |
Tabella 2 – Termini di impugnazione nel processo tributario
| Tipo di impugnazione | Termine | Base normativa |
|---|---|---|
| Ricorso introduttivo in primo grado (CTP) | 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (ordinario). 90 giorni per alcune ipotesi particolari (es. ricorso avverso rifiuto o silenzio-rifiuto su istanza di rimborso). | Art. 21, co. 1 D.Lgs. 546/92 |
| Appello (CTR) | 30 giorni dalla notifica della sentenza di CTP da impugnare. (6 mesi dalla pubblicazione, se la sentenza non viene notificata). | Art. 51, co. 1 D.Lgs. 546/92 (rinvio all’art. 327 c.p.c. per termine lungo) |
| Ricorso per Cassazione | 60 giorni dalla notifica della sentenza di CTR. (6 mesi dalla pubblicazione se non notificata). | Art. 62 D.Lgs. 546/92 (rinvio a termini codice proc. civ.) |
| Costituzione in giudizio (deposito ricorso) | Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso (primo grado). Entro 30 giorni dalla notifica dell’appello (secondo grado). | Art. 22, co. 1 D.Lgs. 546/92 (primo grado); art. 53, co. 2 (appello) |
| Sospensione feriale dei termini | Dal 1° al 31 agosto di ogni anno (31 giorni) – si sospende il decorso dei termini processuali. | L. 742/1969, art. 1 (come modificata da L. 162/2014) |
| Reclamo-mediazione (ora abolito) | 90 giorni dalla notifica del reclamo perché possa formarsi il silenzio-rigetto e il ricorso prosegua. | Art. 17-bis D.Lgs. 546/92 (testo previgente) |
Tabella 3 – Competenza del giudice tributario
| Organo giudicante | Controversie di competenza | Note |
|---|---|---|
| Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado (già Commissione Tributaria Provinciale, CTP) | Ricorsi avverso atti impositivi e sanzionatori, di riscossione e rimborso riguardanti tributi di ogni genere (erariali o locali) emessi dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione nel proprio ambito territoriale. | Competenza per territorio: individuata in base alla sede dell’ufficio che ha emanato l’atto o al domicilio fiscale del contribuente, secondo le norme (ora art. 4 abrogato, ma criteri applicati come in passato). |
| Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (già Commissione Tributaria Regionale, CTR) | Appelli avverso le sentenze delle Corti di primo grado nella stessa regione (o province autonome). | Di norma una CTR per regione. Alcune regioni hanno sezioni staccate. |
| Giudice Ordinario (Tribunale, Giudice di Pace) | Cause escluse dalla giurisdizione tributaria, ad es.: azioni esecutive su tributi (pignoramenti, opposizioni all’esecuzione), crediti non tributari, sanzioni amministrative non fiscali, ecc. | Il confine con la giurisdizione tributaria è dato dal tipo di pretesa dedotta in giudizio. Vedi Sez. Un. 8465/2022: atti fino alla cartella → giudice tributario; atti esecutivi puri → giudice ordinario. |
| Giudice Amministrativo (TAR) | Controversie su atti amministrativi generali in materia tributaria (raro): es. regolamenti comunali impugnati per vizi propri (non attinenti a tributo specifico), oppure diniego di definizione agevolata come atto generale (questioni molto particolari). | Dopo la riforma 2001, quasi tutto ciò che attiene ai tributi è attribuito al giudice tributario, anche contro enti locali. Restano ai TAR i ricorsi contro atti non impositivi ma regolamentari generali (es: delibere tariffarie se non considerate tributarie). |
(PT = primo grado tributario; le denominazioni CTP/CTR in transizione 2023-2025 coincidono con Corte Giust. Trib. di I e II grado.)
Esempi e simulazioni pratiche di eccezioni di rito
Vediamo ora alcune situazioni concrete in cui un vizio di rito incide sul processo tributario, con l’esito relativo, dal punto di vista del contribuente (ricorrente) o delle parti coinvolte:
Esempio 1: Ricorso tardivo – termine perentorio non rispettato
Mario riceve un avviso di accertamento IRPEF il 1° marzo 2025. Presenta ricorso il 5 maggio 2025, notificandolo via PEC all’Agenzia delle Entrate. Il termine di 60 giorni scadeva il 30 aprile 2025, quindi il ricorso è stato notificato 5 giorni oltre il termine. In udienza, la Corte Tributaria di primo grado dichiara il ricorso inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/92. Mario prova a giustificarsi dicendo che aveva capito male la scadenza, ma ciò non rileva: il termine è perentorio e il giudice non può entrar nel merito. Risultato: l’accertamento diventa definitivo. (Nessuna sospensione feriale applicabile, perché marzo-aprile non includono agosto). Mario dovrà eventualmente valutare una conciliazione o altra strada, ma processualmente ha perso per vizio di rito.
Esempio 2: Assenza iniziale di procura alle liti – vizio sanabile
Lucia propone ricorso contro una cartella esattoriale da €10.000. Si affida a un avvocato, il quale però dimentica di allegare la procura alle liti firmata dalla cliente al momento del deposito telematico. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituita in giudizio, eccepisce la mancanza della procura. La Corte Tributaria non dichiara subito l’inammissibilità, bensì emette un’ordinanza dando a Lucia e al difensore 10 giorni di tempo per depositare la procura mancante. L’avvocato prontamente deposita una procura firmata da Lucia (con data anteriore o contestuale alla notifica del ricorso, per sicurezza). A questo punto il giudizio prosegue regolarmente sul merito. La mancanza iniziale della procura è stata considerata un vizio sanabile (nullità) e, essendo stata sanata nei termini, il ricorso resta valido. (Se Lucia/avvocato non avessero ottemperato, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile/inammissibile.)
Esempio 3: Notifica cartacea anziché PEC – ricorso invalido
L’avvocato Carlo presenta per conto di un contribuente un ricorso contro un avviso di accertamento di €50.000. Invece di notificarlo via PEC all’ufficio delle Entrate (come obbligatorio dal 2019), invia il ricorso in forma cartacea tramite Ufficiale Giudiziario alla sede dell’Agenzia. L’ufficio riceve la copia cartacea. In giudizio, eccepisce la nullità della notifica perché effettuata con modalità non consentita (violazione art. 16-bis). La Commissione Tributaria verifica che effettivamente il difensore di Carlo aveva l’obbligo di notifica telematica e non lo ha rispettato. Quindi dichiara il ricorso inammissibile, richiamando la giurisprudenza (Cass. 4815/2025) secondo cui la notifica cartacea di un ricorso soggetto a obbligo PEC è priva di effetti. Carlo ha così perso il ricorso senza discutere il merito. (Notiamo che se l’ufficio, ipotesi remota, non si fosse costituito affatto, il giudice avrebbe rilevato d’ufficio il difetto di notifica e comunque dichiarato inammissibile; se invece l’ufficio si fosse costituito senza eccepire nulla, forse il vizio sarebbe stato considerato sanato. Ma gli uffici eccepiscono sempre in questi casi.)
Esempio 4: Oggetto del ricorso incerto – mancanza di petitum specifico
Pietro impugna un “atto di contestazione di sanzioni” ricevuto, ma nel suo ricorso si limita a scrivere: “Ricorro avverso l’atto in oggetto chiedendone l’annullamento perché infondato in fatto e in diritto”, senza spiegare altro. Non allega l’atto impugnato, non indica importi né anno né motivi specifici. In udienza, la Corte Tributaria constata che dal ricorso non si comprende chiaramente quale atto sia impugnato né perché: ad esempio, l’atto citato come “in oggetto” non è stato identificato con numero o data, e non viene chiarito se si contesta la legittimità nel merito o per vizi formali. In mancanza di specificazione, il giudice dichiara il ricorso inammissibile per assoluta incertezza sull’oggetto e motivi. Pietro obietta che ovviamente voleva annullare quell’atto, ma ormai è tardi: il giudice non può supplire alle carenze dell’atto introduttivo. (Se Pietro avesse almeno allegato copia dell’atto o indicato i motivi sommariamente, avrebbe evitato l’inammissibilità.) Questo esempio sottolinea l’importanza di formulare un petitum e motivi chiari nel ricorso.
Esempio 5: Nuova domanda in appello – violazione del divieto di “ius novorum”
Marco ricorre in CTP contro un avviso di accertamento IRAP, ottenendo parziale annullamento (ad esempio gli vengono tolte delle sanzioni). Propone appello alla CTR per ottenere l’annullamento totale. Nel formulare l’appello, però, aggiunge una richiesta nuova: chiede anche il rimborso di un credito IRAP riportato da anni precedenti, di cui non aveva parlato in primo grado. L’Agenzia eccepisce che questa domanda di rimborso è nuova. La CTR concorda: ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. 546/92, in appello sono inammissibili le domande nuove. Pertanto la CTR dichiara inammissibile la nuova domanda di rimborso e limita l’esame ai motivi già trattati in primo grado. Marco perde quindi quella parte di richiesta per vizio di rito (ius novorum), e l’eventuale rimborso non potrà più ottenerlo in questo giudizio. (Avrebbe dovuto proporre separato ricorso per il rimborso, oppure sollevare la questione già in CTP).
Esempio 6: Difetto di giurisdizione – atto esecutivo impugnato al giudice errato
Enrico riceve un pignoramento presso terzi da Agenzia Entrate-Riscossione (atto di pignoramento ai sensi art. 72-bis DPR 602/73, notificato ad un suo debitore). Enrico vuole contestarlo sostenendo di aver pagato le cartelle sottostanti. Non sapendo bene quale giudice sia competente, presenta ricorso sia al giudice tributario sia al Tribunale civile. Si innesca un conflitto. Il giudice tributario osserva che Enrico non sta contestando un tributo in sé, ma un atto di esecuzione forzata (il pignoramento) per ragioni attinenti la regolarità formale e la prescrizione successiva alla cartella. Seguendo l’indirizzo delle Sezioni Unite, la competenza si sdoppia: per la parte in cui Enrico sostiene che le cartelle erano prescritte prima, la giurisdizione sarebbe tributaria; per la regolarità formale del pignoramento, sarebbe ordinaria. Nel dubbio, le SU in simili casi assegnano prevalenza al giudice tributario se viene contestata la pretesa sostanziale. Dunque il giudice civile e quello tributario potrebbero sollevare conflitto. Alla fine, con ordinanza 2098/2025, la Cassazione a SU ha stabilito che la giurisdizione è tributaria per le eccezioni di prescrizione delle cartelle notificate e di mancata notifica di altre cartelle, mentre è ordinaria solo per eventuali vizi formali del pignoramento. Enrico quindi dovrà concentrare la causa davanti al giudice tributario. Se avesse adito solo il Tribunale ordinario inizialmente, quest’ultimo avrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione, lasciandolo scoperto (a meno di riuscire a ricorrere tardivamente al giudice tributario con qualche escamotage). L’insegnamento qui è: identificare bene la giurisdizione per evitare inammissibilità. Nel caso di Enrico, è stato necessario l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire, ma generalmente per atti dell’esecuzione bisogna valutare cosa si contesta, come spiegato in precedenza.
Esempio 7: Mancato pagamento del contributo unificato – intervento dell’ufficio
Sara propone ricorso avverso un avviso di liquidazione imposta di registro (€10.000). Dimentica però di pagare il contributo unificato di €120 dovuto. Deposita il ricorso telematico senza indicare nulla (ipotizzando erroneamente che fosse esente). L’ufficio si costituisce e nelle controdeduzioni eccepisce che manca la prova del pagamento del contributo unificato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile o inammissibile. A questo punto, prima dell’udienza, l’avvocato di Sara si accorge dell’errore e corre a pagare il contributo, depositando la ricevuta in extremis e chiedendo di considerare sanato il vizio. La Commissione potrebbe avere due approcci: un orientamento formalistico, seguendo Cassazione, considererebbe il ricorso inammissibile comunque perché il pagamento doveva essere contestuale; un altro orientamento più pratico potrebbe accettare la sanatoria tardiva e proseguire. Ipotizziamo che la Commissione accolga la linea dura e dichiari inammissibile il ricorso di Sara per mancato assolvimento del contributo unificato. Sara non avrà modo di discutere il merito e dovrà pagare l’imposta (salvo appello, ma se il vizio è confermato, nulla da fare). Inoltre si vedrà recapitare da Agenzia Entrate-Riscossione un’intimazione a pagare i €120 di contributo unificato dovuti, con aggiunta di €60 di sanzione (il 50%). Un finale amaro per una disattenzione procedurale. Questo esempio evidenzia perché il contributo unificato non va trascurato.
Come si vede dagli esempi, ogni svista procedurale può compromettere l’intera strategia difensiva del contribuente. È fondamentale essere rigorosi nel rispettare termini e forme: un ricorso ben costruito sul piano formale è il primo passo per potersi poi giocare le proprie carte sul merito. In caso di dubbi, il contribuente farebbe bene a farsi assistere sin dall’inizio o quantomeno a informarsi accuratamente sulle regole processuali (oggi, grazie anche ai servizi online e guide come questa, è più facile accedere alle informazioni chiave).
Domande frequenti (FAQ) su questioni di rito nel processo tributario
D1. Cosa succede se deposito il ricorso oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto?
R: Il ricorso è purtroppo inammissibile per tardività. Il termine di 60 giorni (o 30 giorni in appello) è perentorio: basta anche un giorno di ritardo perché scatti la decadenza. Il giudice lo rileva d’ufficio e non entrerà nel merito delle tue ragioni, anche se fossero valide. (Eccezioni molto limitate: ad es. se puoi provare che un caso di forza maggiore ti ha impedito di rispettare la scadenza – situazione rara e difficilissima da far valere). Conviene sempre calcolare con attenzione il termine (considerando eventuale sospensione di agosto) e notificare il ricorso entro la scadenza. Se ti accorgi di essere in ritardo, l’autotutela dell’ente è l’unica speranza, ma processualmente non avrai chances.
D2. Ho notificato il ricorso in tempo, ma ho dimenticato di costituirmi (depositarlo in segreteria entro 30 giorni). Posso rimediare?
R: Purtroppo se sono trascorsi più di 30 giorni dalla tua notifica, il ricorso si considera non perfezionato. L’art. 22 impone il deposito entro tale termine, pena l’inesistenza del ricorso in giudizio. Se il termine è scaduto, la Commissione dichiarerà l’inammissibilità. Non c’è un rimedio vero e proprio nel processo tributario (nel processo civile esiste l’istituto della rimessione in termini in casi eccezionali, ma nel tributario è controverso applicarla). Se però sei ancora entro i 30 giorni, affrettati subito a depositare: farà fede la data di invio telematico (o di consegna in segreteria) per verificare se sei dentro il termine. In extremis, se scopri di aver saltato il deposito ma il termine di impugnazione non è ancora scaduto, potresti provare a notificare un nuovo ricorso (identico) e depositarlo regolarmente – ma sono situazioni limite con esiti incerti. La lezione è: dopo aver notificato il ricorso, non dimenticare mai di depositarlo nel mese successivo.
D3. Ho presentato ricorso senza avvocato per una causa da €10.000. Il mio ricorso verrà respinto perché non avevo un difensore?
R: Non automaticamente. Nelle cause sopra €3.000 la legge richiede la difesa tecnica, ma la giurisprudenza ha chiarito che la mancanza di difensore iniziale è un vizio sanabile. In pratica, la Commissione dovrebbe invitarti a nominare un difensore abilitato entro un termine. Se tu provvedi (conferendo procura a un avvocato, ad esempio, e facendolo costituire in giudizio), il processo potrà proseguire regolarmente. Solo se ignorassi l’invito, a quel punto il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile. Quindi, se hai già depositato da solo, aspettati magari una comunicazione dal giudice. Ti conviene comunque rivolgersi subito a un professionista per regolarizzare la tua posizione, senza aspettare. Diverso sarebbe se stessi in giudizio da solo in Cassazione (lì il difensore è sempre obbligatorio, e la mancanza comporta nullità insanabile) – ma parliamo dei gradi di merito: lì hai questa chance di rimediare.
D4. Ho notificato il ricorso a un ente diverso da quello che ha emesso l’atto (per errore). È un problema di legittimazione passiva?
R: Sì, può essere un problema serio. Se hai indicato come resistente un soggetto sbagliato (ad esempio, hai fatto ricorso contro l’Agenzia delle Entrate quando l’atto lo aveva emesso il Comune, o viceversa), si configura un difetto di legittimazione passiva o un vizio nel contraddittorio. In linea di principio, il ricorso così rivolto rischia di essere dichiarato inammissibile, perché manca il contraddittorio con l’ente realmente competente. Tuttavia, c’è spazio per rimediare: spesso l’errore viene rilevato e il giudice può ordinare di integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto giusto (notificando il ricorso a quest’ultimo) anziché chiudere subito. Ad esempio, se hai fatto ricorso contro Equitalia (Agenzia Riscossione) mentre l’atto era un accertamento dell’Agenzia Entrate, il giudice ti chiederà di chiamare in causa l’Agenzia Entrate entro un termine. Se lo fai, il processo prosegue coinvolgendo il giusto convenuto. Se non lo fai, allora sì che il ricorso verrà dichiarato inammissibile. In pratica: soggetto giusto, giudice giusto! Controlla sempre di indirizzare bene il ricorso. Se ti accorgi dell’errore, attivati subito (anche spontaneamente prima dell’udienza) notificando copia del ricorso al soggetto corretto.
D5. Il mio avvocato ha notificato il ricorso via PEC ma non ha firmato digitalmente il PDF del ricorso. Il documento risulta privo di firma. Cosa succede?
R: La mancanza di firma del difensore sul ricorso è un vizio molto grave: rende il ricorso invalido (atto non sottoscritto). Purtroppo su questo aspetto la giurisprudenza è rigida: non è sanabile dopo. Se davvero il PDF notificato era privo di qualsivoglia firma (né digitale, né autografa scansionata con attestazione), il ricorso sarà dichiarato inammissibile perché non sottoscritto dall’abilitato. L’unica speranza – davvero remota – è che il giudice consideri la PEC certificata come una sorta di firma implicita (ma dubito, occorre proprio la sottoscrizione). Forse il tuo avvocato, accortosi, potrebbe provare a rinotificare un ricorso corretto entro i termini se ancora possibili. Se i termini sono passati, il danno è fatto. Questo evidenzia come nel processo telematico vada prestata attenzione: firma digitale sul file prima di spedirlo! Senza, l’atto è come una lettera anonima… In definitiva, molto probabilmente il ricorso sarà respinto per vizio formale insanabile.
D6. Il ricorso introduttivo non indica espressamente il valore della controversia. È un problema ai fini dell’ammissibilità?
R: Di per sé la mancata indicazione del valore non rende nullo il ricorso. Tuttavia, la legge sul contributo unificato dice che se non indichi il valore, si presume il massimo (oltre €200.000) e devi pagare il contributo massimo. Quindi il rischio principale è che tu possa aver versato un C.U. insufficiente. L’Avvocatura dello Stato spesso, in questi casi, chiede di regolarizzare il pagamento del contributo e finché non lo fai potrebbe chiedere di non procedere (improcedibilità). In pratica: non è un vizio del ricorso tale da farlo rigettare immediatamente, ma comporta conseguenze sul contributo unificato. Se il valore non era indicato, il giudice ti può invitare a specificarlo e a pagare l’eventuale differenza di C.U. Qualora tu non lo faccia, potrebbe arrivare una pronuncia di inammissibilità legata al mancato pagamento del contributo (più che al valore in sé). Quindi, pur non essendo una causa di nullità automatica, è bene sempre indicare il valore. Così eviti equivoci e calcoli forfettari svantaggiosi.
D7. Ho impugnato una cartella di pagamento, ma solo dopo la notifica di un’intimazione di pagamento (non avevo impugnato la cartella nei 60 giorni). Posso eccepire in quel ricorso che la cartella non mi era stata notificata regolarmente?
R: Questa è una questione complessa che tocca giurisdizione e decadenze. Secondo la Cassazione (ord. 23346/2024), se non hai impugnato la cartella nei termini e questa è divenuta definitiva, non puoi più contestarne i vizi notificatori in occasione dell’intimazione successiva. In pratica dicono: dovevi impugnare l’atto presupposto al momento giusto; se l’hai lasciato passare, la pretesa si è consolidata e non puoi sollevare ex post motivi di rito su di essa. Quindi, se nel ricorso contro l’intimazione provi a eccepire che la cartella era nulla per notifica viziata, il giudice potrebbe dichiarare inammissibile l’eccezione (o infondato il motivo) per preclusione da mancata impugnazione. È come dire: la cartella non impugnata è “giudicato interno”. Fanno eccezione le ipotesi in cui la cartella era completamente ignota e impugnare l’intimazione è l’unica via (vedi SU 8445/2022): lì la giurisdizione tributaria ti consente di fare valere la mancata notifica, ma devi aver impugnato l’intimazione stessa. Se invece hai fatto passare anche quella, allora nulla da fare. Insomma, conviene sempre impugnare ogni atto lesivo nei tempi giusti. Le contestazioni su atti non impugnati a tempo debito rischiano di essere respinte come tardive.
D8. Ho ricevuto due atti identici per lo stesso tributo e ho presentato due ricorsi separati, pensando fossero diversi. Posso aver problemi?
R: Se davvero si tratta di duplication (due ricorsi riguardanti la stessa pretesa fiscale tra le stesse parti), allora sì, c’è un problema di litispendenza. Il giudice ne potrà portare avanti uno solo; l’altro verrà dichiarato inammissibile per litispendenza. Di solito prevale il primo ricorso presentato in ordine di tempo (o quello con numero di ruolo minore). L’effetto pratico è che uno dei due verrà estromesso e, se avevi pagato due contributi, uno andrà perso. Per evitare dubbi, avvisa la Commissione magari con una istanza di riunione o precisazione, spiegando che i due ricorsi sono identici e chiedendo di unirli. Così eviti rischi di decisioni contrastanti e magari ti fai restituire un contributo unificato. In generale, mai duplicare le impugnazioni: se succede per errore, segnala subito al giudice la cosa. Ricorda anche: se una questione è già stata decisa con sentenza passata in giudicato, un nuovo ricorso sulla stessa questione è inammissibile (giudicato esterno). Quindi nemmeno in appello o in un altro grado puoi ri-argomentare cose coperte da giudicato.
D9. In appello posso aggiungere motivi nuovi o chiedere cose diverse rispetto al primo grado?
R: No, l’art. 57 D.Lgs. 546/92 vieta espressamente di proporre in appello nuove domande o nuove eccezioni che non siano già comprese nel perimetro del primo grado. Puoi solo “riproporre le domande ed eccezioni non accolte” in primo grado e semmai ampliare le argomentazioni sui motivi già dedotti. Ma non puoi introdurre un capo di domanda del tutto nuovo. Ad esempio, se in primo grado chiedevi solo l’annullamento dell’atto, non puoi in appello per la prima volta chiedere il rimborso di un credito o sollevare un vizio che non avevi sollevato (salvo sia una eccezione rilevabile d’ufficio dal giudice, come difetto di giurisdizione: quelle la CTR le può rilevare comunque). Se provi ad aggiungere qualcosa di nuovo, la CTR la dichiarerà inammissibile d’ufficio. Ad esempio, Cass. 13317/2020 conferma che un motivo nuovo introdotto in appello va stralciato. Quindi, la regola pratica: giocati tutte le carte in primo grado. In appello potrai semmai perfezionare le tesi, ma non inventarti nuove pretese.
D10. Il difensore ha depositato il ricorso ma non ha allegato la procura firmata dal cliente. Il ricorso può andare avanti?
R: Sì, di norma il giudice tributario ti darà modo di rimediare. L’orientamento ormai consolidato è che la mancanza della procura alle liti non comporta più la morte immediata del ricorso, ma solo una sua sospensione finché non regolarizzi. Il giudice ti manderà probabilmente un invito a depositare la procura mancante (magari entro 20 o 30 giorni). Se tu depositi una procura valida, datata e firmata dal cliente, il ricorso verrà considerato valido come se la procura ci fosse stata fin dall’inizio (nullità sanata). Se invece ignorassi l’ordine di depositare la procura, allora sì, il ricorso verrebbe dichiarato inammissibile per difetto di procura. Quindi, certo, il ricorso può andare avanti ma a condizione che integriate la procura. Consiglio: quando depositi telematicamente, verifica sempre di aver allegato la delega firmata; gli errori capitano ma per fortuna c’è questo paracadute.
D11. L’ufficio non si è costituito in giudizio nel termine. Questo può aiutarmi a sanare eventuali vizi del mio ricorso (es. notifica irregolare)?
R: Se l’ufficio (ente impositore) non si costituisce affatto, non sanerà alcun vizio del tuo ricorso, anzi semmai li aggraverà. Mi spiego: se tu avevi notificato male il ricorso e l’ente rimane contumace, il giudice non può essere sicuro che l’ente abbia avuto conoscenza dell’impugnazione, perciò tenderà a dichiarare inammissibile il ricorso per notifica nulla, invece di accoglierlo nel merito a tuo favore. Insomma, l’assenza del resistente non è come nel processo civile dove a volte il convenuto contumace subisce la contumacia; qui se la notifica era viziata, la contumacia non sana nulla. Diverso: se l’ufficio si costituisce tardivamente (oltre i 60 giorni dalla notifica del ricorso) e non eccepisce nulla, allora quell’atto di costituzione tardiva potrebbe essere interpretato come accettazione del contraddittorio e sanatoria di eventuali vizi (questo in teoria, ma di solito la costituzione tardiva dell’ufficio viene ammessa senza problemi). Quindi, la mancata costituzione del resistente non ti avvantaggia sui vizi del tuo ricorso; al massimo, se il tuo ricorso era perfetto, potresti ottenere una sentenza a tuo favore in contumacia dell’ente (ma attenzione: il giudice deve comunque esaminare il merito, non è automatico vincere perché l’altro non c’è). E se c’era un vizio tuo, la contumacia non lo sana. Concludendo: l’ufficio che non si costituisce non eccepisce nulla, ma il giudice tiene conto lo stesso d’ufficio dei tuoi eventuali errori procedurali.
D12. Ho ricevuto un avviso e ho presentato reclamo-mediazione nel 2023, ma l’ente non ha risposto entro 90 giorni. Devo fare qualcosa per perfezionare il ricorso?
R: Se hai presentato il reclamo-mediazione contestualmente al ricorso (com’era la prassi), dopo i 90 giorni il tuo ricorso diventa procedibile automaticamente. In teoria avresti dovuto depositare il ricorso in CTP contestualmente alla notifica del reclamo (dopo la riforma del 2016 funzionava così: si notifica il ricorso/reclamo e lo depositi subito; poi la Commissione sospende l’esame per 90 giorni). Se l’ente non risponde o rigetta la mediazione, trascorsi i 90 giorni devi attivarti per far proseguire il giudizio: in pratica chiedi la fissazione dell’udienza, oppure depositi una memoria con cui comunichi l’esito negativo della mediazione. Molte CTP richiedevano che il contribuente depositasse una dichiarazione di mancato accordo per togliere la causa dal ruolo di sospensione. Se non fai nulla, in teoria potresti far decadere il ricorso, ma di solito fissano comunque l’udienza dopo i 90 giorni. Visto che il reclamo-mediazione è stato abolito dal 2024, nel tuo caso che è 2023 seguono ancora le vecchie regole: il consiglio è di verificare in segreteria se devi formalizzare la riassunzione. Spesso l’atto di ricorso conteneva già una clausola tipo “si chiede sin d’ora, in difetto di accoglimento del reclamo, la trattazione del ricorso decorso il termine di legge”, quindi potrebbe bastare quello. Se l’ente ha inviato un esito negativo (diniego), depositalo. In sintesi: dopo 90 giorni senza accordo, il tuo ricorso va avanti; assicurati solo che la Commissione lo sappia, così da rimetterlo sul ruolo attivo. Non farlo giacere in sospeso troppo a lungo altrimenti rischi che lo considerino rinunciato.
D13. L’Agenzia ha annullato in autotutela l’atto mentre il ricorso era pendente. Il processo si chiude automaticamente?
R: Non automaticamente, ma se entrambe le parti ne danno atto, il giudice dichiarerà la cessata materia del contendere. Dovresti presentare un’istanza informando la Commissione che l’atto impugnato è stato annullato dall’ente (allega la prova, es. provvedimento di autotutela o comunicazione ufficiale). In udienza, il giudice prenderà atto che non c’è più litigio: emanerà un’ordinanza o sentenza che dichiara la causa estinta per sopravvenuta carenza di interesse. Di solito condannano l’ente alle spese (perché l’autotutela arriva grazie al tuo ricorso), ma su questo possono anche compensare se l’ente ha annullato subito riconoscendo l’errore. Quindi, rispondendo: sì, il processo si chiude, ma deve essere formalmente chiuso dal giudice con un provvedimento. Fino ad allora, tecnicamente il processo pende, ma tu hai interesse a farlo chiudere per avere nero su bianco l’estinzione e la liquidazione delle spese eventualmente. Presenta dunque istanza congiunta se riesci (fatta firmare anche dalla controparte) per dichiarare cessata materia.
D14. L’atto impugnato riguarda due contribuenti (coobbligati solidali). Uno ha fatto ricorso, l’altro no. È un problema?
R: Potrebbe. In certi casi di litisconsorzio necessario, tutti i soggetti interessati devono partecipare al giudizio, altrimenti esso è nullo. Nel tributario il litisconsorzio necessario non è molto frequente, ma esiste ad esempio per i soci di società di persone insieme alla società, in impugnazioni di accertamenti imputati per trasparenza. Oppure, in caso di coobbligati solidali per imposta di registro (cedente e cessionario di un contratto): se notifica l’avviso a entrambi e ricorre solo uno, si pone il dubbio. La Cassazione ha altalenato su questo. Diciamo così: se l’atto è uno e unico riferito a più soggetti, idealmente devono tutti costituirsi. Se uno non lo fa, il giudice può ordinare di integrarlo (chiamando l’altro). Se non si integra, la sentenza potrebbe non fare stato per l’assente, con rischi di contrasto. Non sempre dichiarano inammissibile il ricorso del singolo – spesso decidono ugualmente, ma poi quell’esito non vincola il coobbligato assente. Per cautela, se sai che c’è un altro soggetto parimenti interessato, inseriscilo tra i ricorrenti (ricorso congiunto) o almeno menzionalo. Se invece l’altro non vuole aderire, segnala al giudice la sua esistenza: deciderà lui se disporre l’integrazione. Non è una classica “questione di rito” come le altre, ma tocca il contraddittorio. In sintesi, potrebbe non essere immediato motivo di inammissibilità, però può complicare la validità della decisione. Meglio prevenire chiamando tutti i litisconsorziati.
D15. L’ufficio ha depositato documenti nuovi in appello; posso eccepire qualcosa a livello procedurale?
R: Nel processo tributario, in appello sono ammesse nuove prove documentali se il collegio le ritiene rilevanti e se non era stato possibile produrle prima (art. 58 D.Lgs. 546/92). Quindi l’ufficio può produrre nuovi documenti in secondo grado, e questo di per sé non è vietato. Non è come le nuove domande (quelle sì sono inammissibili). Puoi opporti solo se i documenti erano notoriamente già disponibili in primo grado e l’ufficio li ha tenuti nel cassetto: in tal caso potresti eccepire la tardività e chiedere di non ammetterli. Ma spesso i giudici di secondo grado li ammettono per completezza. Quindi non è una questione di rito forte su cui puntare. Diverso se fossero documenti totalmente estranei ai motivi di causa (ma allora sarebbero irrilevanti). Insomma, preparati a contestarne il contenuto nel merito, più che a escluderli processualmente.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 4 (abrogato), 5, 12, 16-bis, 17-bis (abrogato dal 2024), 18, 19, 21, 22, 23, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 61 e ss. – Disciplina del processo tributario (come modificato da L. 130/2022 e D.Lgs. 156/2015, D.Lgs. 220/2023, ecc.).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 49, 50, 72-bis, 77, 86 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte (ruolo, cartella, pignoramento, ipoteca, fermo).
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), artt. 6 e 7 – Tutele del contribuente sui termini (sospensione feriale, termini a favore) e obbligo di indicazione di termini e organi impugnazione negli atti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 e 14 – Contributo unificato nel processo tributario (importi e valore della lite).
Legge 31 agosto 2022, n. 130, e D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 – Riforma della giustizia tributaria (giudici tributari, abrogazione reclamo/mediazione dal 2024, generalizzazione PTT).
Cass. civ. Sez. Unite, 15/03/2022, n. 8465 – Giurisdizione tributaria vs. ordinaria in materia di riscossione coattiva: discrimine della cartella di pagamento.
Cass. civ. Sez. Unite, 29/01/2025, n. 2098 – Giurisdizione su pignoramenti tributari ex art. 72-bis DPR 602/73: competente il giudice tributario per contestazioni sulla pretesa (prescrizione, notifica cartelle), giudice ordinario per soli vizi formali atto esecutivo.
Cass. civ. Sez. Unite, 14/04/2020, n. 7822 – Giurisdizione tributaria su fatti incidenti sul credito fino alla notifica cartella; giudice ord. su atti esecutivi successivi.
Cass. civ. Sez. Unite, 21/12/2022, n. 37445 – Conferma giurisdizione tributaria estesa a tutte le cartelle per crediti tributari (anche addizionali locali, ecc.).
Corte Costituzionale, 17/05/2018, n. 114 – Linea di confine giurisdizione: atti della riscossione forzata post-cartella spettano al giudice ordinario.
Cass. civ. Sez. V, 24/02/2025, n. 4815 (ord.) – Processo tributario telematico: notifica cartacea del ricorso è nulla insanabile; mancato pagamento contributo unificato rende il ricorso inammissibile.
Cass. civ. Sez. V, 19/02/2025, n. 585 (ord.) – Notifica PEC non perfezionata: nullità sanabile se ufficio costituito (principio di sanatoria dei vizi di notifica).
Cass. civ. Sez. V, 29/08/2024, n. 23346 (ord.) – Impugnazione di atti successivi: intimazione non impugnata rende definitiva la cartella e preclude eccezioni tardive su notifica.
Cass. civ. Sez. V, 14/07/2023, n. 20322 (ord.) – Mancato deposito del ricorso nei 30 gg => ricorso inammissibile; litispendenza rilevabile e comporta inammissibilità.
Cass. civ. Sez. trib., 07/03/2024, n. 6864 – Difetto di legittimazione: ricorso proposto da soggetto non titolato (o contro soggetto non competente) è inammissibile; errata individuazione Commissione => inammissibilità salvo invio atti a competente.
Cass. civ. Sez. Unite, 27/05/2010, n. 12059 – Assistenza tecnica obbligatoria come condizione di procedibilità: difetto sanabile mediante invito a munirsi di difensore (litisconsorzio necessario tecnico).
Cass. civ. Sez. Unite, 21/12/2004, n. 22601 – Procura alle liti mancante: nullità non immediata, possibilità di regolarizzazione in corso di causa.
Cass. civ. Sez. V, 06/02/2020, n. 2843 (ord.) – Ricorso tributario privo di motivi specifici e petitum chiaro: inammissibile per incertezza assoluta sull’oggetto.
Cass. civ. Sez. V, 18/09/2013, n. 21850 – Principio di lesività: atti non lesivi (come provvedimenti non definitivi) non impugnabili; necessità di interesse concreto ad agire.
Corte Costituzionale, 07/04/2014, n. 98 – Illegittimità costituzionale dell’art. 17-bis (testo originario 2011) nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale per mancato reclamo/mediazione (violazione diritto azione).
Corte Costituzionale, 11/07/2000, n. 189 – Legittima la previsione di obbligo difensore tecnico, ma va garantito meccanismo di regolarizzazione per evitare eccessive decadenze.
CTR Sicilia (Palermo), 31/07/2017, n. 2834 – Irregolarità della procura: giudice invita a regolarizzare invece di dichiarare inammissibile (orientamento favorevole alla sanatoria).
Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 2012 – Mediazione tributaria: indicazioni applicative (ora superate dall’abrogazione).
Circolare MEF-DGT n. 1/2024 (Comunicato Stampa MEF n. 13/2024) – Chiarimenti transitori sull’abrogazione del reclamo-mediazione: applicazione ai ricorsi notificati dal 4/1/2024.
Sito Giustizia Tributaria – FAQ e guide sul Processo Tributario Telematico (dgt.mef.gov.it) – Indicazioni pratiche su notifiche PEC, depositi telematici, contributo unificato, ecc.
Hai avviato un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate o un altro ente fiscale e hai sentito parlare di “questioni di rito”? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai avviato un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate o un altro ente fiscale e hai sentito parlare di “questioni di rito”? Ti stai chiedendo se possono bloccare o far annullare il giudizio ancora prima che si entri nel merito?
Nel processo tributario, le questioni di rito riguardano la regolarità formale del procedimento, ossia tutto ciò che attiene alla validità dell’atto e del processo, a prescindere dal contenuto fiscale della contestazione. Sono spesso decisive, perché se fondate, possono portare all’annullamento dell’atto senza entrare nel merito.
🧾 Esempi di questioni di rito
- Notifica irregolare dell’avviso di accertamento o della cartella
- Ricorso presentato fuori termine
- Mancata motivazione dell’atto impugnato
- Incompetenza territoriale della Commissione adita
- Difetto di legittimazione attiva o passiva (chi ha proposto il ricorso o contro chi è stato proposto)
- Mancata sottoscrizione del ricorso o dell’atto impugnato
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza gli atti impugnati e la documentazione ricevuta per individuare eventuali vizi procedurali
- 📌 Verifica la corretta instaurazione del processo e il rispetto dei termini e delle regole processuali
- ✍️ Redige eccezioni preliminari fondate su questioni di rito, capaci di far annullare l’intero procedimento
- ⚖️ Ti rappresenta in giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, anche in fase di appello
- 🔁 Ti assiste in eventuali procedimenti successivi, come sospensioni, revoche o impugnative dell’esecutività
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale
- ✔️ Specializzato nella gestione di ricorsi fondati su questioni di rito e vizi procedurali
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Le questioni di rito sono spesso la prima linea di difesa nel processo tributario. Se rilevate e fatte valere in tempo, possono bloccare l’azione del Fisco anche senza discutere il merito del caso.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa comincia dalle fondamenta.