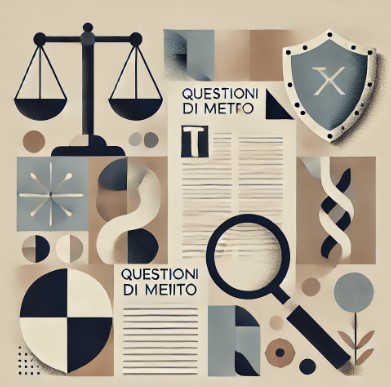Hai sentito parlare di questioni di merito nel processo tributario, ma non sai esattamente cosa significhi?
Se stai affrontando un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate o stai valutando un ricorso fiscale, è fondamentale capire cosa sono le questioni di merito, perché sono importanti e come possono incidere sull’esito della causa.
Cosa si intende per questioni di merito nel processo tributario?
Le questioni di merito riguardano il contenuto sostanziale della pretesa tributaria, cioè la legittimità e fondatezza del tributo richiesto. In altre parole, ci si chiede se l’imposta, la sanzione o il recupero fiscale contestato siano dovuti o meno nel caso concreto.
Esempi tipici di questioni di merito sono:
– Se l’imposta è stata calcolata correttamente
– Se il reddito contestato è realmente esistente e imponibile
– Se il contribuente aveva diritto a una detrazione, deduzione o esenzione
– Se l’Agenzia ha applicato in modo corretto la normativa fiscale
– Se un costo è effettivamente inerente e documentato
– Se il reddito contestato era già tassato all’estero, oppure non era tassabile in Italia
Come si differenziano dalle questioni formali o procedurali?
Le questioni di merito attengono al contenuto della lite fiscale (es. l’ammontare dovuto, l’esistenza del debito), mentre le questioni formali riguardano aspetti tecnici come errori nella notifica, decadenze, vizi dell’atto o mancanza di motivazione.
Perché è importante distinguere le questioni di merito?
– Perché il giudice tributario decide nel merito solo se non rileva vizi formali invalidanti dell’atto
– Perché molte strategie difensive si basano sulla contestazione del merito, ad esempio dimostrando che il reddito contestato non esiste o che il contribuente ha agito in buona fede
– Perché solo chi imposta correttamente la difesa sul piano sostanziale può ottenere una pronuncia favorevole sul contenuto del tributo
Come si difende un contribuente sulle questioni di merito?
– Portando prove documentali e contabili a sostegno della propria tesi (es. fatture, contratti, bilanci, bonifici, perizie)
– Contestando l’applicazione errata della norma fiscale o l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
– Dimostrando che l’imposta è già stata versata, o che il reddito è esente o non imponibile
– Affidandosi a un professionista per predisporre una memoria difensiva completa e ben articolata
Cosa può ottenere il contribuente contestando il merito?
– L’annullamento totale o parziale dell’atto impugnato
– La riduzione delle imposte richieste
– L’esclusione di sanzioni se dimostra la buona fede e la correttezza del comportamento
– La possibilità di evitare un accertamento basato su presunzioni o ricostruzioni arbitrarie
Attenzione: molte difese fiscali si concentrano solo su vizi formali (notifica, motivazione), ma le questioni di merito sono spesso decisive per vincere davvero nel processo tributario. Se il contribuente riesce a dimostrare che la pretesa fiscale è infondata, anche in parte, può ottenere un risultato concreto e duraturo.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario, difesa tecnica e impugnazione degli atti fiscali ti spiega cosa sono le questioni di merito, come affrontarle e come costruire una strategia vincente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
Stai valutando un ricorso o vuoi contestare nel merito una cartella o un accertamento?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a difenderti sul piano sostanziale e a tutelare i tuoi diritti fiscali nel modo più efficace.
Introduzione
Nel processo tributario italiano, le questioni di merito rappresentano il fulcro della controversia fiscale. Si tratta degli aspetti sostanziali del rapporto tributario in disputa, ovvero tutto ciò che attiene alla fondatezza della pretesa tributaria contestata. In altre parole, sono le questioni che riguardano il merito del contenzioso: se e in che misura il tributo sia dovuto, se l’accertamento fiscale sia corretto nel merito dei fatti e del diritto applicabile, l’esistenza o meno dell’obbligazione tributaria e la sua quantificazione.
Queste questioni si contrappongono alle questioni di rito (o procedurali), che invece riguardano la regolarità formale e processuale del contenzioso (ad esempio la tempestività del ricorso, la competenza del giudice, la validità della notifica dell’atto impugnato, ecc.). Mentre le questioni di rito mirano a verificare se il processo possa procedere regolarmente, le questioni di merito mirano a ottenere una decisione sulla sostanza del rapporto fiscale tra contribuente e Fisco.
Aggiornata a luglio 2025, questa guida esamina in dettaglio cosa si intende per questioni di merito nel processo tributario, alla luce delle più recenti riforme normative (come la riforma fiscale del 2023 e il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220) e della giurisprudenza aggiornata (sentenze di Corte di Cassazione, Corte Costituzionale e Corti di Giustizia tributaria regionali). L’obiettivo è fornire un quadro avanzato ma chiaro, con un taglio giuridico-divulgativo utile sia agli avvocati tributaristi sia a privati e imprenditori coinvolti in contenziosi fiscali. Troverete, oltre alle spiegazioni dottrinali, tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti e alcune simulazioni pratiche basate su casi reali semplificati, il tutto dal punto di vista del debitore-contribuente.
Definizione delle questioni di merito nel processo tributario
In termini generali, per questioni di merito si intendono tutte le contestazioni che riguardano la sostanza della pretesa fiscale oggetto del processo. Nel processo tributario, questo significa esaminare se il contribuente effettivamente deve pagare il tributo contestato, in quale misura, su quali basi di fatto e di diritto. Rientrano nelle questioni di merito ad esempio:
- la corretta quantificazione dei redditi, imponibili o valore su cui è calcolata l’imposta;
- l’applicazione delle norme tributarie sostantive, ad esempio se un certo reddito è tassabile o esente, se una detrazione o esenzione spetta o meno;
- la sussistenza del presupposto d’imposta, ossia se si sono verificati i fatti che la legge collega all’obbligo tributario (es. la realizzazione di un reddito, il possesso di un immobile, la ricezione di un’eredità, ecc.);
- l’entità della pretesa tributaria, comprensiva di imposta, sanzioni e interessi, e la verifica di eventuali errori di calcolo;
- eventuali cause di estinzione o riduzione dell’obbligazione tributaria (es. prescrizione o decadenza del potere di accertamento, condoni, definizioni agevolate, ecc.), le quali incidono sul merito perché determinano se il tributo è ancora dovuto;
- la valutazione delle prove sui fatti fiscali contestati (es. documenti contabili, perizie, contratti): stabilire quali fatti sono provati e quali no è parte integrante del giudizio di merito.
In sostanza, le questioni di merito attengono a “chi ha ragione nel merito della causa”, ossia se l’atto impositivo impugnato (tipicamente un avviso di accertamento, una cartella di pagamento, un provvedimento di diniego di rimborso, ecc.) sia giustificato nella sostanza. Il giudice tributario, quando decide sul merito, valuta i fatti e applica la legge tributaria sostanziale a quei fatti per stabilire l’esito della pretesa fiscale.
Va evidenziato che storicamente il processo tributario italiano è classificato come processo di impugnazione-merito, in contrapposizione al modello di impugnazione-annullamento proprio, ad esempio, del processo amministrativo ordinario. Ciò significa che non ci si limita a verificare se l’atto impugnato sia legittimo o meno, ma si mira ad ottenere una pronuncia sostitutiva sul rapporto tributario: il giudice tributario è chiamato idealmente a rideterminare la situazione fiscale tra le parti. La Corte di Cassazione, con una giurisprudenza ormai consolidata, ha infatti affermato che “il giudizio tributario […] non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria”. In altri termini, una sentenza tributaria di merito accoglie o rigetta il ricorso non solo dichiarando valido o nullo l’atto, ma ridefinendo la posizione fiscale del contribuente (ad esempio annullando integralmente l’imposta richiesta, oppure riducendone l’ammontare, ecc.).
Tuttavia, questa decisione sostitutiva avviene entro confini ben precisi: il giudice non può attribuire al Fisco più di quanto richiesto né fondare la decisione su ragioni del tutto estranee a quelle emerse nel contraddittorio. Come chiarito dalla Cassazione, la pronuncia sul merito avviene “previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, sia dalla dichiarazione resa dal contribuente che dall’accertamento dell’ufficio”. Ciò significa che:
- Limite delle ragioni nell’atto impugnato: il giudice può confermare, annullare o modificare l’accertamento solo per i motivi di merito dedotti dall’ufficio nell’atto e contestati dal contribuente. Non può introdurre d’ufficio una giustificazione nuova per far pagare il tributo su basi diverse da quelle esposte nell’avviso di accertamento (pena violazione del principio dispositivo e del contraddittorio). Ad esempio, se l’accertamento si fonda sul rilievo A, il giudice non può rigettare il ricorso adducendo un diverso rilievo B che non era contenuto nell’atto iniziale.
- Limite della domanda del contribuente e dell’accertamento: simmetricamente, il giudice non può neppure andare ultra petita a favore del Fisco aumentando l’imposta oltre quanto richiesto nell’accertamento impugnato, né può concedere al contribuente più di quanto da lui richiesto (salvo i casi di accoglimento totale che annullano l’intera pretesa). Il processo tributario resta pur sempre un processo di impugnazione in cui il contribuente definisce l’oggetto del giudizio con il suo ricorso e l’Amministrazione con l’atto impugnato; il giudice deve muoversi entro questo perimetro.
Le questioni di merito, dunque, comprendono ogni profilo sostanziale del rapporto fiscale dedotto in giudizio, e il giudice tributario ha il dovere di esaminarle tutte quelle rilevanti ai fini della decisione. Se il contribuente solleva più motivi di ricorso sul merito (es. contestazione del metodo di accertamento, contestazione dell’aliquota applicata, eccezione di prescrizione, ecc.), la sentenza dovrebbe pronunciarsi su ciascuno di essi, salvo quelli eventualmente assorbiti da altri motivi accolti (sul punto dell’assorbimento, si veda più avanti). L’art. 36 del D.Lgs. 546/1992 (come modificato dalla riforma del 2023) oggi richiede espressamente che la sentenza contenga “l’indicazione succinta dei motivi di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell’atto”. Questo implica che il giudice tributario in sentenza deve dar conto separatamente delle ragioni per cui accoglie o rigetta i motivi di merito addotti dal contribuente, distinguendoli eventualmente dalle questioni formali (vizi dell’atto) che siano state sollevate.
Questioni di merito vs questioni di rito: differenze e implicazioni
È fondamentale distinguere nettamente le questioni di merito dalle questioni di rito (o pregiudiziali di procedura) nel processo tributario, poiché esse seguono logiche diverse e hanno effetti diversi sul giudizio. Di seguito una tabella riepilogativa delle differenze principali:
| Profilo | Questioni di merito | Questioni di rito (procedurali) |
|---|---|---|
| Definizione | Riguardano la sostanza della pretesa tributaria: se il tributo è dovuto, in che misura, secondo quali norme sostanziali. | Riguardano la regolarità del processo e dell’atto impugnato: competenza, ammissibilità, procedure seguite, vizi formali dell’atto. |
| Esempi | – Errata applicazione di un’aliquota o di una norma impositiva- Computo sbagliato dell’imponibile o dell’imposta- Insussistenza del presupposto d’imposta (es: reddito inesistente)- Prescrizione o decadenza del tributo- Illegittimità costituzionale della norma impositiva (questione che incide sul merito della pretesa) | – Ricorso presentato oltre i termini (tardività)- Notifica dell’atto viziata o nulla- Difetto di giurisdizione o incompetenza della Commissione- Difetto di legittimazione attiva/passiva in giudizio- Vizi formali dell’atto (mancata motivazione, mancata sottoscrizione, ecc.) |
| Momento di esame | Vengono esaminate dopo le questioni di rito. Il giudice affronta il merito solo se il processo è valido e l’atto impugnato non viene annullato per motivi formali preliminari. | Vengono esaminate prima del merito, in quanto possono definire il giudizio senza bisogno di affrontare la sostanza. Sono pregiudiziali: se fondate, il giudice chiude il caso (es. dichiarando il ricorso inammissibile o annullando l’atto per vizio procedurale) senza valutare il merito. |
| Effetti sul processo | Se accolta una questione di merito (es: il tributo non è dovuto), la sentenza decide nel merito: annulla l’atto impositivo (in toto o in parte) per ragioni sostanziali e chiude la controversia fiscale sul punto. Se tutte le questioni di merito sono respinte, il ricorso viene rigettato nel merito (il tributo risulta dovuto). | Se accolta una questione di rito, blocca o chiude il processo senza entrare nel merito. Esempio: se il ricorso è tardivo, viene dichiarato inammissibile; se l’atto è nullo per difetto di notifica, viene annullato per vizio di forma. In entrambi i casi il merito (la fondatezza della pretesa fiscale) non viene analizzato. |
| Possibilità di sanatoria | In genere, le questioni di merito, essendo legate al rapporto sostanziale, non possono essere sanate se fondate: ad es., se il tributo non è dovuto, non c’è “sanatoria” che tenga, il giudice deve darne atto. Possono semmai essere superate da fatti successivi (condoni, pagamenti, ecc.) intervenuti nel corso del giudizio. | Alcuni vizi procedurali possono essere sanati o superati: es. un vizio di rappresentanza (mancata nomina del difensore) può essere sanato invitando la parte a regolarizzare. Molti vizi, però, se non eccepiti tempestivamente dal contribuente, si considerano convalidati: la Cassazione ha chiarito che anche i vizi invalidanti degli atti tributari sono eccezioni di parte che devono essere sollevate nei termini, altrimenti l’atto – pur viziato – si consolida. |
In pratica, dunque, le questioni di rito fungono da filtro preliminare. Il giudice tributario è tenuto dapprima a verificare che il processo sia validamente instaurato e che l’atto impugnato non presenti vizi formali tali da dover essere annullato immediatamente; solo dopo passa a valutare il merito della pretesa fiscale. Questo approccio “a due stadi” è comune a molti rami del diritto processuale: prima il rito, poi il merito.
Dal punto di vista strategico per il contribuente (debitore), è importante sollevare sia eventuali eccezioni di rito, sia le questioni di merito nel ricorso introduttivo. Le eccezioni di rito (es: notifica invalida, difetto di motivazione dell’atto, tardività dell’accertamento, ecc.) possono portare a una vittoria rapida – il giudice accoglie il ricorso senza neppure esaminare il merito – ma spesso non chiudono definitivamente la partita con il Fisco. Infatti, se l’annullamento avviene per un vizio formale dell’atto, l’Amministrazione finanziaria può rimediare e riprendere la pretesa: ad esempio, se un avviso di accertamento viene annullato perché mancava la firma del funzionario competente, l’ufficio può emetterne uno nuovo sanando quel difetto (purché siano ancora aperti i termini per farlo). Invece, una vittoria fondata sul merito (ad esempio “il reddito non era imponibile” oppure “il tributo è decaduto”) preclude in genere definitivamente una nuova pretesa sullo stesso fatto, perché forma cosa giudicata sostanziale sul rapporto tributario.
Esempio esplicativo: Tizio riceve un avviso di accertamento per IRPEF ritenendo che sia infondato in quanto ha già pagato tutte le imposte dovute. Nel ricorso Tizio eccepisce due cose: (1) che l’atto è nullo perché notificato oltre il termine di decadenza; (2) che, nel merito, l’Ufficio ha male interpretato i suoi redditi, tassando somme non dovute. Se la Commissione tributaria accoglie la prima eccezione (vizio di rito), annulla l’atto senza valutare i redditi: vittoria di Tizio, ma solo formale. L’Agenzia potrebbe emettere un nuovo atto (ad esempio, se la decadenza non era effettivamente maturata, oppure contando su una sospensione dei termini), oppure appellare la sentenza. Se invece il giudice respinge la questione di decadenza ma accerta che Tizio, nel merito, ha ragione (ad es. le somme erano esenti da IRPEF), accoglie il ricorso sul merito: annulla l’accertamento per infondatezza della pretesa. In tal caso l’Agenzia non potrà più pretendere quel tributo (salvo appello o ricorso per Cassazione, ovviamente). Nel dubbio, Tizio ha fatto bene a sollevare entrambe le questioni: se avesse puntato solo sul merito e avesse avuto torto su quello, avrebbe perso la causa; viceversa, se avesse puntato solo sul vizio formale e poi l’ufficio avesse potuto rinnovare l’atto, avrebbe solo ritardato il pagamento senza risolvere la questione sostanziale.
Un altro aspetto peculiare: cosa accade se il giudice omette di pronunciarsi su una questione? In Cassazione, la omessa pronuncia è motivo di nullità della sentenza (error in procedendo ex art. 360 n.4 c.p.c.) ma solo se riguarda domande o eccezioni di merito. La giurisprudenza ha infatti chiarito che l’omessa pronuncia è configurabile solo in caso di mancato esame di questioni di merito, **“e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale”*. In altre parole, se il giudice dimentica di decidere su un motivo di ricorso di merito sollevato dal contribuente, la sentenza sarà impugnabile per omessa pronuncia; ma se “salta” una questione di solo rito (magari ritenendola assorbita), ciò non integra vizio di omessa pronuncia. Anche per questo il giudice spesso, quando accoglie un’eccezione preliminare e chiude il caso, dichiara assorbiti i motivi di merito, in modo da far capire che non li ha esaminati perché non necessario. Con la riforma del 2023, come detto, l’art. 36 D.Lgs. 546/92 ora richiede di menzionare in motivazione i motivi di accoglimento o rigetto sia sulle questioni di merito che su quelle di nullità annullabilità dell’atto. Ciò dovrebbe ridurre i casi di mancata chiarezza sulle pronunce dei giudici tributari (che in passato a volte non motivavano sui punti assorbiti, generando incertezze).
Il giudizio di merito nel processo tributario: poteri del giudice e natura del giudizio
Come anticipato, il processo tributario è configurato come un giudizio di impugnazione-merito. Questo ha diverse conseguenze pratiche sul ruolo e sui poteri del giudice tributario di primo e secondo grado (oggi denominati Corti di Giustizia Tributaria di primo grado – ex Commissioni Tributarie Provinciali – e di secondo grado – ex Commissioni Regionali).
Innanzitutto, il giudice tributario di merito (giudice di primo e secondo grado) ha piena giurisdizione sul rapporto tributario in contestazione, pur nei limiti delle domande e dei motivi di cui si è detto. Ciò significa che se il ricorso viene accolto, il giudice annulla in tutto o in parte l’atto impugnato. Questa statuizione di annullamento può avvenire sia per motivi formali (es. nullità dell’atto) sia – soprattutto – per motivi di merito. Ma a differenza di un giudice amministrativo di solo annullamento, il giudice tributario di merito, quando accoglie nel merito, emette una decisione che in sostanza sostituisce l’accertamento fiscale: definisce lui l’obbligazione tributaria tra le parti. Ad esempio, se ritiene che il maggior reddito accertato dall’ufficio sia inferiore a quanto preteso, può rideterminare la cifra e annullare l’atto in parte qua. Se ritiene che nulla fosse dovuto, annulla integralmente l’atto (spesso si parla di “annullamento dell’avviso” pur se in realtà la sentenza ha natura di accertamento negativo del tributo).
Un principio affermato dalla Cassazione è che il giudice tributario non può limitarsi a annullare l’atto per motivi sostanziali senza quantificare il dovuto se dall’istruttoria emerga comunque un debito. In altri termini, “ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, riconosciuta l’incongruenza dell’accertamento dell’Ufficio, ha il dovere di decidere sul merito ed accertare la maggiore imposta dovuta”. Ciò capita, ad esempio, quando l’accertamento fiscale è solo parzialmente sbagliato: il giudice non dovrebbe annullarlo totalmente lasciando un vuoto, ma individuare l’importo corretto. Immaginiamo che il Fisco contesti ricavi non dichiarati per 100, ma il giudice accerti che in realtà i ricavi non dichiarati sono 60: invece di annullare l’accertamento tout court, dovrebbe dichiarare dovuta l’imposta sui 60. In questo senso, si dice appunto che è un giudizio di merito, volto a una “decisione sostitutiva dell’accertamento dell’amministrazione”.
Tuttavia, bisogna considerare i limiti pratici: il giudice tributario non ha uffici investigativi propri come l’Amministrazione; la sua decisione dipende dalle prove fornite dalle parti e dai fatti disponibili. In alcuni casi, può succedere che il giudice, pur ritenendo l’accertamento originario viziato (ad esempio perché basato su presunzioni troppo deboli), non abbia però elementi sufficienti per quantificare diversamente il tributo. In tali situazioni, la linea prevalente è che il giudice annulla comunque l’atto e semmai sarà l’Amministrazione, se ne ha facoltà, a emanare un nuovo atto meglio fondato (a meno che il vizio non fosse insanabile). È quanto avviene, per esempio, quando si annulla un accertamento induttivo perché gravemente infondato: si chiude quel giudizio, lasciando al Fisco la scelta se riprovarci con ulteriori elementi (se i termini lo consentono). Al contrario, quando in giudizio sono stati acquisiti abbastanza elementi per rideterminare l’imponibile, il giudice dovrebbe farlo.
La giurisdizione di merito del giudice tributario comprende anche il potere di valutare le prove. Egli può ammettere prove documentali, testimonianze (dal 2022 è stata introdotta in via sperimentale la testimonianza scritta nel processo tributario, sia pure con limiti stringenti), consulenze tecniche, ecc., sempre entro i limiti di legge. In particolare, l’art. 7 del D.Lgs. 546/92 conferisce al giudice tributario poteri istruttori, tra cui richiedere documenti alle parti o ad altre amministrazioni e, nei casi consentiti, disporre consulenze e perizie. Tradizionalmente era preclusa la prova testimoniale orale nel processo tributario, ma la riforma del 2022 (L. 130/2022) e i successivi decreti attuativi hanno introdotto una sperimentazione della testimonianza scritta. Ad oggi, la testimonianza è ammessa solo in forma di dichiarazione scritta extragiudiziale resa dal terzo, con valore meramente indiziario, per controversie su fatti accaduti a partire dal 1° gennaio 2023 (come da art. 4, comma 1-bis D.Lgs. 546/92 introdotto dalla L. 130/2022). Questo è un potenziamento dei poteri istruttori del giudice di merito, il quale però resta privo della possibilità di disporre ispezioni o perquisizioni (tipiche invece del processo penale o delle attività amministrative).
Un’altra caratteristica del giudizio tributario di merito è che si sviluppa su due gradi di merito: primo grado e appello. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex CTR) riesamina sia i fatti che il diritto, potendo confermare, riformare o annullare la sentenza di primo grado. In appello, tipicamente, l’Amministrazione ricorre se ha perso, contestando l’erronea valutazione del merito da parte del primo giudice, oppure il contribuente ricorre se è soccombente. Il giudice d’appello riesamina le questioni di merito già trattate e può anche valutare nuove circostanze sopravvenute. Non sono ammesse nuove domande in appello, ma possono essere presentati nuovi motivi di ricorso se derivano da fatti scoperti dopo il primo grado (c.d. motivi aggiunti in appello, soggetti però a limiti temporali e di notificazione). Soprattutto, è dibattuta la questione delle nuove prove in appello: prima della riforma 2022-2023 era pacifico che i nuovi documenti potessero essere prodotti liberamente anche in secondo grado (art. 58 D.Lgs. 546/92), mentre nuove prove orali o tecniche non erano ammesse se non in casi eccezionali. La riforma fiscale di fine 2023 (attuata col D.Lgs. 149/2022 per il processo civile e riflessi nel processo tributario) aveva irrigidito molto questo aspetto, introducendo un quasi-divieto di nova in appello anche per i documenti. In particolare, era stato previsto che non si potessero produrre in appello documenti che si sarebbero potuti produrre prima, includendo tra questi persino gli atti relativi alla rappresentanza processuale (come le deleghe e procure non allegate in primo grado). Questa novità ha destato preoccupazione, in quanto rischiava di penalizzare eccessivamente i contribuenti, specie in situazioni di contenzioso complesso. E infatti la Corte Costituzionale è intervenuta prontamente: con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025 ha dichiarato parzialmente illegittimo il nuovo art. 58 comma 3 D.Lgs. 546/92 (come modificato dal 2023) nella parte in cui imponeva tale divieto assoluto. La Consulta ha ritenuto irragionevole impedire la produzione in appello di documenti come la procura alle liti non allegata in primo grado, in quanto ciò violava il diritto di difesa e il principio del giusto processo. In concreto, la Corte Costituzionale ha “riaperto la possibilità di depositare in appello deleghe, procure e atti di legittimazione non prodotti prima”, eliminando l’automatismo della loro inutilizzabilità. Ha così ripristinato un margine di flessibilità: restano ferme le preclusioni per le vere e proprie nuove domande, ma quanto alle prove documentali la regola deve essere applicata in modo da non ledere il diritto di difesa. Questa pronuncia costituzionale è un esempio di come l’equilibrio tra esigenze di celerità del processo (evitare appelli dilatori con nuove allegazioni) e di completezza del vaglio di merito sia delicato e in continua evoluzione.
È interessante notare che la Corte di Cassazione già prima di questa sentenza costituzionale aveva interpretato restrittivamente il regime di preclusione probatoria, soprattutto riguardo all’art. 32 del DPR 600/1973 (che sanziona la mancata esibizione di documenti al Fisco in sede amministrativa con l’inutilizzabilità in giudizio degli stessi). La giurisprudenza di legittimità aveva affermato che tale preclusione doveva essere applicata con giudizio, per evitare di comprimere il diritto di difesa del contribuente. In linea con ciò, la Corte Costituzionale, sentenza n. 137 del 28 luglio 2025, ha ulteriormente rafforzato la posizione garantista: ha sottolineato che la regola dell’inutilizzabilità dei documenti non forniti in fase di verifica va interpretata in modo molto rigoroso e restrittivo, confermando che non possono essere pretesi dal contribuente documenti o informazioni che l’Amministrazione finanziaria già possiede. In pratica, se il contribuente in fase di controllo non ha prodotto un documento perché magari l’ufficio già lo aveva o poteva averlo, non gli si può poi impedire di usarlo in giudizio. Questa decisione (Cassazione e poi Consulta) tutela il merito del processo: evita che questioni di mera forma procedurale (come la fase di verifica) impediscano al giudice di merito di conoscere la verità materiale.
Riassumendo, primo e secondo grado del processo tributario sono sedi di accertamento del merito: il giudice può valutare nuove prove (sia pur con limiti), può rivedere i fatti e applicare il diritto in modo anche difforme dall’ufficio. Ogni grado di merito culmina in una sentenza che statuisce sul merito (salvo pronunce processuali come inammissibilità per rito). Invece, come vedremo, il giudizio di Cassazione è diverso, limitato alle questioni di legittimità.
Il giudizio di legittimità in Cassazione: limiti alle questioni di merito
La Corte di Cassazione rappresenta il terzo livello di giudizio nelle controversie tributarie, ma a differenza dei primi due gradi essa non è un giudice di merito, bensì un giudice di legittimità. Questo significa che in Cassazione non si possono riesaminare i fatti né rivalutare le prove liberamente: l’oggetto del giudizio è circoscritto alla verifica del corretto uso del diritto da parte dei giudici di merito e del rispetto delle norme processuali.
In termini pratici: se una parte soccombente (contribuente o Agenzia delle Entrate) ricorre in Cassazione, può far valere solo i motivi di impugnazione tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c., ossia principalmente:
- violazione o falsa applicazione di norme di diritto (errores in iudicando di diritto sostanziale o processuale);
- nullità della sentenza o del procedimento (vizi di attività processuale, es. violazione del contraddittorio, omessa pronuncia su un punto di merito – come detto sopra, ecc.);
- vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, nei limiti oggi molto ristretti dell’art. 360 n.5 c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo che era stato discusso).
Non è invece consentito ricorrere in Cassazione lamentando un “errore di giudizio sul fatto” da parte della CTR, né presentare nuove prove o rideporre la questione di merito come se fosse un terzo grado nel merito. La Cassazione non rivede la quantificazione del reddito, non ricalcola le imposte, non sente testimoni né acquisisce nuovi documenti (salvo quelli necessari ad decidendum su questioni processuali, come la prova della notifica degli atti, ecc.).
Questa impostazione comporta che molte questioni di merito non sono direttamente deducibili in Cassazione. Ad esempio, se la Commissione regionale ha valutato una prova testimoniale credendo ad un testimone invece che ad un altro, questa valutazione di merito è insindacabile in Cassazione (salvo il caso estremo di motivazione inesistente o contraddittoria, ma dopo la riforma del 2012 tale vizio è invocabile solo se la motivazione manca del tutto o salta un fatto decisivo). Ancora, se la CTR ha stimato un reddito in una certa misura, Cassazione non può dire “era troppo alto o troppo basso” – a meno che la CTR non abbia commesso un errore di diritto nel criterio, come applicare un tasso o un metodo non previsto dalla legge. Quindi in Cassazione la discussione verte più sui principi di diritto applicati che sul merito fattuale.
È importante per il contribuente capire che la Cassazione non è un terzo grado di merito: se si è perso sul fatto, difficilmente si può ribaltare in Cassazione. Ad esempio, se la CTR ha ritenuto non provato un costo e quindi ha confermato l’accertamento, non si può in Cassazione portare una fattura “dimenticata” o invocare una nuova perizia sui costi: quell’elemento doveva emergere prima. La Cassazione potrà al più verificare se la CTR ha applicato correttamente la norma sull’onere della prova o ha motivato adeguatamente il suo convincimento.
Detto ciò, la Cassazione può però intervenire su questioni di merito mediante l’applicazione del diritto: ad esempio può stabilire che una certa tipologia di provento è o non è imponibile secondo una corretta interpretazione normativa, e cassare la sentenza che avesse deciso diversamente. In tal caso incide sul “merito” in senso lato (perché stabilisce se quel reddito era tassabile), ma lo fa come giudice di legittimità, fissando la regola giuridica.
Quando la Cassazione accoglie un ricorso (per motivi di diritto o procedura), in genere rinvia la causa al giudice di merito (ad una diversa sezione della Corte tributaria che ha emesso la sentenza impugnata, oppure, oggi, a una Corte di giustizia tributaria di secondo grado diversa, se esistente, o ancora ad altra sezione competente). Il giudice di rinvio riesaminerà il merito attenendosi ai principi di diritto affermati dalla Cassazione. Solo in rari casi la Cassazione decide nel merito essa stessa ex art. 384 c.p.c.: ciò avviene se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ad esempio, se la Cassazione stabilisce che un certo tributo è non dovuto per prescrizione, e i fatti su decorrenza e sospensione dei termini sono già tutti accertati, allora può direttamente decidere definitivamente annullando l’atto (o la parte di pretesa) senza rinvio.
Tabella di sintesi sui tre gradi di giudizio tributario:
| Aspetto | Primo grado (Corte Giust. Trib. I grado) | Secondo grado (Corte Giust. Trib. II grado) | Cassazione (giud. legittimità) |
|---|---|---|---|
| Tipo di giudice | Giudice di merito (valuta fatti e diritto) – collegiale in genere; monocratico per cause minori (introdotto dal 2023). | Giudice di merito (rivaluta fatti e diritto su appello) – collegiale. | Giudice di legittimità (valuta solo diritto e regolarità processuale) – collegio (Sez. V tributaria o Unite). |
| Oggetto del giudizio | Atto impositivo e rapporto tributario: esame completo di fatto e diritto nei limiti dei motivi di ricorso. | Sentenza di primo grado e rapporto tributario: riesame completo (nei limiti dei motivi d’appello). | Sentenza di secondo grado: verifica applicazione legge (errori di diritto o vizi gravi di procedimento). Non rivede i fatti se non indirettamente. |
| Poteri sul merito | Pieni poteri di accertamento sul merito: può annullare l’atto, confermarlo o modificarlo (parzialmente annullare, rideterminare il dovuto). | Pieni poteri sul merito (come il primo grado): può confermare o riformare la sentenza di primo grado, quindi annullare/modificare ulteriormente l’atto. Può anche peggiorare la situazione del contribuente se questi aveva vinto in primo grado (no divieto di reformatio in peius per l’appellato se l’appellante è l’ente). | Nessun potere di merito in senso stretto: non può stabilire nuovi fatti né riquantificare il tributo. Può cassare la sentenza se ha violato la legge, rinviando al giudice di merito per la quantificazione. Solo eccezionalmente decide definitivamente (es. causa matura in fatto). |
| Nuove prove | Ammesse nei limiti generali (documenti anche tardivi entro certi termini processuali, testimonianza scritta sperimentale ex art. 7, possibilità di CTU). | Fino al 2023, ammessa produzione di nuovi documenti; dopo la riforma 2023 era quasi del tutto preclusa, ma Corte Cost. 36/2025 ha reintrodotto la possibilità per documenti indispensabili e atti di rappresentanza. Non ammessa nuova prova testimoniale (resta quella scritta se non già fatta). In sintesi, nuove prove in appello limitate, specie se la parte poteva fornirle prima senza impedimenti. | Non ammesse nuove prove (art. 372 c.p.c. permette solo produzione di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso o sulla nullità della sentenza impugnata). Il giudizio si fonda sugli atti già acquisiti nei gradi di merito. |
| Esito decisione | Sentenza di merito: accoglimento (totale/parziale) → annullamento dell’atto impugnato in tutto o in parte; rigetto → atto confermato. In alcuni casi sentenza può essere solo processuale (es. inammissibilità). | Sentenza di merito: conferma o riforma quella di primo grado. Se riforma a favore contribuente → annulla/modifica l’atto; se riforma a favore Fisco (ribaltando un annullamento) → ricorso originario respinto, atto valido. | Sentenza di legittimità: può rigettare il ricorso (allora la sentenza di secondo grado diviene definitiva) oppure accogliere il ricorso su uno o più motivi. In caso di accoglimento normalmente cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte tributaria per nuovo esame. Se decide nel merito (raro), emette propria decisione finale. |
Come evidenziato, la Cassazione opera su un piano diverso: garantisce l’uniforme interpretazione della legge, corregge errori giuridici, ma non è un “terzo round” dove rivedere tutta la vicenda. Pertanto, è cruciale impostare bene la causa già nei primi due gradi, perché la partita sul merito si gioca lì.
Dalla prospettiva del contribuente, rivolgersi alla Cassazione ha senso se c’è un principio di diritto importante da far valere (ad es. si ritiene che i giudici di merito abbiano male interpretato la norma tributaria, o abbiano ignorato una causa di nullità che invece era decisiva) oppure se vi sono stati vizi procedurali gravi. Non ci si può aspettare che la Suprema Corte riconsideri l’equità della pretesa fiscale o la credibilità di un testimone: questi aspetti dovevano essere curati in Commissione.
Va segnalato che con la riforma del 2022-2023 sono state introdotte alcune novità anche in Cassazione: ad esempio, la possibilità di definire in via conciliativa le liti persino in sede di legittimità. Il D.Lgs. 220/2023 ha espressamente previsto che le norme sulla conciliazione si applichino, in quanto compatibili, anche ai giudizi pendenti in Cassazione, con la previsione di uno sconto del 60% delle sanzioni in caso di accordo conciliativo raggiunto durante il giudizio di Cassazione. Ciò incentiva le parti (soprattutto il contribuente, che può beneficiare della riduzione delle sanzioni) a trovare un accordo anche molto tardi nel contenzioso, evitando il rischio di un esito incerto. Ovviamente, una conciliazione in Cassazione avrà senso per questioni quantitative (importi dovuti) più che per questioni di principio.
Riassumendo questa sezione: nel processo tributario le questioni di merito vanno prevalentemente affrontate e risolte nei gradi di merito (primo e secondo). La Cassazione è un giudice che interviene solo per garantire legalità e coerenza giuridica, e non serve a “riaprire” il merito salvo errori giuridici clamorosi. Dunque, chi si difende in una causa tributaria deve portare tutte le argomentazioni di merito e le prove il prima possibile, senza contare di poterlo fare in ultimo grado.
Vizi di legittimità dell’atto vs questioni di merito: annullabilità e nullità nel processo tributario
Un concetto strettamente legato alla distinzione tra merito e rito è quello dei vizi dell’atto tributario impugnato. Spesso si parla di “questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell’atto” contrapposte alle questioni di merito. In breve, i vizi dell’atto sono tutte quelle irregolarità formali o procedimentali dell’atto impositivo (o riscossivo) che il contribuente può far valere per ottenerne l’annullamento in sede processuale, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa.
Esempi tipici di vizi dell’atto (questioni di legittimità formale) sono:
- Difetto di motivazione: l’atto non espone in modo comprensibile le ragioni, di fatto e di diritto, della pretesa tributaria. La legge (art. 7 L. 212/2000 Statuto del contribuente e norme speciali) richiede una motivazione chiara; la sua mancanza è causa di annullabilità.
- Mancata sottoscrizione: l’avviso di accertamento non è firmato dal capo ufficio o funzionario delegato come prescritto dall’art. 42 DPR 600/73. La Cassazione conferma che il difetto di sottoscrizione è causa di nullità dell’accertamento ex art. 42, trattandosi di elemento essenziale dell’atto.
- Notifica inesistente o nulla: se l’atto non è stato notificato regolarmente (es. notifica a soggetto o indirizzo errato, vizi insanabili nella relata), il ricorso può far valere l’inesistenza/nullità della notifica, con effetti sul decorso dei termini e sulla validità dell’atto.
- Violazione di termini perentori: se l’avviso è stato emesso oltre i termini di decadenza previsti dalla legge (es: accertamento notificato dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di dichiarazione, salvo sospensioni), esso è illegittimo perché emesso fuori tempo massimo.
- Violazione del contraddittorio (dove previsto): ad esempio, per accertamenti emanati dopo la riforma 2015 su materie in cui è obbligatorio il confronto endoprocedimentale (p.es. nei tributi armonizzati come l’IVA, o più di recente in tutti i casi per via delle novità normative del 2023-2024), la mancata attivazione del contraddittorio preventivo può comportare l’annullabilità dell’atto. Da aprile 2024, a seguito del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 attuativo della delega fiscale, l’obbligo generalizzato del contraddittorio è entrato nello Statuto del contribuente (art. 6-bis L. 212/2000) per ogni tipo di avviso di accertamento: ciò implica che un avviso emesso senza invitare il contribuente a interloquire 60 giorni prima potrebbe essere viziato.
- Errata indicazione del responsabile del procedimento: fino a qualche tempo fa, la mancata indicazione del responsabile procedimentale nell’atto comportava l’annullabilità (lo prevedeva l’art. 7 L. 212/2000). Tuttavia, con le riforme recenti, questa omissione non è più causa di annullamento: infatti il nuovo art. 7-quater dello Statuto (introdotto dal D.Lgs. 219/2023) dispone che la mancanza dell’indicazione del responsabile non produce invalidità. Si tratta di un cambiamento normativo importante: prima numerose liti vertevano su tale mancanza formale, ora non più contestabile.
- Altri vizi formali: errori nell’intestazione, nell’indicazione del contribuente, mancanza degli allegati obbligatori, ecc., che però normalmente devono risultare sostanziali per avere effetto (non ogni refuso rende nullo un atto: occorre che incida sui diritti di difesa o sulla comprensibilità dell’atto).
Questi vizi sono di natura diversa rispetto al merito. Non affermano che “il tributo non è dovuto”, bensì che “l’atto è irregolare” e merita di essere eliminato per garantire la legalità dell’azione amministrativa e la tutela procedurale del contribuente. Come si è visto, se accolti, portano all’annullamento processuale dell’atto, talora senza esame del merito.
In dottrina si distingue tra nullità assolute e annullabilità (nullità relative) degli atti tributari. La nullità assoluta sarebbe un vizio talmente grave (es: mancanza di elementi essenziali) da poter essere rilevato d’ufficio in ogni tempo; l’annullabilità invece richiede un’impugnazione da parte del contribuente entro i termini, altrimenti l’atto si consolida. Nel diritto tributario questa distinzione è sfumata, perché comunque anche un atto potenzialmente “nullo” va impugnato entro 60 giorni dalla notifica, altrimenti diviene definitivo. La Corte di Cassazione ha infatti affermato in più pronunce che i vizi invalidanti degli atti tributari sono comunque eccezioni di parte: se il contribuente non li solleva tempestivamente, l’atto – per quanto viziato – diventa inoppugnabile. Ciò significa che, ad esempio, un accertamento senza firma (nullo ex lege) se non impugnato nei termini produce i suoi effetti come se fosse valido. Dal punto di vista pratico per il contribuente: non bisogna mai fare affidamento sul fatto che un vizio sia talmente grave da essere “automaticamente” considerato dal giudice; va sempre eccepito nel ricorso introduttivo, pena la decadenza.
Un altro sviluppo normativo recente è la tendenza a tipizzare meglio i vizi: il già citato D.Lgs. 219/2023 (riforma Statuto contribuente) ha introdotto nell’art. 7 dello Statuto alcune lettere (7-quater, 7-quinquies, 7-sexies) che elencano espressamente quali omissioni non causano annullabilità e disciplinano la nullità della notifica degli atti. In particolare:
- L’art. 7-quater chiarisce che non sono cause di annullamento la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l’omessa sottoscrizione del capo ufficio se l’atto è firmato digitalmente (con certificato valido). Dunque chi riceve un atto privo di firma autografa non può eccepirlo se c’è firma digitale valida; viceversa, se manca del tutto la sottoscrizione (né firma autografa né digitale), rimane un vizio radicale.
- L’art. 7-sexies disciplina le irregolarità nella notifica, stabilendo ad esempio che errori formali nella relata non producono nullità se è comunque raggiunto lo scopo, mentre restano insanabili i casi di notifica totalmente omessa o a soggetto inesistente.
- L’art. 7-quinquies introduce un principio di non aggravamento per il contribuente, stabilendo che non possono essere richiesti documenti già in possesso dell’ufficio (questo risponde anche ai rilievi di incostituzionalità citati sopra in tema di preclusione probatoria).
Queste norme, entrate in vigore tra inizio 2024 e metà 2024, mirano a bilanciare garanzie del contribuente e snellezza dell’azione amministrativa. Ad esempio, eliminando come motivo di ricorso la mancanza dell’indicazione del responsabile, si è tolto un cavillo spesso usato in giudizio (non sempre determinante sul diritto di difesa sostanziale). Invece introducendo l’obbligo generalizzato di contraddittorio, si è data al contribuente una garanzia in più sul merito della pretesa, perché il dialogo preventivo consente spesso di chiarire o risolvere questioni sostanziali prima dell’atto definitivo.
Questioni di merito e vizi formali possono coesistere: spesso nel ricorso si invocano sia vizi dell’atto che infondatezza nel merito. Ad esempio, Tizio impugna l’accertamento sostenendo sia che manca la firma (vizio formale) sia che il reddito è stato calcolato male (merito). Il giudice, come detto, esaminerà prima la firma: se ritiene la mancanza, annullerà l’atto per quel vizio e non affronterà il calcolo del reddito (lo dichiarerà “assorbito”). Se invece giudica che la firma c’è o che il vizio non sussiste, passerà a valutare la correttezza del calcolo del reddito. Il fatto che la legge ora chieda di motivare sulle questioni di merito e di legittimità separatamente non significa che il giudice debba per forza decidere entrambe: significa piuttosto che se decide il merito dovrà chiarire le ragioni di accoglimento o rigetto di quei motivi, e se decide su un vizio formale dovrà dare atto di aver accolto quel motivo (e gli altri sono assorbiti). L’importante è che in sentenza sia chiaro perché il ricorso è accolto o respinto, e quale tipo di questione è risultata decisiva.
Dal lato pratico per un contribuente/imprenditore: sollevare un vizio formale forte può essere una “scialuppa di salvataggio” nel caso in cui il merito sia incerto. Tuttavia, se il vizio è sanabile dall’ente (perché ad esempio è un atto viziato ma rinnovabile entro termini) la vittoria rischia di essere temporanea. Ad esempio, se un accertamento è annullato per difetto di motivazione ma i termini di decadenza non sono ancora scaduti, l’Ufficio potrebbe emettere un nuovo atto motivato meglio e notificartelo. Al contrario, un vizio formale insanabile (tipo la decadenza dei termini) dà una vittoria definitiva al contribuente perché l’ente non può più riprovarci. Sta all’abilità del difensore individuare se ci sono eccezioni di rito definitive, e puntare molto su quelle, oppure se il punto forte è il merito. In ogni caso, nulla vieta di sostenere più fronti in parallelo.
Le recenti riforme del processo tributario (2022-2025) e impatto sul merito
Negli ultimi anni il processo tributario italiano è stato oggetto di profonde riforme normative, che ne hanno modificato sia l’organizzazione (nascita di una magistratura tributaria professionale) sia diversi aspetti procedurali e di merito. Con particolare riferimento alle questioni di merito, evidenziamo le novità più significative introdotte dalle riforme recenti, soffermandoci su come esse incidono sulle tutele del contribuente e sulla trattazione del merito delle controversie.
- Legge 31 agosto 2022 n. 130 – Questa legge ha avviato una riforma organica della giustizia tributaria. Due effetti salienti: (a) ha trasformato le Commissioni tributarie in Corti di giustizia tributaria, introducendo giudici tributari professionali reclutati per concorso (gradualmente) e ammettendo la figura del giudice monocratico per le cause di minor valore; (b) ha modificato alcune norme del processo, ad esempio prevedendo per la prima volta la possibilità di prova testimoniale scritta (su base sperimentale, come già accennato) e potenziando la conciliazione giudiziale (innalzando la percentuale di riduzione sanzioni in caso di accordo in appello). Sul piano del merito, la figura del giudice monocratico in primo grado (per cause fino a 3.000 euro, e poi elevabile a 5.000 euro) potrebbe influire sulla gestione delle questioni di merito, in quanto un solo giudice decide l’intera controversia, ma il diritto applicato è lo stesso – è soprattutto un tema di snellimento. La L. 130/2022 ha inoltre chiarito che il processo tributario segue i principi del giusto processo (art. 111 Cost.), sancendo espressamente l’indipendenza della giurisdizione tributaria e introducendo l’equo compenso per i giudici tributari. Tutto ciò, pur non impattando direttamente la definizione di “questione di merito”, crea un contesto in cui ci si attende giudici più preparati e decisioni meglio motivate.
- Delega fiscale 2023 (Legge 9 agosto 2023 n. 111) – Ha conferito al Governo il compito di emanare diversi decreti legislativi di attuazione, alcuni dei quali incidono sul contenzioso tributario. Tra i principi indicati c’era la revisione del processo per renderlo più efficiente e la garanzia di un più ampio contraddittorio tra le parti.
- Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 220 – È il decreto attuativo specificamente dedicato al contenzioso tributario, pubblicato a gennaio 2024. Le sue disposizioni mirano principalmente a ridurre le liti e i tempi di definizione, introducendo modifiche al D.Lgs. 546/1992. Alcune innovazioni importanti:
- Obbligatorietà del processo tributario telematico: viene sancito che notifiche e depositi di atti e provvedimenti devono avvenire con modalità telematiche (PEC o piattaforma dedicata), salvo autorizzazioni temporanee per il cartaceo. Questo ha un effetto più procedurale che di merito, ma indirettamente velocizza il processo e mette tutte le parti (anche i contribuenti non assistiti) nella condizione di usare strumenti digitali. La violazione di queste norme non comporta nullità (tranne la mancata firma digitale del giudice), ma obbligo di regolarizzazione.
- Trattazione e decisione più rapide: viene introdotto il nuovo art. 47-ter D.Lgs. 546/92, che consente al giudice (monocratico o collegiale) di definire il giudizio in camera di consiglio in sede di istanza cautelare (sospensiva) se la causa è matura e non vi sono richieste di passaggio a pubblico udienza o altre pendenze. In pratica, se durante l’udienza sulla sospensiva (sospensione dell’atto impugnato) il giudice riscontra che la causa è chiara (ricorso manifestamente fondato o infondato, ecc.), può decidere il merito immediatamente con sentenza “in forma semplificata”. Ciò tende a velocizzare i casi limpidi, evitando di farli durare anni. Per il contribuente ciò significa che, ad esempio, se ha chiesto la sospensiva e il giudice la vede chiaramente a suo favore (o contro), può direttamente chiudere la lite nel merito. Questo però implica anche che occorre arrivare preparati già alla fase cautelare con tutte le argomentazioni di merito, perché la discussione cautelare potrebbe trasformarsi in decisione definitiva.
- Sentenze in forma semplificata: il D.Lgs. 220/2023 disciplina meglio la sentenza “semplificata” (già esistente ma poco utilizzata). Essa è prevista nei casi di ricorso manifestamente fondato o infondato (o inammissibile/improcedibile). La motivazione può essere sintetica, facendo riferimento “al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. Questa misura serve a concentrare lo sforzo giudiziario sulle cause più complesse, semplificando le decisioni ovvie. Dal punto di vista delle questioni di merito, una sentenza semplificata focalizza l’unico motivo dirimente (ad esempio: “il ricorso è manifestamente infondato perché la questione è già decisa dalla legge in modo chiaro in senso avverso al contribuente” oppure “manifestamente fondato perché l’Ufficio non ha considerato un pagamento provato in atti”). L’importante è che comunque anche queste sentenze succinte rispettino l’obbligo di indicare il motivo decisivo di accoglimento/rigetto, come da nuovo art. 36 comma 2 n. 4.
- Compensazione delle spese: è un aspetto processuale ma che incide sulle parti in caso di esito incerto. Il nuovo art. 15 del D.Lgs. 546/92, comma 2 come modificato, prevede che le spese processuali possono essere compensate (cioè ogni parte le sopporta proprie) non solo in caso di soccombenza reciproca o “gravi ed eccezionali ragioni”, ma anche quando la parte vittoriosa vince sulla base di documenti decisivi che però essa stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. È una norma importante: ad esempio, se un contribuente tira fuori in giudizio un documento essenziale (magari una ricevuta di pagamento) che però non aveva esibito all’Ufficio prima, e grazie a quello vince, il giudice può decidere di non addebitare le spese all’ente soccombente. L’idea è responsabilizzare le parti a collaborare e fornire prima possibile le prove, altrimenti niente condanna alle spese per l’altra parte. In ottica debitoriale, il contribuente deve essere consapevole che serbare le carte migliori solo per il giudizio potrebbe fargli poi perdere il rimborso delle spese legali pur vincendo.
- Litisconsorzio necessario esteso: per evitare conflitti tra giudicati, si è introdotto l’art. 14 c.6-bis D.Lgs. 546 che richiede, nel caso si impugni un atto che presuppone altro atto emesso da un diverso ente, di fare causa congiuntamente a entrambi gli enti coinvolti. Esempio: impugnazione di una cartella di pagamento (atto di riscossione) per vizi sia della cartella che dell’accertamento presupposto – ora vanno citati sia l’Agenzia Entrate che l’Agente della riscossione nella stessa causa. Questo assicura che il merito venga esaminato una volta sola per tutti gli atti concatenati.
- Atti impugnabili – rifiuti di autotutela: in tema di merito, notevole è l’estensione degli atti impugnabili al rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria e al rifiuto espresso di autotutela facoltativa. Tradotto: se il contribuente chiede al Fisco in autotutela di annullare un atto (cosa che può fare ad esempio in casi di errore palese, o nei casi previsti dall’art. 10-quater e 10-quinquies L. 212/2000, introdotti dal D.Lgs. 219/2023), e il Fisco rifiuta o non risponde, ora quel diniego è impugnabile in Commissione. Prima non era così: l’autotutela era considerata atto non impugnabile (salvo casi di silenzio-rifiuto su istanza di rimborso). Con questa modifica, si apre un ulteriore fronte di contenzioso “di merito indiretto”: il contribuente può far valutare al giudice se il rifiuto dell’autotutela è legittimo, il che implica spesso riesaminare il merito del tributo (per vedere se c’erano i presupposti per annullare in autotutela). È una tutela aggiuntiva per il debitore, che può cercare giustizia anche dopo aver eventualmente perso un ricorso, se emergono motivi per un annullamento in autotutela.
- Altre novità: ce ne sono molte (notifiche a mezzo posta ora per via amministrativa, termini di fissazione udienza abbreviati, eliminazione dell’inappellabilità delle sentenze sulle spese, ecc.), ma dal punto di vista delle questioni di merito meritano menzione ancora:
- La conferma che il giudice monocratico può decidere le sospensive (art. 47 modificato) e che la sua ordinanza cautelare è reclamabile al collegio.
- L’aggiornamento delle denominazioni: ora le sentenze di primo grado si appellano alla “Corte di giustizia tributaria di secondo grado” e non più alla CTR, e così via (questioni nominali che però vanno conosciute dagli operatori).
- La previsione di termini più stringenti per il deposito della sentenza (7 giorni per il deposito del dispositivo letto in udienza), per accelerare la formazione del titolo esecutivo.
In sintesi, il D.Lgs. 220/2023 (in vigore dal 2024) ha introdotto strumenti per accelerare la definizione del merito quando possibile (decisione immediata sulla sospensiva, sentenze semplificate) e per rendere più efficiente il processo, anche tramite il telematico e la concentrazione di parti in un unico giudizio. Ha anche ampliato l’accesso alla giurisdizione (impugnabilità dei dinieghi di autotutela) e bilanciato la posizione delle parti (spese compensabili se vittoria dovuta a prova tardiva). Tutto ciò incide sul come e quando le questioni di merito vengono esaminate:
- Quando: potenzialmente prima e più rapidamente, se i presupposti sono chiari (grazie a strumenti come art. 47-ter e sentenza semplificata). Dunque il contribuente deve preparare il caso in modo robusto fin dall’inizio.
- Come: con un processo più incentrato sul contraddittorio preventivo e su scambi telematici, la “carta” del merito viene giocata in parte anche prima del processo (nel contraddittorio obbligatorio il contribuente può già convincere l’ufficio, altrimenti quell’assenza di dialogo può far annullare l’atto).
- Chi decide: l’introduzione di giudici tributari professionali a tempo pieno (anziché solo togati in prevalenza di altre giurisdizioni o laici) e la specializzazione, unita alla stabilizzazione delle Sezioni Unite come interpreti di principi, fa sperare in una maggiore uniformità nelle decisioni di merito, con meno sorprese tra commissioni diverse.
Giurisprudenza recente in materia di merito nel processo tributario
La giurisprudenza degli ultimi anni fornisce chiarimenti fondamentali su vari aspetti attinenti alle questioni di merito. Abbiamo già citato alcune pronunce chiave (Cass. 2020 sulla natura impugnazione-merito; Cass. 2019-2024 su omessa pronuncia; Corti Costituzionali 2025 su prove in appello e art. 32 DPR 600). Qui riepiloghiamo i contributi giurisprudenziali più rilevanti per il nostro tema:
- Natura del giudizio tributario (merito vs annullamento): Cassazione Sez. V ha ribadito più volte (sent. n. 18904/2020, ord. n. 10117/2023, etc.) che “il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito”, in quanto mira a una decisione sul rapporto tributario, sostitutiva di quella dell’amministrazione. Ciò comporta che il giudice, se riscontra un errore sostanziale nell’accertamento, deve quantomeno indicare l’esito giusto. Ad esempio Cass. n. 18904/2020 (caso “Albergo Aurora”, citato) ha affermato il dovere del giudice di merito di rideterminare i ricavi quando ritenga inattendibile l’accertamento originario, invece di annullarlo totalmente, purché vi siano elementi in atti. Questo orientamento responsabilizza i giudici tributari a occuparsi del merito fino in fondo.
- Omessa pronuncia: Cass. n. 10422/2019, Cass. n. 25154/2018 e da ultimo Cass. Sez. Lavoro n. 7450/2024 hanno chiarito (con principi estensibili al tributario) che il vizio di omessa pronuncia sussiste solo su domande di merito non decise, non su eccezioni di rito non esaminate. La Cass. SS.UU. n. 11082/2021 ha escluso l’omessa pronuncia se la decisione adottata implica un rigetto implicito di un motivo (principio dell’assorbimento implicito). Questi principi garantiscono che in Cassazione non si annullino sentenze solo perché il giudice non ha menzionato espressamente ogni singolo motivo, purché la sua decisione di merito li abbia “assorbiti”. Per il contribuente, ciò significa che è importante articolare chiaramente i motivi di ricorso di merito, ma non sorprendersi se il giudice poi non li affronta uno per uno quando alcuni diventano irrilevanti per come ha deciso.
- Preclusioni probatorie e diritto di difesa: la Suprema Corte, ancor prima dell’intervento costituzionale, aveva mostrato sensibilità nel mitigare l’art. 32 DPR 600/73 (quello che preclude in giudizio i documenti non esibiti al Fisco). Cass. n. 701/2023, ad esempio, ha ritenuto che il divieto non operi se il contribuente non ha ottemperato a una richiesta generica o se il documento era già conosciuto all’ufficio. Questa linea è stata pienamente confermata da Corte Cost. n. 137/2025, come visto, che ha richiesto un’interpretazione restrittiva della preclusione per non ledere il diritto di difesa. In termini di merito: i giudici dovranno valutare i documenti pervenuti anche tardivamente, quando il loro diniego sarebbe irragionevole. Ciò rafforza la posizione del contribuente nel merito, perché amplia il materiale probatorio utilizzabile per provare la sua ragione.
- Divieto di nuovi documenti in appello: con la riforma 2022 era stato introdotto (nell’art. 58) un forte limite ai nuovi documenti in secondo grado. Molte Commissioni avevano iniziato ad applicarlo rigidamente, dichiarando inammissibili documenti prodotti per la prima volta in appello (come nuove perizie, nuovi contratti, ecc.), salvo che fossero “indispensabili”. La Consulta, come detto, con la sent. 36/2025 ha censurato questo irrigidimento, almeno per la parte più irragionevole (procure e documenti analoghi). Le Corti di giustizia tributaria d’appello ora dovranno attenersi a quella pronuncia: in pratica, un documento che completa le allegazioni del contribuente potrà essere accettato in appello se la sua mancata produzione prima non è dipesa da dolo o colpa grave, specie se riguarda aspetti formali. Resta invece esclusa la presentazione di nuovi motivi di ricorso in appello, salvo quelli ammessi dal codice (motivi aggiunti per fatti nuovi). Dunque, in linea di massima, sul merito dei fatti noti non si può cambiare tesi in appello: il contribuente non può in secondo grado inventare una nuova ragione sostanziale non dedotta prima (ad es. aggiungere una eccezione di prescrizione se in primo grado non l’aveva sollevata, a meno che sia maturata dopo).
- Giudicato interno e merito: una tematica connessa è quella del giudicato su singole questioni. Se il contribuente non appella un capo sfavorevole della sentenza di primo grado riguardante un motivo di merito, quel punto diventa definitivo (giudicato interno) e non può essere rimesso in discussione oltre. Ad esempio, se in primo grado erano stati proposti 5 motivi di merito e il giudice ne accoglie 1 e ne rigetta 4, e il contribuente impugna solo su 2 di quelli rigettati, gli altri 2 non contestati diventano incontrovertibili. Cass. n. 2456/2024 (Sez. Trib.) ha rammentato l’importanza del giudicato interno implicito: il silenzio su un punto in appello equivale ad accettazione di quanto deciso. Anche Cass. 17011/2022 menziona che se una questione non esaminata non era incompatibile con l’impianto della sentenza, l’omissione andava censurata come violazione di legge più che come omessa pronuncia. In sostanza, per preservare le proprie questioni di merito, il contribuente deve stare attento ad impugnare tutti gli aspetti sfavorevoli della sentenza, altrimenti quelli non impugnati non saranno più recuperabili.
- Sentenze di merito e motivazione: la giurisprudenza recente ha anche affrontato il tema della sufficienza della motivazione delle sentenze tributarie. Ad esempio, Cass. n. 26384/2022 ha cassato una sentenza di CTR che si era limitata a motivare per relationem (cioè richiamando pedissequamente quanto affermato dall’ufficio) senza un autonomo vaglio critico: ciò è stato ritenuto vizio di motivazione. Questo per dire che, sebbene sintetiche, le sentenze devono dare conto del perché rigettano o accolgono il merito. Con la modifica all’art. 36, comma 2, n.4, si vuole proprio evitare motivazioni generiche: il giudice deve indicare i motivi di accoglimento o rigetto riguardo alle questioni di merito. Una “motivazione apparente” (frasi generiche o copia-incolla delle tesi d’ufficio) è equiparata a mancanza di motivazione e può portare ad annullamento in Cassazione.
- Conciliazione e merito: infine, un cenno alla giurisprudenza in tema di conciliazione giudiziale. Mentre non ci sono vere “sentenze” sulla conciliazione (dato che è un accordo fra le parti ratificato dal giudice), è utile ricordare che la possibilità di conciliare in appello è stata ampliata e la Cassazione con ord. n. 22332/2021 ha chiarito che la conciliazione può intervenire anche quando la causa è in Cassazione, purché nel frattempo sia pendente (infatti ora è legge con D.Lgs. 220/2023). La prassi sta vedendo un aumento di conciliazioni soprattutto in appello, specie in casi in cui l’esito è incerto: le parti preferiscono trovare un punto di equilibrio (il contribuente paga magari il 50% di quanto richiesto, l’ente rinuncia a sanzioni) invece di rischiare tutto. Ciò evidenzia che, alla fine, il merito economico della controversia è centrale: conciliare è una scelta basata su valutazioni di merito (quanto il contribuente ritiene effettivamente di dover pagare vs quanto l’ente pensa di poter recuperare). La conoscenza approfondita del merito della questione fiscale aiuta le parti a trovare l’accordo in sede conciliativa.
In conclusione su questo punto, la giurisprudenza degli organi apicali (Cassazione e Corte Costituzionale) sta cercando di razionalizzare il contenzioso tributario: da un lato ribadendo la necessità che il merito sia davvero affrontato e risolto nel processo (evitando formalismi eccessivi che ne precludano l’esame), dall’altro mantenendo fermi i limiti che separano i diversi gradi di giudizio. Per un professionista o imprenditore che affronta il fisco, essere aggiornato su queste pronunce significa poter calibrare meglio la propria strategia difensiva, sapendo ad esempio che certi vizi formali non valgono più, che certi documenti vanno prodotti subito, che in Cassazione non potrà rimediare a eventuali mancanze istruttorie, e così via.
Implicazioni pratiche per contribuenti, imprenditori e professionisti
Dal punto di vista del debitore (il contribuente chiamato a pagare tributi), comprendere cosa siano le questioni di merito nel processo tributario e come vengono trattate si traduce in alcuni consigli pratici e strategici per la gestione del contenzioso fiscale:
- Sollevare tutti i motivi (rito e merito) sin dall’inizio: è fondamentale che nel ricorso introduttivo davanti al giudice di primo grado il contribuente, tramite il suo difensore, articoli tutte le contestazioni possibili contro l’atto impugnato. Ogni motivo che attiene al merito della pretesa (es.: “il fatto non sussiste”, “la norma è applicata male”, “il calcolo è errato”, “c’è prescrizione”, ecc.) dev’essere esposto chiaramente, così come ogni eccezione di rito (es.: “atto notificato oltre termine”, “difetto di motivazione”, ecc.). Questo perché quello è il momento in cui si fissano i confini della disputa. Motivi nuovi in corso di causa sono ammessi solo entro limiti stretti, e in appello lo spazio si restringe ulteriormente. Inoltre, come visto, se si omette un motivo e la decisione avversa diventa definitiva, non si potrà più recuperare. Dunque occorre un’analisi accurata dell’atto fiscale per individuare tutti i possibili punti deboli sia sul piano formale che sostanziale e includerli nel ricorso iniziale.
- Curare il contraddittorio preventivo (quando previsto): con le nuove norme, prima di alcuni avvisi di accertamento l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti (obbligo generalizzato da metà 2024). Questo contraddittorio pre-atto è un’opportunità da non sprecare: il contribuente dovrebbe presentarsi (personalmente o tramite professionista) e fornire tutte le spiegazioni e i documenti che possano chiarire la sua posizione. Molte questioni di merito possono essere risolte o limitate in questa fase, evitando l’atto o ridimensionandolo. Inoltre, se poi l’ufficio emette comunque l’atto senza tener conto delle difese, il contribuente avrà ulteriori argomenti nel ricorso (ad esempio, sottolineare di aver già fornito prova contraria ignorata dall’ufficio, il che rafforza la propria posizione in giudizio). In più, se l’ufficio violasse l’obbligo di contraddittorio (non convocando affatto il contribuente), ciò stesso costituirebbe motivo formale di annullamento dell’atto in causa.
- Raccogliere e produrre tempestivamente le prove: il cuore delle questioni di merito è spesso probatorio. Se si contesta un reddito non dichiarato, bisogna provare perché non era reddito (es. era un prestito, era esente, ecc.) con documenti, testimonianze, perizie. È cruciale raccogliere questa documentazione quanto prima e depositarla già in primo grado. Le regole attuali, specie dopo la parziale riforma del 2023 e il correttivo della Corte Costituzionale 36/2025, consentono ancora di produrre documenti nuovi in appello in alcuni casi, ma è molto più sicuro e persuasivo esibirli subito. Ciò vale ancor più per elementi che l’ufficio vi aveva richiesto in sede di controllo: se non li avete dati allora, forniteli almeno al giudice spiegando il perché del ritardo (per evitare che l’ufficio ne chieda l’inutilizzabilità). Siate proattivi anche con i mezzi istruttori: se servono testimoni (ora ammessi in forma scritta) identificate quali persone potrebbero attestare determinati fatti e preparate le loro dichiarazioni secondo le regole; se serve una perizia tecnica (es. di contabilità, di stima, ecc.), valutate di farla svolgere da un consulente di parte già in primo grado, così da poter chiedere eventualmente una CTU al giudice su basi solide.
- Utilizzare i vizi formali in modo strategico: se ci sono vizi procedurali dell’atto (notifica nulla, firma mancante, ecc.), vanno ovviamente eccepiti. Ma bisogna essere consapevoli dell’effetto di una vittoria su quei vizi. In particolare:
- Se il vizio è sanabile o ripetibile, valutare se conviene farlo valere da solo. Spesso conviene sempre affiancarlo anche ad altri motivi di merito. Una volta annullato l’atto per vizio formale, monitorate i termini: se l’ente può riemetterlo, sarà bene farsi trovare pronti (e magari nel frattempo raccogliere ulteriori difese di merito, perché la seconda volta l’ufficio potrebbe colmare anche le lacune sostanziali).
- Se il vizio è non sanabile (come una decadenza dei termini o un difetto di giurisdizione insanabile), è un motivo potentissimo che chiude la partita. In tal caso, spingete con convinzione su di esso. Però attenzione: la decadenza è spesso controversa (ci sono sospensioni dei termini o differenti interpretazioni) quindi portate anche qui documentazione a supporto (es. la cronologia delle notifiche, eventuali proroghe emergenziali tipo Covid, ecc.).
- Non dare mai per scontato che il giudice rilevi d’ufficio un vizio, anche se vi pare macroscopico. Ponetelo espressamente. Ad esempio, se notate che manca la firma, non dite solo “il fatto è infondato”: aggiungete “in via preliminare, l’atto è nullo per difetto di sottoscrizione ai sensi art. 42 DPR 600/73” e magari citate giurisprudenza a supporto. Questo costringe il giudice a pronunciarsi (o quantomeno a tenerne conto).
- Se un vizio formale viene “sanato” dal giudice (ad esempio concesso termine per integrare difesa tecnica mancante, ex art. 182 c.p.c. come richiamato), non scoraggiatevi: si procede sul merito. L’importante era non farsi buttare fuori per un vizio evitabile.
- Attenzione alle preclusioni e ai termini nel processo: oggi il processo tributario richiama molti istituti del processo civile. Ad esempio, grazie al rinvio all’art. 182 c.p.c., se il contribuente propone ricorso senza difensore quando sarebbe obbligatorio, il giudice gli dà tempo per sanare. Ma non sempre c’è rimedio: alcuni errori restano fatali (ricorso oltre i 60 giorni, appello oltre i termini, motivi nuovi tardivi ecc.). Questi sono aspetti “di rito” che però decidono il destino anche del merito: un appello tardivo sarà inammissibile anche se nel merito avevi ragione marcia. Quindi la disciplina processuale va seguita con rigore. Per professionisti: occhio alle notifiche via PEC (ora obbligatorie, salvo eccezioni), alle iscrizioni a ruolo, ai contributi unificati da pagare (se non pagati l’appello può essere dichiarato improcedibile), ecc. Non sottovalutare questi aspetti per concentrarsi solo sul merito: bisogna gestire entrambi.
- Non contare sulla “pietas” del giudice: anche se il giudice tributario è sensibile all’equità, è vincolato a norme. Se il contribuente non fornisce prove o se sbaglia approccio, il giudice non può supplire (anche se gli dispiace l’iniquità fiscale). Quindi il contribuente deve attivamente costruire il proprio caso di merito. Ad esempio, se pensate che una norma sia incostituzionale, sollevate l’eccezione di legittimità costituzionale; se ritenete vi siano profili comunitari (diritto UE), sollevate la questione e chiedete eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Sono passi sofisticati, ma in cause di un certo rilievo possono fare la differenza. Il giudice spesso accoglie queste istanze se ben impostate (diversamente, difficilmente ci penserà da solo). Ricordate che è possibile (ed è capitato) che giudici tributari sollevino questioni di costituzionalità su aspetti processuali o sostantivi: fornire loro nel ricorso un argomento ben articolato può incoraggiarli a farlo.
- Valutare strumenti deflativi e accordi: affrontare il merito in giudizio non è l’unica strada. Prima di arrivare alla sentenza, ci sono strumenti per chiudere la lite: acquiescenza (pagamento con sconto delle sanzioni entro 60 gg dall’atto), mediazione/reclamo (per controversie sotto €50.000, obbligatoria, anche se con la riforma 2023 potrebbe essere rivista), conciliazione giudiziale (in qualunque grado, ora pure in Cassazione, con sanzioni ridotte) e le varie forme di definizioni agevolate che il legislatore propone (condoni, rottamazioni, ecc.). Questi strumenti spesso implicano rinunciare a far valere alcune questioni di merito in cambio di uno sconto o della pace fiscale. Ad esempio, la conciliazione spesso comporta che il contribuente ammetta una parte del debito e l’ente rinunci a una parte. È una scelta non giuridica ma pratica: conviene pagare subito il 50% o rischiare di non dover pagare nulla ma con possibilità del 100%? Ogni contribuente deve fare questa valutazione col proprio consulente. Le implicazioni delle questioni di merito qui sono: quanto siete convinti di vincere sul merito? Se le chance sono basse, una definizione riduce i danni; se sono alte, forse vale combattere. Anche la tempistica incide: un accordo può chiudere tutto subito, mentre insistere sul merito può portare avanti la questione per anni (con interessi che maturano). Dal punto di vista imprenditoriale, a volte togliersi un debito con lo Stato a costo di un esborso parziale può essere preferibile all’incertezza di lungo periodo.
- Conoscere i propri diritti nel processo: spesso privati e imprenditori non sanno di avere delle tutele specifiche. Ad esempio, pochi sanno che nel processo tributario:
- Se il valore della lite è modesto (fino a €3.000 per atti ante 2023, ora €5.000 per atti successivi), il contribuente può stare in giudizio da solo senza difensore (cosiddetta autodifesa). Questo però non significa prendere alla leggera il merito: se si decide di difendersi da soli, bisogna ancor più studiare la questione di merito perché non si avrà l’assistenza tecnica di un esperto. Talvolta conviene comunque farsi aiutare da un consulente nella stesura.
- Il giudice ha l’obbligo di mettere le parti in grado di esporre compiutamente le proprie ragioni. Ad esempio, se in udienza emergono nuovi elementi, potete chiedere un rinvio per esaminarli. Oppure, se l’ufficio produce documenti all’ultimo momento, avete diritto a tempo per controbattere.
- In caso di esito negativo in primo grado, la notifica della sentenza dà il via al termine breve d’appello (che è di 60 giorni). Se l’ente non notifica la sentenza, il termine lungo è di 6 mesi. Quindi, se perdete ma volete guadagnare tempo per decidere se appellare, può convenire attendere senza sollecitare notifica. Viceversa, se vincete in primo grado, sappiate che l’ente spesso aspetterà molti mesi prima di notificare l’appello (per ragioni interne o strategiche); intanto però, grazie alle novità della riforma 2022, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva (lo era già prima, ma ora con minor necessità di cauzione), quindi potete avviare la riscossione di eventuali rimborsi o sospendere pagamenti già dovuti. La provvisorietà vale fino a un certo limite (10 milioni di euro oltre cui serve apposita fideiussione per riscuotere in pendenza di appello, se non erro).
- Se ottenete una sospensiva (sospensione dell’atto), quell’ordinanza ha effetti immediati ma temporanei. Sfruttate quel tempo per prepararvi ancora meglio sul merito per il prosieguo del giudizio, perché può essere un segnale che avete buone possibilità, ma nulla è scontato fino alla sentenza finale.
In generale, per imprenditori e professionisti è consigliabile farsi assistere da un difensore abilitato e competente in materia tributaria. Il panorama normativo e giurisprudenziale, come si è visto, è in evoluzione e piuttosto complesso. Un avvocato tributarista o un commercialista esperto saprà individuare le questioni di merito rilevanti, impostare il ricorso in modo completo e navigare tra le insidie procedurali. Anche perché, come evidenziato, a fronte di maggiori garanzie (contraddittorio obbligatorio, testimonianza ammessa, ecc.) ci sono anche nuovi oneri e tecnicismi (processo telematico, formalità di attestazioni, rispetto di termini perentori abbreviati, ecc.) che possono sorprendere chi non è addentro.
Infine, una riflessione: dal punto di vista del contribuente “debitore”, spesso una questione di merito nel processo tributario non è solo una disquisizione legale, ma qualcosa che tocca la sua attività, i suoi beni, la sua vita finanziaria. Ad esempio, contestare nel merito un accertamento IVA significa magari rivendicare la legittimità di operazioni fatte, oppure sostenere che non c’è stata evasione ma al più un errore. Pertanto, è importante presentare al giudice tributario anche la realtà sostanziale dietro i numeri: chi sono, che azienda ho, perché avrebbe senso che io non debba quel tributo (magari perché ho chiuso in perdita, o perché l’operazione contestata era diversa da come la vede il fisco). I giudici, pur dovendo applicare le norme, sono persone che comprendono i contesti: spiegare bene i fatti, con documenti ma anche con una narrazione chiara, può fare emergere questioni di merito che inizialmente non erano neanche state considerate dall’ufficio.
In conclusione, le questioni di merito nel processo tributario sono il campo di battaglia principale su cui si decide se il contribuente dovrà pagare o meno ciò che gli viene richiesto. Conoscere le regole del gioco – dagli aspetti processuali ai più recenti orientamenti giurisprudenziali – permette al “debitore” di giocare al meglio le proprie carte e di vedere tutelati i propri diritti sostanziali.
Domande frequenti (FAQ)
Domanda: Cosa si intende esattamente per “questione di merito” nel processo tributario?
Risposta: Si intende qualsiasi profilo della controversia che riguarda la sussistenza e l’entità dell’obbligo tributario contestato. In pratica sono le questioni relative al rapporto fiscale in sé: ad esempio, se un reddito è tassabile, se un bene è soggetto a imposta, se l’aliquota applicata è corretta, se l’importo dovuto è quello preteso o un altro, se la pretesa è decaduta, ecc. Sono quindi distinte dalle questioni procedurali (di rito), che invece riguardano la validità formale dell’atto o del processo (come la regolarità della notifica, il rispetto dei termini, la competenza del giudice, ecc.). Le questioni di merito mirano ad ottenere dal giudice una decisione sul fondo della pretesa tributaria (pagare o non pagare, e quanto), non solo sulla forma.
Domanda: Quali sono alcuni esempi concreti di questioni di merito in una causa tributaria?
Risposta: Esempi comuni di questioni di merito sono:
- La contestazione di elementi reddituali o basi imponibili: per es. il Fisco mi imputa ricavi non dichiarati per 100.000 €, io sostengo nel merito che in realtà erano solo 40.000 € (magari il resto erano finanziamenti soci non tassabili).
- L’interpretazione di una norma tributaria: per es. il contribuente ritiene di aver diritto a una certa esenzione o regime fiscale, l’Agenzia no. La questione di merito è quale interpretazione della norma sia corretta.
- L’applicazione di un regime fiscale: es. stabilire se un’operazione è imponibile IVA o esente IVA; se un dividendo incassa una certa detassazione; se un bene rientra in una certa categoria catastale ai fini IMU, ecc.
- La quantificazione di imposte e sanzioni: es. il contribuente ammette magari un’imposta evasa, ma contesta il calcolo degli interessi o la proporzionalità della sanzione.
- Questioni di prova sostanziale: es. il Fisco accusa di aver emesso fatture false, il contribuente in merito porta prove che le operazioni erano reali.
- L’eccezione di prescrizione o decadenza del tributo: benché abbiano natura temporale, queste sono considerate in genere questioni di merito, perché attengono all’esistenza dell’obbligazione tributaria (se un tributo è decaduto, significa che non è più dovuto sostanzialmente). Ad esempio, sostenere che un’accertamento IVA notificato nel 2023 per l’anno d’imposta 2016 è decaduto (oltre il termine) è una questione che, se accolta, incide sul merito: il tributo non è più dovuto.
- La legittimità costituzionale o comunitaria di una norma impositiva: se ad esempio una legge tributaria viene ritenuta discriminatoria e se ne chiede la rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia UE. È una questione di merito perché determina se quel tributo (fondato su quella legge) va applicato o no.
Domanda: Qual è la differenza tra questioni di merito e questioni di legittimità dell’atto (vizi formali)?
Risposta: Le questioni di merito riguardano ciò che c’è scritto nell’atto (le ragioni sostanziali della pretesa) e la correttezza di quelle ragioni; le questioni di legittimità dell’atto riguardano come l’atto è stato emanato e se rispetta i requisiti formali e procedurali di legge. Ad esempio:
- Merito: “Non dovevo pagare questa imposta perché il reddito era esente”.
- Vizio formale: “L’avviso di accertamento è nullo perché non è stato firmato dal dirigente competente” oppure “perché è stato notificato oltre il termine previsto”.
In caso di accoglimento, una questione di merito porta a dichiarare che il tributo non è dovuto (annullando l’atto per infondatezza); una questione di legittimità formale porta ad annullare l’atto indipendentemente dal tributo (magari anche se il tributo in teoria sarebbe dovuto, ma l’atto è irregolare e va rifatto). Da notare che la nuova formulazione dell’art. 36 D.Lgs. 546/92 impone di dare conto in sentenza sia delle questioni di merito che di quelle sui vizi di nullità, segno che il legislatore vuole evidenziare la distinzione.
Domanda: Se vinco per un vizio formale dell’atto, la questione è chiusa o possono tassarmi di nuovo?
Risposta: Dipende dal vizio:
- Se il vizio è sanabile e i termini non sono scaduti, l’Amministrazione finanziaria può emettere un nuovo atto correggendo il vizio. Ad esempio, se l’accertamento è annullato perché mancava la firma, l’ufficio può rifirmarlo e rinotificarlo (purché avvenga entro i termini di decadenza o entro il diverso termine concesso da norme in casi di annullamento). Oppure se è annullato per difetto di motivazione, possono emetterlo con motivazione più dettagliata. In questi casi la vittoria è temporanea: si annulla quell’atto, ma il tributo può essere richiesto di nuovo.
- Se il vizio è insanabile o sono decorsi i termini, la pretesa sostanziale non può più essere fatta valere. Ad esempio, se l’accertamento è annullato perché notificato oltre i termini di decadenza, l’ufficio non può più rimediare perché il potere impositivo è ormai decaduto: il tributo non potrà più essere richiesto. Altro esempio: se l’atto è nullo per mancanza di un elemento essenziale e intanto è pure scaduto il termine ultimo per accertare, non c’è scappatoia.
Quindi, dal punto di vista del contribuente, vincere su un vizio formale è ottimo se è un vizio “finale” (come la decadenza); se è un vizio “riparabile”, di solito conviene comunque aver sollevato anche questioni di merito, perché l’ente potrebbe tornare alla carica. In ogni caso, dopo aver vinto per un vizio formale, è bene attendere la scadenza dei termini di accertamento (se non sono già scaduti) prima di cantar vittoria definitiva.
Domanda: Il giudice tributario può aumentare le imposte rispetto a quanto chiesto dal Fisco?
Risposta: No, il giudice non può aumentare l’importo contestato né introdurre nuovi capi di pretesa. È vincolato dal principio della domanda e dai limiti dell’atto impugnato. In altre parole, la Commissione (o Corte di giustizia tributaria) può al massimo confermare l’importo accertato o ridurlo (annullando in parte qua), ma non può condannare il contribuente a pagare più di quanto l’ufficio aveva indicato nell’avviso impugnato. Ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate dice che il reddito non dichiarato è €100.000, il giudice potrebbe dire “in realtà è €50.000” (riduzione) ma non potrebbe dire “secondo me è €120.000”. Questo perché il processo tributario è di impugnazione dell’atto: non c’è una “domanda” dell’ente di ottenere di più di quanto ha accertato. Unica eccezione indiretta: se l’ufficio in atto aveva riconosciuto qualche detrazione e poi in giudizio sostiene che non spettava (nel quadro della stessa pretesa), potrebbe accadere che eliminando quella detrazione l’imposta effettiva sia maggiore di quella liquidata: ma in genere l’ufficio dovrebbe emettere un nuovo atto integrativo se volesse il delta, non può ottenerlo semplicemente dal giudice. Quindi si può stare tranquilli che appellare una sentenza per chiedere giustizia non espone al rischio di vedersi aumentare le imposte (principio di divieto di reformatio in peius per chi impugna, salvo appello incidentale dell’altra parte). Se solo il contribuente appella e il Fisco no, la somma contestata non può essere aumentata in secondo grado. Se invece appella il Fisco, può succedere che una pretesa ridotta in primo grado torni all’importo originario (o a un importo comunque non superiore a quello iniziale).
Domanda: Posso presentare nuovi documenti o nuove prove in appello?
Risposta: In linea generale, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita in modo più limitato rispetto al passato, ma non è del tutto vietata. La riforma del 2023 aveva introdotto un’art. 58 comma 3 D.Lgs. 546/92 molto restrittivo, che di fatto vietava nuovi documenti salvo poche eccezioni. Questo però è stato corretto dalla Corte Costituzionale nel 2025, che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto, aprendo la porta almeno ai documenti relativi alla regolarità processuale (procure, deleghe) e comunque invitando a una lettura restrittiva ma ragionevole della preclusione. Dunque, oggi si può dire:
- Documenti nuovi: se sono strettamente necessari e il contribuente ha una giustificazione per cui non li ha prodotti prima, il giudice d’appello tende ad ammetterli. Ad esempio, un documento scoperto dopo la sentenza di primo grado, o un documento che l’ufficio conosceva già, può essere accettato. Resta opportuno, comunque, allegare in appello una memoria che spieghi perché il documento è prodotto ora e perché è rilevante.
- Nuove prove orali: la testimonianza scritta in primo grado è sperimentale; in appello in teoria se non è stata chiesta prima potrebbe non essere ammessa. Non c’è molta casistica ancora. In generale nuove prove “costituende” (come perizie o testimonianze) in appello non sono di norma ammesse, salvo che il giudice le ritenga indispensabili e che la necessità sia sorta dopo.
- Nuovi motivi di ricorso: questi invece non sono ammessi (principio del divieto di nova in appello per le domande). Si può semmai proporre motivi aggiunti in primo grado (entro certi termini) se emergono nuovi fatti prima della decisione di primo grado. In appello ci si deve concentrare su ciò che è già stato oggetto del primo giudizio. Ad esempio, non si può in appello introdurre per la prima volta una contestazione che l’atto era nullo per un vizio X se su quel vizio in primo grado nulla era stato detto (a meno che il vizio sia emerso solo dopo, ma ciò è raro per un vizio d’atto).
In sintesi: portate tutto il possibile in primo grado. In appello vi rimangono spazi per integrare, ma dovrete convincere il giudice che si tratta di elementi davvero necessari e non presenti prima per motivi indipendenti dalla vostra volontà.
Domanda: Cosa succede se il giudice non affronta una delle questioni che ho sollevato?
Risposta: Dipende dal perché non l’ha affrontata:
- Se la questione era di merito ed è stata completamente ignorata (non c’è traccia né esplicita né implicita in sentenza), allora c’è un vizio di omessa pronuncia. In tal caso, la sentenza è impugnabile (in appello o Cassazione a seconda del grado) per violazione dell’art. 112 c.p.c. Si dovrà far valere che il giudice non si è pronunciato su un motivo specifico.
- Se la questione era pregiudiziale di rito e non viene affrontata, molto probabilmente il giudice l’ha considerata assorbita dal merito (ad esempio, ha rigettato nel merito e quindi non ha discusso del vizio formale). In tal caso non c’è omessa pronuncia censurabile. Tuttavia, se la ritieni ancora rilevante, dovrai riproporla in appello (nel caso di vizio non esaminato in primo grado) affinché il giudice di secondo grado ne tenga conto in via subordinata. Attenzione: con l’art. 56 D.Lgs. 546/92, le eccezioni non accolte (o assorbite) in primo grado devono essere riproposte nel controricorso in appello dalla parte vittoriosa, pena decadenza. Quindi se hai vinto in primo grado per merito ma il giudice non ha esaminato un tuo vizio, e l’Agenzia appella sul merito, tu nel tuo atto di risposta in appello dovrai “riproporre” l’eccezione di rito assorbita, altrimenti si considera rinunciata.
- Può darsi che il giudice, pur non menzionando espressamente un motivo, vi abbia comunque deciso implicitamente contro, nel senso che la sua decisione finale lo rende incompatibile. Ad esempio: non menziona la tua eccezione di prescrizione, ma poi accoglie il ricorso per un altro motivo e annulla tutto; implicitamente ha reso irrilevante la prescrizione (perché magari l’atto era nullo comunque). In Cassazione non potrai lamentare omessa pronuncia, perché la giurisprudenza dice che se la decisione adottata assorbe logicamente un motivo, non c’è vizio. Potevi semmai lamentare quel punto come violazione di legge se ritenevi dovesse essere esaminato diversamente.
In ogni caso, il consiglio pratico è: se una tua questione non viene esaminata e tu sei parzialmente vittorioso, riproponila esplicitamente nel grado successivo; se sei soccombente e il giudice ha ignorato un motivo di merito, impugna per omessa pronuncia (insieme eventualmente ad altri motivi di merito o rito). La nuova formulazione dell’art. 36 impone ai giudici di essere più chiari, quindi sperabilmente questi problemi diminuiranno.
Domanda: Che significa che il processo tributario è di “impugnazione-merito”?
Risposta: Significa che quando impugni un atto del Fisco, non chiedi solo di annullarlo per eventuali vizi, ma chiedi anche al giudice di verificare la pretesa fiscale in sé e sostituirsi all’Amministrazione nell’accertare il dovuto. In un processo di puro “impugnazione-annullamento” (come avviene di solito nel processo amministrativo), il giudice se trova un vizio annulla l’atto e basta, dopodiché l’amministrazione eventualmente riprovvede; e se non trova vizi lo lascia intatto. Nel processo tributario invece il giudice può (e deve) entrare nel merito: se trova vizi formali annulla l’atto, ma se trova errori sostanziali ridetermina il rapporto fiscale. In pratica il giudice tributario dice: “Agenzia Entrate, tu hai accertato X, io giudice dico se X è corretto; se non lo è, o lo annullo o lo correggo in Y”. Questa caratteristica è riconosciuta dalla Cassazione: “il giudizio tributario mira alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione”. Ciò comporta, ad esempio, che:
- il giudice tributario può diminuire l’imposta accertata (cosa che un giudice amministrativo di solito non farebbe, limitandosi ad annullare l’atto e rimandare all’ente);
- la sentenza tributaria fa stato sul rapporto d’imposta (diventa giudicato sostanziale), quindi stabilisce in via definitiva chi deve cosa su quel tributo per quell’anno;
- non c’è bisogno di un ulteriore provvedimento amministrativo per dare esecuzione alla sentenza (se la sentenza annulla l’atto, il tributo non è dovuto; se lo modifica, è dovuto nei limiti fissati dalla sentenza).
Questa natura “di merito” del processo si vede anche nel fatto che le Commissioni possono riconoscere, ad esempio, un rimborso al contribuente se emerge che ha pagato il non dovuto, o possono compensare un debito con un credito emerso durante il giudizio, ecc., atti tipici di un giudice che entra nel merito della situazione fiscale complessiva e non si limita a dire “atto legittimo sì/no”.
Domanda: Chi può difendermi in una causa tributaria sul merito? Serve per forza un avvocato?
Risposta: Dipende dal valore della controversia:
- Se il valore (importo del tributo contestato + sanzioni) è entro €3.000 (per atti antecedenti) o €5.000 per atti successivi alle riforme, la legge consente al contribuente di stare in giudizio personalmente, senza assistenza tecnica, se lo desidera. In tal caso può redigere da solo il ricorso e difendersi (si parla di autotutela giudiziale o autodifesa). Tuttavia, pur possibile, non è sempre consigliabile: il processo tributario anche per piccole somme è pieno di insidie procedurali. Se la questione di merito è complessa (interpretazioni di legge, ecc.) è meglio farsi assistere.
- Oltre tali soglie, la difesa tecnica è obbligatoria. Significa che il ricorso deve essere firmato da un difensore abilitato. Non è necessariamente un avvocato: la legge tributaria (art. 12 D.Lgs. 546/92) elenca diversi professionisti che possono difendere: avvocati, commercialisti (sezione A), consulenti del lavoro (per alcune materie), periti agrari/agrotecnici (per tributi agricoli), ingegneri, architetti, geometri (per tributi su materie tecniche come edilizia, catasto), purché iscritti ai rispettivi Albi. Oggi la platea è ampia, ma in pratica le figure più frequenti sono avvocati tributaristi e dottori commercialisti.
- In Cassazione, però, la difesa è riservata ad avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione (c.d. avvocati cassazionisti). Dunque se hai vinto/perduto e vuoi andare in Cassazione, devi farti rappresentare da un avvocato abilitato (anche il commercialista non può più, deve lasciare la mano a un avvocato cassazionista).
Consiglio pratico: scegli il difensore in base alla natura della questione di merito. Se è molto giuridica (interpretazione di norme, questioni costituzionali, ecc.) un avvocato tributarista è indicato. Se è molto contabile o fiscale tecnica (es: contestazioni IVA intracomunitaria, transfer pricing, ecc.), un commercialista tributarista esperto può andare bene ed eventualmente collaborare con un avvocato se si arriva in Cassazione. L’importante è che il professionista sia aggiornato sulle recenti evoluzioni normative (ad esempio che conosca la riforma 2023-2024, le sentenze Corte Cost. 2025, ecc.) perché il diritto tributario è in continuo movimento.
Domanda: Dopo la sentenza di secondo grado, posso ancora discutere il “merito” in qualche modo?
Risposta: Dopo la sentenza di secondo grado (Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ex CTR), l’unico mezzo ordinario è il ricorso per Cassazione, ma come detto la Cassazione non rivede il merito salvo errori di diritto. Quindi, se per “discutere il merito” intendi rivedere i fatti e le prove, la risposta è no, non c’è un terzo grado di merito. La Cassazione può solo verificare se ci sono stati vizi di legge.
C’è però uno strumento speciale detto revocazione (art. 64 D.Lgs. 546/92, rinvia all’art. 395 c.p.c.): si può chiedere alla stessa Corte tributaria che ha emesso la sentenza definitiva di revocarla per motivi eccezionali (ad es. se è emerso dopo un documento decisivo prima nascosto dall’altra parte, o se la sentenza è frutto di dolo, o di errore di fatto macroscopico, ecc.). La revocazione è però un mezzo straordinario, ammesso solo in casi rari e ben tipizzati. Non è una “terza possibilità” sul merito in senso generico.
Dunque, in pratica, dopo l’appello la partita di merito è chiusa. In Cassazione ci si gioca solo eventuali vizi di legittimità. Tuttavia, a livello amministrativo, se proprio emergono nuovi elementi favorevoli al contribuente dopo la sentenza passata in giudicato, si può sempre provare a chiedere un riesame in autotutela all’Amministrazione (che a volte corregge spontaneamente se ci sono evidenti errori). Ma sul piano giudiziario, il giudicato tributario fa stato: se la sentenza d’appello dice che devi €100, quella è la verità giudiziaria definitiva sul merito.
Domanda: In caso di esito favorevole al contribuente, può ottenere il rimborso di quanto già pagato?
Risposta: Sì. Se il contribuente aveva pagato in pendenza di causa (ad esempio perché aveva ricevuto una cartella di pagamento dopo la sentenza di primo grado sfavorevole, o perché aveva pagato spontaneamente una parte), e poi ottiene una sentenza definitiva favorevole che annulla o riduce il tributo, ha diritto al rimborso delle somme indebitamente versate. Il rimborso va richiesto all’ente impositore presentando un’istanza, allegando la copia conforme della sentenza. L’ufficio dovrà rifare i conteggi e restituire il capitale più interessi legali. Ci sono anche norme che prevedono il pagamento di interessi per il periodo della giacenza del denaro presso il Fisco.
Va però distinta la situazione:
- Se avevi ottenuto sospensione dell’atto, probabilmente non hai pagato nulla durante il processo, quindi non c’è nulla da restituire.
- Se non avevi ottenuto sospensione e l’Agente della riscossione ha riscosso (in genere un terzo dopo la sentenza di primo grado se sfavorevole, a meno di sospensione in appello), allora quello che hai pagato in più ti viene restituito.
- Se la sentenza definitiva riduce il debito, l’eccedenza pagata va rimborsata; se invece aumenta (caso raro: ad esempio appello dell’ente che porta a dover pagare di più rispetto al primo grado), il contribuente dovrà pagare la differenza (ma non oltre quanto accertato dall’ente originariamente, come detto).
In ogni caso, il contribuente vittorioso ha pure diritto alle spese di giudizio liquidate a suo favore (se non sono state compensate). Quindi l’ente dovrebbe pagargli anche quelle, entro il termine indicato in sentenza (o 120 giorni dalla notifica della sentenza se non specificato).
Se l’ente non adempie spontaneamente al rimborso, il contribuente può attivare il giudizio di ottemperanza presso la stessa Commissione (ora Corte) che ha emesso la sentenza passata in giudicato, chiedendo che sia ordinato all’Amministrazione di eseguire (art. 70 D.Lgs. 546/92). È uno strumento di tutela aggiuntivo per fare in modo che la vittoria nel merito abbia effetti concreti.
Domanda: Quali riforme recenti dovrei conoscere che impattano sul mio contenzioso?
Risposta: Se hai una controversia tributaria in corso nel 2024-2025, dovresti sicuramente essere informato di:
- Riforma Giustizia Tributaria 2022 (L. 130/2022): nuovi giudici, possibilità di testimonianza scritta, spinta alle conciliazioni, giudice monocratico per liti minori, ecc.
- Decreti attuativi 2023: in particolare il D.Lgs. 119/2023 (sanzioni penali-tributarie), D.Lgs. 120/2023 (procedura dichiarativa), D.Lgs. 121-128/2023 (vari aspetti fiscali), D.Lgs. 218-219/2023 (Statuto contrib. e accordi preventivi) e soprattutto D.Lgs. 220/2023 (contenzioso tributario). Di quest’ultimo abbiamo trattato le principali novità: processo telematico obbligatorio, ampliamento atti impugnabili (rifiuti autotutela), definizione anticipata dei ricorsi, sentenze più snelle, criteri sulle spese.
- Statuto del Contribuente riformato dal D.Lgs. 219/2023: contraddittorio obbligatorio generalizzato, chiarimenti su nullità/annullabilità (es. responsabile procedimento la cui mancanza non annulla l’atto, vizi di notifica), nuove garanzie sui tempi di risposta (ad es. fermi amministrativi solo dopo 60 giorni dallo schema di atto). Queste norme impattano sul merito perché un contraddittorio mancato può far annullare l’atto anche se il tributo era dovuto, e viceversa forniscono al contribuente un’occasione di difesa anticipata.
- Sentenze Corte Costituzionale 2023-2025: in particolare la n. 212/2022 (che ha dichiarato illegittima la norma sul giudice monocratico retroattivo per le liti in corso, questione transitoria ormai superata), la n. 4/2023 (su sanzioni e ne bis in idem), e soprattutto le n. 36/2025 (nuove prove in appello) e n. 137/2025 (preclusioni probatorie) di cui si è detto. Queste orientano come dovranno comportarsi i giudici d’ora in poi.
- Nuovo Codice di Giustizia Tributaria? Si parla anche di un possibile Testo Unico della Giustizia Tributaria (menzionato nei programmi di riforma), ma al luglio 2025 non risulta ancora emanato come atto unico: per ora ci si riferisce ancora al vecchio D.Lgs. 546/92 aggiornato.
Tenere conto delle riforme è importante: ad esempio se la tua causa riguarda un avviso notificato a fine 2023, devi sapere che si applicano in parte le regole vecchie e in parte le nuove (ci sono norme transitorie). Dal 2024 in poi, notifica e deposito atti telematici sono la regola; se fai un deposito cartaceo quando non permesso, il giudice potrebbe invitarti a regolarizzare. Insomma, informarsi o affidarsi a consulenti aggiornati è fondamentale per non incorrere in errori procedurali e per sfruttare a proprio vantaggio le novità (come la possibilità di impugnare un rifiuto di autotutela, cosa prima non fattibile).
Domanda: In fase di contestazione (verifica fiscale) avevo consegnato tutto, ma l’ufficio dice che non posso produrre altri documenti al giudice. È vero?
Risposta: Dipende. Se hai già consegnato tutto durante la verifica, non dovresti neanche avere altri documenti da produrre dopo. Forse intendi dire che non hai consegnato qualcosa in verifica e ora vorresti produrlo in giudizio, e l’ufficio eccepisce che non si può (ex art. 32 DPR 600/73). Ebbene, la norma dice effettivamente che i documenti non forniti al fisco su richiesta non sono utilizzabili in sede amministrativa e contenziosa. Tuttavia, come abbiamo spiegato, la Cassazione e la Corte Costituzionale ne danno un’interpretazione restrittiva: se l’omessa consegna non è dipesa da una tua colpa (es. l’ufficio non ha specificato bene cosa voleva, oppure ti chiedeva cose che aveva già o impossibili da avere in quel momento), il giudice può ammettere comunque il documento. Inoltre, quella preclusione si riferisce a richieste specifiche e mirate fatte dall’ufficio: se tu presenti un documento spontaneamente in giudizio che l’ufficio non ti aveva esplicitamente chiesto, non c’è alcuna preclusione formale (anche se l’ufficio potrebbe dire “potevi tirarlo fuori prima”).
Grazie alla sentenza Corte Cost. 137/2025, è stato chiarito che non possono essere richiesti al contribuente documenti che il Fisco ha già, e di riflesso non si può sanzionare la mancata esibizione di cose che erano nel suo database. Quindi, se ti oppongono l’art. 32, verifica:
- c’era stata una richiesta formale e specifica di quel documento? (se no, la preclusione non scatta proprio)
- se sì, tu hai un motivo valido per cui non lo hai prodotto allora? (es. non l’avevi reperito in tempo, oppure pensavi non servisse, o hai dubbi sulla legittimità della richiesta)
- il documento per caso era una cosa tipo estratto conto bancario che l’AdE poteva ottenere via anagrafe dei conti? (allora rientri nel caso di documento già acquisibile dall’ufficio)
Presenta comunque il documento al giudice, spiegando perché va accettato. Molto spesso i giudici tributari ammettono i documenti perché vogliono decidere con completezza di cognizione. Al massimo, se la controparte protesta, potrebbero valutare di tenerlo in considerazione ai fini di equità nelle spese (come da nuova norma: vittoria basata su documento tardivo => spese compensate). Ma difficilmente lo ignoreranno se è cruciale per stabilire la verità. Insomma: hai ancora buone chance di far valutare quel documento in giudizio.
Domanda: È vero che con le nuove norme devo fare tutto online?
Risposta: Sì, in larga parte sì. Il Processo Tributario Telematico (PTT) da facoltativo è divenuto obbligatorio. Significa che:
- Il ricorso va predisposto tramite i canali telematici (oggi si usa il Portale della Giustizia Tributaria chiamato SIGIT o la PEC). Ci si registra come utente (se sei difensore lo sei già, se sei contribuente in proprio devi ottenere le credenziali SPID ecc.), poi si carica il ricorso in formato PDF firmato digitalmente e lo si notifica via PEC all’ente resistente.
- Anche la costituzione in giudizio (deposito ricorso) si fa telematicamente sul Portale, allegando tutta la documentazione in PDF.
- Le comunicazioni dal tribunale (es. avvisi di udienza, comunicazione sentenza) avvengono via PEC.
- L’udienza stessa può tenersi da remoto (videoconferenza) su richiesta di parte: con le modifiche 2023 ora basta che una sola parte chieda discussione da remoto e questa avviene da remoto, a meno che l’altra non insista per presenza (in tal caso prevale la presenza).
- Solo i contribuenti che stanno senza difensore (autodifesa) o i casi eccezionali con autorizzazione possono usare ancora la carta. Ma anche in quei casi, di regola, il personale di segreteria scannerizza gli atti e li inserisce nel fascicolo elettronico.
Quindi, di fatto, sì: preparatevi a interagire telematicamente col processo. Per un imprenditore o privato non avvezzo, vuol dire delegare queste operazioni al proprio difensore (che lo fa abitualmente). Il difensore deve rispettare le regole tecniche (firma digitale degli atti, dimensione massima dei file, uso di formati consentiti, ecc.). Attenzione: un deposito privo di firma digitale è nullo, così come un ricorso via PEC da indirizzo non risultante dagli elenchi ufficiali può essere invalidante. Sono tecnicismi informatici, ma ormai sono parte integrante del processo.
L’aspetto positivo è che il telematico consente di seguire lo stato del procedimento online, scaricare gli atti dell’altra parte immediatamente dopo il deposito, evitare ritardi postali. Quindi, se ben sfruttato, aiuta anche la parte debole (contribuente) a stare sul pezzo e non perdersi scadenze.
Domanda: Che tempi devo aspettarmi per una decisione nel merito?
Risposta: I tempi del processo tributario possono variare molto a seconda del carico di lavoro delle Corti e della regione. Storicamente, mediamente:
- Primo grado: da 6 mesi fino a 2 anni, con medie intorno a 12-18 mesi in molte regioni. Alcune sedi sono più veloci, altre lente. Ad esempio, le Commissioni di regioni come Lombardia o Veneto spesso risolvono entro un anno; altre come la Puglia o la Sicilia a volte impiegano più tempo. Con la riforma e l’organico potenziato, c’è la volontà di ridurre i tempi. L’obiettivo sarebbe stare entro 12 mesi dappertutto, ma è un processo in divenire.
- Secondo grado (appello): qui storicamente c’era più arretrato. Si poteva attendere 2-3 anni per un’udienza d’appello. Anche qui dipende dalla regione. La riforma 2023 introdurrà gradualmente filtri e incentivi a conciliare per ridurre l’arretrato. Diciamo che un appello oggi come oggi potrebbe durare tra 1 e 3 anni mediamente.
- Cassazione: i ricorsi per Cassazione tributari potevano attendere anche 3-4 anni prima di essere trattati, ma la Suprema Corte ha fatto uno sforzo di smaltimento negli ultimi anni, tant’è che definisce più cause di quante ne entrino. Una stima attuale potrebbe essere 2-3 anni per avere una sentenza (salvo casi di particolare urgenza o materia trattata da Sezioni Unite che possono richiedere più tempo).
Quindi, in totale, una causa tributaria complessa, se percorre tutti e 3 i gradi, può durare tranquillamente 5-7 anni. È tanto, motivo per cui il sistema spinge su strumenti come la conciliazione o la definizione agevolata, per chiuderle prima.
Tieni però presente: se la tua è una piccola causa e la vinci in primo grado, magari l’ente neanche appella (per costi vs benefici) e finisce lì in pochi mesi. Oppure se perdi piccola causa, tu magari decidi di non appellare. Insomma, non tutte le liti fanno i 3 gradi.
Con i nuovi strumenti: - Sentenza in camera di consiglio su sospensiva (art. 47-ter): potresti avere un giudizio di merito in poche settimane se la cosa è chiara (casi rari, ma possibili in situazioni lampanti).
- Definizioni agevolate (tipo rottamazione, conciliazione): potresti chiudere tutto entro un anno senza proseguire.
Quindi la forbice temporale è ampia. Pianifica la tua strategia legale considerando il costo del tempo: a volte tirare avanti anni non conviene (interessi che maturano, risorse impegnate, incertezza), altre volte sì (es. attendere Cassazione sperando in una giurisprudenza favorevole maturata nel frattempo).
Domanda: Come incide la prospettiva del contribuente/debitore sulle questioni di merito?
Risposta: “Prospettiva del debitore” significa mettere al centro le ragioni del contribuente che deve difendersi da una pretesa fiscale. Questo incide sul modo di porre le questioni di merito:
- Il contribuente enfatizzerà sempre l’equità e la correttezza sostanziale: cercherà di far emergere se ha agito in buona fede, se c’è stata un’interpretazione incerta delle norme (dando magari rilievo allo Statuto del contribuente, allo spirito delle leggi), se l’importo preteso è sproporzionato rispetto alla realtà economica. Tutti questi argomenti, pur non giuridici in senso stretto, colorano le questioni di merito e possono influenzare la valutazione del giudice (specialmente nella fase di apprezzamento delle prove e nella quantificazione).
- Il contribuente punterà sui diritti e garanzie: ad esempio il diritto alla motivazione dell’atto, il diritto al contraddittorio, il diritto all’affidamento se c’erano circolari o prassi su cui si è basato, etc. Questi aspetti sono formalismi? Sì e no: sono formali ma servono a proteggere il merito, evitando che il cittadino subisca imposizioni ingiuste senza spiegazioni o confronto.
- Il contribuente, in quanto “debitore”, avrà interesse a ridurre il suo debito fiscale. Questo si traduce nel far valere tutte le possibili cause di riduzione: pagamenti già fatti (compensazioni), decadenze, prescrizioni, errori di calcolo, applicazione di sanzioni nella misura minima se ci sono attenuanti, non applicazione di interessi se non dovuti, etc. Ogni dettaglio che riduca la somma è rilevante dal suo punto di vista. Il suo difensore deve quindi scandagliare la cartella di pagamento o l’avviso per vedere se ad esempio sono stati computati interessi oltre il tasso legale, se è stata applicata una sanzione piena anziché ridotta in caso di particolare tenuità, e così via. A volte l’ente stesso fa errori di calcolo – tutt’altro che rari – e portarli alla luce è merito del contribuente.
- La prospettiva del debitore enfatizza anche le conseguenze pratiche del tributo: far capire al giudice che quell’imposizione magari metterebbe in crisi l’azienda, o colpisce un patrimonio familiare modesto, può non essere un argomento giuridico, ma certamente umanizza la vicenda. Un giudice, dovendo scegliere tra due possibili interpretazioni, potrebbe – inconsciamente o meno – propendere per quella meno distruttiva per il cittadino, se è sostenibile. Naturalmente non si può fare affidamento su questo (la legge è legge), ma fa parte dell’arte forense dipingere la vicenda anche nei suoi riflessi sul contribuente.
- D’altro canto, il contribuente dovrebbe evitare approcci meramente dilatori o pretestuosi: i giudici riconoscono quando un ricorso è fatto solo per perdere tempo o contestare l’ovvio. Questo potrebbe ritorcersi contro in termini di spese di giudizio (condanna aggravata, se considerato temerario) e nella minore credibilità complessiva. Meglio concentrarsi su questioni di merito serie e fondate.
In sintesi, la prospettiva del debitore porta a trattare le questioni di merito con un occhio di riguardo ai diritti del contribuente e alla sostanza economica della vicenda, cercando giustizia sostanziale oltre che formale.
Domanda: Le sentenze della Corte Costituzionale n. 36/2025 e n. 137/2025 come mi riguardano concretamente?
Risposta:
- La sentenza 36/2025 sulla preclusione delle nuove prove in appello ti riguarda se sei in sede di appello (o lo sarai) e hai bisogno di depositare documenti che non avevi prodotto in primo grado. Ad esempio, mettiamo che in primo grado hai perso anche perché non avevi presentato un certo documento (magari la procura del commercialista, o un documento bancario); col vecchio art. 58 novellato 2023 non avresti potuto rimediare in appello, rischiando l’inammissibilità del documento e quindi di perdere di nuovo. Ora, grazie a Corte Cost. 36/2025, puoi presentare quel documento in appello e il giudice deve ammetterlo almeno nei casi come procure e simili, e in generale ha più margine per ammetterlo se è importante. Quindi concretamente hai una chance in più di far valutare le tue prove in secondo grado. Se invece sei la controparte (il Fisco) questa sentenza significa che non potrai più far leva su quel divieto per far escludere documenti del contribuente; dovrai giocartela nel merito.
- La sentenza 137/2025 sulla preclusione probatoria art. 32 DPR 600/73 ti riguarda se durante la verifica fiscale magari non avevi dato alcuni documenti all’ufficio e ora l’ufficio sostiene che non li puoi usare a tua difesa. La Corte Costituzionale ha detto che la norma va interpretata in modo da non ledere il diritto di difesa, e soprattutto che non è ragionevole pretendere documenti che il Fisco già ha. Quindi, se il tuo caso è che l’ufficio ti chiede fatture che in realtà erano nel suo database (tipo spesometro) o estratti che poteva ottenere da Banca d’Italia, ecc., tu potrai dire: “Guardi, secondo la Consulta questa preclusione non si applica, perché quell’informazione l’Agenzia poteva già averla o comunque la richiesta era eccessiva”. Anche se il tuo caso non rientra perfettamente in quell’esempio, c’è un clima più favorevole ad una lettura pro-contribuente: il giudice potrebbe accettare i tuoi documenti con la motivazione che il tuo diritto di difesa prevale sull’eventuale inerzia che hai avuto in fase amministrativa, specie se non dolosa.
In pratica, queste pronunce costituzionali aumentano le armi difensive del contribuente in giudizio, garantendo che il processo tributario rimanga incentrato sul merito vero e non su formalità (come “hai dimenticato di allegare la delega, quindi perdi il ricorso” – scenario ora scongiurato). Dovresti quindi essere certo che il tuo avvocato conosca queste sentenze e le richiami se del caso nelle memorie, per convincere i giudici ad adottare un’interpretazione conforme.
Domanda: Cosa posso aspettarmi dall’introduzione dei nuovi giudici tributari “professionali”?
Risposta: La riforma ha previsto che gradualmente verranno inseriti in organico giudici tributari reclutati tramite concorso, a tempo pieno. Questo dovrebbe portare vari benefici:
- Maggiore specializzazione e preparazione tecnica: avendo giudici dedicati solo al tributario (prima molti erano magistrati civili/amministrativi aggregati o professionisti/laici nominati per mandato), è probabile che conoscano a fondo la materia e siano aggiornati. Ciò dovrebbe riflettersi in sentenze di merito più centrate e qualificate, con minori errori o superficialità.
- Uniformità: un corpo di giudici reclutati con criteri uniformi e formati potenzialmente in modo coordinato potrebbe portare a decisioni meno “a macchia di leopardo” sul territorio. Ad esempio, finora capitava che la Commissione di Regione X avesse un orientamento completamente diverso da quella di Regione Y su una certa questione di merito (tipo deducibilità di certi costi): con giudici professionali e un più forte ruolo nomofilattico della Cassazione, queste differenze potrebbero ridursi.
- Tempestività: giudici a tempo pieno dovrebbero smaltire più velocemente gli arretrati e fissare prima le udienze. Questo è l’auspicio per i prossimi anni – di già si è visto un incremento di udienze fissate anche in periodi tradizionalmente meno attivi.
Per il contribuente, avere un giudice più preparato è una garanzia in più che la sua questione di merito venga capita correttamente. Di contro, gli “svuotamenti di backlog” potrebbero significare che cause vecchie vengono decise più rapidamente ora – quindi se un contribuente contava sul trascinare la causa all’infinito, dovrà ricredersi.
Inoltre, la professionalizzazione potrebbe ridurre certe “empatie” locali: talora commissioni locali erano accusate di essere troppo vicine all’ente locale o viceversa troppo morbide coi contribuenti locali. Giudici terzi e professionali dovrebbero assicurare terzietà assoluta.
Dunque, aspettati più professionalità e rigore: errori procedurali saranno colti al volo (quindi occhio a non farne), ma al contempo pretese fiscali infondate saranno (si spera) bacchettate con altrettanta competenza.
Conclusione: Le questioni di merito nel processo tributario rappresentano il nodo cruciale attorno a cui ruota la tutela del contribuente contro le pretese fiscali. Grazie a un quadro normativo in evoluzione e a importanti arresti giurisprudenziali, oggi vi è una maggiore attenzione a garantire che tali questioni vengano trattate con completezza e giustizia, senza restare soffocate da formalismi. Per avvocati, imprese e cittadini, ciò significa opportunità ma anche la necessità di prepararsi e agire con consapevolezza. La conoscenza approfondita dei propri diritti e dei meccanismi processuali – unita a una solida difesa nel merito – è l’arma migliore per affrontare con successo il contenzioso tributario dal lato del “debitore” fiscale.
Fonti (normative e giurisprudenziali)
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato fino al 2025), in particolare art. 36, comma 2, n.4, modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 – Disposizioni in materia di contenzioso tributario (in vigore dal 2024): introduce, tra le altre cose, la motivazione sulle questioni di merito e di nullità atto, la definizione anticipata in fase cautelare, sentenze semplificate, compensazione spese per prova tardiva, obbligo PTT, impugnabilità dinieghi di autotutela.
Legge 31 agosto 2022, n. 130 – Riforma della giustizia tributaria (istituzione Corti Giust. Trib., giudici professionali, testimonianza scritta, ecc.).
D.Lgs. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 – Sottoscrizione avvisi di accertamento: la giurisprudenza (Cass. Sez. V n. 1042/2023) ha affermato la nullità dell’atto non sottoscritto dal capo ufficio o delegato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4 – Preclusione utilizzo documenti non esibiti: interpretato restrittivamente da Cass. (v. Cass. n. 701/2023) e oggetto di sentenza Corte Cost. 137/2025.
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 8 aprile 2020 n. 8265 (caso “Albergo Aurora”) – Principio: il processo tributario è di impugnazione-merito e il giudice, ravvisata l’infondatezza sostanziale dell’atto, deve decidere nel merito quantificando la pretesa entro i limiti delle ragioni addotte dall’ufficio e dei dati forniti.
Corte di Cassazione, Sez. VI-5, ordinanza 17 aprile 2023 n. 10117 – Ribadisce che il processo tributario mira a una decisione sul rapporto fiscale, non alla mera legittimità formale.
Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 16 maggio 2019 n. 10422 – Chiarisce che l’omessa pronuncia è configurabile solo su questioni di merito non esaminate, non su eccezioni processuali.
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 15 marzo 2024 n. 7450 – Conferma (anche per analogia al tributario) che l’omessa pronuncia non ricorre se il punto non deciso è assorbito implicitamente dalla decisione adottata.
Corte Costituzionale, sentenza 27 marzo 2025 n. 36 – Ha dichiarato incostituzionale in parte la norma (art. 58 c.2-bis D.Lgs. 546/92 introdotta nel 2023) che vietava la produzione di nuovi documenti in appello, ripristinando la possibilità di produrre in secondo grado procure, deleghe e documenti non prodotti prima.
Corte Costituzionale, sentenza 28 luglio 2025 n. 137 – Ha affermato la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32 DPR 600/73: la preclusione probatoria va applicata in modo restrittivo, escludendo che colpisca documenti che l’Amministrazione già possedeva, così da non ledere il diritto di difesa.
Dipartimento per il Programma di Governo – Scheda di sintesi D.Lgs. 220/2023 (15 gennaio 2024): illustra le principali novità della riforma del processo tributario 2023 (telematico obbligatorio, sentenze semplificate, nuove ipotesi di compensazione spese, ampliamento atti impugnabili).
Hai sentito parlare di questioni di merito nel contenzioso fiscale ma non sai cosa significano davvero? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai sentito parlare di questioni di merito nel contenzioso fiscale ma non sai cosa significano davvero? Se hai ricevuto un avviso di accertamento o hai avviato un ricorso tributario, è fondamentale capire la differenza tra vizi formali e questioni di merito, perché è proprio su queste ultime che spesso si gioca l’esito della causa.
Le questioni di merito riguardano il contenuto sostanziale della pretesa fiscale: in altre parole, se il Fisco ha davvero ragione nel chiederti quella somma.
🎯 Esempi di questioni di merito
- La somma richiesta è sbagliata nel calcolo
- I redditi contestati non sono realmente percepiti
- Le spese considerate “non deducibili” in realtà lo sono
- Il contribuente ha già versato quanto dovuto, ma non risulta nei sistemi
- L’atto si basa su presunzioni non dimostrate o infondate
A differenza dei vizi formali (come notifiche errate o mancanza di motivazione), le questioni di merito chiedono al giudice di valutare se l’imposta, la sanzione o il tributo richiesto siano effettivamente dovuti o no.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Esamina nel dettaglio l’avviso di accertamento o l’atto impugnato
- 📌 Individua le questioni di merito più rilevanti su cui fondare la difesa
- ✍️ Redige un ricorso tecnico, con prove concrete e riferimenti normativi
- ⚖️ Ti rappresenta in giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
- 🔁 Ti assiste anche nelle fasi successive: appello, definizione agevolata, sospensione del ruolo
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale
- ✔️ Specializzato nella gestione di ricorsi basati su questioni sostanziali e tecniche
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Nel processo tributario, le questioni di merito sono il cuore della tua difesa. Riguardano la verità sostanziale del tuo caso: se non sei davvero debitore, il giudice può annullare l’atto anche se è formalmente corretto.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa comincia dal merito.