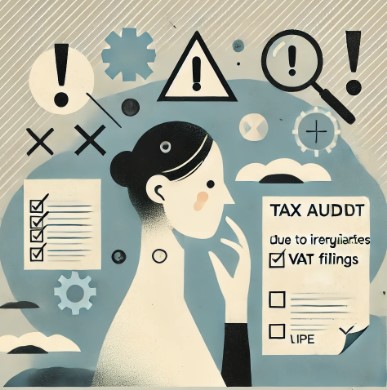Hai ricevuto un accertamento per irregolarità nelle comunicazioni LIPE?
L’Agenzia delle Entrate ti contesta differenze tra le liquidazioni periodiche IVA (LIPE) e i dati presenti nella dichiarazione annuale IVA? In questi casi è fondamentale capire l’origine dell’incongruenza, valutare se si tratta di un errore formale o sostanziale e difendersi tempestivamente per evitare sanzioni o avvisi di accertamento esecutivi.
Quando può arrivare un accertamento per irregolarità LIPE?
– Quando le LIPE trasmesse non coincidono con la dichiarazione IVA annuale
– Quando hai omesso l’invio di una o più comunicazioni trimestrali
– Quando l’Agenzia rileva crediti IVA indicati nelle LIPE non confermati nella dichiarazione
– Quando risultano debiti IVA omessi o riportati in modo errato
– Quando hai effettuato rettifiche parziali non comunicate correttamente
Cosa contiene l’avviso dell’Agenzia delle Entrate?
– Il riepilogo delle liquidazioni IVA trasmesse trimestralmente
– Il confronto con la dichiarazione IVA annuale
– L’indicazione delle anomalie rilevate (es. eccedenze di credito, imposta dovuta non versata)
– L’invito a fornire chiarimenti o a regolarizzare spontaneamente con ravvedimento operoso
– L’avvertimento che, in caso di inerzia, verrà emesso avviso di accertamento con sanzioni e interessi
Come puoi difenderti da un accertamento per irregolarità LIPE?
– Verifica se le differenze derivano da errori di compilazione, inversione di segno o saldi riportati male
– Controlla se hai già presentato dichiarazioni integrative che sanano l’errore
– Se si tratta di un errore formale, valuta la correzione con ravvedimento operoso, per ridurre al minimo le sanzioni
– Predisponi una risposta scritta e documentata, con il supporto del tuo commercialista o di un avvocato tributario
– Dimostra l’esistenza di giustificazioni contabili (es. proroghe, compensazioni, versamenti tardivi ma effettuati)
– Se l’Agenzia ha già emesso un avviso esecutivo, valuta la possibilità di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Cosa puoi ottenere con la giusta difesa?
– L’archiviazione dell’irregolarità, se giustifichi correttamente le anomalie
– La riduzione delle sanzioni, in caso di adesione o ravvedimento tempestivo
– La rateizzazione del debito IVA, se non puoi pagare in un’unica soluzione
– La tutela della tua posizione fiscale, evitando iscrizioni a ruolo e pignoramenti
– L’evitamento di ulteriori controlli o verifiche, se sistemi anche gli anni successivi
Attenzione: molte irregolarità LIPE derivano da errori formali o comunicazioni omesse in buona fede, ma possono trasformarsi rapidamente in accertamenti esecutivi con sanzioni rilevanti. Intervenire subito è essenziale per evitare danni maggiori.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in IVA, contenzioso tributario e irregolarità dichiarative ti spiega cosa fare in caso di avviso per difformità nelle LIPE, come rispondere, quando correggere e come difenderti in modo efficace.
Hai ricevuto un avviso per irregolarità nelle LIPE?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a chiarire la tua posizione, correggere eventuali errori e proteggerti da sanzioni e accertamenti.
Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento per irregolarità LIPE – ossia per errori, omissioni o comunicazioni inesatte nelle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) – può generare forte preoccupazione nel contribuente. Dal punto di vista di chi subisce l’accertamento (il debitore), è fondamentale comprendere sia la natura di queste contestazioni sia gli strumenti di difesa a disposizione. La normativa italiana prevede specifici obblighi e sanzioni in caso di mancato invio, invio tardivo o dati inesatti nelle comunicazioni trimestrali IVA, ma offre anche mezzi per regolarizzare spontaneamente le violazioni e per impugnare eventuali atti impositivi. In questa guida avanzata – aggiornata a luglio 2025 e arricchita con fonti normative e giurisprudenziali aggiornate – illustreremo in dettaglio come difendersi efficacemente da un accertamento legato alle LIPE.
Affronteremo inizialmente cosa sono le LIPE e perché sono importanti, quindi esamineremo le varie irregolarità che possono verificarsi (omissioni, comunicazioni tardive o infedeli) e le sanzioni previste. Vedremo come regolarizzare tali violazioni tramite ravvedimento operoso e quali sono le conseguenze se non si interviene in tempo (dall’arrivo di una comunicazione di irregolarità fino agli atti di accertamento veri e propri). Saranno trattate le strategie di difesa in sede amministrativa (richieste in autotutela, accertamento con adesione, definizioni agevolate) e in sede contenziosa (ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, fino alla Corte di Cassazione). Non mancheranno esempi concreti, modelli di atti difensivi (come un fac-simile di ricorso tributario) e un’analisi dei possibili profili penali connessi alle irregolarità in materia IVA, supportati dalle più recenti sentenze delle autorità giudiziarie. Troverete inoltre tabelle riepilogative (ad esempio sulle sanzioni e riduzioni, sulle scadenze LIPE, sul procedimento di impugnazione) e una sezione finale di Domande e Risposte per chiarire i dubbi frequenti.
Le comunicazioni LIPE: quadro generale
Le Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) sono un adempimento introdotto nell’ordinamento italiano a partire dal 2017 (in attuazione dell’art. 21-bis del D.L. 78/2010, come modificato dalla legge 225/2016). Si tratta di comunicazioni trimestrali (o mensili, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile) attraverso le quali i soggetti passivi IVA comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati delle proprie liquidazioni IVA periodiche. In ogni modello LIPE vengono riepilogati gli elementi fondamentali del periodo di riferimento: IVA a debito, IVA a credito e saldo (eventualmente, l’IVA da versare ovvero il credito da riportare). Lo scopo di questo adempimento è incrementare la trasparenza e il controllo sul versamento dell’IVA, consentendo al Fisco di monitorare infrannualmente l’andamento dell’imposta e di contrastare più tempestivamente eventuali evasioni o irregolarità.
Chi è obbligato: devono presentare la comunicazione LIPE tutti i titolari di partita IVA obbligati alla liquidazione periodica dell’imposta, a prescindere dalla natura giuridica o dal regime contabile (incluse società, ditte individuali, professionisti e anche gli enti pubblici per le attività commerciali). Sono invece esonerati dall’obbligo i contribuenti per i quali non sussiste la liquidazione periodica IVA, ad esempio chi applica regimi che escludono l’IVA (come il regime forfettario e altri contribuenti minori). In generale, se un soggetto è tenuto a presentare l’dichiarazione IVA annuale, allora durante l’anno deve anche inviare le comunicazioni LIPE relative ai trimestri di attività.
Periodicità e scadenze: le liquidazioni periodiche IVA normalmente seguono cadenza trimestrale:
- 1º trimestre (gennaio-marzo) – scadenza invio: 31 maggio dell’anno corrente;
- 2º trimestre (aprile-giugno) – scadenza invio: 30 settembre dell’anno corrente (inizialmente prevista al 16 settembre, poi prorogata al 30/09 con il DL Semplificazioni 2022);
- 3º trimestre (luglio-settembre) – scadenza invio: 30 novembre dell’anno corrente;
- 4º trimestre (ottobre-dicembre) – scadenza invio: 28 febbraio dell’anno successivo.
Le date esatte possono subire piccole variazioni se cadono di sabato, domenica o festivi (in tal caso la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo). Ad esempio, per il II trimestre 2025 la scadenza sarà il 30 settembre 2025 (essendo il 30/09 un martedì lavorativo), mentre per il IV trimestre 2024 è stata il 29 febbraio 2025 (poiché il 28 cadeva di venerdì, comunque giorno lavorativo). È bene tenere d’occhio eventuali proroghe legislative: negli ultimi anni alcune scadenze sono state eccezionalmente posticipate da decreti “semplificazioni” o “proroga termini” (come avvenuto per il secondo trimestre 2022 e 2023).
Modalità di invio: la presentazione avviene esclusivamente in forma telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite i canali online dell’Agenzia (Fisconline/Entratel) direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente fiscale, CAF, etc.). Si utilizza uno specifico modello ministeriale per le LIPE, approvato annualmente, in cui indicare i dati contabili riepilogativi di ciascuna liquidazione periodica. I dati trasmessi sono di natura provvisoria, nel senso che costituiscono un riepilogo intermedio: eventuali differenze o correzioni possono emergere con la dichiarazione IVA annuale, che rimane il documento dichiarativo principale ai fini IVA.
Importanza delle LIPE: pur essendo “semplici” comunicazioni (non contengono il calcolo dettagliato di tutte le operazioni come fa la dichiarazione annuale), le LIPE hanno una rilevanza significativa. Esse infatti:
- Permettono al Fisco di confrontare periodicamente l’IVA dichiarata e versata dal contribuente con altre risultanze (ad esempio i dati delle fatture elettroniche o dello spesometro fino al 2021) per individuare tempestivamente incongruenze.
- Segnalano in anticipo eventuali posizioni a credito o a debito di IVA: se un contribuente risulta costantemente a credito o se viceversa omette di versare l’IVA dovuta in un trimestre, ciò può far scattare controlli o comunicazioni di compliance.
- Sono propedeutiche alla dichiarazione annuale: benché il dichiarativo IVA finale resti l’adempimento più importante (ed è quello da cui scaturisce l’eventuale imposta a conguaglio annuale), le comunicazioni trimestrali ne costituiscono l’anticipo, tanto che l’art. 21-bis D.L. 78/2010 prevede sanzioni proprio per garantire che i dati infrannuali vengano forniti correttamente e puntualmente al Fisco.
In sintesi, le LIPE rappresentano un obbligo formale ma con implicazioni sostanziali sul controllo IVA: dimenticarsene o commettere errori può comportare sanzioni anche pesanti e potenziali accertamenti. Nei paragrafi successivi vedremo nel dettaglio quali irregolarità possono presentarsi e come difendersi.
Irregolarità nelle LIPE: omissioni, errori e sanzioni
L’ordinamento tributario considera una violazione ogni irregolarità legata all’adempimento LIPE. In particolare, l’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 (introdotto con decorrenza 2017) stabilisce che “l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000”. Tale norma, di rango primario, unifica in un’unica fattispecie sanzionatoria le varie possibili irregolarità delle LIPE, ossia:
- Omessa comunicazione: la LIPE non è stata trasmessa affatto entro la scadenza prevista; rientra in questa categoria sia la totale omissione, sia la presentazione oltre un termine considerato utile (vedremo a breve il discorso della lieve tardività entro 15 giorni).
- Comunicazione tardiva: la LIPE è stata sì inviata spontaneamente dal contribuente, ma oltre la scadenza trimestrale (ad esempio invio del 1º trimestre a luglio anziché entro il 31 maggio). In questi casi si configura comunque un’infrazione, ma la norma prevede una attenuazione della sanzione se il ritardo è contenuto entro 15 giorni.
- Comunicazione incompleta o infedele: la LIPE è stata inviata ma contiene errori od omissioni nei dati riportati, rendendola non veritiera rispetto alla liquidazione IVA effettiva. Ad esempio, indicazione errata dell’IVA a debito/credito, mancato inserimento di alcuni dati, oppure invertire segni e importi, ecc. In generale qualsiasi divergenza tra i dati reali della liquidazione e quelli comunicati costituisce infedeltà o incompletezza.
Dal punto di vista sanzionatorio, omissione, tardività e infedeltà sono trattate allo stesso modo dal citato art. 11 co.2-ter D.Lgs. 471/97, con una sanzione amministrativa variabile da €500 a €2.000 per ciascuna comunicazione violata. Ciò significa che la sanzione si applica per ogni trimestre in cui viene riscontrata l’irregolarità: ad esempio, se un contribuente non invia affatto le LIPE di due trimestri, formalmente commette due violazioni distinte e potenzialmente subisce due sanzioni (ciascuna fra €500 e €2.000). Analogamente, invii tardivi o infedeli relativi a trimestri differenti configurano pluralità di violazioni. È importante notare che la soglia di €500 rappresenta il minimo edittale (la sanzione minima prevista dalla legge) mentre €2.000 è il massimo edittale: entro questo range, l’Agenzia delle Entrate può determinare l’importo concreto della sanzione tenendo conto di eventuali criteri di gravità, recidiva, entità del ritardo o altre circostanze. Nella prassi, in assenza di elementi aggravanti particolari, viene generalmente contestata la sanzione minima edittale (€500 per ciascuna LIPE omessa/incompleta) oppure la metà di tale minimo (€250) se ricorre l’attenuante del lieve ritardo entro 15 giorni.
Riduzione a metà della sanzione per ritardi entro 15 giorni: la norma prevede espressamente che la sanzione di €500-2.000 sia ridotta alla metà (quindi diventa €250-1.000) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria, oppure se entro lo stesso termine di 15 giorni viene inviato un nuovo file con i dati corretti (nel caso di precedente comunicazione errata). In altre parole, è concesso un breve margine di tolleranza di 15 giorni oltre la deadline: se il contribuente vi si attiene, la violazione è comunque sanzionata ma in misura dimezzata. Ad esempio, per una LIPE del 1º trimestre con scadenza 31 maggio, l’invio effettuato entro il 15 giugno determina l’applicazione di sanzione ridotta (€250 minima); se invece l’invio avviene dal 16 giugno in poi (oltre i 15 gg di tolleranza), la sanzione minima sale a €500. Questa attenuazione opera anche nel caso in cui la comunicazione originaria conteneva errori: se i dati vengono corretti e ritrasmessi entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione per infedeltà dati è dimezzata. Oltre tale finestra temporale, scatta il trattamento ordinario.
Esempio: l’azienda Alfa doveva trasmettere la LIPE del 2º trimestre entro il 30 settembre, ma per dimenticanza la invia solo il 10 ottobre (10 giorni di ritardo): incorrerà nella sanzione ridotta (€250 minima) perché entro 15 giorni dal termine. Se invece avesse inviato il 25 ottobre (25 giorni di ritardo), sarebbe applicabile la sanzione piena (€500 minima). Allo stesso modo, se Alfa inviando la LIPE il 30 settembre aveva commesso un errore materiale nei dati e lo rettifica con un nuovo invio correttivo entro il 15 ottobre, la sanzione per “dati infedeli” sarà dimezzata.
Carattere formale o sostanziale della violazione: la mancata o inesatta comunicazione LIPE viene generalmente considerata una violazione formale ai fini fiscali, nel senso che riguarda un obbligo comunicativo e non incide direttamente sulla determinazione del tributo dovuto. Tuttavia, attenzione: la Cassazione ha chiarito che non si tratta di un mero formalismo privo di effetti, ma di un obbligo strumentale la cui omissione può comportare (e in effetti comporta) un danno all’azione di controllo e un ritardato incasso per l’Erario. In particolare, l’omessa presentazione delle comunicazioni IVA, specie se accompagnata dal mancato versamento dell’imposta nelle scadenze periodiche, non è una violazione meramente formale non punibile. Al contrario, essa rimane sanzionabile (ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997, nel caso di omessa dichiarazione annuale, e ai sensi dell’art. 11 co.2-ter per le LIPE) perché provoca un ritardato versamento d’imposta e un deficit temporaneo di cassa per l’Erario. Questa impostazione è coerente con la giurisprudenza unionale e nazionale che tutela la sostanza degli obblighi IVA: il contribuente non perde il diritto alla detrazione di eventuali crediti IVA se rispetta i requisiti sostanziali entro termini prorogati, ma parallelamente l’Amministrazione finanziaria può irrogare sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi formali di comunicazione e dichiarazione (interessi e sanzioni restano comunque dovuti anche se alla fine il credito è riconosciuto). Dunque, dal punto di vista difensivo, non è efficace sostenere che l’omissione di una LIPE sia un’infrazione puramente formale da non sanzionare: la legge la qualifica come violazione e i giudici la ritengono lesiva degli interessi erariali (in misura del temporaneo ritardo informativo e finanziario). Semmai, come vedremo, si potrà argomentare in sede di contestazione sulla proporzionalità della sanzione in rapporto al caso concreto o sul cumulo con altre sanzioni.
Cumulo di sanzioni e violazioni plurime: se un contribuente omette o sbaglia più comunicazioni LIPE (ad esempio tutti i trimestri di un anno), si pone il problema se le sanzioni debbano sommarsi o se si applichi il cumulo giuridico (ossia un’unica sanzione più grave anziché tante sanzioni minori sommate). In via generale, l’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 prevede il cumulo giuridico quando si commettono più violazioni formali della medesima indole in tempi ravvicinati, applicando la sanzione per la violazione più grave aumentata da 1/4 al doppio (nei limiti dei massimi edittali). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le violazioni “prodromiche” come l’omessa fatturazione o – per analogia – l’omessa comunicazione non beneficiano del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso, dovendosi pagare ogni sanzione singolarmente. In fase contenziosa, alcune Commissioni Tributarie potrebbero valutare l’applicazione del cumulo giuridico se più omissioni di LIPE sono contestate con un unico atto, ma in assenza di un orientamento univoco è prudente aspettarsi che ogni periodo sia sanzionato autonomamente (come “violazione plurima” si applicherebbe il cumulo materiale, cioè la somma delle sanzioni). Quindi, quattro trimestri omessi possono significare – nel peggiore dei casi – quattro sanzioni da €500 (totale €2.000) se applicato il minimo per ciascuno. Solo se l’ufficio emettesse un unico atto di contestazione che considera l’omissione prolungata potrebbe invocarsi il criterio del cumulo giuridico, ma ciò è discrezionale e non obbligatorio, e comunque la somma non supererebbe il doppio del massimo (€4.000).
Sanzioni ulteriori in caso di irregolarità sostanziali: va sottolineato infine che l’irregolarità LIPE spesso si accompagna o segnala inadempimenti sostanziali. Ad esempio, se la comunicazione è infedele perché il contribuente non ha registrato o non ha dichiarato alcune operazioni imponibili, oltre alla sanzione formale di cui sopra, troveranno applicazione le sanzioni sostanziali pertinenti: in particolare l’art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 punisce la mancata fatturazione o registrazione di operazioni imponibili con una sanzione dal 90% al 180% dell’IVA non documentata. Quindi, se ad esempio Tizio non comunica una LIPE perché ha omesso interamente di fatturare alcuni ricavi (evadendo così l’IVA relativa), sarà sanzionato sia per l’omessa comunicazione (€500-2.000) sia per l’omessa fatturazione (minimo 90% dell’imposta evasa). Analogamente, se la LIPE manca perché non è stata proprio presentata la dichiarazione IVA annuale di quell’anno, oltre alla sanzione fissa per la LIPE vi sarà la ben più grave sanzione per dichiarazione omessa (che, in caso di imposta dovuta, è pari al 120% – fino a 240% – dell’imposta non dichiarata, con minimo €250) ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 471/97. È importante avere chiaro questo aspetto: la sanzione da €500-2.000 è relativa solo alla violazione dell’obbligo comunicativo; non esime il contribuente dalle responsabilità per eventuali violazioni sul versante sostanziale (mancati versamenti IVA, dichiarazioni infedeli, ecc.). Dunque, un accertamento per irregolarità LIPE potrebbe contenere sia la contestazione formale (omessa comunicazione) sia il recupero dell’imposta non versata con relative sanzioni proporzionali. In questi casi, la difesa dovrà articolarsi su entrambi i fronti: provare la correttezza sostanziale (se possibile) o regolarizzare l’imposta dovuta, e contestare errori o eccessi nell’applicazione delle sanzioni formali e sostanziali. Nella sezione esempi pratici vedremo una simulazione di questo scenario complesso.
Riassumendo le sanzioni principali per le irregolarità LIPE (per singola comunicazione violata):
- Omessa, tardiva o infedele comunicazione LIPE: sanzione amministrativa da €500 a €2.000 (art. 11, co.2-ter D.Lgs. 471/97); ridotta alla metà (€250-1.000) se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
- Se la violazione LIPE si accompagna a mancato versamento di IVA dovuta, si aggiunge la sanzione per omesso versamento: 30% dell’imposta non versata (art. 13 D.Lgs. 471/97) ridotta a 15% se il versamento avviene con un ritardo inferiore a 90 giorni.
- Se la violazione LIPE consegue a operazioni non fatturate/non registrate (evasione d’imposta), si applica la sanzione del 90-180% dell’IVA evasa (art. 6, co.1 D.Lgs. 471/97), salvo che il fatto configuri reato (in tal caso si valutano anche i profili penali, come vedremo).
- In caso di omessa dichiarazione annuale IVA, la mancata presentazione delle LIPE di quell’anno non fa venir meno l’obbligo dichiarativo: se la dichiarazione annuale è poi presentata tardivamente, rimane la sanzione fissa (omessa dichiarazione, da €250 a €1000 se senza debito d’imposta, altrimenti sanzione proporzionale min.120% imposta) e restano dovute le sanzioni per ciascuna LIPE omessa.
Le sanzioni amministrative tributarie si prescrivono in 5 anni (dalla commissione della violazione) se non contestate prima, e gli atti di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Ad esempio, per una LIPE omessa nel 2020, l’atto sanzionatorio deve essere notificato entro il 31/12/2025. Questo termine di decadenza sarà importante da verificare in sede difensiva: qualora l’Agenzia notifichi la contestazione oltre i termini, la sanzione non è dovuta per intervenuta decadenza.
Nota: in caso di contestazioni multiple di sanzioni formali e sostanziali, possono attivarsi procedure di cumulo e riduzione in sede di definizione o giudizio. Ad esempio, il contribuente che definisce in acquiescenza un avviso di accertamento con più sanzioni beneficia in genere del cumulo giuridico e di riduzioni (vedi oltre). La complessità delle interazioni fra sanzioni rende ancora più importante, per il debitore, conoscere gli strumenti di regolarizzazione e di difesa, illustrati nei capitoli seguenti.
Come regolarizzare le violazioni LIPE: il ravvedimento operoso
Prima che l’irregolarità LIPE venga contestata dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Questo strumento consente di sanare violazioni tributarie commesse, beneficiando di sanzioni ridotte in misura proporzionale alla tempestività del ravvedimento. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 104/E del 28 luglio 2017, ha espressamente chiarito che il ravvedimento operoso è applicabile anche alle violazioni in materia di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Ciò non era scontato in origine (né la legge né le istruzioni del modello LIPE lo disciplinavano esplicitamente), ma il Fisco ha confermato che la comunicazione LIPE, pur distinta e autonoma rispetto alla dichiarazione annuale, è comunque un adempimento fiscale per il quale si possono regolarizzare omissioni o errori pagando la sanzione in misura ridotta.
Come effettuare il ravvedimento: il contribuente che si accorge di non aver presentato una LIPE, di averla presentata in ritardo o con dati sbagliati, può intervenire spontaneamente seguendo questi passi:
- Invio (o re-invio) della comunicazione corretta: se la violazione consiste in un’omissione totale, occorre trasmettere la LIPE mancante il prima possibile. Se invece si tratta di errori nei dati inviati, occorre inviare una comunicazione sostitutiva corretta. L’invio va fatto utilizzando i canali telematici come di consueto.
- Nota: Se la regolarizzazione avviene dopo che si è già presentata la dichiarazione IVA annuale per l’anno in questione (che ricomprende i dati di quel periodo), l’Agenzia ha chiarito che non è necessario inviare una LIPE integrativa tardiva. In pratica:
- se si ravvede prima di presentare la dichiarazione annuale IVA, bisogna inviare la LIPE omessa/corretta;
- se ci si ravvede compilando la dichiarazione annuale (ad esempio indicando nel quadro VH i dati di un trimestre omesso) entro il termine di presentazione di quest’ultima, allora la LIPE mancante si considera sanata senza bisogno di invio separato;
- se il ravvedimento avviene dopo aver già presentato la dichiarazione annuale (e quindi quell’omissione non è stata sanata in sede dichiarativa), occorrerà presentare una dichiarazione IVA integrativa per correggere i dati dell’anno. In tal caso alle sanzioni LIPE si aggiungeranno quelle per dichiarazione integrativa tardiva (violazione di cui all’art. 5 o art. 8 D.Lgs. 471/97, a seconda dei casi).
- Nota: Se la regolarizzazione avviene dopo che si è già presentata la dichiarazione IVA annuale per l’anno in questione (che ricomprende i dati di quel periodo), l’Agenzia ha chiarito che non è necessario inviare una LIPE integrativa tardiva. In pratica:
- Calcolo della sanzione ridotta e degli eventuali interessi: una volta predisposto l’invio, occorre versare la sanzione in misura ridotta secondo i parametri del ravvedimento operoso, nonché gli interessi legali (se dovuti) calcolati giornalmente sull’eventuale tributo non versato.
- Sanzione ridotta: per le violazioni LIPE, la sanzione base da considerare è quella “ordinaria” o quella già dimezzata a €250 a seconda del momento in cui si effettua la regolarizzazione. In particolare:
- se si riesce a ravvedere entro 15 giorni dalla scadenza (quindi entro lo stesso termine che garantisce la riduzione a metà), la sanzione di riferimento è €250 (minimo dimezzato) e sul questa si applica la riduzione ulteriore del ravvedimento (1/9);
- trascorsi i 15 giorni, la sanzione di riferimento torna ad essere €500 (minimo pieno), su cui si applicano le percentuali di riduzione ravvedimento previste per i vari intervalli di tempo.
- Interessi: se la violazione LIPE si accompagna a un omesso versamento di IVA, occorre versare anche l’imposta dovuta e gli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento era dovuto. Tuttavia, se la LIPE omessa non implicava IVA da versare (ad esempio perché a credito), non vi sono imposte né interessi da corrispondere – in tal caso si paga solo la sanzione ridotta per la comunicazione omessa. Gli interessi legali in Italia sono attualmente (2025) al 5% annuo, ma vanno calcolati al tasso vigente pro-tempore per ciascun periodo di ritardo. Per versare correttamente interessi e imposta (se dovuta) insieme alla sanzione, si usano codici tributo appositi (es. tributo IVA dovuta con codice 600x per acconti, e codici interessi 138E per IVA in ravvedimento).
- Sanzione ridotta: per le violazioni LIPE, la sanzione base da considerare è quella “ordinaria” o quella già dimezzata a €250 a seconda del momento in cui si effettua la regolarizzazione. In particolare:
- Versamento tramite modello F24: la sanzione ridotta calcolata va pagata utilizzando il modello F24 (se il contribuente è un privato o impresa) oppure F24 Enti Pubblici (F24 EP) se trattasi di ente pubblico. Il codice tributo generalmente utilizzato per le sanzioni da ravvedimento è “8911” – Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie IVA, indicando come anno di riferimento l’anno d’imposta cui si riferisce la violazione (ad es. 2024 per una LIPE del 2º trim. 2024 ravveduta nel 2025). Nel caso in cui si operi con l’F24 EP (enti pubblici), alcuni codici specifici di sanzione potrebbero differire (891E per sanzioni IVA), ma per la generalità dei contribuenti 8911 è il codice corretto. È importante compilare l’F24 inserendo l’importo esatto della sanzione ridotta calcolata e, se dovuti, gli importi dell’IVA tardivamente versata e interessi (ciascuno con i propri codici). Il pagamento perfeziona il ravvedimento solo se la LIPE viene poi effettivamente inviata e la violazione rimossa.
- Conservare la documentazione: dopo aver effettuato ravvedimento, il contribuente dovrebbe conservare copia della LIPE inviata tardivamente (o della dichiarazione annuale integrativa se ha sanato lì) e le ricevute dell’F24 pagato. In caso di futuri controlli, queste prove documenteranno l’avvenuta regolarizzazione ante accertamento, il che in genere impedisce all’Ufficio di irrogare ulteriormente la sanzione (o al massimo consente di richiedere la differenza se per errore si versò un importo ridotto non corretto).
Il ravvedimento operoso presenta dunque un forte incentivo: pagando importi minimi (come €27,78 entro 15 giorni o €55,56 entro 90 giorni) il contribuente può evitare l’irrogazione piena di €500 di sanzione. Naturalmente ciò vale se l’Amministrazione non ha ancora intrapreso azioni attive sulla violazione: se invece la violazione è già stata constatata o è arrivata una comunicazione ufficiale, il ravvedimento potrebbe non essere più applicabile in forma ordinaria.
Limiti temporali del ravvedimento: la legge consente di ravvedersi fino a quando non sia stata notificata al contribuente la formale constatazione della violazione o un atto di accertamento (in caso di controlli automatizzati, il limite è la ricezione della comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis DPR 633/72, equiparabile a una contestazione). Oltre quel momento, scatta la fase contenziosa e non è ammessa la definizione tramite ravvedimento classico. Va detto però che la normativa ha progressivamente esteso la finestra di ravvedimento: oggi è possibile ravvedersi anche dopo l’inizio di verifiche purché prima della notifica di un atto impositivo. In particolare:
- se la violazione è già stata constatata (ad esempio tramite un PVC – processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza), il contribuente può ravvedersi pagando 1/5 del minimo entro 30 giorni dalla constatazione (questo è un ravvedimento “speciale” previsto dall’art. 13, c.1, lett. b-ter D.Lgs. 472/97) – caso raramente applicato nelle LIPE, ma teoricamente possibile se durante un controllo gli ispettori segnalano l’omessa comunicazione e danno la chance di sanare subito.
- se invece è stata già ricevuta una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia, quella di norma non è considerata un atto impositivo definitivo (è un invito bonario, come vedremo), ma secondo alcuni interrompe la possibilità di ravvedersi sull’imposta, pur restando la facoltà di definire in via agevolata quanto richiesto. In pratica, una volta che il Fisco vi ha notificato un’irregolarità su una LIPE, difficilmente potrete ancora effettuare un ravvedimento spontaneo puro su quella stessa violazione, perché non sarebbe più “spontaneo”.
Regolarizzazioni speciali (tregua fiscale 2023): va segnalato che la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto alcune misure straordinarie di definizione agevolata di violazioni, utili anche per le LIPE:
- La “sanatoria delle irregolarità formali” (commi 166-173 L.197/2022) ha consentito di regolarizzare violazioni formali commesse fino al 31/10/2022 (incluse quindi omesse LIPE di anni fino al 2021) pagando €200 per anno (in due rate, 2023 e 2024) e rimuovendo la violazione entro il 31/03/2024 (termine poi prorogato al 31/10/2024). Le omesse comunicazioni dei dati IVA rientravano nelle “violazioni formali” definibili, come confermato dall’Agenzia (es. invio tardivo di fatture elettroniche, omissione LIPE ritenuta sanabile in tale procedura). Chi ha usufruito di questa sanatoria non sarà più sanzionabile singolarmente per quelle LIPE (si considera perfezionata la definizione pagando i 200 euro e presentando eventualmente le comunicazioni dovute). Questa opportunità, tuttavia, era a tempo e si è chiusa definitivamente nel 2023-2024.
- La “definizione agevolata delle somme dovute da controlli automatizzati” (commi 153-159 L.197/2022) prevede per alcuni avvisi bonari relativi a periodi d’imposta 2019-2020 la possibilità di pagare le imposte dovute con una sanzione ridotta del 3% invece del 10% ordinario. L’Agenzia Entrate ha chiarito, con la Risoluzione 7/E del 14 febbraio 2023, che tale definizione agevolata si applica anche alle comunicazioni di irregolarità derivanti dalle LIPE. In pratica, se a seguito di controlli automatici sulle LIPE (ai sensi dell’art. 54-bis DPR 633/72) emergono somme da versare, le relative comunicazioni rientrano nel perimetro della “tregua fiscale” sugli avvisi bonari. Pertanto, ad esempio, un avviso bonario emesso nel 2023 su LIPE del 2020 poteva essere definito pagando imposta + interessi + sanzione 3% invece di 10%. Inoltre, è stato precisato che rientrano le rateazioni già in corso al 1° gennaio 2023 riguardanti liquidazioni periodiche IVA. Anche questa misura è straordinaria e legata a precisi requisiti temporali.
In generale, si può affermare che il legislatore ha offerto varie chance di regolarizzazione a costi ridotti per spingere i contribuenti a sanare spontaneamente le omissioni LIPE e altre violazioni minori, evitando di intasare il contenzioso con migliaia di piccoli casi. Dal punto di vista del debitore, approfittare di ravvedimenti e definizioni agevolate conviene quasi sempre: oltre a limitare l’esborso (basti pensare €27,78 contro €500), permette di evitare conseguenze peggiori, come l’arrivo di una cartella esattoriale, l’aumento di sanzioni per ritardi ulteriori, o addirittura il rischio che l’omissione formale porti alla scoperta di violazioni sostanziali con sanzioni ben più alte.
Suggerimento pratico: se vi accorgete di aver saltato una LIPE, intervenite prima possibile. Ad esempio, entro 90 giorni la sanzione è ridotta a poco più di €55 – una cifra quasi simbolica rispetto al potenziale di €500. Anche qualora vi rendiate conto dell’errore dopo più tempo, finché non avete ricevuto atti ufficiali potete ravvedervi e chiudere la partita pagando importi molto inferiori al minimo edittale. In caso di dubbi su come compilare il modello o calcolare sanzioni e interessi, è consigliabile farsi assistere dal proprio commercialista di fiducia. Tenete inoltre presente che, se la LIPE omessa riguardava un periodo in cui dovevate anche versare IVA e magari ve ne siete dimenticati, il ravvedimento tardivo vi permette di pagare ora quell’IVA con sanzioni ridotte (il 30% verrebbe ridotto a 3,75% se entro 90 gg, 4,29% entro 1 anno, ecc., stante l’art.13 D.Lgs.472/97) e di evitare l’accusa di omesso versamento prolungato.
Caso particolare: se vi siete completamente dimenticati di presentare la dichiarazione IVA annuale di un anno ma avete comunque presentato e pagato tutte le LIPE trimestrali, siete tecnicamente in violazione per omessa dichiarazione. È noto, tuttavia, che secondo la Cassazione il credito IVA non si perde se la dichiarazione omessa viene poi presentata l’anno seguente e i requisiti sostanziali sono rispettati. In tal caso, potreste presentare una dichiarazione annuale “omessa” entro il termine biennale, riportando i dati (incluso un quadro VH con i dati delle liquidazioni periodiche che avreste dovuto inviare). Le sanzioni fisse per l’omessa dichiarazione annuale verranno irrogate (da €250 a 1000 se senza debito, altrimenti quelle proporzionali per omesso pagamento) e restano ferme quelle per le singole LIPE eventualmente non inviate. Anche in questi scenari intricati conviene valutare il ravvedimento speciale o l’assistenza di un legale, perché è possibile evitare duplicazioni o chiedere clemenza sulla base della collaborazione mostrata.
In conclusione, il ravvedimento operoso è il primo baluardo di difesa – in via amministrativa e preventiva – contro le sanzioni da LIPE irregolari. Vediamo ora cosa accade se, invece, l’irregolarità non viene regolarizzata per tempo e scaturisce una comunicazione o un atto ufficiale da parte del Fisco: quali sono i passi successivi e come difendersi.
Accertamento e comunicazioni di irregolarità derivanti dalle LIPE
Quando una violazione relativa alle LIPE non è stata sanata spontaneamente dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate può rilevarla attraverso le proprie attività di controllo. In molti casi il primo segnale è l’arrivo di una comunicazione di irregolarità (talvolta detta anche avviso bonario) a seguito di un controllo automatizzato dei dati. Infatti, il sistema informativo dell’Agenzia incrocia le comunicazioni LIPE con altri dati disponibili (dichiarazione annuale IVA, versamenti effettuati, dati delle fatture, ecc.) e può generare delle segnalazioni automatiche. La Legge di bilancio 2023 ha equiparato espressamente il controllo sulle comunicazioni LIPE a quello svolto sulla dichiarazione annuale IVA ai sensi dell’art. 54-bis DPR 633/72. Ciò significa che la mancata presentazione o l’infedeltà di una LIPE può essere oggetto di un controllo automatizzato con emissione di una comunicazione al contribuente, analoga a quelle che si ricevono per i controlli 36-bis (imposte dirette) o 54-bis (IVA annuale). Tali comunicazioni rientrano nel novero degli atti di “compliance” e permettono al contribuente di correggere la situazione o far valere le proprie ragioni prima di un atto impositivo formale.
Comunicazione di irregolarità (avviso bonario) sulle LIPE
Cos’è: Si tratta di una lettera inviata dall’Agenzia delle Entrate (di solito via PEC, oppure per posta ordinaria se il contribuente non ha PEC attiva) nella quale si segnalano delle presunte irregolarità relative alle liquidazioni periodiche IVA. Può avere diversi contenuti a seconda del caso:
- segnalazione di LIPE non pervenuta per un determinato periodo, con invito a verificare e a regolarizzare la posizione;
- segnalazione di disallineamenti tra i dati dichiarati nelle LIPE e quelli risultanti dalla dichiarazione annuale IVA o da altre fonti. Ad esempio, se la somma dei versamenti IVA riportati nelle quattro LIPE è inferiore all’IVA dovuta emergente dalla dichiarazione annuale, la comunicazione d’irregolarità evidenzierà il maggior debito e calcolerà l’IVA non versata con sanzioni e interessi;
- comunicazione di un omesso/insufficiente versamento emerso dalle LIPE: per esempio, se da una LIPE risultava un saldo a debito di €X ma l’Agenzia riscontra che il contribuente non ha versato tale importo (o lo ha versato parzialmente), la lettera inviterà a pagare il dovuto con la sanzione ridotta.
Le comunicazioni di irregolarità non sono provvedimenti sanzionatori definitivi, bensì atti amministrativi di natura preventiva. Esse tipicamente riportano:
- l’anno d’imposta e il periodo cui si riferisce l’irregolarità (es: “LIPE 2º trimestre 2024”);
- la descrizione della difformità riscontrata (es: “risulta omessa la comunicazione dei dati della liquidazione periodica” oppure “dalla LIPE risulta un debito IVA non versato” ecc.);
- l’importo dell’imposta eventualmente dovuta, con calcolo di interessi e sanzioni ridotte al 10% se si paga entro 30 giorni (nel caso di imposte non versate), oppure l’importo della sola sanzione amministrativa dovuta (ad esempio €500 ridotto a 1/3 se definita subito, vedremo questo meccanismo);
- i termini entro cui regolarizzare o fornire chiarimenti, generalmente 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- le modalità di pagamento (spesso allegano già i modelli F24 precompilati con codici e importi per pagare in unica soluzione o in rate, se consentito);
- l’avvertimento che, in mancanza di riscontro, si procederà all’iscrizione a ruolo delle somme dovute (cioè verrà emessa una cartella di pagamento) o ad atto impositivo.
Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità:
Prima di tutto non ignorare la comunicazione. Il contribuente ha due opzioni fondamentali in questa fase:
- Se riconosce la fondatezza dell’addebito, può procedere a pagare quanto richiesto (imposte e interessi, più la sanzione ridotta). Il pagamento entro 30 giorni comporta infatti il beneficio della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinaria in caso di omessi versamenti. Ad esempio, se dall’avviso risulta un’IVA non versata di €1.000, la sanzione ordinaria per omesso versamento sarebbe 30% (€300); pagando entro 30 giorni dalla comunicazione, si riduce a 1/3, quindi 10% (€100). La comunicazione stessa riporta già gli importi “scontati”. Analogamente, se si tratta di sola sanzione fissa per omessa LIPE (€500), in molti casi l’Agenzia nelle comunicazioni bonarie invita a pagare una somma ridotta (ad esempio potrebbero applicare direttamente 1/3 del minimo edittale, ~€167). Occorre verificare nel proprio caso come è impostata la definizione: a volte per sanzioni formali l’ufficio propone la definizione ex art. 16, comma 3 D.Lgs. 472/97 (cioè 1/3 della sanzione irrogabile). In ogni caso, pagando come indicato l’irregolarità si intende definita e non si subiranno ulteriori conseguenze.
Esempio: Caio riceve comunicazione per una LIPE omessa con richiesta €167 di sanzione (che corrisponde a 1/3 del minimo €500). Se paga tale importo entro 30 giorni, l’irregolarità è estinta e non seguiranno accertamenti né cartelle. - Se contesta la fondatezza o ritiene l’avviso errato, può fornire chiarimenti o documentazione all’Agenzia oppure attendere che la stessa emetta un atto formale da impugnare. In pratica, in questa fase “bonaria” il contribuente non può proporre ricorso (perché la comunicazione di irregolarità non è un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/92, non essendo né un avviso di accertamento né una cartella esattoriale). Tuttavia, può e deve reagire:
- Segnalazione di errori all’ufficio (istanza di correzione/autotutela): La comunicazione spesso indica che, se il contribuente ha elementi per ritenere sbagliata la pretesa, può rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro il termine indicato, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Ad esempio, se la lettera dice che manca la LIPE del 3º trimestre ma voi avete prova di averla inviata nei termini (ricevuta telematica positiva), potete trasmetterla all’ufficio chiedendo l’annullamento in autotutela della comunicazione. Oppure se conti e calcoli dell’agenzia sono sbagliati (può capitare), potete evidenziarlo. Questa è un’azione informale (di autotutela appunto): l’ufficio se riconosce l’errore annullerà o rettificherà la richiesta, altrimenti confermerà le somme.
- Non adesione e attesa dell’atto successivo: se ritenete che la pretesa sia infondata e l’ufficio non accoglie le vostre spiegazioni, potete decidere di non pagare l’avviso bonario. In tal caso, dopo 30 giorni (o 60 in certi casi) l’Agenzia procederà comunque: per i rilievi derivanti da controlli automatizzati, la norma prevede che l’iscrizione a ruolo (quindi la formazione di una cartella di pagamento) può avvenire trascorsi 30 giorni dalla comunicazione se non avete pagato o segnalato errori. In alternativa, l’ufficio potrebbe emettere un atto di contestazione/irrogazione sanzioni formale. In entrambe le ipotesi, avrete finalmente un atto impugnabile di fronte al quale attivare il ricorso (ne parliamo nel prossimo paragrafo).
In sintesi, la comunicazione di irregolarità è una fase di pre-accertamento in cui conviene, se possibile, sfruttare i benefici (pagamento con sanzione ridotta) o chiarire malintesi. Ad esempio, se la LIPE risultava omessa ma in realtà l’avevate trasmessa e c’è stato un disguido, mostrate la ricevuta all’Agenzia: possono annullare la richiesta senza formalità. Se invece effettivamente avete dimenticato di inviare la LIPE ma non dovete IVA (perché eravate a credito), potrebbe valer la pena segnalare che la mancanza è formale e chiedere quantomeno la riduzione della sanzione al minimo (cosa che già fanno, di solito).
Mancata risposta alla comunicazione: se il contribuente non paga né risponde, trascorso il termine indicato l’Agenzia procede. A questo punto, di solito, due sono le vie:
- Per somme derivanti da controllo automatizzato (es. IVA non versata) si forma un ruolo e viene emessa la Cartella di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione (ex Equitalia, ora ADER). La cartella includerà l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (non più ridotta) oltre agli aggi e spese di notifica. Ad esempio, se su €1000 di IVA non pagata la sanzione era ridotta a €100 nell’avviso bonario, in cartella sarà al 30% intero (€300). La cartella è notificata generalmente entro fine dell’anno successivo a quello dell’avviso bonario.
- Per sole sanzioni formali (come la sanzione €500 per omessa LIPE, che non rientra precisamente in 36-bis/54-bis perché lì ci sono imposte) l’ufficio potrebbe invece emettere un Atto di contestazione e irrogazione di sanzioni (un provvedimento ad hoc) e notificarlo al contribuente. In alcuni casi, però, anche sanzioni “fisse” vengono iscritte a ruolo direttamente. La prassi può variare: spesso l’omessa LIPE rilevata in automatico viene comunque gestita con iscrizione a ruolo e cartella (dopo 30 giorni) poiché si tratta di somma certa. Il D.Lgs. 472/97 infatti consente l’iscrizione a ruolo senza preventiva contestazione per le sanzioni da controlli automatizzati concernenti omessi versamenti, mentre per le sanzioni puramente formali sarebbe corretto inviare un atto prima.
Come difensore del contribuente, bisogna quindi prepararsi a due possibili fronti di contenzioso:
- L’arrivo di una Cartella esattoriale contenente imposte/sanzioni da LIPE: questa è impugnabile entro 60 giorni, ma solo per vizi formali o per contestare che manca un atto precedente. Se ad esempio arrivi una cartella per €500 di sanzione omessa LIPE e il contribuente non ha mai ricevuto la comunicazione di irregolarità, si può eccepire la nullità della cartella per difetto di notifica della fase pre-ruolo. Viceversa, se la comunicazione c’è stata (anche se non impugnabile) la cartella potrà essere contestata nel merito della pretesa (sostenendo che la sanzione non è dovuta o va ridotta). Approfondiremo più avanti come impostare il ricorso.
- La notifica di un Avviso di accertamento o di un Atto di irrogazione sanzioni relativo alle LIPE irregolari. Questo è un atto amministrativo impositivo a tutti gli effetti, che contiene la descrizione della violazione, l’indicazione della norma violata e l’irrogazione della sanzione (e/o il recupero dell’imposta). Sarà corredato dalla motivazione e dall’indicazione dei rimedi: termine di 60 giorni per il ricorso, possibilità di definizione agevolata pagando 1/3 entro 60 giorni, ecc.
Va notato che, talvolta, l’ufficio può emettere un avviso di accertamento unitario per IVA omessa che ingloba anche la sanzione per la LIPE non fatta. Esempio: “Avviso di accertamento IVA 2023” che contesta €X di IVA dovuta per il 4º trim. non versata, con sanzione 30% su X, più sanzione €500 per omessa comunicazione. In tal caso l’atto è uno solo e andrà impugnato in un unico contenzioso, ma con motivi distinti per le diverse componenti.
In ogni caso, quando arriva un atto formale (cartella o avviso), si apre la fase contenziosa vera e propria. Nel prossimo capitolo illustreremo come difendersi: dai rimedi pre-contenziosi (richiesta di annullamento in autotutela, accertamento con adesione, mediazione) alla predisposizione del ricorso tributario e alle successive fasi di giudizio (Commissioni Tributarie/Corti di Giustizia Tributaria, Cassazione).
Fase contenziosa: difendersi dall’accertamento in Commissione Tributaria
Quando il contribuente (debitore) si vede notificare un atto impositivo formale riguardante le irregolarità LIPE – tipicamente una cartella di pagamento o un avviso di accertamento/atto di irrogazione sanzioni – ha il diritto di contestarlo nelle sedi opportune. La difesa entra così nella fase giudiziale, davanti agli organi della giustizia tributaria. Vediamo in dettaglio come procedere e quali strategie attuare.
Tipologie di atti impugnabili
Nel contesto in esame, i principali atti contro cui potrebbe essere necessario ricorrere sono:
- Cartella di pagamento emessa dall’Agente della Riscossione (ADER). Può contenere la richiesta di pagamento di imposte, interessi e sanzioni risultanti dal controllo automatizzato di cui sopra. La cartella è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Nel ricorso contro cartella derivante da controllo automatizzato, si possono far valere sia motivi procedurali (es. mancata notifica dell’avviso bonario, decadenza dei termini, difetti formali della cartella) sia motivi di merito relativi alla pretesa sottostante (ad esempio, contestare che la sanzione non era dovuta perché si era in regola, o che è già stata pagata in ravvedimento, etc.). Importante: se la cartella è la prima e unica comunicazione giunta (ipotesi di mancato invio di avviso bonario), tutti i motivi possono essere svolti; se invece c’è stato un avviso bonario non impugnabile e il contribuente non ha contestato in quella sede, il giudice potrà comunque esaminare il merito perché la cartella è il primo atto impugnabile.
- Avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni: è un atto “ibrido” che può contenere accertamento di maggior IVA dovuta e contestuale irrogazione di sanzioni (sia quelle proporzionali sia quelle fisse da LIPE). Anche questo va impugnato entro 60 giorni presso la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado competente. Spesso l’avviso di accertamento consente una definizione agevolata in acquiescenza: pagando entro 60 giorni si possono ottenere riduzioni sulle sanzioni (generalmente ridotte ad 1/3 ex art. 17 D.Lgs. 472/97). Se però si intende far ricorso, non pagare nulla entro i 60 giorni, altrimenti l’atto diviene definitivo.
- Atto di contestazione e irrogazione di sanzioni (autonomo): è il caso in cui l’Ufficio contesti solo la violazione formale LIPE, senza questioni di imposta. Ad esempio, atto intitolato “Contestazione di violazione e irrogazione sanzione art.11 c.2-ter D.Lgs 471/97” con importo €500. Questo atto è impugnabile entro 60 giorni e segue le stesse regole del ricorso. Anche qui spesso è indicata la possibilità di definire la sanzione pagando 1/3 del suo importo entro 60 giorni (ai sensi dell’art. 16, c.3 D.Lgs. 472/97). Esempio: nell’atto vi chiedono €500, pagando ~€167 entro 60gg chiudete la questione senza ricorrere. Se ritenete di aver torto e non volete aggravare spese, conviene valutare questa opzione di definizione agevolata post notifica, che comunque è un diritto del contribuente. Attenzione però: il pagamento definitorio impedisce poi di ricorrere (costituisce acquiescenza). Se invece si ricorre, la definizione agevolata non è più ammessa dopo.
La tabella seguente riassume i principali atti e le caratteristiche difensive:
| Atto ricevuto | Contenuto | Impugnabilità | Termine ricorso | Pagamento agevolato |
|---|---|---|---|---|
| Comunicazione di irregolarità (bonario) | Avviso bonario: anomalia su LIPE, invita a pagare con 10% | NON impugnabile (fase pre-contenziosa) | n/a | Entro 30 gg: sanzione 1/3 (per omessi vers.) |
| Cartella di pagamento (da 36/54-bis) | Ruolo con sanzioni LIPE e/o IVA non versata (+ interessi) | Impugnabile per vizi e merito | 60 gg dalla notifica | Rottamazione (se prevista da norme speciali) |
| Avviso di accertamento (Agenzia Entrate) | Contestazione formale e/o sostanziale (sanzioni + imposta) | Impugnabile (CGT I grado) | 60 gg dalla notifica | Acquiescenza: –1/3 sanzioni entro 60 gg |
| Atto di irrogazione sanzioni autonomo | Solo sanzione LIPE (es. €500) | Impugnabile (CGT I grado) | 60 gg dalla notifica | Definizione art.16: paga 1/3 (€167) in 60 gg |
(CGT = Corte di Giustizia Tributaria, nuovo nome delle Commissioni Tributarie dal 2023)
Procedura del ricorso in Commissione Tributaria (Corte Giustizia Tributaria)
Una volta individuato l’atto da impugnare, il contribuente deve seguire la procedura per il ricorso tributario di primo grado, regolata dal D.Lgs. 546/1992 (come modificato dalle riforme del 2022). I passi principali sono:
- Redazione del ricorso: va predisposto un atto scritto (in formato PDF se telematico) contenente:
- le generalità del ricorrente (nome, CF/P.IVA, residenza o sede) e del suo eventuale difensore (se si avvale di un avvocato o commercialista abilitato, come consigliabile per questioni complesse);
- l’ente convenuto (es. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di…, e l’Agente della Riscossione se si impugna anche una cartella);
- gli estremi dell’atto impugnato (numero/protocollo, data notifica);
- i motivi di ricorso, ossia le ragioni di fatto e di diritto per cui si chiede l’annullamento/riforma dell’atto. Qui si articolano in punti distinti le varie censure: es. “1) Violazione di legge e difetto di motivazione: l’atto impugnato non indica le ragioni per cui si ritiene omessa la comunicazione LIPE, avendo il ricorrente invece regolarmente presentato la stessa come da ricevuta allegata…”; “2) Inosservanza dei termini di decadenza: la sanzione è stata irrogata oltre il quinto anno successivo (omissione 2018, atto notificato nel 2024)…”, ecc. Bisogna essere chiari e puntuali: ciò che non viene dedotto nei motivi non potrà essere introdotto successivamente (specie in appello).
- l’istanza finale (petitum), cioè cosa si chiede al giudice: annullamento totale della sanzione, o in subordine riduzione della stessa, annullamento interessi, ecc., con vittoria di spese. Ad esempio: “Si chiede dunque l’annullamento dell’atto impugnato e, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione entro il minimo edittale, con vittoria di spese di lite.”.
- eventuale richiesta di sospensione se l’atto comporta un pagamento imminente che si vuole bloccare (nel caso di cartelle, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione).
- allegati: copia dell’atto impugnato, eventuali documenti probatori (ricevute di invio LIPE, ricevuta PEC notifica, F24 di ravvedimento già effettuati, normative o circolari rilevanti) e la prova della notifica del ricorso (vedi punto 3). Nel caso si impugni una cartella, è opportuno allegare anche la comunicazione bonaria se ricevuta, per far constatare eventuali omissioni procedurali.
- Notifica del ricorso: una volta redatto e sottoscritto, il ricorso va notificato alla controparte (Agenzia Entrate e/o Agente Riscossione) entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Oggi la notifica avviene in via telematica tramite PEC obbligatoriamente (dal 1° luglio 2019 il processo tributario è telematico): si invia il ricorso a mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’ente (reperibile da registri pubblici), firmando digitalmente il file PDF del ricorso e degli allegati. In alternativa, è ancora possibile la notifica a mezzo ufficiale giudiziario o servizio postale, ma la PEC è lo standard. La notifica tempestiva è essenziale: se si sfora il 60º giorno anche di poco, il ricorso è inammissibile (fatti salvi casi di sospensione termini per ferie ex lege dal 1 al 31 agosto, che comunque congelano il decorso). Nel nostro caso tipico, la notifica dell’atto impugnato (es. cartella) avviene a mezzo PEC, quindi i 60 gg decorrono dalla data di ricezione PEC.
- Iscrizione a ruolo (costituzione in giudizio): entro 30 giorni dalla notifica del ricorso all’ente, il ricorrente deve costituirsi presso la segreteria della Commissione/Corte tributaria depositando il fascicolo (ricorso notificato con ricevute) tramite il Portale della Giustizia Tributaria (SIGIT). Questo adempimento è tecnico ma va fatto: consiste nell’inviare telematicamente il ricorso e allegati firmati sul portale, indicando gli estremi della propria notifica. A questo punto la causa è iscritta e verrà assegnata a una sezione giudicante.
- Attesa della discussione e scambio memorie: l’Agenzia delle Entrate si costituirà a sua volta in giudizio (entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso) depositando controdeduzioni scritte in cui replica ai motivi. Il contribuente può, se necessario, depositare memorie illustrative aggiuntive fino a 5 giorni prima dell’udienza (o memorie di replica entro 10 giorni prima, secondo il D.Lgs. 546). Queste memorie servono a meglio argomentare, replicare a difese dell’ufficio, segnalare nuove sentenze sopravvenute ecc. Ad esempio, se l’Agenzia nella controdeduzione sostiene che la sanzione è stata notificata in tempo, il ricorrente potrebbe in memoria ribadire che invece la notifica è tardiva documentando ciò.
- Udienza (o trattazione scritta): di prassi viene fissata un’udienza pubblica o camerale per la discussione. In molti casi, soprattutto per cause di modesto valore, la trattazione può avvenire sulla base degli atti scritti senza presenza in aula (la recente riforma ha introdotto la possibilità del processo tributario da remoto o su istanza di parte di discussione orale). È comunque possibile che il difensore del contribuente chieda di discutere oralmente per enfatizzare alcuni punti di fronte ai giudici.
- Sentenza di primo grado: al termine, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado emette la sentenza. Essa può accogliere totalmente il ricorso (annullando l’atto impugnato), accoglierlo parzialmente (es. riducendo la sanzione) oppure respingerlo. Ad esempio, il giudice potrebbe ritenere valida la tesi del contribuente che la sanzione è decaduta e annullare l’atto; oppure potrebbe decidere che la violazione c’è stata ma la sanzione va ridotta al minimo in virtù di circostanze attenuanti; oppure rigettare tutte le eccezioni e confermare l’atto. La sentenza è provvisoriamente esecutiva, ma se il contribuente vince ottenendo l’annullamento, non deve pagare (o gli devono rimborsare quanto eventualmente già versato).
- Passaggi successivi: se la sentenza di primo grado è sfavorevole (o parzialmente sfavorevole), la parte soccombente (contribuente o Agenzia) può proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. La fase di appello ricalca quella di primo grado, ma è incentrata sulle censure di legittimità e merito alla sentenza stessa. Nel nostro contesto, raramente le cause esclusivamente su sanzioni LIPE raggiungono la Cassazione, ma è possibile se ci sono questioni di diritto rilevanti (in tal caso, dopo l’appello, la parte soccombente entro 60 gg può proporre ricorso per Cassazione, limitatamente a vizi di legge).
Novità 2023-2024: va segnalato che la riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha eliminato l’obbligo del reclamo-mediazione a partire dai ricorsi notificati dal 2024 in poi. In passato, per le controversie di valore fino a €50.000, il contribuente doveva prima presentare il ricorso in via amministrativa come “reclamo” e tentare la mediazione con l’ufficio, e solo se falliva allora il ricorso proseguiva in giudizio. Dal 4 gennaio 2024 questo passaggio è stato abrogato: pertanto, anche se il valore della controversia è inferiore a 50.000 €, non è più necessario presentare l’istanza di mediazione, potendo il ricorso essere depositato direttamente in Commissione. Nel nostro caso, spesso si tratta di sanzioni di poche centinaia di euro, quindi fino al 2023 il reclamo-mediazione sarebbe stato obbligatorio; per i ricorsi nuovi nel 2024 tale obbligo è venuto meno. Questo semplifica la procedura per il contribuente.
Naturalmente, nulla vieta all’ufficio e al contribuente di accordarsi bonariamente anche dopo l’impugnazione, tramite gli istituti deflativi: conciliazione giudiziale in udienza (con sanzioni ridotte del 40%) o rinuncia al ricorso con pagamento ridotto. Ma non è più un passaggio formale obbligato.
Strategie difensive e motivi di ricorso
Nella difesa contro un accertamento per irregolarità LIPE, i motivi di ricorso possono spaziare su vari aspetti. Eccone alcuni tipici, che il difensore valuterà di sollevare a seconda del caso concreto:
- Inesistenza della violazione: se il contribuente ha effettivamente adempiuto all’obbligo LIPE (magari l’ha presentata ma l’Agenzia non l’ha recepita per problemi tecnici), si deve dimostrare che l’atto è infondato in fatto. Ad esempio, allegando la ricevuta telematica di avvenuta presentazione della LIPE contestata come omessa. Oppure provando che i dati non erano infedeli (es. l’errore segnalato in realtà non c’è o è dovuto a errata interpretazione dell’ufficio). Se si riesce a convincere il giudice che la LIPE non era omessa né infedele, la sanzione sarà annullata in toto.
- Errore di persona o di soggetto obbligato: a volte il Fisco sbaglia soggetto (ad esempio contesta la mancanza a una società che era nel regime di gruppo IVA e quindi la comunicazione spettava a capogruppo). Se si dimostra che l’obbligo non incombeva su quel contribuente, la sanzione va annullata.
- Violazione del termine di decadenza: come già accennato, le sanzioni tributarie devono essere contestate entro 5 anni dall’anno della violazione. Se l’Agenzia ha notificato oltre tale termine, il difensore eccepirà la decadenza, che il giudice può rilevare e quindi annullare l’atto perché tardivo. Ad esempio, LIPE 2017 contestata con atto del 2023 è tardiva (doveva avvenire entro il 31/12/2022).
- Difetto di motivazione o motivazione insufficiente: l’atto impugnato deve contenere, a pena di nullità, una chiara motivazione sulle cause della pretesa (art. 7 L.212/2000, Statuto Contribuente). Se l’avviso di irrogazione sanzioni si limitasse a dire “mancato invio LIPE – sanzione €500” senza spiegare quali periodi, quale obbligo violato e come è determinata la sanzione, ciò potrebbe configurare nullità per difetto di motivazione. Il ricorso può sottolineare queste carenze formali.
- Errore nei calcoli o nel quantum sanzione: per esempio se l’ufficio applica €1000 di sanzione quando invece per legge avrebbe dovuto essere €500, oppure non ha riconosciuto la riduzione della metà spettante perché l’invio era entro 15 giorni (caso di errata interpretazione). Oppure ha calcolato male interessi. Tutti questi errori aritmetici o di diritto sul quantificare la somma sono motivi validi di ricorso, quantomeno per ottenere la riduzione dell’importo. Il giudice può correggere l’atto rideterminando la sanzione dovuta (principio di conservazione dell’atto se possibile) oppure annullarlo se l’errore lo rende completamente viziato.
- Doppia punizione per lo stesso fatto (bis in idem): se al contribuente vengono contestate due sanzioni per un’unica condotta, ad esempio €500 per omessa LIPE e anche €250 per dichiarazione IVA integrativa tardiva per lo stesso periodo, si può invocare il principio del ne bis in idem sanzionatorio. Spesso però qui i fatti sono distinti (uno è non invio comunicazione, l’altro è dichiarazione tardiva), quindi non sempre questo argomento passa. Ma se, ad esempio, l’ufficio avesse sanzionato sia l’omessa LIPE sia la mancata presentazione del quadro VH nella dichiarazione successiva, si potrebbe sostenere che è la medesima omissione punita due volte.
- Disproporzione della sanzione (principio di proporzionalità): nella cornice giuridica attuale è difficile far annullare una sanzione fissa minima per sproporzione, poiché è stabilita per legge in misura fissa. Tuttavia, si può tentare di persuadere la Commissione che, essendo il contribuente sostanzialmente in regola col pagamento dell’IVA (nessun danno erariale), la sanzione andrebbe applicata nel minimo e magari esclusa in virtù di buona fede. Richiamare i principi europei di proporzionalità e neutralità IVA a volte porta i giudici a interpretazioni favorevoli: ad esempio, se un errore formale non ha precluso al Fisco il controllo e non ha comportato evasione, alcuni orientamenti (per ora minoritari) potrebbero ritenere applicabile l’esimente per violazioni formali di cui all’art. 6, co.5-bis D.Lgs. 472/97 (non punibilità delle violazioni formali che non arrecano pregiudizio all’attività di controllo). La Cassazione, come visto, considera l’omessa LIPE non meramente formale proprio perché un qualche pregiudizio lo arreca. Quindi questo motivo è più debole, ma in chiave di equità il difensore lo può invocare per sostenere quantomeno la non applicazione di aggravanti o la conversione in ammonimento.
- Irregolarità nella notifica dell’atto: se l’avviso o la cartella non sono stati notificati correttamente (es. PEC a indirizzo sbagliato, notifica a soggetto non legittimato, vizi di relata), si può chiederne l’annullamento. Ad esempio, Cassazione n.29989/2022 ha annullato un’intimazione di pagamento perché l’avviso presupposto non era stato mai notificato. Nel nostro contesto, se la cartella è arrivata senza che l’avviso bonario fosse notificato perché la PEC era errata, si può chiedere l’annullamento della cartella per vizio procedurale, o quantomeno l’annullamento delle sanzioni per non aver potuto fruire del contraddittorio endoprocedimentale.
- Già definito per ravvedimento/condono: qualora il contribuente abbia in realtà già pagato in ravvedimento la sanzione (magari con F24, ma l’ufficio non lo ha collegato) o abbia aderito alla sanatoria formale 2023 per quell’anno, dovrà farlo presente. L’atto in tal caso chiede un pagamento non dovuto perché la violazione è stata già definita. Si allegheranno le prove dei versamenti di ravvedimento o delle sanatorie. Spesso l’ufficio, ricevute queste evidenze, rinuncia alla pretesa in giudizio (potreste ottenere anche il rimborso spese).
- Richiesta di cumulo giuridico: se vi sono più sanzioni per più trimestri contestati in uno stesso atto, in via subordinata si può chiedere al giudice di applicare il cumulo giuridico ex art.12 D.Lgs. 472/97, riducendo la sanzione complessiva. Ad esempio, per 3 LIPE omesse il Fisco chiede €1500 (500×3): il giudice potrebbe applicare la sanzione di €500 aumentata di 1/2 (nel range fino a €2000) ottenendo €750 totale, se ritiene unitarietà della condotta. Ci sono pronunce altalenanti su ciò; vale la pena invocarlo come subsidium in caso di soccombenza sul resto.
Spesso nei ricorsi in materia di sanzioni si usa anche richiamare principi costituzionali (art.3 e 53 Costituzione per l’uguaglianza e capacità contributiva, art.97 per buon andamento). Ad esempio, si può sostenere che punire con €500 un ritardo di pochi giorni è eccessivo e contrasta con principi di ragionevolezza. La Corte Costituzionale ha in passato dichiarato illegittime sanzioni fisse sproporzionate (ad es. su omessa presentazione elenchi clienti-fornitori), e ha ribadito che la quantificazione delle sanzioni tributarie deve avere una connessione razionale col disvalore del fatto. Nel caso delle LIPE, la Consulta di recente (sent. n.111/2024, in tema di contributo straordinario sugli extraprofitti) ha osservato che fare riferimento ai dati delle LIPE per scopi impositivi può essere irragionevole, in quanto le LIPE offrono un quadro provvisorio e incompleto rispetto alla dichiarazione annuale. Questa osservazione, seppur in un diverso contesto, potrebbe essere usata retoricamente: le LIPE sono dati provvisori, quindi sanzionare duramente eventuali loro difformità che poi sono state corrette in dichiarazione annuale potrebbe considerarsi eccessivo. Non è un argomento di diritto forte (la legge è chiara nel prevedere la sanzione), ma può aiutare a creare quel convincimento nel giudice per accogliere magari soluzioni di equità.
Accertamento con adesione e altre soluzioni pre-giudiziali
Prima di approfondire la fase giudiziale successiva (appello, Cassazione), merita cenno la possibilità di risolvere la vicenda senza attendere la sentenza, attraverso istituti deflattivi del contenzioso:
- Accertamento con adesione: dopo la notifica di un avviso di accertamento (che includa sanzioni LIPE e magari IVA dovuta), il contribuente può presentare istanza di adesione all’ufficio entro 60 giorni. Questo sospende i termini di ricorso per 90 giorni e avvia un dialogo col Fisco per trovare un accordo. Nell’adesione si può ottenere una riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo edittale e magari sconti sugli imponibili. Se c’è margine di trattativa (ad es. l’ufficio riconosce qualche errore, o il contribuente porta elementi nuovi), può convenire. Se si chiude l’adesione, si paga quanto concordato e non si fa ricorso.
- Mediazione/conciliazione: benché la mediazione obbligatoria non ci sia più dal 2024, è sempre possibile per le parti accordarsi in corso di causa. La conciliazione può avvenire entro la prima udienza: l’ufficio propone una rideterminazione (ad esempio dimezza le sanzioni) e il contribuente accetta. In caso di conciliazione giudiziale, le sanzioni restanti sono ulteriormente ridotte del 40% per legge e gli interessi al 50% (art. 48 D.Lgs.546/92). Quindi se siete in giudizio per €500, l’ufficio potrebbe proporre di chiudere a €250, e di questi il contribuente pagherà solo il 60% (quindi €150) più interessi ridotti. È un risultato spesso interessante. Va formalizzato con un accordo omologato dalla Commissione.
- Definizione agevolata delle liti pendenti: in alcuni periodi il legislatore ha offerto sanatorie per le cause tributarie in corso (ad esempio nel 2023, definizione liti pendenti pagando percentuali del valore a seconda dei gradi). Se la vostra causa rientra e conviene, potete aderire e pagare magari solo il 15% o 20% del valore in litigio per chiudere la lite. Sono misure occasionali, ma vale la pena tenerle d’occhio.
Giudizio di appello e ricorso per Cassazione
Se il giudizio di primo grado non risolve la questione in modo soddisfacente, si passa ai gradi successivi:
- Appello (CGT II grado): qui si possono far valere errori di giudizio del primo grado, testimoniando perché la sentenza è sbagliata in fatto o diritto. Ad esempio, se il giudice ha rigettato ritenendo la notifica valida mentre ci sono prove contrarie, si ribadirà. L’appello va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (o 6 mesi dalla pubblicazione se non notificata) e richiede di norma assistenza professionale. In appello non si possono introdurre nuovi motivi non dedotti in primo grado, salvo eccezioni (fatti sopravvenuti, nullità insanabili rilevabili d’ufficio, etc.). Il procedimento è analogo a quello di primo grado. La sentenza di appello sostituisce quella di primo grado. Se l’appello conferma la sanzione, il contribuente potrà valutare se andare in Cassazione.
- Cassazione: è il terzo e ultimo grado, ammesso solo per questioni di legittimità (violazione di legge o vizi motivazionali gravi della sentenza di appello). Non si rivalutano i fatti; ci si concentra su possibili errori di diritto. Ad esempio, se i giudici di merito hanno applicato male l’art. 11 co.2-ter (magari negando indebitamente la riduzione sanzione del 50% che spettava), si può ricorrere in Cassazione su questo punto di diritto. La Cassazione ha già avuto modo di esprimersi su casi vicini al nostro: ad esempio, in Cass. n. 37146/2021 ha ribadito che l’omessa dichiarazione annuale IVA non fa decadere il credito se riportato l’anno dopo, ma non esime dalle sanzioni; oppure in Cass. n. 9739/2023 ha confermato che il contribuente, pur se omettente, può dimostrare in giudizio l’esistenza del credito IVA non dichiarato, salvandolo, ma rimane soggetto a sanzioni e interessi dovuti. Questi orientamenti, se calzanti, verranno citati in supporto.
Il ricorso per Cassazione deve essere proposto da un avvocato cassazionista (abilitato alle giurisdizioni superiori) e notificato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello. La Cassazione può respingere (allora la sanzione diviene definitiva), accogliere (e se accoglie in toto di solito cassa senza rinvio se la causa è decisa in diritto, oppure cassa con rinvio per nuova valutazione) oppure dichiarare inammissibile. È un percorso lungo e costoso, perciò in materia di sanzioni di importo modesto raramente si arriva fino a qui se non ci sono questioni di principio ampie.
In conclusione, difendersi in contenzioso da un accertamento su LIPE significa padroneggiare sia gli strumenti processuali (ricorsi, termini, eccezioni) sia la materia sostanziale (IVA e sanzioni). Il contribuente-debitore deve essere attivo e diligente: come notato da esperti legali, l’errore peggiore è restare inerti e lasciar scadere i termini. Invece, con un’azione tempestiva (anche solo per guadagnare una sospensione o per trattare una conciliazione) e con il supporto di professionisti competenti, vi sono buone probabilità di mitigare gli effetti dell’accertamento, se non di annullarlo quando vi sono ragioni valide.
Profili penali connessi alle irregolarità IVA (cenni)
Le violazioni relative alle LIPE, di per sé, costituiscono illeciti amministrativi e non penali. Infatti, l’ordinamento riserva le sanzioni penali tributarie ai casi di evasione d’imposta più gravi, disciplinati dal D.Lgs. 74/2000 (reati tributari). L’omessa o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche non è tipizzata come reato. Tuttavia, non bisogna ignorare i possibili riflessi penali che potrebbero emergere dalle situazioni sottostanti alle irregolarità LIPE, qualora queste siano sintomo di evasione consistente. In pratica:
- Omesso versamento IVA (reato ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000): se il contribuente, omettendo magari le comunicazioni e non presentando la dichiarazione annuale o comunque non versando l’IVA dovuta, accumula un debito IVA superiore a €250.000 nell’anno d’imposta, scatta la fattispecie penale di omesso versamento IVA (punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni). Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche 2024 risultavano debiti per €300.000 che non sono stati versati entro la scadenza di versamento dell’IVA annuale (16 marzo 2025), il contribuente – oltre alle sanzioni amministrative – risponde penalmente. Spesso chi si trova in questa situazione ha anche omesso di presentare la dichiarazione annuale, aggravando la posizione. È bene sapere che il reato di omesso versamento può essere estinto con il pagamento integrale del dovuto prima del giudizio (cosa difficile per cifre alte, ma è un incentivo importante).
- Dichiarazione infedele o fraudolenta: se l’irregolarità LIPE dipende dal fatto che il contribuente ha sotto-dichiarato l’IVA a debito mediante artifici, potrebbero configurarsi reati di dichiarazione fraudolenta (art.2 e 3 D.Lgs.74/2000) o di dichiarazione infedele (art.4). Ad esempio, se uno presenta una dichiarazione IVA annuale mendace (non dichiarando operazioni imponibili per nascondere l’IVA) sopra soglie di punibilità (IVA evasa oltre €100.000 e imponibile sottratto oltre il 10% del dichiarato, soglia 2 milioni) allora vi è reato di dichiarazione infedele. Le LIPE falsate in corso d’anno potrebbero costituire elementi indiziari, ma il reato si consuma sulla dichiarazione annuale. In un eventuale procedimento penale, tuttavia, verrà esaminato tutto il comportamento: le comunicazioni trimestrali potrebbero essere usate come indizio di volontà fraudolenta, oppure al contrario come elemento difensivo (“avevo indicato i dati poi corretti a fine anno”).
- Omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs.74/2000): se un soggetto omette del tutto la presentazione della dichiarazione IVA annuale e l’imposta evasa supera €50.000, commette reato. In tale situazione, è molto probabile che non abbia neppure inviato le LIPE (come visto, scenario di totale inadempimento). L’omessa dichiarazione è punita con reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. Se l’autorità scopre ciò (magari tramite controlli incrociati, fatture elettroniche non coerenti con dichiarazioni, ecc.), partirà la segnalazione penale. Anche qui il pagamento integrale di quanto dovuto entro il processo può attenuare la posizione (in alcuni casi, per reati dichiarativi non c’è causa di non punibilità integrale, ma possibili circostanze attenuanti).
- Altri reati tributari: eventuali false comunicazioni potrebbero configurare reati residuali come frode IVA tramite uso di fatture false (art.2, se emesse fatture per operazioni inesistenti) o sottrazione a controllo (art.11, se uno nasconde libri o atti). Tuttavia, è raro che la semplice omissione di LIPE in sé porti a questi reati; di solito sono le condotte economiche sottostanti (es. falsa fatturazione, creazione di crediti fittizi) a costituire reato, e l’omissione LIPE è una conseguenza.
Difendersi sul piano penale: se dovesse aprirsi un procedimento penale a carico del contribuente per fatti connessi (es. omesso versamento oltre soglia), il “difendersi” lì assume connotati diversi: serve un avvocato penalista tributario, andranno eventualmente prodotte prove che riducano l’accusa (ad esempio dimostrare che l’IVA non versata è sotto soglia se si considerano detrazioni spettanti, oppure che c’erano cause di forza maggiore per il mancato pagamento). Importante è sapere che:
- Il procedimento amministrativo tributario e quello penale corrono su binari distinti ma comunicanti. Un esito favorevole in quello amministrativo (es. Commissione che annulla l’accertamento perché il fatto non sussiste) può influire positivamente come prova nel penale; viceversa una condanna penale definitiva può rendere molto difficile sostenere in Commissione che nulla era dovuto (ma teoricamente la Commissione non è vincolata al giudicato penale se non per l’accertamento dell’esistenza del fatto).
- Pagare il dovuto conviene sempre: nel reato di omesso versamento IVA, se entro la dichiarazione del periodo successivo uno paga l’intero dovuto, il fatto non è punibile (in passato era così per soglie più basse, ora con 250k € è più difficile saldare in tempo, ma se succede). Anche dopo, pagare integrale può portare a patteggiamenti favorevoli o cause di non punibilità per particolare tenuità (se l’importo residuo è di poco superiore a soglia).
- In reati come dichiarazione fraudolenta o infedele, la riforma del 2019 ha introdotto che se prima dell’apertura del dibattimento il contribuente paga il debito tributario (imposta, interessi, sanzioni), le pene sono diminuite di un terzo e i reati di minore gravità (infedele, omessa) diventano addirittura estinguibili con causa speciale di non punibilità (art.13-bis D.Lgs.74/2000). Questo spinge chi può a definire in via amministrativa l’accertamento (magari con adesione o conciliazione) e pagare, per poi estinguere o mitigare il penale.
Fortunatamente, la stragrande maggioranza dei casi di irregolarità LIPE riguarda inadempimenti formali o ritardi di modesta entità, senza sconfinare nel penale. Tuttavia, il debitore accorto deve essere consapevole che se la sua situazione fiscale è molto compromessa (ad esempio anni di IVA non versata e dichiarazioni mancanti), potrebbe trovarsi non solo a difendersi davanti al giudice tributario, ma anche di fronte al giudice penale. In queste situazioni, la coordinazione della difesa è fondamentale: a volte conviene risolvere prima l’aspetto tributario (pagare il possibile, ottenere sconti) per poi portare elementi favorevoli nel penale, dove l’obiettivo è magari evitare una condanna con pena detentiva.
In sintesi, dal punto di vista del contribuente, non prendere sotto gamba le irregolarità IVA: sebbene inizino con “semplici” multe amministrative, possono essere il campanello di allarme di una condotta che – se protratta e di importo rilevante – sfocia in responsabilità penali. Una corretta gestione (magari grazie al ravvedimento per tempo) evita di arrivare a quegli estremi. Se invece vi siete già spinti troppo oltre, la miglior difesa è la collaborazione attiva: regolarizzare il più possibile, e affrontare con trasparenza eventuali procedimenti (mostrando buona fede e impegno a sanare il debito tributario, atteggiamento che spesso viene valorizzato anche in sede penale per escludere l’intento fraudolento).
Esempi pratici e modelli di atti difensivi
Di seguito presentiamo alcuni casi concreti simulati, con la descrizione della situazione e le possibili soluzioni difensive, inclusi estratti di modelli di atti (es. istanza di autotutela e ricorso tributario).
Esempio 1: LIPE omessa senza debito d’imposta
Scenario: La ditta individuale XYZ di un professionista in regime IVA trimestrale ha dimenticato di inviare la comunicazione LIPE del 3º trimestre 2024. In quel trimestre, però, la ditta era a credito IVA (aveva più acquisti che vendite, quindi nessuna IVA da versare). Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate invia una lettera di compliance segnalando l’omessa LIPE e invitando a regolarizzare. Il professionista non se ne avvede in tempo e non risponde. Nel novembre 2025, riceve tramite PEC una cartella di pagamento per €500 di “sanzione LIPE omessa 3º trim. 2024” + spese, iscritta a ruolo.
Come difendersi:
- Ravvedimento operoso perso: Ormai essendo arrivata la cartella, non è più possibile ravvedersi. Si poteva farlo prima: se avesse inviato la LIPE entro il termine del 28 febbraio 2025 (presentazione IVA annuale) e pagato ad esempio €55,56, avrebbe chiuso la questione. Ma ora siamo in fase di accertamento.
- Controllo atti: si verifica che effettivamente la LIPE non risulta inviata (magari il commercialista non l’aveva trasmessa). Vero, è omessa. La cartella è quindi basata su un fatto corretto.
- Autotutela: essendo a credito IVA e trattandosi di dimenticanza formale, il contribuente può contattare l’ufficio locale chiedendo la remissione in autotutela o quantomeno la riduzione della sanzione. Argomenta che non c’era danno erariale. L’ufficio, probabilmente, risponderà che non può annullare la sanzione (perché la legge la prevede comunque), ma potrebbe suggerire di fare ricorso per chiedere l’applicazione del minimo se per caso fosse stato applicato l’importo massimo (non è il caso, qui €500 è il minimo edittale pieno).
- Rateazione: la cartella di €500 è piccola, ma qualora il contribuente avesse difficoltà, può richiederne la rateizzazione all’ADER (fino a 8 rate trimestrali è concessa praticamente automaticamente per importi sotto 5.000 €). Ciò non impedisce di ricorrere, però attenzione: se si inizia a pagare rate e poi si vince il ricorso, le somme pagate andranno rimborsate. Si può comunque fare.
- Ricorso in Commissione: per 500 euro di valore, si potrebbe anche pensare di non ricorrere (valutazione costi/benefici). Ma se il contribuente è assistito da un professionista in abbonamento o vuole far valere un principio (ad esempio evitare precedenti), può fare ricorso. Nei motivi di ricorso si punterà su:
- “Violazione art. 6 co.5-bis D.Lgs.472/97 – Violazione di legge – Erronea applicazione sanzione in assenza di danno erariale”: si sostiene che l’omissione, essendo a credito, non ha pregiudicato il controllo (poiché il credito è stato poi riportato in dichiarazione annuale) e quindi rientra nelle violazioni formali non punibili. Si citeranno magari precedenti di analoghe situazioni dove i giudici hanno annullato per particolare tenuità o art.10 Statuto (non sanzionare chi senza colpa non adempie a formalità). Questo motivo tenta l’annullamento totale per principio di non punibilità del mero formalismo.
- “In subordine, eccesso di sanzione e violazione dei principi di proporzionalità (art.3 Cost)”: qui si chiede che, se proprio deve essere punito, si consideri come circostanza attenuante l’assenza di debito d’imposta, applicando la sanzione nel minimo (che già è, in realtà) o addirittura riducendola ulteriormente per analogia con riduzioni ravvedimento. Si potrebbe qui chiedere al giudice di applicare direttamente la riduzione a 1/3 prevista in caso di acquiescenza, visto il comportamento collaborativo (anche se non è acquiescenza, ma si prova).
- Eventualmente un motivo procedurale: “Travisamento dei presupposti, omessa considerazione del ravvedimento operoso speciale”, se nel frattempo c’era la sanatoria formale disponibile e il contribuente afferma di volerla applicare retroattivamente (anche se scaduta).
- Esito possibile: Non è garantito che il giudice annulli la sanzione, in molti casi su questi elementi formali le Commissioni si attengono alla legge e confermano i €500 (“dura lex sed lex”). Tuttavia, ci sono stati casi in cui per situazioni di puro credito qualche giudice ha annullato la sanzione in quanto violazione formale non lesiva (specie se il contribuente aveva poi dichiarato tutto annualmente). È un po’ un terno al lotto. Una strategia alternativa potrebbe essere cercare una conciliazione con l’ufficio in giudizio: ad esempio accordarsi per pagare €300 e chiudere lì, per evitare spese ulteriori. L’ufficio potrebbe accettare di buon grado in casi di credito (che implicano buona fede). Con la conciliazione, poi, il 40% di sconto sulle sanzioni porterebbe quei €300 a €180 da pagare.
- Miglior pratica: Questa situazione insegna che anche se si è a credito, bisogna inviare le LIPE. La legge non fa distinzione. Quindi il consiglio è di organizzare un sistema di promemoria o delegare a un commercialista, perché ravvedere entro 90 giorni sarebbe costato solo €55. Trasformato in €500 per una banale dimenticanza, è amaro.
Esempio 2: LIPE infedele con IVA non versata – accertamento sostanziale
Scenario: La società Alfa Srl, per problemi di liquidità, nel 2023 decide di posticipare i versamenti IVA: presenta le LIPE trimestrali indicando i debiti IVA corretti (ad esempio, €50.000 dovuti per ogni trimestre), ma non effettua i relativi versamenti o li fa solo parzialmente. In più, nell’ultima LIPE (4º trim) indica erroneamente un credito, confidando di compensare, ma poi la dichiarazione annuale mostra il debito reale. L’Agenzia delle Entrate, attraverso i controlli incrociati, nel 2024 invia un avviso bonario per IVA non versata risultante dalle LIPE (art.54-bis). Alfa non riesce a pagare tutto entro 30 giorni – versa solo una piccola quota. Nel 2025 riceve un Avviso di accertamento che liquida l’IVA dovuta per l’intero 2023, applicando la sanzione del 30% su ciascun ritardato versamento (con riduzione a 10% sull’avviso bonario non perfezionato, ora salita al 30% perché non definito), più la sanzione di €500 per ogni LIPE infedele/omessa (in particolare contesta omissione 4º trim e infedeltà negli altri). In totale l’atto chiede: imposta €200.000, sanzioni da omesso versamento €60.000, sanzioni LIPE €2.000 (4×500), interessi vari.
Come difendersi:
- Accertamento con adesione: data la somma consistente, Alfa attiva subito la procedura di adesione (entro 30gg dall’avviso) per negoziare. L’azienda mira quantomeno a rateizzare e ridurre sanzioni. Durante l’adesione, Alfa mostra che nel frattempo (2024) ha versato parte del debito e chiede che ne venga tenuto conto. Propone di pagare l’imposta residua in 8 rate e chiede sanzioni ridotte. L’ufficio può concordare: riduzione delle sanzioni LIPE da 500 a 250 ciascuna, e applicazione delle sanzioni omesso versamento al minimo 30% ridotto 1/3 (quindi 20% per adesione). Si firma un atto di adesione in cui Alfa dovrà pagare, poniamo, €180.000 di imposta, €40.000 di sanzioni totali, più interessi, in rate trimestrali. Questo risolve la vicenda senza contenzioso (ma Alfa dovrà rispettare i pagamenti per non decadere).
- Se adesione fallisce: poniamo che l’accordo non si trovi (magari perché Alfa contesta ancora qualcosa). Allora entro i 60gg dal ricevimento dell’avviso, Alfa dovrà fare ricorso. I motivi di ricorso possibili:
- Contestare errori di calcolo: magari l’ufficio ha duplicato una quota di debito, o non ha scomputato quanto Alfa effettivamente versò in ritardo. Si allegheranno quietanze di F24 per dimostrare che l’imposta residua non è 200k ma, ad es., 150k.
- Contestare la sanzione piena per omessi versamenti, sostenendo che l’ufficio avrebbe dovuto lasciare la riduzione 10% perché Alfa aveva aderito alla rateazione bonaria. (In realtà, se Alfa non paga regolarmente l’avviso bonario, perde il beneficio e scatta 30%; ma se Alfa aveva iniziato una rateazione e poi ripreso, potrebbero esserci appigli di clemenza).
- Contestare il cumulo sanzioni LIPE: qui 4 trimestri = 4 sanzioni. Si può chiedere al giudice di ritenere unico l’arco evasivo e di applicare una sola sanzione per violazione continuata aumentata (cumulo giuridico). Forse può ridurre i 2000 a, ipotizziamo, 800.
- Evidenziare circostanze attenuanti: es. Alfa era in crisi di liquidità per crediti verso PA non incassati – questo non giustifica in diritto, ma in equità potrebbe convincere a ridurre le sanzioni al minimo.
- Se la notifica dell’avviso presenta problemi (es. PEC inviata a indirizzo errato e per caso presa visione tardivamente), includere come vizio.
- Nessun vizio su merito: in realtà Alfa non può negare di dover quell’IVA – l’ha dichiarata lei stessa. Quindi non potrà dire “non devo pagare”, ma punterà su ridurre sanzioni e ottenere più tempo.
- Istanza di sospensione: visto che 200k è tanto, Alfa nel ricorso chiede al giudice sospensione dell’atto, per non dover pagare subito tutto. Mostra bilanci per far vedere che il pagamento immediato arrecherebbe danno grave all’attività. Spesso in simili importi, se c’è un minimo dubbio su qualche aspetto (calcolo sanzioni ad es.), la sospensione può essere concessa per la parte contestata.
- Processo: può darsi che in udienza la società proponga una conciliazione: “accettiamo di pagare l’imposta e sanzione 15% in 2 anni” – l’ufficio potrebbe accettare. Se no, si va a sentenza. Probabilmente la Commissione confermerà il dovuto (perché c’è) ma potrebbe mostrare un po’ di clemenza sulle sanzioni LIPE: ad esempio, riducendole al minimo e unificandole in cumulo. Potrebbe dire: “applicate art.12, unica sanzione 500+1/4=625 invece di 2000” – un piccolo risparmio.
- Profilo penale: notare che 200k IVA non versata è sotto soglia penale (250k), quindi Alfa non subisce processo penale per omesso versamento. Bene così. Se però fosse stata sopra, allora le conviene davvero pagare entro fine 2024 almeno per scendere sotto soglia.
- Dopo primo grado: se Alfa ancora trova troppo severe le sanzioni, può appellare la sentenza. Ma visti i costi, forse no. Intanto starà pagando a rate (sempre chiedendo eventualmente in Equitalia di rateizzare la parte non sospesa).
Modello di ricorso (estratto) – Esempio 2:
Di seguito un ipotetico stralcio del ricorso introduttivo che Alfa Srl (tramite difensore) presenterebbe:
**RICORSO**
Alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano
Ricorrente: **Alfa S.r.l.**, CF/P.IVA 01234567890, con sede in Milano, Via Roma n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Mario Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. … (CF …) in Milano, Via … n…, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;
Resistente: **Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano**, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata per legge in Milano, Via …;
**Agente della Riscossione – ADER Milano**, in persona del legale rapp.te pro tempore (solo eventualmente, se si impugna anche la cartella/ruolo);
**Atto impugnato:** Avviso di accertamento n. T1234567890/2025, emesso dall’Agenzia delle Entrate DP Milano, notificato via PEC il 10/09/2025, avente ad oggetto IVA annualità 2023 – Liquidazioni periodiche e omessi versamenti.
**Fatti in breve:** Con l’atto impugnato l’Ufficio contesta al ricorrente l’omesso versamento di IVA per €200.000 relativamente all’anno d’imposta 2023, nonché l’omessa e infedele trasmissione di 4 comunicazioni trimestrali LIPE per il medesimo anno. Vengono richieste sanzioni per €60.000 ex art.13 D.Lgs.471/97 (omessi versamenti) ed €2.000 ex art.11 c.2-ter D.Lgs.471/97 (omessa/infedele LIPE), oltre interessi. Si assume che Alfa S.r.l. avrebbe omesso integralmente il versamento dell’IVA dovuta nei 4 trimestri 2023 e omesso la LIPE del 4° trimestre 2023. In realtà la ricorrente, come meglio dettagliato infra, ha effettuato versamenti parziali per €50.000 e verserà il residuo in sede di definizione. Si contesta inoltre l’illegittima duplicazione di sanzioni e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.
**Motivi di ricorso:**
1. **Erroneità del quantum imponibile e sanzionatorio – Omesso scomputo di versamenti effettuati (Violazione art.54-bis DPR 633/72)**. L’atto impugnato risulta determinare l’IVA dovuta in €200.000 senza tenere conto di pagamenti pari ad €50.000 che la società ha eseguito (seppur tardivamente) a valere sul debito 2023. […] (si spiega con documenti allegati che in data X la società ha versato Y euro, ecc). Ciò comporta che l’imposta residua dovuta fosse al massimo €150.000. Di conseguenza, anche le sanzioni per omesso versamento andavano calcolate su tale importo ridotto. La liquidazione dell’ufficio è dunque sovrastimata e l’atto va annullato/rettificato in parte qua:contentReference[oaicite:110]{index=110}.
2. **Ingiustificata applicazione di sanzione piena 30% – Violazione art.13 D.Lgs.472/97 e art.6, c.5 Statuto Contribuente**. L’Ufficio ha irrogato la sanzione piena del 30% per omesso versamento, senza considerare che la società aveva iniziato a sanare il debito prima dell’accertamento. In particolare Alfa Srl aveva aderito alla rateazione dell’avviso bonario prot. …, versando la prima rata. Sebbene poi la rateazione sia decaduta, si ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto mantenere la sanzione ridotta (10%) quantomeno sulla parte di debito versata entro il 30/06/2024. L’aver sanzionato al 30% anche somme già spontaneamente corrisposte contrasta con i principi di leale collaborazione e proporzionalità della risposta sanzionatoria (artt. 6, c.5 e 10 L.212/2000). **Si chiede quindi la riduzione della sanzione omesso versamento**, almeno nella misura minima del 15% (tenuto conto del ravvedimento parziale):contentReference[oaicite:111]{index=111}.
3. **Cumulo giuridico delle violazioni LIPE – Violazione art.12 D.Lgs.472/97**. L’atto cumulativamente sanziona quattro violazioni formali LIPE (3 infedeli e 1 omessa) con il massimo edittale complessivo (€2000). Tuttavia, trattandosi di violazioni della *medesima indole* commesse in esecuzione di un medesimo disegno (posticipare i pagamenti IVA del 2023), avrebbe dovuto applicarsi il cumulo giuridico: un’unica sanzione base (500€) aumentata fino al doppio. L’ufficio non ha motivato sul punto, incorrendo in violazione di legge. **Si chiede quindi di ridurre la sanzione LIPE complessiva ad un importo non superiore a €1.000**, ritenendosi tale cifra congrua ex art.12 cit. (minimo edittale euro 500 aumentato del 100%). In difetto, l’atto sarebbe affetto da duplicazione sanzionatoria.
4. **Circostanze attenuanti e sproporzione della sanzione complessiva – Violazione principi di proporzionalità (art.3 e 53 Cost.)**. Si evidenzia come la ricorrente abbia versato l’IVA afferente al 2023 con ritardo a causa di gravi difficoltà finanziarie dovute a crediti insoluti per oltre €300.000 verso clienti pubblici. Tale situazione, documentata in allegato (cfr. bilancio 2023 e solleciti di pagamento a ASL …), dimostra l’assenza di dolo evasivo e la volontà di onorare il debito tributario appena possibile. In tale contesto, una sanzione amministrativa globale di oltre €62.000 risulta manifestamente sproporzionata e punitiva oltre il necessario, a fronte di un danno erariale temporaneo poi in parte rientrato. La Corte di Giustizia Tributaria è tenuta ad applicare le sanzioni in modo proporzionato alla gravità effettiva del comportamento (Corte Cost. n.110/2019). **Si invoca quindi una riduzione giudiziale delle sanzioni al minimo edittale**, tenendo conto dell’opera di resipiscenza del contribuente (pagamento spontaneo parziale) e del fatto che l’IVA è stata dichiarata (seppur non versata). In subordine, qualora ciò non fosse ritenuto praticabile, si solleva questione di legittimità costituzionale dell’art.11 co.2-ter D.Lgs.471/97, nella parte in cui fissa una sanzione minima rigida (€500 per ciascuna violazione) anche in situazioni di mera tardività senza occultamento di gettito, per contrasto con gli artt.3 e 27 Cost.:contentReference[oaicite:112]{index=112}.
…
**Si chiede** che codesta On.le Corte voglia:
- in via principale, annullare l’avviso di accertamento impugnato, eliminando o riducendo le sanzioni ivi irrogate secondo giustizia;
- in via subordinata, riquantificare l’imposta e le sanzioni dovute nei limiti di cui ai motivi sopra esposti;
- con vittoria di spese del presente giudizio.
…
(Segue la firma del difensore e l’elenco degli allegati: copia avviso impugnato, documenti contabili, ricevute pagamenti parziali, comunicazione bonaria, bilanci, ecc.)
L’esempio di ricorso sopra mostra come si intrecciano questioni di merito (calcoli, pagamenti) e questioni di diritto (cumulo sanzioni, proporzionalità). È uno stile discorsivo ma giuridicamente fondato, con richiami normativi e ai fatti, come richiesto in un ricorso tributario ben motivato.
Esempio 3: Istanza di autotutela per errore materiale
Scenario: Il contribuente Tizio ha ricevuto una comunicazione di irregolarità perché la LIPE del 1º trimestre 2025 da lui inviata risulta illeggibile al sistema (forse un file errato) e dunque come non pervenuta. In realtà Tizio ha il PDF protocollato della LIPE e la ricevuta Entratel di avvenuta trasmissione. Evidentemente c’è stato un errore nei sistemi interni del Fisco che non hanno acquisito i dati. La comunicazione chiede €500 di sanzione.
Difesa in autotutela: In questo caso, prima ancora di arrivare a un atto formale, conviene presentare all’Agenzia un’istanza di annullamento in autotutela allegando le prove dell’avvenuto adempimento. Un modello sintetico:
Oggetto: Istanza di autotutela – Comunicazione irregolarità LIPE I trim. 2025 prot.n…
Il sottoscritto Tizio (CF …) ha ricevuto in data … la Vs. comunicazione prot…. relativa all’omessa comunicazione LIPE I trimestre 2025. Con la presente evidenzio che trattasi di un errore: la comunicazione in oggetto è stata regolarmente trasmessa in data 30/05/2025, come da ricevuta telematica allegata (Prot. AE n. …). Probabilmente vi è stato un disguido tecnico per cui i dati non risultano nei vostri archivi, ma come dimostrato il mio adempimento è stato tempestivo e completo.
Pertanto, chiedo cortesemente l’**annullamento in autotutela** della suddetta comunicazione di irregolarità e di ogni atto conseguente, non essendo dovuta alcuna sanzione.
In fede,
Tizio – Firma
(Allego: copia ricevuta Entratel invio LIPE 1º trim.2025, copia LIPE protocollata)
Un’istanza così strutturata, inviata via PEC o consegnata all’ufficio, di solito risolve situazioni di mero errore senza bisogno di ricorrere. L’ufficio, verificate le carte, annullerà la pretesa e magari inviterà a re-inviare il file se serve.
Esempio 4: Regolarizzazione post-accertamento e riflessi penali
Scenario: Il sig. Caio non ha presentato né le LIPE trimestrali 2022 né la dichiarazione IVA 2023 per l’anno 2022, evadendo IVA per €300.000. Nel 2024 subisce una verifica dalla Guardia di Finanza, che scopre il tutto e redige processo verbale di constatazione (PVC). Caio a questo punto vuole evitare guai seri: nel frattempo, l’IVA evasa è stata usata per tenere in piedi l’azienda che ora genera utili. Caio decide di pagare integralmente l’imposta evasa (€300k) con relativi interessi e sanzioni. Nel 2025, l’Agenzia, recepito il PVC, notifica un accertamento ma Caio ha già versato. Caio patteggia anche in sede penale.
Difesa: Qui più che difendersi dall’accertamento (che Caio definisce aderendo e pagando con riduzione 1/5 sulle sanzioni per via del ravvedimento post PVC), l’esempio mostra come agire tempestivamente può mitigare i problemi:
- Caio presenta la dichiarazione IVA omessa (per scrupolo e per poter imputare formalmente l’IVA dovuta) e nel quadro VH indica i dati delle liquidazioni 2022 non inviate.
- Caio paga le sanzioni LIPE con ravvedimento 1/5 (dopo PVC: €100 cadauna) e paga l’IVA con sanzione 1/5 del 30% (6%). Insomma versa un bel po’, ma tutto prima dell’accertamento.
- L’Agenzia emette atto ma sostanzialmente conferma il versato, applicando solo eventuale differenza.
- In sede penale, Caio porta prova di aver pagato tutti i 300k di IVA prima dell’apertura del dibattimento: questo, ai sensi dell’art.13 D.Lgs.74/2000, lo pone al riparo dalla pena (il reato di omesso versamento IVA non è più punibile se il pagamento totale avviene prima della dichiarazione dell’anno successivo; qui era tardivo ma comunque comporterà attenuanti rilevanti, e per dichiarazione omessa idem pagamento integrale giova).
- Caio quindi se la cava con un patteggiamento minimo o addirittura una richiesta di archiviazione per particolare tenuità se il PM considera la condotta successiva.
Questo esempio evidenzia come, al di là delle strategie processuali, a volte la miglior difesa è collaborare e pagare (nei limiti del possibile), perché consente di beneficiare di tutti gli sconti amministrativi e di evitare sanzioni penali pesanti.
Domande e Risposte (FAQ)
Domanda: Cosa si intende esattamente per “irregolarità LIPE”?
Risposta: In generale, si parla di irregolarità LIPE riferendosi a qualsiasi violazione dell’obbligo di comunicare correttamente e tempestivamente i dati delle liquidazioni periodiche IVA. Le principali situazioni sono: omessa presentazione di una o più comunicazioni trimestrali; presentazione tardiva oltre la scadenza; oppure presentazione infedele/incompleta, cioè con dati sbagliati rispetto alla liquidazione reale. Tutti questi casi sono sanzionati dall’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/97. In pratica, se un trimestre non viene comunicato, o viene comunicato in ritardo, o con errori (ad es. importi errati di IVA a debito/credito), si ha un’irregolarità LIPE.
Domanda: Quali sanzioni si rischiano per il mancato invio o per errori nelle LIPE?
Risposta: La legge prevede una sanzione amministrativa da €500 a €2.000 per ogni comunicazione LIPE omessa, tardiva o infedele. Questa sanzione può essere ridotta alla metà (quindi €250 minimo) se la LIPE viene inviata correttamente entro 15 giorni dalla scadenza originaria. In altre parole, c’è una sorta di “periodo di tolleranza” di 15 giorni oltre la scadenza, entro il quale l’errore costa la metà. Oltre tale periodo, si applica la sanzione piena. Va aggiunto che grazie al ravvedimento operoso si può beneficiare di ulteriori riduzioni: ad esempio pagando spontaneamente la sanzione prima dell’accertamento, l’importo può scendere fino a €55 circa se si regolarizza entro 90 giorni (vedi tabella ravvedimento sopra). Le sanzioni si applicano per ciascun trimestre violato. Quindi, se non si inviano 2 trimestri, la sanzione minima (in difetto di ravvedimento) sarebbe 2 × €500 = €1.000. Ricordiamo che se l’omissione LIPE si accompagna a mancate fatturazioni o mancati versamenti IVA sostanziali, possono aggiungersi ulteriori sanzioni proporzionali (ad es. 30% dell’IVA non versata, 90-180% per IVA evasa su operazioni non registrate).
Domanda: Non ho presentato una LIPE ma il trimestre era a credito IVA (nessuna imposta da versare). Posso evitare la sanzione dato che il fisco non ha perso gettito?
Risposta: Purtroppo, anche se non c’era imposta da versare, l’omissione della comunicazione è comunque sanzionabile. La norma non fa distinzione tra LIPE a debito o a credito: l’obbligo di invio esiste in entrambi i casi. Si può provare a far valere, in sede di ricorso, il fatto che la violazione è “meramente formale” e non ha arrecato pregiudizio (dato che in dichiarazione annuale poi risulterà il credito), ma la giurisprudenza non sempre accoglie questa tesi. La Cassazione, ad esempio, ha escluso che l’omissione di dichiarazioni IVA possa considerarsi violazione formale non punibile, proprio perché comunque ostacola i controlli infrannuali e ritarda potenziali rimborsi. Quindi, di regola la sanzione va applicata anche se l’IVA era a credito. Tuttavia, in sede di difesa si potrà chiedere almeno l’applicazione del minimo edittale, evidenziando la buona fede e l’assenza di danno erariale. In pratica: meglio inviare sempre le LIPE, anche a credito, perché la dimenticanza può costare €500 comunque.
Domanda: Ho presentato la LIPE ma con un errore (ho indicato un importo sbagliato). Come posso rimediare?
Risposta: Se ti accorgi di aver commesso un errore in una LIPE già inviata, hai due opzioni:
- Se sei ancora entro la scadenza originaria o entro i 15 giorni successivi: puoi trasmettere una LIPE correttiva con i dati esatti. In questo modo eviti la sanzione o quantomeno la riduci della metà (perché correzione entro 15 gg).
- Se il termine è passato: puoi comunque inviare una comunicazione integrativa appena scopri l’errore. L’errore costituisce “dichiarazione infedele” nella LIPE, punibile con sanzione €500-€2.000. Però se agisci spontaneamente con ravvedimento operoso, pagherai una sanzione ridotta (ad esempio ~€55 se correggi entro 90 giorni, come detto). A seconda del tipo di errore, potresti anche risolvere direttamente in dichiarazione annuale: l’Agenzia ha chiarito che se l’errore viene sistemato durante la compilazione della dichiarazione IVA annuale, non serve inviare una LIPE rettificativa e basta pagare la sanzione formale dovuta. In sintesi, correggi i dati appena possibile e ravvediti pagando il dovuto, così l’errore non avrà ulteriori conseguenze.
Domanda: Ho saltato l’invio di una LIPE. Meglio inviarla in ritardo spontaneamente o aspettare che me la chiedano?
Risposta: Molto meglio provvedere spontaneamente il prima possibile. Se invii in ritardo spontaneamente, rientri nel caso del ravvedimento operoso e puoi versare una sanzione ridotta. Se aspetti che sia l’Agenzia a rilevarlo, ti arriverà una comunicazione con la sanzione intera (o 1/3 se paghi subito). Ad esempio, se invii la LIPE mancante entro 90 giorni con ravvedimento pagherai solo €55,56. Se aspetti la comunicazione, probabilmente ti chiederanno €167 (un terzo di 500) entro 30 giorni, o €500 se tardivo. Inoltre, sanando tu spontaneamente eviti il “marchio” di irregolare e l’avvio del procedimento. Dunque, è sempre consigliabile regolarizzare subito appena ci si accorge dell’omissione (o errore), senza aspettare controlli.
Domanda: Entro quanto tempo l’Agenzia delle Entrate può contestarmi l’omessa LIPE?
Risposta: L’accertamento/sanzione per violazioni LIPE deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione. Ad esempio, se hai saltato una LIPE del 2020 (violazione commessa nel 2020), l’ufficio ha tempo fino al 31/12/2025 per notificarti un atto di contestazione o emettere una cartella relativa a quella sanzione. Oltre tale termine scatta la decadenza, e la sanzione non è più dovuta. Questo termine coincide con quello ordinario di accertamento IVA (5 anni, in assenza di reato). In pratica, l’Agenzia tende a contestare abbastanza in fretta queste cose, spesso entro 1-2 anni, ma sappi che legalmente hanno fino a cinque anni. Perciò conserva le ricevute e documenti almeno per 6 anni, così potrai difenderti in caso di contestazioni tardive.
Domanda: Ho ricevuto una “comunicazione di irregolarità” per una LIPE: è un vero accertamento? Devo fare ricorso subito?
Risposta: La comunicazione di irregolarità (anche detta avviso bonario) non è un atto di accertamento definitivo, quindi non si propone ricorso in questa fase. È sostanzialmente un invito a regolarizzare: ti informa dell’errore (o imposta non versata) e ti chiede di pagare con una sanzione ridotta entro 30 giorni. Quindi, prima di tutto leggi bene cosa ti contesta e verifica se ha ragione. Se sì, paghi entro i termini e risolvi con sanzioni ridotte (in genere 1/3 del normale). Se non sei d’accordo, puoi contattare l’ufficio (anche tramite PEC o andando in sede su appuntamento) e fornire spiegazioni o documenti che provino l’errore dell’Agenzia. In questa fase non c’è un giudice: dialoghi con l’amministrazione in autotutela. Solo se la cosa non si risolve e successivamente ti verrà notificata una cartella di pagamento o un atto formale potrai proporre ricorso (entro 60 giorni da quell’atto). In breve: la comunicazione bonaria non si impugna in Commissione; devi decidere se pagare (e chiudere la questione) o se contestare informalmente/produrre documenti all’Agenzia. Ignorarla non è consigliabile, perché scaduti i termini ti arriverà la cartella con importi maggiorati e a quel punto dovrai comunque agire.
Domanda: Cosa succede se ignoro la comunicazione di irregolarità e non pago nulla?
Risposta: Se non paghi (o non fai sapere nulla) entro il termine indicato nella comunicazione, l’Agenzia procederà con l’iscrizione a ruolo delle somme. In pratica, trasforma quella richiesta bonaria in un debito esigibile coattivamente: ti verrà notificata una cartella esattoriale emessa dall’Agente della Riscossione per gli importi dovuti. A quel punto, la sanzione non sarà più ridotta ma in misura piena (ad esempio la sanzione passerà dal 10% al 30% per omessi versamenti, oppure la sanzione fissa passerà da 1/3 del minimo al minimo intero). Inoltre, sulla cartella si aggiungono le maggiori spese (interessi di mora dal 31° giorno, compensi di riscossione, etc.). Quindi ignorare l’avviso bonario ha due effetti: 1) perdi lo sconto sulle sanzioni; 2) dopo qualche mese ti trovi una cartella da pagare, che se ignori ancora può portare ad azioni esecutive (fermo auto, pignoramenti). Naturalmente, la cartella potrai impugnarla in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, se ritieni che la pretesa sia illegittima. Ma intanto il debito sarà formalizzato e potenzialmente gravato di ulteriori oneri. Meglio dunque usare la fase bonaria per chiarire/pagare, salvo casi in cui sei certo dell’errore dell’ufficio (in tal caso potresti anche aspettare la cartella e far valere le tue ragioni in giudizio).
Domanda: Posso impugnare una cartella di pagamento che contiene solo una sanzione per omessa LIPE?
Risposta: Sì. La cartella di pagamento è un atto impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria (ora Corte Giustizia Tributaria) entro 60 giorni. Se la cartella contiene una sanzione per omessa LIPE, puoi fare ricorso e contestare nel merito la sanzione stessa (es. perché la LIPE in realtà l’avevi inviata, o perché è decaduto il termine per sanzionarti, ecc.). Tieni presente che spesso l’Agenzia dovrebbe prima emettere un atto di contestazione e poi la cartella; ma per violazioni da controlli automatizzati può anche iscrivere direttamente a ruolo le sanzioni. Nel ricorso contro la cartella potrai eccepire, se applicabile, la mancata notifica dell’avviso bonario (che se obbligatorio e saltato rende nulla la cartella). Però in materia di LIPE l’avviso bonario è prassi ma non sempre considerato obbligatorio per sanzioni formali. In sintesi, la cartella “diretta” per €500 di sanzione può essere impugnata sia per motivi formali (vizi di notifica, mancato invio del bonario, etc.) sia per motivi sostanziali (insussistenza o improcedibilità della sanzione). Importante: mentre il ricorso è pendente, puoi chiedere all’Agente di Riscossione di sospendere la riscossione oppure al giudice tributario di sospendere gli effetti della cartella (se pagare ti creerebbe danno grave). Se non fai nulla, la cartella diventa definitiva dopo 60 giorni e a quel punto l’Agente può agire.
Domanda: Quali difese posso opporre in giudizio per farmi annullare o ridurre la sanzione?
Risposta: Dipende dal caso concreto, ma le strategie difensive più comuni le abbiamo riassunte sopra. Eccone alcune in sintesi:
- Provare che la violazione non c’è stata: se hai prove di aver presentato la LIPE o di averla presentata in tempo, portale: il giudice può annullare la sanzione perché “il fatto non sussiste”. Questo è l’ideale (es. errore dell’ufficio).
- Eccepire vizi formali/procedurali: es. l’atto è stato notificato fuori termine (oltre 5 anni), oppure non è motivato adeguatamente (non spiega quale LIPE sarebbe omessa), oppure manca la preventiva notifica del avviso bonario quando richiesta. Un vizio procedurale grave può portare all’annullamento indipendentemente dal merito.
- Chiedere il cumulo giuridico: se ci sono tante violazioni simili, chiedi di applicare l’art.12 D.Lgs.472/97, così la sanzione potrebbe essere ridotta (non più somma aritmetica ma un unico importo un po’ più basso).
- Invocare la non punibilità per violazioni formali: è una linea difensiva delicata, ma si può sostenere che, non avendo l’omissione influito sull’imposta dovuta (ad esempio perché hai comunque versato tutto), si tratti di un formalismo non punibile. La legge lo prevede solo in casi di nessun impatto sul controllo, e l’Agenzia su questo è restrittiva, però alcuni giudici tributari potrebbero essere sensibili all’argomento se il contribuente era sostanzialmente in regola.
- Sproporzione e buona fede: evidenziare che sei incappato in una svista, magari per cause di forza maggiore, e che la sanzione è eccessiva rispetto al disvalore. Ad esempio, tardare di 1 giorno non dovrebbe costare €500: alcuni giudici in passato hanno ridotto sanzioni riconoscendo l’attenuante della lieve entità. Non è garantito, ma tentare non nuoce.
- Documentare la correzione spontanea: se prima dell’accertamento hai comunque presentato la dichiarazione annuale riportando i dati, hai pagato l’IVA, ecc., fallo presente: può convincere il giudice a essere clemente (ad esempio applicando il minimo).
- Precedenti giurisprudenziali: citare sentenze favorevoli simili (es. se c’è una CTR che ha annullato sanzione LIPE a credito, o Cassazione su principi generali). Dare al giudice basi per decidere a tuo favore.
In definitiva, l’approccio migliore è contestare sia su questioni formali (termini, difetto di notifica, ecc.) sia su questioni sostanziali (assenza di danno, ecc.), in modo alternativo e subordinato. Così aumenti le chance che almeno una linea difensiva venga accolta (ad es. anche se non ti annulla la sanzione, magari la dimezza applicando cumulo o attenuanti).
Domanda: È possibile rateizzare il pagamento delle sanzioni?
Risposta: Sì, ma con differenze a seconda della fase:
- In fase bonaria: non è prevista una vera rateazione per la comunicazione d’irregolarità; però se quell’avviso riguarda anche imposte, spesso viene proposta la possibilità di pagare in rate trimestrali (massimo 8 rate se importo <€5.000, o 20 rate se >€5.000). Questo vale per gli avvisi bonari da controllo automatico: ad esempio, se devi €2.000 (tra imposta e sanzioni), puoi chiedere di dilazionare in 8 rate da €250 circa.
- Cartelle di pagamento: le cartelle, comprese quelle per sole sanzioni, sono rateizzabili rivolgendosi all’ADER. Importi fino a €120.000 sono concessi in modo abbastanza automatico in 72 rate (6 anni). Per somme maggiori serve documentare la difficoltà economica. Quindi, se ti arriva una cartella per €500, puoi senz’altro spalmarla (anche se essendo piccola, conviene pagarla subito; la rateazione ha un costo di interessi di rateazione).
- Atto di irrogazione sanzioni (non a ruolo): se l’Agenzia ti notifica un atto di contestazione sanzioni (non cartella), in genere nell’atto stesso ti offrono la definizione in 60 giorni con 1/3. Se non vuoi o puoi pagare subito, puoi comunque chiedere all’Agenzia una dilazione in applicazione dell’art. 8 D.Lgs.218/97. Spesso per importi non enormi l’ufficio accorda la rateazione (fino a 8 rate) anche sulle sanzioni in fase amministrativa, ma devi fare istanza motivata entro 30 giorni dalla notifica dell’atto. Nota: se rateizzi e stai nei termini, di solito ti chiedono di firmare che rinunci al ricorso.
- Dopo sentenza: se perdi e la sentenza è definitiva, la somma dovuta va pagata entro 30 giorni. Anche a quel punto se non ce la fai puoi chiedere ad ADER la rateazione, come per le cartelle.
Quindi sì, esistono margini per rateizzare. Il caso più tipico: arrivi a cartella, fai ricorso ma perdi, avrai una cartella da pagare – a quel punto puoi diluire il pagamento. Attenzione però: rateizzare non sospende il termine di ricorso. Se vuoi contestare devi comunque farlo nei 60 giorni, la rateazione non blocca la possibilità di impugnare (anzi, l’Agenzia a volte fa firmare che rinunci al ricorso se vuoi la rateazione sull’avviso bonario). Valuta bene con un consulente il da farsi.
Domanda: L’omissione di una LIPE può portare ad una verifica fiscale o addirittura a conseguenze penali?
Risposta: L’omissione in sé di solito no – è considerata una violazione minore. Tuttavia, potrebbe fare da campanello d’allarme. Se ad esempio ometti le LIPE perché stai nascondendo un grosso giro di IVA non versata, il Fisco incrociando i dati potrebbe decidere di approfondire con un controllo. Quindi, sì, più LIPE omesse potrebbero aumentare il rischio di una verifica fiscale (specie se contestualmente risultano fatture emesse o acquisti anomali). Quanto ai profili penali: non c’è un reato specifico per “omessa comunicazione LIPE”. Però, se dietro c’è un’evasione IVA significativa, possono configurarsi reati tributari:
- Omesso versamento IVA (penale): se a fine anno non versi IVA per oltre €250.000, commetti reato (anche se hai o non hai inviato le LIPE, è il fatto di non pagare che conta). L’omissione delle LIPE magari ha nascosto temporaneamente la cosa, ma il reato scatta comunque se non paghi entro la scadenza legale.
- Dichiarazione infedele/fraudolenta: se le LIPE omesse erano parte di un disegno fraudolento (es. non fatturavi vendite e quindi non dichiaravi quell’IVA), il reato si concretizza sulla dichiarazione annuale infedele (sopra certe soglie) o, se non dichiari affatto, sull’omessa dichiarazione (soglia €50.000 di imposta evasa).
In breve: la singola LIPE saltata non ti porta in tribunale penale, ma se fa parte di un’evasione più ampia, sì. Dunque, se hai omesso LIPE e contestualmente evaso molta IVA, preparati perché oltre alle sanzioni amministrative potresti ricevere un invito della Procura. Il consiglio, in tal caso, è di correre ai ripari: presentare la dichiarazione annuale anche se tardiva, pagare il possibile (il ravvedimento o l’adesione possono mitigare anche in sede penale). Ricorda che per l’omesso versamento IVA il pagamento integrale del debito anche tardivamente può evitare la condanna.
Domanda: Le micro-imprese in regime forfettario o altri esonerati IVA devono inviare le LIPE?
Risposta: No, i contribuenti forfettari (regime ex L.190/2014) e in generale chi non è tenuto a liquidazioni periodiche IVA non deve inviare le LIPE. Il regime forfettario infatti non prevede addebito dell’IVA in fattura né detrazione, quindi non ci sono liquidazioni da comunicare. Anche i contribuenti in regime di vantaggio (minimi) o agricoltori esonerati non fanno LIPE. Inoltre, soggetti che per legge non presentano dichiarazione IVA (es. soggetti solo con operazioni esenti che rientrano in esonero se previsto) non presentano neanche LIPE. In pratica le LIPE riguardano chi liquida l’IVA periodicamente: tutti i normali titolari di partita IVA nel regime IVA ordinario o semplificato. Se sei esonerato dall’IVA, sei esonerato anche dalla comunicazione LIPE. Quindi, ad esempio, un forfettario che per errore ricevesse una contestazione per LIPE mancante potrebbe semplicemente chiarire che non era soggetto all’obbligo (errore dell’ufficio). La base normativa è nell’art. 21-bis DL 78/2010 e nei provvedimenti attuativi, che escludono i regimi che non prevedono liquidazioni periodiche.
Domanda: Quali sono le scadenze esatte per presentare le LIPE?
Risposta: Per i contribuenti trimestrali (la maggior parte, a meno che tu non sia mensile per volume d’affari):
- 1º trimestre (gen-mar): entro il 31 maggio;
- 2º trimestre (apr-giu): entro il 30 settembre (dal 2022 prorogato al 30/09 invece del 16/09);
- 3º trimestre (lug-set): entro il 30 novembre;
- 4º trimestre (ott-dic): entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Per i mensili (liquidazione IVA ogni mese), formalmente dovrebbero inviare la comunicazione con cadenza trimestrale ugualmente, includendo i dati di tre mesi per volta (es. mensili di Jan/Feb/Mar vanno nel trimestre 1 da inviare a maggio, e così via). In pratica la comunicazione è trimestrale anche per loro ma con dettaglio mensile. Le date sono le stesse. Se la scadenza cade di sabato o domenica, di solito non scorre (per LIPE è specificato un giorno preciso, salvo diversa indicazione normativa di slittamento). Nel dubbio, controlla sempre un calendario fiscale aggiornato per l’anno corrente, perché possono esserci proroghe normative occasionali (specie per il secondo trimestre che in passato è slittato). Ad esempio, la scadenza del 2º trimestre 2023 è stata il 2 ottobre 2023 anziché 16 settembre, perché il 30 settembre era sabato e c’è stato il DL che ha spostato a fine mese. In generale però, le date sopra sono quelle ordinarie.
Domanda: Le LIPE influenzano la dichiarazione annuale IVA?
Risposta: Le LIPE sono comunicazioni propedeutiche all’annuale, ma i dati definitivi sono quelli della dichiarazione annuale IVA. In fase di dichiarazione annuale (modello IVA) c’è un quadro riepilogativo (il quadro VH) dove vanno indicati gli importi delle liquidazioni periodiche effettuate. In passato il quadro VH era obbligatorio solo se dovevi rettificare dati di LIPE non inviate; attualmente è facoltativo (l’Agenzia riprende i dati dalle LIPE stesse). Comunque, la dichiarazione annuale “assorbe” eventuali correzioni: se avevi sbagliato una LIPE ma correggi in dichiarazione, il calcolo dell’IVA da versare a saldo è fatto su base annuale. Però occhio: se la somma di quanto versato nelle LIPE è inferiore al dovuto annuale, scatterà quasi certamente un controllo automatizzato (avviso bonario) per quell’anno. Viceversa, se hai versato trimestre per trimestre, la dichiarazione annuale potrebbe chiudersi a credito (che puoi chiedere a rimborso o compensare). Formalmente, presentare le LIPE non ti esime dal presentare la dichiarazione annuale IVA (che è un obbligo a sé e molto più importante: la mancata presentazione è reato oltre che sanzionata pesantemente). E presentare la dichiarazione annuale non sana automaticamente l’omissione delle LIPE, anche se fornisci lì i dati: la sanzione formale per le LIPE resta dovuta. In sintesi: le LIPE servono al fisco durante l’anno, la dichiarazione annuale “tira le somme”; entrambe vanno rispettate. Solo nel caso tu abbia saltato una LIPE ma l’hai inclusa nei conteggi annuali, come detto pagherai la sanzione ma almeno non perdi eventuali crediti IVA (la Cassazione ha riconosciuto che il credito IVA spetta comunque se dimostri le operazioni, anche se hai omesso di dichiarare in tempo).
Fonti e Riferimenti
- D.Lgs. 18/12/1997 n.471, art. 11, comma 2-ter (introdotto dal DL 193/2016 conv. L.225/2016) – Sanzione per omessa/infedele comunicazione LIPE.
- D.Lgs. 18/12/1997 n.471, art.13 (sanzioni omesso versamento IVA 30%) e art.6 (sanzioni violazioni IVA sostanziali 90-180%).
- D.Lgs. 18/12/1997 n.472, art.13 (ravvedimento operoso) e art.12 (cumulo giuridico di violazioni tributarie).
- Agenzia Entrate – Risoluzione 104/E del 28/07/2017 – Chiarisce l’applicabilità del ravvedimento operoso alle comunicazioni LIPE.
- Agenzia Entrate – Risposta a interpello n.450/2023 (20/10/2023) – Chiarimenti su omessa dichiarazione IVA e regolarizzazione (cita sanzione €500 per omessa LIPE).
- Provv. Ag.Entrate 27/03/2017 – Istituzione modello “Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA” e istruzioni, attuativo dell’art.21-bis DL 78/2010 (obbligo LIPE).
- Legge 29/12/2022 n.197 (Bilancio 2023), commi 153-159 – Definizione agevolata avvisi bonari (sanzioni 3%) applicabile anche a controlli LIPE; commi 166-173 – Regolarizzazione violazioni formali (sanatoria €200).
- Circ. AE 2/E del 27/01/2023 – Chiarimenti “tregua fiscale” 2023 (include conferma che definizione avvisi bonari riguarda anche LIPE).
- Corte Costituzionale, sent. n.111/2024 – Principi su proporzionalità base imponibile extraprofitti: nota che le LIPE sono dati provvisori e incompleti rispetto all’annuale.
- Cassazione SS.UU. n.17757/2016 – Principio di sostanza vs forma in IVA (diritto a detrazione nonostante omissioni formali, se requisiti sostanziali rispettati).
- Cass. Sez.V n.37146/2021 – Omessa dichiarazione IVA non fa perdere credito se indicato anno dopo, ma è sanzionabile (omesso versamento infrannuale causa deficit erariale).
- Cass. Sez.V n.15060/2022 (ord.) – Conferma diritto a detrazione IVA se esercitato entro secondo anno successivo nonostante omissione dichiarativa (richiama Cass. SS.UU. 17757/16).
- Cass. Sez.V n.9739/2023 – Il contribuente che ha omesso dichiarazione IVA può, in sede contenziosa contro controllo automatizzato (36-bis, 54-bis), dimostrare l’esistenza del credito non dichiarato con documentazione, ponendosi nella stessa condizione come se avesse dichiarato – ciò non toglie che sanzioni e interessi restino dovuti.
- Cass. Sez.V n.31433/2018 – Richiamata da Cass.9739/23: possibilità in giudizio di opporre errori di dichiarazione incidenti sull’obbligazione tributaria, a prescindere da decadenze formali.
- Cass. Sez.V n.29989/2022 – In tema di notifica atti: annullato atto successivo perché il precedente non era stato notificato (principio valido per intimazioni vs accertamenti).
- Circ. AE 42/E del 12/10/2016 – Chiarisce che violazioni “prodromiche” (es omessa fatturazione) vanno ravvedute singolarmente, niente cumulo in ravvedimento.
- Agenzia Entrate – sito ufficiale, sezione ravvedimento operoso – Istruzioni generali su come regolarizzare violazioni (rimozione violazione e pagamento sanzione ridotta).
- Agenzia Entrate – “Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità” (sito) – Spiega come regolarizzare pagando imposte+interessi+sanzione ridotta a 1/3 entro 30 gg, o come segnalare errori all’ufficio.
- MEF – DGT, 2023 – Abrogazione reclamo/mediazione per ricorsi notificati dal 2024 (valore fino 50k).
Accertamento per Irregolarità LIPE: Come Difendersi
Hai ricevuto una comunicazione o un avviso di accertamento per irregolarità nelle LIPE (Comunicazioni Periodiche IVA)? Ti contestano differenze tra le liquidazioni IVA inviate e la dichiarazione annuale?
Le incongruenze tra LIPE e dichiarazione IVA sono tra le cause più frequenti di accertamenti automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ma non sempre si tratta di evasione: molti errori derivano da omissioni formali o dati non aggiornati. E puoi difenderti in modo efficace.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’atto ricevuto e la documentazione relativa alle liquidazioni e alla dichiarazione IVA
- 📌 Verifica la natura dell’irregolarità (errore formale, scostamento giustificabile, omissione parziale)
- ✍️ Redige memorie difensive, istanze di autotutela o opposizioni a sanzioni automatiche
- ⚖️ Ti rappresenta nel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, se l’anomalia genera un avviso di accertamento
- 🔁 Ti assiste in eventuali procedure di regolarizzazione o ravvedimento operoso per limitare i danni
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e contenzioso su IVA e comunicazioni periodiche
- ✔️ Specializzato nella gestione di anomalie fiscali e difesa da accertamenti automatizzati
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Un’irregolarità nelle LIPE può sembrare un errore banale, ma può trasformarsi in una sanzione pesante o in un accertamento vero e proprio. Intervenire subito è fondamentale.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa fiscale comincia da qui.