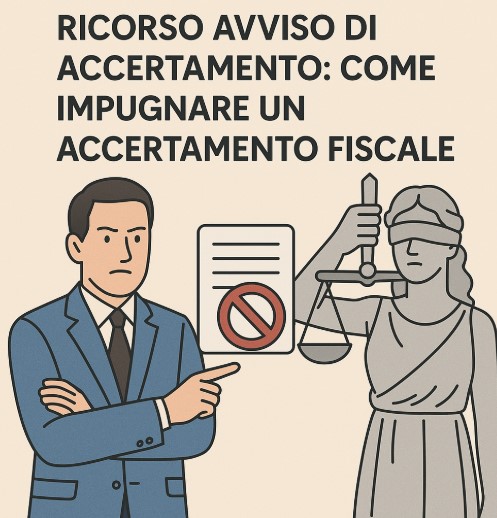Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate?
Ti contestano imposte non pagate, redditi non dichiarati, IVA evasa o errori nella dichiarazione dei redditi? In questi casi è fondamentale capire come impugnare l’atto entro i termini previsti, quali strategie difensive adottare e come presentare un ricorso efficace per annullare o ridurre le pretese dell’Amministrazione.
Quando si può presentare ricorso contro un avviso di accertamento?
– Quando ritieni che l’accertamento sia infondato o viziato da errori
– Quando non ti è stato concesso il contraddittorio preventivo o il termine per le osservazioni
– Quando i calcoli dell’Agenzia sono basati su presunzioni arbitrarie o dati errati
– Quando sono stati violati i termini di decadenza o le regole di notifica
– Quando non sono stati considerati documenti o elementi a tuo favore
Cosa contiene un avviso di accertamento?
– Il dettaglio delle violazioni fiscali contestate (redditi, IVA, IRAP, imposte locali)
– Le motivazioni dell’accertamento e i riferimenti normativi
– L’indicazione dell’importo da versare, comprensivo di imposte, interessi e sanzioni
– Il termine per aderire o impugnare l’atto (in genere 60 giorni dalla notifica)
– L’avvertimento che, in caso di mancata impugnazione, l’accertamento diventa definitivo
Come si presenta ricorso contro un avviso di accertamento?
– Il ricorso va redatto in forma scritta, con l’assistenza di un avvocato tributarista o commercialista abilitato
– Deve contenere i motivi specifici di contestazione, le prove documentali e le richieste al giudice
– Va depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto
– Deve essere notificato anche all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dalla legge
– Può essere preceduto da una richiesta di mediazione tributaria, se l’importo contestato non supera i 50.000 euro
Cosa puoi ottenere con un ricorso ben costruito?
– L’annullamento totale dell’avviso, se l’Agenzia ha sbagliato nel merito o nella procedura
– La riduzione delle somme richieste, se l’accertamento è solo parzialmente fondato
– La sospensione dell’esecutività dell’atto, per evitare iscrizioni a ruolo o pignoramenti
– Il riconoscimento di circostanze attenuanti, che riducono le sanzioni
– La possibilità di definire la lite in corso d’opera, evitando lunghi contenziosi
Attenzione: non rispondere a un avviso di accertamento nei tempi previsti significa accettarlo tacitamente. Ma con una difesa tecnica e puntuale, puoi ribaltare le pretese dell’Agenzia e tutelare la tua posizione fiscale in modo pieno e legittimo.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in accertamenti fiscali, ricorsi tributari e difesa del contribuente ti spiega quando e come impugnare un avviso di accertamento, quali errori contestare e come ottenere giustizia fiscale.
Hai ricevuto un avviso di accertamento e vuoi sapere se è possibile contestarlo?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti diremo come valutare l’atto, preparare il ricorso e difendere i tuoi diritti fino in fondo.
Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento fiscale – l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria rettifica o contesta le imposte dovute – è un evento critico per ogni contribuente. Dal punto di vista del debitore (sia esso privato cittadino, imprenditore o società), conoscere come impugnare correttamente un avviso di accertamento è fondamentale per tutelare i propri diritti. Questa guida avanzata, aggiornata a luglio 2025, fornisce un quadro completo della normativa italiana e delle ultime novità in materia, inclusi riferimenti normativi, sentenze recenti e strumenti pratici di difesa. Il linguaggio utilizzato è giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) sia ai contribuenti che vogliono comprendere a fondo la procedura. Troverete tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande e Risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni.
Le riforme degli anni 2023-2025 hanno inciso profondamente sul contenzioso tributario. In particolare, la Legge 130/2022 e i successivi decreti attuativi del 2023/24 hanno introdotto cambiamenti quali: l’abolizione del reclamo-mediazione obbligatorio (per le liti sotto una certa soglia), l’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo (il fisco deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di emettere l’atto), nonché nuove regole sull’autotutela tributaria (con doveri di annullamento in casi di errore e possibilità di impugnare il diniego). Queste novità – entrate in vigore tra gennaio 2024 e aprile 2024 – saranno evidenziate nel corso della trattazione.
Struttura della guida: dapprima definiremo cos’è un avviso di accertamento e quali elementi deve contenere. Analizzeremo poi i termini e le modalità per presentare ricorso, le strategie difensive (vizi formali e sostanziali che si possono far valere) e la procedura processuale davanti alle nuove Corti di Giustizia Tributaria. Saranno illustrati gli strumenti “deflativi” del contenzioso – come l’adesione, l’acquiescenza, l’autotutela e la conciliazione – che consentono di evitare o attenuare la lite. Una sezione ad hoc è dedicata alle peculiarità per i tributi locali (es. IMU, TARI) e per i dazi doganali, ambiti in cui vigono le stesse garanzie processuali con alcune specificità. Nel corso del testo, riquadri esplicativi e tabelle riassumeranno i punti chiave (ad esempio, scadenze e riduzioni sanzionatorie), mentre in conclusione troverete un elenco di FAQ – Domande e Risposte e le Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali utilizzati.
Avvertenza: In materia tributaria la tempestività è essenziale. Un atto viziato deve comunque essere impugnato entro i termini di legge, altrimenti diventa definitivo. Anche se l’avviso presenta errori palesi, il contribuente deve attivarsi entro 60 giorni per non perdere ogni tutela. È quindi importante leggere attentamente l’atto ricevuto, valutare le opzioni (pagare con sanzioni ridotte, chiedere una rettifica o fare ricorso) e, se del caso, farsi assistere da un professionista. Procediamo dunque con ordine, approfondendo ciascun aspetto dal punto di vista del contribuente che intende contestare un accertamento fiscale.
Cos’è un avviso di accertamento fiscale
L’avviso di accertamento è un atto formale con cui l’ente impositore (ad esempio, l’Agenzia delle Entrate per le imposte erariali, il Comune per i tributi locali, o l’Agenzia delle Dogane per i dazi) comunica al contribuente una rettifica dell’imponibile e la conseguente maggiore imposta dovuta, spesso applicando anche sanzioni amministrative e interessi. In altre parole, tramite l’avviso l’Amministrazione contesta al contribuente una differenza tra il dichiarato (o versato) e il dovuto, determinando un nuovo ammontare di tasse da pagare.
Un avviso di accertamento valido deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge. In particolare, secondo lo Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) e la normativa vigente, l’atto deve indicare chiaramente:
- L’ufficio emanante e il funzionario responsabile del procedimento, con relativa sottoscrizione (firma digitale o autografa).
- Il destinatario (dati anagrafici o societari del contribuente) e gli estremi dell’eventuale suo rappresentante.
- L’anno d’imposta e la natura dei tributi contestati (es.: IRPEF 2019, IVA 2020, IMU 2021, dazi doganali su importazioni dell’anno X, ecc.).
- La motivazione dell’atto, ovvero i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano la pretesa. Questo significa che l’Ufficio deve spiegare perché ritiene dovute le maggiori imposte: ad esempio, indicando gli errori od omissioni riscontrati nella dichiarazione, il verbale di verifica da cui scaturisce l’accertamento, i calcoli effettuati, le norme violate, ecc. La motivazione può essere “per relationem”, cioè facendo riferimento ad altri atti (es. processo verbale di constatazione – PVC) purché tali documenti siano allegati all’avviso o ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
- L’ammontare delle imposte dovute in base all’accertamento, con separata indicazione di eventuali sanzioni irrogate e interessi calcolati.
- Le modalità e i termini per impugnare l’atto dinanzi al giudice tributario, ovvero l’indicazione che il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni e dinanzi a quale organo giudiziario. Spesso l’atto riporta anche il riferimento normativo (art. 19 D.Lgs. 546/1992) che elenca gli atti impugnabili.
- Le eventuali procedure deflative applicabili prima del ricorso: ad esempio, l’avviso informa se è possibile definire il tutto in acquiescenza (pagando con sanzioni ridotte) o mediante accertamento con adesione (concordando l’imposta). Dal 2024, tutti gli avvisi devono essere preceduti (salvo eccezioni) da un “schema di atto” inviato al contribuente per il contraddittorio: l’avviso finale richiamerà tale fase e conterrà l’invito a definire in adesione se il contribuente non ne ha già usufruito in sede di contraddittorio.
- L’autorità competente alla riscossione (ad esempio, Agenzia Entrate–Riscossione per i tributi erariali) e l’avvertimento che, decorso il termine per il ricorso, l’atto diverrà definitivo ed esecutivo.
Vale la pena chiarire proprio questo ultimo punto: oggi l’avviso di accertamento ha anche efficacia esecutiva. Ciò significa che trascorsi 60 giorni senza ricorso né pagamento, l’atto diventa titolo idoneo per la riscossione coattiva, senza necessità di un’ulteriore cartella di pagamento. Questa regola, introdotta dalla manovra 2011, vale per la generalità dei tributi erariali e locali (il cosiddetto “accertamento esecutivo”): l’avviso contiene già l’intimazione di pagamento e, se il debitore non paga né impugna, dopo ulteriori solleciti di legge (ad es. un’intimazione finale) si può procedere al pignoramento dei beni. Attenzione: ciò differenzia l’avviso di accertamento dalla cartella esattoriale (o cartella di pagamento). La cartella è uno strumento della riscossione utilizzato per riscuotere somme già definite (per esempio, dopo un accertamento divenuto definitivo, o per versamenti omessi risultanti da controlli automatici). L’avviso, invece, è l’atto impositivo “originario” che il contribuente può ancora contestare nel merito. Molti contribuenti confondono le due cose: in sintesi, l’avviso di accertamento accerta e ingiunge, mentre la cartella riscuote somme già accertate (oltre ad essere essa stessa impugnabile per vizi propri).
Esempio: Tizio riceve nel luglio 2025 un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate che rettifica la sua dichiarazione dei redditi 2020, chiedendo €10.000 di IRPEF in più, oltre sanzioni e interessi. L’atto, firmato dal Direttore dell’Ufficio, spiega che il Fisco ha rilevato maggiori ricavi non dichiarati grazie a un PVC della Guardia di Finanza allegato all’avviso. Sono indicati l’anno d’imposta (2020), l’imposta accertata (€10.000 IRPEF), la sanzione (100% dell’imposta, ridotta a 1/3 in caso di acquiescenza) e gli interessi calcolati. Viene riportato che Tizio ha 60 giorni per fare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente, con l’avvertenza che, scaduto tale termine, l’atto è esecutivo e si procederà alla riscossione coattiva.*
Requisiti formali e vizi dell’atto
Affinché l’avviso sia valido, deve rispettare i requisiti sopra elencati. Alcune mancanze comportano nullità, altre sono irregolarità sanabili. Ad esempio, la legge una volta prevedeva espressamente la nullità dell’atto per omessa indicazione del responsabile del procedimento; dal 2023 tale omissione non è più causa di annullamento (resta comunque un obbligo inserire quel dato). Viceversa, la mancata motivazione o la totale assenza di sottoscrizione sono vizi gravissimi che rendono l’accertamento nullo in radice. La Cassazione ha più volte ribadito che l’atto privo di una motivazione comprensibile lede il diritto di difesa e va annullato. Anche una motivazione interna contraddittoria (ad esempio: l’avviso indica due distinte e incompatibili ragioni della pretesa, creando confusione) costituisce un vizio che inficia l’atto.
Altri vizi formali frequenti riguardano la notifica dell’atto: se l’avviso non viene notificato secondo le forme di legge (mancato rispetto delle regole sulla consegna a mezzo posta, o notifica a soggetto non legittimato a riceverlo, ecc.), il contribuente può eccepirne la nullità nel ricorso. Ancora, l’avviso potrebbe provenire da un ufficio incompetente territorialmente o materialmente: ad esempio, un Comune notifica un accertamento IMU per un immobile fuori dal suo territorio, oppure l’atto è emesso da un funzionario non avente potere di firma. Questi vizi rientrano tra le cause di annullabilità. Occorre tuttavia sottolineare che, in materia tributaria, i vizi invalidanti (nullità/annullabilità) devono essere fatti valere dal contribuente: non esiste quasi mai una nullità “automatica” rilevabile d’ufficio a distanza di tempo. Se il contribuente non impugna nei termini, anche un avviso illegittimo si “consolida” e diventa definitivo e incontestabile. Pertanto, ogni irregolarità va sollevata nel ricorso entro 60 giorni.
Riassumiamo sinteticamente in tabella alcuni possibili vizi dell’avviso di accertamento e la relativa rilevanza:
| Vizio/Irregolarità | Effetto sull’atto | Note |
|---|---|---|
| Motivazione mancante o incomprensibile | Nullità assoluta dell’atto | Violazione di art. 7 L.212/2000. Da impugnare entro 60 gg. |
| Motivazione “per relationem” senza allegati | Nullità dell’atto per difetto di motivazione | Se il PVC o altri atti richiamati non sono allegati né sintetizzati. |
| Motivazione interna contraddittoria | Nullità dell’atto | Cass. 13620/2023: motivi contraddittori non danno certezza al contribuente. |
| Omessa indicazione del responsabile procedimento | Irregolarità (non più nullità dal 2023) | Modifica introdotta dalla riforma 2023 (D.Lgs. 219/2023). |
| Firma mancante (atto non sottoscritto) | Nullità dell’atto | Vizio insanabile (manca elemento essenziale). |
| Errore sul soggetto destinatario (es. cod.fiscale, indirizzo) | Potenziale nullità della notifica | Da valutare caso per caso (notifica inesistente o nulla se destinatario errato). |
| Notifica inesistente o radicalmente viziata | Nullità dell’atto (inesistenza giuridica) | Es. notifica mai avvenuta o eseguita fuori termine. |
| Notifica nulla (vizi sanabili, es. consegna a familiare senza relata) | Sanabile se il contribuente ha comunque avuto conoscenza dell’atto | Il contribuente può eccepire la nullità nel ricorso se il vizio non si è sanato con la conoscenza. |
| Emissione oltre i termini decadenziali | Nullità dell’atto per tardività | L’atto emesso fuori tempo (oltre il termine ultimo di legge, v. oltre) è illegittimo. |
| Ufficio incompetente | Nullità/Annullabilità (a seconda dei casi) | Incompetenza per territorio o materia va fatta valere nel ricorso. |
| Omesso contraddittorio (per atti dal 2024 in poi, dove obbligatorio) | Annullabilità dell’atto su ricorso | Violazione di art. 6-bis Statuto: se l’ufficio non ha invitato al contraddittorio, l’atto è annullabile dal giudice. (Vedi sez. dedicata) |
Come si vede, alcuni vizi (es. motivazione assente) sono così gravi da rendere l’atto invalido nella sostanza; altri (es. omissioni di dati meno essenziali) costituiscono irregolarità formali che difficilmente portano all’annullamento, specie se non hanno leso concretamente il diritto di difesa. Sarà compito del difensore tributario individuare e far valere in ricorso tutti i vizi utili. Si noti ancora che, anche per i vizi più gravi, è onere del contribuente impugnare tempestivamente: la Corte di Cassazione ha chiarito che nel processo tributario non esistono nullità insanabili rilevabili d’ufficio dopo la scadenza dei termini, poiché prevale l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Termini di notifica dell’accertamento e decadenza
Prima di esaminare come fare ricorso, è utile sapere se l’accertamento è stato notificato in tempo utile dall’ente impositore. La legge infatti fissa precisi termini di decadenza oltre i quali il Fisco perde il potere di accertare un dato periodo d’imposta. Un avviso notificato tardivamente (oltre il termine ultimo previsto) è illegittimo e può essere annullato se il contribuente eccepisce la decadenza. I termini variano a seconda del tributo e dell’anno d’imposta, nonché in base alla presentazione o meno della dichiarazione. Ecco i principali termini di decadenza per l’emissione degli avvisi di accertamento (a pena di nullità):
- Imposte dirette (IRPEF, IRES) e IVA: se il contribuente ha presentato la dichiarazione annuale, l’avviso dev’essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi 2019 presentata nel 2020, il termine è il 31/12/2025. In caso di omessa dichiarazione, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (Es.: se per il 2019 non è stata presentata la dichiarazione, l’accertamento può arrivare fino al 31/12/2026). Questi termini, già prorogati dal DL 193/2016, sono attualmente in vigore. Vi sono cause straordinarie di sospensione/proroga (es. raddoppio dei termini in caso di reati tributari con notifica di denuncia entro termini ordinari) che possono estendere ulteriormente la decadenza, fino a raddoppiarla in casi gravi, ma si tratta di situazioni particolari.
- Tributi locali (IMU, TARI, TASI): anche per i tributi degli enti locali la regola generale dal 2012 è un termine di 5 anni. L’accertamento dev’essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato o la dichiarazione presentata. Ad esempio, l’IMU 2020 (dovuta nel 2020) può essere accertata fino al 31/12/2025.
- Altri tributi: per alcune imposte indirette come l’imposta di registro, ipotecaria, bollo, successioni, ecc., vigono termini diversi stabiliti dalle relative leggi (spesso 5 anni, o 3 anni per il bollo auto, ecc.). È impossibile in questa sede coprire ogni tributo minore, ma la regola di base è che ogni avviso riporta in motivazione la norma applicata e va verificato se l’anno contestato rientra nei termini.
- Dazi doganali: la normativa unionale (art. 103 Reg. UE 952/2013, Codice Doganale dell’Unione) prevede che il dazio all’importazione non possa essere accertato oltre 3 anni dalla data dell’obbligazione doganale (salvo casi di frode in cui si estende a 5 anni). In ambito nazionale, l’Agenzia delle Dogane emette avvisi di rettifica entro tali termini. Ad esempio, dazi su importazioni del 2021 non possono essere pretesi dopo il 2024 (salvo frodi).
Se l’atto viene notificato oltre il termine decadenziale, la decadenza va eccepita nel ricorso come motivo di nullità. Esempio: una dichiarazione IVA 2018 presentata regolarmente aveva come termine di accertamento il 31/12/2023; l’avviso notificato a gennaio 2024 sarebbe tardivo e dunque illegittimo. In giudizio sarà sufficiente provare la data di notifica (esibendo la ricevuta postale con data) per ottenere l’annullamento dell’atto per tardività.
Oltre alla decadenza per notifica dell’avviso, c’è da considerare la prescrizione del credito tributario dopo che l’avviso sia divenuto definitivo. In pratica: una volta che l’avviso non è più impugnabile (perché scaduti i termini o confermato da sentenza passata in giudicato) l’Amministrazione ha un certo numero di anni per riscuotere le somme: decorso tale periodo, il debito si prescrive e non è più esigibile. Ad esempio, i debiti tributari definitivi derivanti da accertamento erariale in genere si prescrivono in 10 anni (termine ordinario civile) se non sono previste prescrizioni brevi; i tributi locali si prescrivono in 5 anni in assenza di atti interruttivi; il bollo auto in 3 anni. Questi termini però esulano dal ricorso: riguardano fasi successive (cartelle di pagamento, ingiunzioni) e non l’impugnazione dell’avviso stesso. Per il contribuente che ha ricevuto l’accertamento, il focus immediato è il rispetto dei 60 giorni per ricorrere; questioni di prescrizione possono eventualmente rilevare più tardi, se il Fisco tenta il recupero a distanza di molti anni.
Come e quando impugnare l’avviso: termini di ricorso e procedimento
Vediamo ora cosa deve fare in concreto il contribuente che intenda impugnare un avviso di accertamento. La procedura di ricorso tributario è regolata dal D.Lgs. 546/1992 (come modificato dalle riforme più recenti). I passi fondamentali sono:
- Valutazione iniziale e tempi – Dal momento in cui riceve l’avviso, il contribuente ha 60 giorni di tempo per decidere il da farsi. Entro questo termine può eventualmente chiedere chiarimenti all’Ufficio, valutare con un professionista i motivi di ricorso e verificare se esistono alternative (ad esempio, accertamento con adesione o acquiescenza con sanzioni ridotte). Allo scadere del 60° giorno dalla notifica, l’avviso diventa definitivo se non è stato impugnato. Dunque 60 giorni è il termine perentorio per notificare il ricorso. È importante sapere che i termini che scadono in certi periodi possono slittare: esiste la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. 742/1969), quindi un ricorso il cui termine ricade ad agosto beneficia di un’estensione di 31 giorni. Ad esempio, per un avviso notificato il 10 luglio, i 60 giorni cadrebbero il 8 settembre, ma togliendo agosto in mezzo il termine effettivo slitta al 8 ottobre. Inoltre, se il termine scade di sabato o giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Queste regole generali vanno tenute a mente nel calcolo dei 60 giorni.
- Redazione del ricorso – Il ricorso tributario è un atto introduttivo di giudizio, in forma di atto scritto, con cui il contribuente (detto ricorrente) chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Provinciale) di annullare, in tutto o in parte, l’avviso di accertamento. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
- Le generalità del contribuente ricorrente e dell’eventuale difensore incaricato (con indicazione della procura alle liti).
- L’ente impositore convenuto in giudizio (es.: “Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di …” o “Comune di …, Ufficio Tributi”).
- Gli estremi dell’atto impugnato (numero e data dell’avviso, importi, anno d’imposta) e l’oggetto della controversia (es.: impugnazione avviso IRPEF 2019).
- I motivi di ricorso, cioè l’esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto per cui si chiede l’annullamento. Qui si articolano tutti i vizi riscontrati: ad esempio “violazione di legge e difetto di motivazione” se l’avviso non è chiaro; “erronea applicazione di aliquota IVA” se c’è un errore di calcolo; “infondatezza nel merito” contestando le riprese fiscali; eccezioni procedurali (mancato contraddittorio, decadenza, notifica nulla, ecc.). È fondamentale essere specifici: ogni motivo va delineato con riferimento a fatti e norme.
- L’indicazione del valore della controversia, pari all’importo del tributo principale contestato (senza interessi e sanzioni) – se si impugnano anche sanzioni autonome, queste fanno parte del valore. Il valore serve, tra l’altro, a determinare il contributo unificato da pagare (vedi oltre) e la possibilità di stare in giudizio da soli se entro €3.000.
- La richiesta al giudice (“conclusioni”) di accogliere il ricorso e annullare l’atto (integralmente o parzialmente), con eventuale condanna alle spese dell’ente impositore.
- Notifica del ricorso all’ente – Il ricorso va notificato all’Ufficio che ha emesso l’avviso, entro il 60° giorno. La notifica può avvenire in vari modi:
- Via PEC (Posta Elettronica Certificata): oggi è la forma ordinaria per i difensori. Il ricorso firmato digitalmente viene inviato tramite PEC all’indirizzo PEC istituzionale dell’ente impositore (reperibile da registri pubblici). È il metodo più rapido e sicuro, obbligatorio per i professionisti abilitati al PTT (Processo Tributario Telematico).
- A mezzo posta: è possibile per chi non ha l’obbligo PEC. Si spedisce il ricorso in plico senza busta raccomandato con ricevuta di ritorno all’Ufficio competente. Fa fede la data di spedizione.
- Consegna diretta o tramite Ufficiale giudiziario: opzioni meno comuni. L’Ufficiale giudiziario può notificare l’atto all’ente; oppure, se il ricorrente è senza difensore (ammesso solo nelle cause minori, v. sotto), può personalmente consegnare il ricorso a mano presso l’ente che rilascia ricevuta.
- Costituzione in giudizio (deposito del ricorso) – Dopo aver notificato il ricorso alla controparte, il contribuente deve procedere alla costituzione in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado competente. Questo consiste nel depositare telematicamente il ricorso (con la prova dell’avvenuta notifica, es. la ricevuta PEC o la cartolina postale) e gli allegati, attraverso il SIGIT – il portale del processo tributario telematico. Dal 2024 la costituzione avviene solo con modalità telematica per tutti, difensori e contribuenti, salvo i casi di esonero dall’assistenza tecnica. In passato era prevista la possibilità di deposito cartaceo se si notificava in modo cartaceo, ma le nuove norme (D.Lgs. 119/2018 e D.Lgs. 220/2023) hanno di fatto reso obbligatorio l’uso degli strumenti telematici per iscrivere a ruolo il ricorso. Il termine per la costituzione è di 30 giorni dalla data di perfezionamento della notifica del ricorso. Importante novità: con l’eliminazione del reclamo-mediazione nel 2024, non vi è più il prolungamento a 90+30 giorni per il deposito. Ora in tutti i casi il ricorso va depositato entro 30 giorni dalla notifica alla controparte. Dunque, ad esempio, se si notifica il ricorso il 1° settembre 2025, bisogna depositarlo entro il 1° ottobre 2025. Il deposito si effettua caricando tramite il portale PTT una “busta telematica” contenente: il ricorso firmato digitalmente, la relata di notifica (o ricevuta PEC), la copia dell’atto impugnato, gli allegati di prova, la nota di iscrizione a ruolo (NIR) compilata con i dati della causa. Il sistema genererà data e ora di deposito. Se tutto è corretto, la Segreteria della CGT assegnerà un numero di RG (registro generale) alla causa. Mancata costituzione entro 30 giorni: attenzione, se il ricorrente non deposita il ricorso nei termini, il ricorso si considera improcedibile (come se non fosse mai stato proposto). I termini di notifica e deposito sono quindi entrambi essenziali: 60 giorni per notificare, 30 giorni per costituirsi. Nota: Solo nel caso di ricorrente senza difensore e notifica cartacea è tuttora ammesso il deposito in modalità analogica (cartacea) presso la segreteria della CGT, allegando la documentazione in copia. Tuttavia, anche in tali casi il MEF sta incentivando l’utilizzo del telematico tramite l’assistenza dei propri uffici.
- Pagamento del contributo unificato (CU) – Come per tutte le cause civili, anche il processo tributario richiede il versamento di un contributo unificato il cui importo dipende dal valore della lite. Si paga un F23/ pagoPA con codice tributo e lo si allega al ricorso. Ad esempio: per liti fino a €3.000 CU di €30; fino a 20.000 è €60; fino a 50.000 è €120; e così via fino a €1.500 per liti oltre 200.000. La mancata prova di pagamento del CU non comporta immediata inammissibilità, ma la Segreteria chiederà la regolarizzazione; in caso di inottemperanza, il ricorso può essere dichiarato improcedibile.
- Fase processuale – Una volta iscritto a ruolo, il processo tributario si svolge secondo il rito proprio: l’ente resistente (Agenzia Entrate, Comune, Dogane, ecc.) deve costituirsi entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, depositando il memoriale difensivo (controdeduzioni) e gli atti a sostegno (es. il PVC, ecc.). Il processo è prevalentemente scritto, ma ciascuna parte può chiedere la pubblica udienza. In assenza di richiesta, la CGT può decidere la causa in camera di consiglio (senza presenza delle parti) sulla base degli atti depositati. Se invece viene tenuta l’udienza, di norma il difensore del contribuente svolge una discussione orale di sintesi e il collegio giudicante (di regola composto da 3 giudici tributari) decide la causa, spesso in un secondo momento, emettendo la sentenza. Le sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado vengono depositate in genere entro 1-3 mesi dalla discussione (a volte più a lungo, dipende dal carico di lavoro).
- Esito e comunicazione della sentenza – La sentenza viene comunicata alle parti. Se il ricorso è accolto, l’avviso di accertamento viene annullato (in tutto o in parte) e il contribuente vittorioso potrà ottenere lo sgravio o rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso. Se è respinto, l’accertamento è confermato e le somme diventano dovute (salvo appello). In caso di accoglimento parziale, la tassa viene rideterminata. Il giudice decide anche sulle spese di lite: frequentemente in base al principio di soccombenza chi perde paga le spese legali (oppure può disporre la compensazione, specialmente se la materia era incerta). Dal 2023, grazie all’introduzione dell’immediata esecutività delle sentenze di primo grado (art. 67-bis D.Lgs. 546/92), una sentenza favorevole al contribuente è provvisoriamente esecutiva, il che significa che l’ente dovrebbe attivarsi per sgravare o rimborsare senza attendere l’esito finale. In pratica, se Tizio vince in primo grado l’annullamento dell’accertamento, le somme richieste diventano inesigibili immediatamente; qualora avesse già versato (es. il terzo in pendenza di giudizio), ha diritto al rimborso. Se l’ente non ottempera, il contribuente può avviare il giudizio di ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. 546/92 davanti alla CGT per costringerlo all’esecuzione. D’altro canto, se è il contribuente a perdere, l’ente può riprendere la riscossione (ad esempio, dopo sentenza di primo grado sfavorevole l’Agenzia Entrate Riscossione può esigere intanto il doppio di quanto riscosso provvisoriamente, vedi oltre).
Effetti del ricorso sulla riscossione: sospensione e pagamento provvisorio
Proporre ricorso non sospende automaticamente l’obbligo di pagamento dell’avviso. In base alla normativa (art. 19 D.Lgs. 472/97 e art. 68 D.Lgs. 546/92), durante la pendenza del giudizio il contribuente è comunque tenuto a pagare in parte le somme accertate, a titolo provvisorio, salvo ottenere una sospensione. Precisamente:
- Se il contribuente impugna l’avviso entro 60 giorni, non deve pagare l’intero importo immediatamente, ma è tenuto a versare il 1/3 delle imposte accertate (oltre ai relativi interessi) entro il termine di presentazione del ricorso. Questa è la cosiddetta riscossione frazionata: l’ente potrà iscrivere a ruolo provvisoriamente solo un terzo del tributo in contestazione. Il pagamento di questo importo evita misure cautelari immediate su tale quota. Se il contribuente non versa spontaneamente il terzo, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può comunque avviare la riscossione coattiva per quel terzo anche pendente causa.
- Dopo la sentenza di primo grado: se la CGT respinge il ricorso, l’ente può riscuotere altri 2/3 (arrivando quindi ai 2/3 del tributo) in attesa dell’esito dell’eventuale appello. Se anche la sentenza d’appello è sfavorevole al contribuente, si può riscuotere il residuo (fino al 100%). Queste regole garantiscono che il contribuente paghi gradualmente mano a mano che perde nei vari gradi, mentre se vince ha diritto alla restituzione di quanto versato in eccedenza.
- Se il contribuente non fa ricorso entro 60 giorni, deve pagare tutto: trascorso inutilmente il termine di impugnazione, l’avviso diviene definitivo e l’intera somma (100% del tributo + sanzioni intere + interessi) è dovuta. L’ente iscriverà a ruolo l’importo e, dopo aver notificato una intimazione di pagamento, potrà procedere con esecuzione forzata.
Sospensione giudiziale: il contribuente che ritiene di subire un danno grave e irreparabile dall’esecuzione dell’atto impugnato (ad esempio, una richiesta molto elevata che potrebbe portarlo al fallimento prima della fine del processo) può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto. Questa istanza di sospensiva va presentata con un’istanza motivata, di solito già nel ricorso o con atto separato, evidenziando il periculum (il danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (ossia che il ricorso non è pretestuoso ma presenta valide ragioni di fondatezza). La Corte di Giustizia Tributaria decide sulla sospensione in tempi brevi, con ordinanza. Di regola, l’istanza viene discussa in camera di consiglio entro 30–60 giorni dal deposito. Se accoglie la richiesta, la CGT sospende l’efficacia esecutiva dell’avviso fino alla decisione di merito (o per un periodo definito), bloccando la riscossione. Se la rigetta, l’atto resta esecutivo. L’ordinanza collegiale sulla sospensione è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 15 giorni. In caso di esito negativo, comunque, il merito del ricorso sarà deciso più avanti: la sospensione è solo un rimedio cautelare. Va sottolineato che la sospensione viene concessa solo in presenza di circostanze eccezionali di gravità: il semplice “fastidio” di pagare non basta, occorre dimostrare che il pagamento integrale causerebbe un danno serio (es. mettere a repentaglio la continuità aziendale, oppure portare una persona a dover vendere la casa, etc.). Se concessa, la sospensione tutela il contribuente dall’azione esecutiva (nessuna cartella né fermi amministrativi nel frattempo). Se negata, il contribuente può valutare di pagare almeno il terzo provvisorio per evitare aggravio di interessi e ulteriori azioni.
Sospensione amministrativa (in autotutela): indipendentemente dal giudice, l’ente impositore può volontariamente sospendere la riscossione dell’atto in via amministrativa, ad esempio se il contribuente presenta un’istanza di autotutela (vedi oltre) con elementi convincenti. L’art. 15 del DPR 602/1973 consente all’ufficio finanziario di sospendere la cartella/accertamento in casi particolari (ad esempio quando riconosce un probabile errore). Tuttavia, questa è una facoltà discrezionale e non interrompe i termini per il ricorso.
Caso dei dazi doganali: in ambito doganale, la regola UE è che il ricorso non sospende l’obbligo di pagare i dazi contestati, salvo che l’autorità (Agenzia delle Dogane) decida di sospendere l’esecuzione se vi sono fondati motivi per ritenere l’atto illegittimo o timore di un danno irreparabile. In pratica, spesso all’importatore è richiesto di prestare una garanzia (fideiussione) per ottenere la sospensione dell’esazione dei dazi in pendenza di ricorso. Se non offre garanzie, potrebbe dover pagare e poi chiedere rimborso in caso di esito favorevole. Questa disciplina peculiare è prevista dagli artt. 44–45 del Codice Doganale dell’Unione.
Reclamo e mediazione tributaria (aboliti dal 2024)
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma del processo tributario (D.Lgs. 130/2022 e attuativi) riguarda l’istituto del reclamo-mediazione. Fino al 2023, per le controversie di valore non eccedente €50.000 era obbligatorio, prima di andare in giudizio, presentare un reclamo all’ente impositore, contenente eventualmente una proposta di mediazione. Era un passaggio deflativo pensato per tentare di risolvere bonariamente le liti minori: si presentava il ricorso come reclamo e l’Ufficio aveva 90 giorni per eventualmente accoglierlo (annullare l’atto in tutto o parte) o proporre un accordo di mediazione, spesso consistente in una riduzione delle sanzioni (ridotte al 35% del minimo in caso di accordo mediato). Se entro 90 giorni non si trovava un accordo, il ricorso poteva essere proceduto davanti al giudice entro i 30 giorni successivi. Questa procedura non è più in vigore per i nuovi ricorsi:
– Abrogazione dal 2024: Il D.Lgs. 31 dicembre 2023 n. 220 ha eliminato l’obbligo del reclamo-mediazione per gli atti notificati dal 1° gennaio 2024 in poi. In base all’art. 2 co.1 di tale decreto, per i ricorsi notificati dal 2024 il contribuente può adire direttamente il giudice tributario entro 60 giorni, senza dover esperire preventivamente il reclamo. Cessa dunque quella sospensione di 90 giorni che prolungava i tempi. Transitorio: per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 si continuano ad applicare le vecchie disposizioni (art. 17-bis D.Lgs. 546/92); dal 4 gennaio 2024 in avanti, il reclamo obbligatorio è abrogato. In pratica, nel 2024 c’è stata una fase transitoria: i ricorsi notificati nei primissimi giorni dell’anno ancora soggetti (perché l’abolizione entrava in vigore il 4/1/24), ma la differenza è minima. Dall’1 settembre 2024 è comunque tutto a regime.
– Effetti pratici: la soppressione del reclamo significa che non bisogna più attendere 90 giorni prima di depositare il ricorso. Come detto, ora vi è un unico termine di 30 giorni dalla notifica per iscrivere a ruolo. Ciò snellisce la procedura e accorcia i tempi per ottenere giustizia. Di contro, viene meno la possibilità di ottenere lo sconto del 35% sulle sanzioni che prima era concesso se la lite si chiudeva in mediazione con esito favorevole all’ente. Adesso, il contribuente che vuole un taglio delle sanzioni deve valutare altri strumenti (adesione, conciliazione giudiziale, ecc., ne parliamo oltre). Non c’è più l’obbligo di formulare una proposta conciliativa nel ricorso: dal 2024 il ricorso introduttivo può andare dritto al merito, senza la sezione “reclamo” e “proposta di mediazione” che prima si era soliti inserire.
– Valore di €50.000: ricordiamo che la mediazione era limitata alle liti fino a 50.000 euro. Oggi quella soglia rimane significativa solo per un istituto simile nel processo civile (mediazione civile) che però non si applica al tributario. Nel tributario l’unica soglia rilevante è quella dei €3.000 per l’auto-rappresentanza; per il resto, anche una lite da 1.000 euro segue ora lo stesso iter di una da 1 milione (fermo restando l’ovvia differenza di organi competenti in appello, ecc.).
– Possibilità di accordo bonario anche senza mediazione: l’abrogazione non preclude comunque che l’Ufficio e il contribuente possano accordarsi prima o dopo la causa. Ad esempio, l’ente può ancora accogliere in autotutela un buon reclamo facoltativo presentato dal contribuente, oppure durante il processo si può raggiungere una conciliazione (vedi conciliazione giudiziale più avanti). Semplicemente, non c’è più un procedimento strutturato di mediazione obbligatoria gestito dall’ente. Secondo le statistiche, la mediazione obbligatoria spesso si risolveva in un nulla di fatto o in un allungamento dei tempi (pochissimi accordi transattivi venivano conclusi in quella sede), per questo il legislatore ha scelto di eliminarla. Da notare che il ricorso presentato come reclamo entro il 2023 se non definito in mediazione si perfezionava come ricorso giurisdizionale dopo 90 giorni; quei casi residui in cui un reclamo 2023 è divenuto ricorso 2024 sono ora in corso ma destinati ad esaurirsi col tempo.
Esempio (mediazione nel 2023 vs 2025): Caio riceve a novembre 2023 un avviso TARI da €5.000. Nel gennaio 2024 propone reclamo-mediazione (poiché la legge previgente lo imponeva ancora per quell’atto notificato nel 2023). L’ufficio entro aprile 2024 può accogliere parzialmente riducendo le sanzioni e chiudendo la lite, oppure non rispondere; in tal caso Caio dovrà perfezionare il deposito del ricorso entro 30 gg dallo scadere dei 90. – Viceversa, Sempronio riceve a marzo 2024 un accertamento IRPEF da €20.000: in questo caso (atto notificato nel 2024) non deve fare alcun reclamo; notificherà direttamente il ricorso all’AE entro 60 gg e depositerà entro 30 gg. Se lo desidera, potrà allegare al ricorso una proposta transattiva, ma non è obbligatoria e la causa seguirà comunque il suo corso senza attendere 90 giorni.*
In conclusione, dal 2024 il processo tributario di primo grado parte immediatamente col ricorso, senza filtri amministrativi obbligatori. Ciò comporta per il contribuente la necessità di essere ben preparato sin dall’inizio (non c’è più la “finestra” dei 90 giorni per magari integrare motivi o discutere con l’ufficio). È consigliabile presentare un ricorso completo e approfondito da subito.
Accertamento con adesione (definizione concordata dell’accertamento)
L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo del contenzioso che consente al contribuente di “definire” l’avviso di accertamento trovando un accordo con l’Ufficio, con benefici sulle sanzioni. Diversamente dalla mediazione (che comunque presupponeva un ricorso), l’adesione è un procedimento amministrativo che si svolge su iniziativa del contribuente (o dell’ufficio) e può concludersi con un atto di adesione, cioè un vero e proprio accordo transattivo fiscale. La disciplina base è nel D.Lgs. 218/1997, ma è stata innovata nel 2023/24 per coordinarla col nuovo contraddittorio obbligatorio. Ecco come funziona:
Presupposti: si può attivare l’adesione per la generalità dei tributi accertati dall’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, IVA, registro, ecc.) e, facoltativamente, anche per tributi locali se previsto dai regolamenti comunali (molti comuni lo consentono per IMU, TARI, etc, su base volontaria). Non è invece applicabile per sanzioni amministrative non collegate a tributi o per atti della riscossione. Si distingue tra:
- Adesione prima dell’avviso: se il contribuente è oggetto di una verifica fiscale o riceve un PVC (processo verbale di constatazione) o un invito al contraddittorio su cui ancora non è stato emesso l’avviso, può chiedere di avviare l’adesione su quelle risultanze, evitando che esca un avviso formale. In genere l’ufficio invita a comparire il contribuente e, se raggiungono un accordo, emette direttamente un atto di accertamento con adesione (saltando l’emissione dell’avviso “ordinario”). Questa fase è spesso discrezionale e legata agli esiti della verifica.
- Adesione dopo la notifica dell’avviso: se il contribuente ha già ricevuto un avviso di accertamento (non preceduto da adesione), può comunque chiedere di essere ammesso alla procedura di adesione entro il termine di impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’avviso). In sostanza, anziché presentare subito ricorso, il contribuente presenta un’istanza in carta libera all’ufficio, dichiarando di voler aderire e indicando eventualmente i punti su cui chiede revisione. Questa istanza sospende il termine per fare ricorso per 90 giorni. L’Ufficio, ricevuta l’istanza, deve convocare il contribuente entro 15 giorni per un incontro di contraddittorio. Durante l’incontro (o più incontri) le parti discutono e possono concordare una riduzione di imponibile o sanzioni. Se trovano l’accordo, viene redatto un atto di accertamento con adesione che il contribuente e il funzionario firmatari sottoscrivono.
Benefici dell’adesione: In caso di accordo, le sanzioni vengono ridotte a 1/3 di quelle minimo per legge (o di quelle irrogate). Inoltre, il contribuente può chiedere una rateazione fino a 8 rate trimestrali (ovvero 16 rate se l’importo supera 50.000 €). L’accordo si perfeziona con il pagamento (entro 20 giorni) dell’intero importo concordato ovvero della prima rata + presentazione di garanzia per le restanti. Una volta perfezionato, l’adesione chiude la partita: l’atto di adesione sostituisce l’avviso, che perde efficacia. È importante evidenziare che l’adesione non comporta mai un aumento dell’imposta rispetto all’avviso: al più il contribuente ottiene un abbattimento parziale; dunque male che vada confermerà il dovuto come da avviso (non rischia un importo maggiore attraverso adesione).
Relazione con il ricorso: se si firma l’accertamento con adesione, il contribuente rinuncia al ricorso. Non è ammesso infatti impugnare in seguito l’avviso originario una volta concluso l’accordo. La Cassazione ha affermato chiaramente che la sottoscrizione dell’adesione non attribuisce alcun ius poenitendi al contribuente: non può prima aderire e poi ripensarci per fare causa. In particolare, l’ordinanza Cass. n. 26618/2024 ha stabilito che la semplice firma dell’atto di adesione preclude l’impugnazione dell’avviso accertato, rendendo inammissibile un successivo ricorso. Questo perché l’accordo di adesione “cristallizza” definitivamente il rapporto tributario, escludendo la possibilità di contestarlo in giudizio. Coerentemente, l’art. 6 del D.Lgs. 218/97 già prevedeva che la presentazione del ricorso implica rinuncia all’istanza di adesione e viceversa il perfezionamento dell’adesione fa decadere l’avviso. Dunque, se si perfeziona l’accordo, non si può più fare ricorso. Se però non si perfeziona, il contribuente mantiene il diritto di impugnare l’avviso.
Esiti dell’adesione: possiamo avere tre casi:
- Adesione perfezionata: l’accordo è firmato e il contribuente paga nei termini. L’avviso originario è definito e non impugnabile. Le somme concordate dovranno essere versate (subito o rate) e il contribuente beneficia dello sconto sanzioni a 1/3. Se in futuro non paga le rate, quelle somme saranno riscosse coattivamente, ma non può riaprire la discussione sull’an o quantum dovuto.
- Adesione non perfezionata: il contribuente magari sottoscrive l’accordo ma non paga nei 20 giorni, oppure presenta istanza di adesione ma non si raggiunge alcun accordo entro i 90 giorni (per inerzia o disaccordo). In tal caso l’adesione salta e l’avviso originario rimane pienamente valido. Il contribuente a quel punto deve affrettarsi a impugnare l’avviso nei termini (nel calcolo si consideri la sospensione di 90 giorni, che comunque opera anche se l’accordo non è stato concluso). Se non lo fa, l’avviso diverrà definitivo trascorsi i 90 gg + residuo. Chi aderisce ma poi fa ricorso, perde il beneficio delle sanzioni ridotte: qualora la causa abbia esito negativo, le sanzioni tornano nella misura piena iniziale. Lo stesso se il ricorso viene accolto parzialmente: il giudice ricalcola imposta e sanzioni senza tener conto dello sconto che era legato all’adesione (ormai saltata). In pratica, tentare l’adesione e poi litigare senza successo può comportare un costo sanzionatorio maggiore rispetto a non aver aderito affatto (perché si era ottenuto uno sconto solo teorico, poi perso).
- Mancata richiesta di adesione: il contribuente può anche scegliere di non attivare l’adesione, se ritiene l’accertamento totalmente infondato o non vuole alcun accordo. In tal caso nulla cambia: dovrà proporre ricorso entro 60 giorni (senza la sospensione). L’avviso seguirà l’iter contenzioso ordinario. Va però evidenziato che la riforma 2023/24 ha introdotto un’interazione tra adesione e contraddittorio: se l’avviso era preceduto dallo schema di atto (contraddittorio obbligatorio), il contribuente ha già avuto una chance di confronto. In tale scenario, se riceve l’avviso definitivo e decide di chiedere adesione, deve farlo entro 15 giorni e ottiene solo 30 giorni di sospensione per il ricorso. Questo per incentivare a trovare l’accordo già prima (durante il contraddittorio). Se invece l’atto non era soggetto a contraddittorio preventivo (pochi casi, come urgenze), allora l’avviso conterrà l’invito all’adesione e il contribuente avrà i soliti 60 giorni per chiederla, con sospensione di 90 giorni.
Novità 2024 sull’adesione: Il D.Lgs. 12/2024 (riforma del procedimento di accertamento) ha rimodellato l’adesione. In sintesi: per atti con contraddittorio obbligatorio, l’invito a presentare adesione è ora inserito già nella lettera di invito a comparire; il contribuente può manifestare volontà di aderire entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. Se lo fa, l’ufficio e contribuente possono chiudere in adesione prima che esca l’avviso definitivo. Se invece dopo il contraddittorio l’ufficio emette comunque l’avviso (mantenendo la pretesa) e il contribuente cambia idea e vuole aderire a quel punto, deve fare richiesta entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso e, come detto, in tal caso la sospensione del termine per ricorrere è ridotta a 30 giorni (in luogo di 90). Questa riduzione serve a evitare che si allunghi troppo il procedimento: di fatto, chi ha già avuto contraddittorio ha tempi più stringati per l’adesione post-avviso. Resta ferma la sospensione di 90 giorni per gli atti non soggetti a contraddittorio (es. alcuni accertamenti derivanti da controlli automatizzati o formali non inclusi nell’obbligo). Inoltre, il decreto prevede che dopo il contraddittorio l’ufficio in adesione non considererà elementi nuovi rispetto a quelli emersi: il contribuente non può in adesione tirare fuori fatti del tutto nuovi se non li aveva già rappresentati nelle osservazioni del contraddittorio.
Vantaggi e svantaggi dell’adesione: Per il contribuente, aderire significa ridurre le sanzioni (a 1/3) e talvolta strappare anche un abbattimento parziale dell’imponibile, evitando il rischio e i costi del giudizio. È utile in caso di violazioni effettivamente commesse e difficili da difendere in giudizio – con adesione spesso si ottiene una chiusura più conveniente. Di contro, se il contribuente è convinto di avere ragione piena, l’adesione comporta comunque di pagare qualcosa (è difficile che l’ufficio in adesione annulli tutto). Inoltre, aderendo si rinuncia alla possibilità di far valere in giudizio eventuali questioni di legittimità (vizi formali, eccezioni procedurali). In pratica si “patteggia” l’imposta. È sempre una valutazione caso per caso. Per l’Ufficio, l’adesione è vantaggiosa perché incassa prima e sicuro, anche se un po’ meno. Ecco perché spesso la proposta di adesione viene dallo stesso Ufficio (invito a comparire).
Esempio pratico: Alfa Srl riceve un avviso di accertamento per IRES 2021: l’Agenzia contesta costi indeducibili per €100.000, con maggiore imposta €24.000 e sanzioni 100% (€24.000). Alfa ritiene che una parte dei costi siano effettivamente indeducibili, ma non tutti. Decide di presentare istanza di adesione. Nel contraddittorio con l’ufficio, emerge un possibile accordo: vengono riconosciuti €30.000 di costi in più (quindi imponibile ridotto), la maggiore imposta scende a €16.800, con sanzione ridotta al 1/3 del minimo (diciamo €5.600). L’accordo viene formalizzato e Alfa paga €22.400 (imposta + sanzione ridotta) invece di rischiare in giudizio €24.000 + €24.000 sanzioni. Se Alfa paga la prima rata e garantisce le successive, l’adesione è perfezionata; l’avviso originario è annullato e non ci sarà processo.*
Altri strumenti deflativi: acquiescenza, conciliazione, autotutela
Oltre all’accertamento con adesione, l’ordinamento prevede altri strumenti per evitare o chiudere la lite in modo agevolato, dal punto di vista del contribuente. Vediamo i principali.
Acquiescenza all’accertamento
L’acquiescenza è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. 218/1997. Consiste nella accettazione integrale dell’avviso da parte del contribuente, il quale si astiene dal fare ricorso e provvede a pagare quanto richiesto entro il termine per impugnare (60 giorni). In cambio, la legge concede una riduzione delle sanzioni ad un terzo. In pratica, il contribuente che “prende atto” dell’accertamento e paga subito viene premiato con sanzioni ridotte al 1/3 delle somme irrogate. Spesso nell’avviso stesso l’Agenzia delle Entrate evidenzia l’importo ridotto da versare in caso di definizione in acquiescenza (ad es. “se paghi entro 60 giorni, sanzioni ridotte a 1/3 = tot euro”).
Modalità: per perfezionare l’acquiescenza occorre pagare tutto l’importo richiesto (imposta + interessi) e le sanzioni ridotte a un terzo entro i 60 giorni. Non è ammessa rateazione (a differenza dell’adesione); bisogna pagare in un’unica soluzione. Inoltre, va rinunciato al ricorso. Non serve inviare comunicazioni particolari all’ufficio: sarà l’ufficio stesso a prendere atto del pagamento e, decorso il termine, a non iscrivere a ruolo le sanzioni restanti.
Effetti: pagando con acquiescenza, l’avviso si considera definito e non più impugnabile. Il contribuente rinuncia al contenzioso e “cristallizza” il debito nell’importo agevolato. Se dovesse successivamente cambiare idea, non potrà ricorrere (il pagamento eseguito con lo sconto è considerato accettazione). L’ente dal canto suo rinuncia a perseguire le sanzioni piene.
L’acquiescenza conviene quando il contribuente riconosce la fondatezza (integrale) dell’accertamento o comunque valuta che una contestazione avrebbe poche chance e costi alti: in tal caso, pagare subito con 2/3 di sanzioni risparmiate è preferibile. Ad esempio, in un avviso con €10.000 di imposta e €6.000 di sanzioni (60%), pagare in acquiescenza significa versare €10.000 + €2.000 (1/3 di 6.000) + interessi, invece di rischiare di pagarne €16.000 più interessi dopo anni. In genere, se ci sono motivi anche parziali di contestazione, si può preferire l’adesione (per trattare uno sconto anche sul merito) o il ricorso.
Differenza con adesione: nell’adesione c’è trattativa sul merito, in cui magari l’ufficio riconosce qualcosa; nell’acquiescenza no, si accetta tutto com’è. Quindi l’acquiescenza ha senso solo se l’ufficio “ha ragione” su tutto oppure se lo sconto 2/3 sanzioni è comunque un buon compromesso e non si vuole spendere in cause. Da notare che adesione e acquiescenza non sono cumulabili: o si fa l’una o l’altra. Se il contribuente presenta istanza di adesione, quel solo fatto impedisce l’acquiescenza integrale (perché è come manifestare dissenso). Viceversa, se paga in acquiescenza non può poi chiedere adesione.
Procedura: il contribuente effettua i versamenti (modello F24 con codici tributo specifici) e poi normalmente comunica all’ufficio di aver pagato chiedendo lo sgravio di eventuali importi a ruolo. Ma anche se non lo comunica, conta il pagamento tempestivo. Non occorre un atto formale di accettazione: il pagamento vale come acquiescenza.
Conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è la possibilità di definire la lite dopo l’instaurazione del processo, con un accordo tra contribuente ed ente sottoposto all’approvazione del giudice. È regolata dagli artt. 48 e 48-bis D.Lgs. 546/92. Può avvenire sia in primo grado sia in appello (con sanzioni ridotte diverse). In pratica, durante la pendenza del giudizio, le parti possono trovare un compromesso: il contribuente accetta di pagare una parte della pretesa (o l’intero tributo senza sanzioni), l’ente riduce o annulla sanzioni e/o importi. L’accordo viene formalizzato in un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e ratificato dal collegio giudicante con decreto o sentenza.
Beneficio sulle sanzioni: la conciliazione comporta per legge una riduzione delle sanzioni al: 40% del minimo se la conciliazione avviene in primo grado, 50% in secondo grado (e la riforma 2022 ha previsto 60% se in Cassazione, per i casi di rinvio). Ciò significa, ad esempio, che se la sanzione sarebbe minimo 100, col patteggiamento in primo grado se ne paga 40. Questo incentivo è meno generoso dell’adesione (dove si paga 33%), ma rimane interessante. Le parti possono anche accordarsi sulla rateazione (max 8 rate in primo grado, 6 in appello). La conciliazione chiude la lite su tutti i punti oggetto di accordo, e la sentenza di conciliazione è inoppugnabile (tranne che per l’eventuale parte non conciliata, se l’accordo è parziale).
Conciliazione su invito del giudice: Novità del 2023 (D.Lgs. 130/2022) è che il giudice di primo grado può farsi promotore di proposta conciliativa (specie nelle liti sotto €50.000, ora che non c’è più mediazione), invitando le parti a trovare un accordo. Questo per potenziare lo strumento.
In pratica, la conciliazione è poco usata in passato, ma potrebbe divenire più frequente. Ad esempio, a processo avviato, l’ufficio – valutate le difese del contribuente – potrebbe offrire di abbandonare metà delle pretese se il contribuente paga il resto. Il contribuente, assicurandosi anche il taglio sanzioni al 40%, potrebbe accettare. Si redige verbale, il giudice emette decreto di estinzione. Fine del processo, con risparmio reciproco di tempo e costi.
Quando conviene? Quando emergono in giudizio elementi nuovi o più chiari che lasciano spazio a un compromesso. Spesso all’inizio le posizioni sono rigide; dopo la fase istruttoria potrebbe darsi che né l’ufficio né il contribuente siano sicuri al 100% della vittoria, quindi si “incontrano a metà strada”. La conciliazione è utile anche se il contribuente vuole evitare l’appello: chiudendo al 40% sanzioni in primo grado può evitare rischi di peggiorare in secondo.
Autotutela tributaria (annullamento d’ufficio)
L’autotutela è il potere dell’Amministrazione finanziaria di annullare o rettificare i propri atti quando riconosce che sono illegittimi o errati. È uno strumento diverso dagli altri: non è transazione né sanzione ridotta, ma semplicemente correzione di errori da parte dell’ente stesso, che può avvenire su iniziativa d’ufficio o su istanza del contribuente. Ad esempio, se l’ufficio si accorge (o il contribuente segnala) che un avviso di accertamento presenta un errore evidente (doppia imposizione, persona sbagliata, calcolo sbagliato, sopravvenuta documentazione che prova il contrario, ecc.), può procedere in autotutela ad annullarlo totalmente o parzialmente.
Caratteristiche chiave:
- L’autotutela è tradizionalmente considerata un potere discrezionale dell’amministrazione. Il contribuente non ha un diritto soggettivo all’annullamento, ma solo un interesse legittimo. In pratica può solo chiedere, motivando bene.
- La richiesta di autotutela non sospende né il termine di pagamento né quello per fare ricorso. Ciò è cruciale: se presentate un’istanza di autotutela, comunque dovete valutare di fare ricorso entro 60 giorni, perché se l’ufficio poi non annulla l’atto, rischiate di restare scoperti.
- L’autotutela può essere totale (annullamento integrale dell’avviso) o parziale (rettifica di alcuni errori). Ad esempio, se l’avviso contiene 3 rilievi e uno è palesemente sbagliato, l’ufficio potrebbe annullare quella parte mantenendo il resto. Oppure, se è stato notificato due volte lo stesso tributo per errore, annulla uno dei due atti.
- Di norma, l’autotutela viene esercitata entro i termini di decadenza dell’accertamento (non avrebbe senso oltre, perché comunque l’atto sarebbe invalido). Una volta scaduti i termini, l’ufficio può agire solo in casi eccezionali e comunque non a sfavore del contribuente (principio di autotutela in bonam partem).
Novità normativa (2023/2024): Il D.Lgs. 219/2023 ha inserito nello Statuto del contribuente gli articoli 10-quater e 10-quinquies, distinguendo autotutela obbligatoria e facoltativa. In particolare:
- L’autotutela obbligatoria è ora prevista in alcuni casi tassativi di vizi rilevanti, in cui l’ufficio deve procedere all’annullamento d’ufficio entro un certo termine. Ad esempio, se ci sono doppie imposizioni sul medesimo presupposto, oppure errori evidenti riconosciuti, l’ufficio ha l’obbligo di annullare in autotutela. Questo obbligo però cessa se l’atto è divenuto definitivo da oltre un anno o se c’è una sentenza passata in giudicato a favore del fisco. Quindi l’ufficio non è tenuto a rimuovere gli atti viziati all’infinito: c’è un limite temporale (1 anno dalla definitività) e non opera in presenza di giudicato. L’introduzione dell’autotutela obbligatoria è significativa perché trasforma in dovere quello che era una facoltà, almeno per vizi gravi.
- L’autotutela facoltativa (art. 10-quinquies) rimane per tutti gli altri casi in cui l’ente può intervenire se lo ritiene opportuno, per ragioni di economicità, equità, ecc. Qui resta la discrezionalità piena.
In ogni caso, se il contribuente presenta istanza di autotutela, l’ente è ora tenuto a fornire una risposta (espressa) entro determinati termini, soprattutto nei casi obbligatori. E la novità ulteriore è che il contribuente può impugnare il diniego di autotutela (espresso o tacito) se ricorrono le condizioni dell’obbligatorietà. In passato la giurisprudenza escludeva la possibilità di impugnare il rifiuto di autotutela, ora invece l’art. 10-quater prevede esplicitamente che il contribuente può ricorrere contro il diniego di autotutela obbligatoria. Questo apre la strada a un controllo giudiziale sull’operato dell’ufficio in questi casi. Resta invece non impugnabile il rifiuto di autotutela facoltativa (essendo atto non dovuto).
Rapporto con il ricorso: come detto, l’autotutela non ferma il termine del ricorso. Una buona prassi può essere: se si riscontra un errore manifesto, inviare subito un’istanza di autotutela dettagliata all’ente e contemporaneamente preparare il ricorso, che potrà essere presentato sul filo dei 60 giorni solo se l’ente non annulla nel frattempo. Se l’ente annulla completamente l’atto prima, il ricorso diventa inutile. Se l’ente annulla parzialmente, il ricorso potrà riguardare la parte residua. E se l’ente rigetta l’istanza, si proseguirà col contenzioso. In sede di giudizio, il fatto di aver invocato inutilmente l’autotutela può essere menzionato (anche ai fini delle spese).
Esempi di situazioni tipiche di autotutela: errori di persona (avviso intestato al cod.fiscale sbagliato), errori di calcolo aritmetico evidenti, doppia imposizione dello stesso reddito (due uffici tassano la stessa cosa), errore sul presupposto (es. tassa su immobile che non è del contribuente). In questi casi spesso l’ufficio stesso preferisce annullare perché sa che in giudizio perderebbe di sicuro.
Attenzione: l’autotutela in “mala partem” (peggiorativa) è ammessa? Cioè l’ufficio può annullare un atto viziato per emetterne uno nuovo con pretesa maggiore? La Cassazione a Sezioni Unite nel 2024 (sent. 30051/2024) ha affermato di sì: se l’atto originario è viziato, l’ufficio può annullarlo e sostituirlo con uno nuovo più corretto, anche con maggiore pretesa, purché sia nei termini. Ad esempio, se per errore formale l’avviso originario era nullo e sottostimava il dovuto, l’ufficio in autotutela può ritirarlo e farne uno nuovo più “salato” (entro la decadenza). Questa autotutela “sostitutiva” non va confusa con l’accertamento integrativo (che aggiunge pretese senza annullare la prima). Naturalmente, l’atto nuovo sarà impugnabile. Comunque, l’uso dell’autotutela peggiorativa è raro e limitato a situazioni specifiche (la norma tende a tutelare il contribuente, non a consentire al fisco di rimediare ai propri errori in peius senza limiti).
In sintesi, l’autotutela è uno strumento importante: sempre opportuno segnalare all’ufficio gli errori palesi, magari l’atto viene annullato subito evitando il ricorso. Ma non bisogna farci eccessivo affidamento in situazioni dubbie, né lasciarsi trascinare oltre i termini confidando in una risposta che potrebbe non arrivare.
Impugnare accertamenti su tributi locali (IMU, TARI, ecc.)
I tributi locali (come IMU – Imposta Municipale sugli Immobili, TARI – Tassa rifiuti, ICP – imposta pubblicità, COSAP/TOSAP oggi Canone Unico, ecc.) seguono attualmente, quanto a impugnazione, le stesse regole dei tributi erariali. Fino al 2011, infatti, c’era una separazione: alcune controversie locali finivano davanti al giudice ordinario. Ma con il D.Lgs. 150/2011 e D.L. 98/2011 si è attribuita al giudice tributario la competenza su quasi tutti i tributi locali. Dove si impugna quindi un avviso di accertamento IMU o TARI? Davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente (quella relativa alla provincia in cui ha sede l’ente impositore). Ad esempio, per un avviso IMU del Comune di Milano, il ricorso va alla CGT primo grado di Milano. La procedura è identica: 60 giorni per ricorrere, stesso processo telematico, stesse regole di mediazione (ormai abolita) e adesione (possibile se il Comune l’ha prevista).
Elementi specifici degli accertamenti locali:
- Spesso l’avviso di accertamento IMU/TARI deve indicare, oltre agli elementi generali, anche riferimenti a delibere comunali (es. delibera aliquote IMU, regolamento TARI). È importante verificare che le aliquote o tariffe applicate siano quelle giuste e che il Comune le abbia regolarmente approvate e pubblicate. Ad esempio, un ricorrente potrebbe eccepire l’illegittimità dell’aliquota se la delibera comunale è tardiva.
- Per IMU e TARI, frequenti motivi di ricorso sono legati a errori di fatto: immobili non di proprietà in quel periodo, errori catastali, riduzioni TARI non riconosciute, ecc. Bisogna raccogliere la documentazione (visure catastali, certificati di residenza per eventuali agevolazioni prima casa, foto per TARI su aree non utilizzate, ecc.) e allegarla al ricorso.
- IMU – motivazione particolare: la Cassazione ha puntualizzato (es. ord. 29141/2023) che l’avviso IMU è validamente motivato se indica gli elementi essenziali che permettono al contribuente di capire perché deve pagare: ad esempio, l’identificazione degli immobili, la rendita o valore su cui è calcolata l’imposta, l’aliquota applicata, e il confronto con quanto eventualmente versato. Se manca qualcuno di questi elementi (es. l’atto si limita a dire “dovete €X di IMU 2019” senza spiegare come è stato calcolato), c’è vizio di motivazione. Nella pratica, molti avvisi IMU indicano in allegato il dettaglio dei fabbricati, rendite, aliquote e calcolo. Va controllato.
- TARI – superficie e utenze: analogamente, gli avvisi TARI devono specificare gli immobili (indirizzo, metri quadri tassati, categoria d’uso) e le tariffe applicate. Spesso i ricorsi TARI riguardano metrature errate o riduzioni (per compostaggio, per unico occupante, per inutilizzo oltre 6 mesi, ecc.) non concesse. Qui è fondamentale la prova (es. planimetrie, attestati).
Accertamento con adesione per tributi locali: la legge prevede che gli enti locali possano applicare l’istituto in via facoltativa (art. 50 L. 449/1997). Molti comuni si sono dotati di regolamento per l’adesione su IMU, TARI ecc., modellato su quello statale. In pratica, se previsto, il contribuente può chiedere adesione al Comune entro 60 gg dall’avviso (sospende termini 90 gg). Se il Comune non ha proprio previsto l’adesione, non sarà possibile. L’elenco dei comuni che l’hanno introdotta non è centralizzato; bisogna verificare sul sito o regolamento comunale. Ad esempio, il Comune di Roma consente adesione IMU; altri piccoli comuni magari no.
Conciliazione e altri istituti: con la riforma 2022, la conciliazione è possibile anche per tributi locali; inoltre è stato introdotto l’obbligo di contraddittorio anche per questi (dal 2024 tutti gli atti impositivi, inclusi quelli comunali, devono essere preceduti da invito se non urgenti). Ciò comporta che anche i Comuni dovranno adeguarsi inviando avvisi bonari o inviti al contraddittorio prima di notificare l’accertamento, pena l’annullabilità dell’atto. Molti uffici tributi comunali nel 2024 si stanno organizzando: per esempio, prima di fare un accertamento IMU per omessa dichiarazione, manderanno un invito al contribuente a presentare osservazioni.
Conclusione sui tributi locali: dal punto di vista procedurale, impugnare un accertamento locale è sostanzialmente uguale ad un avviso AE: ricorso in 60 gg alla CGT, stessi gradi di giudizio, ecc. Dal punto di vista sostanziale, bisogna conoscere le particolarità del tributo locale (norme specifiche, regolamenti comunali, eventuali obblighi dichiarativi) e le sentenze rilevanti. Ad esempio, la Cassazione ha chiarito che per ICI/IMU il Comune deve motivare indicando i criteri di calcolo del valore (soprattutto se accertamento su aree fabbricabili), e che il contraddittorio è dovuto se dalla normativa (ora comunque obbligatorio per tutti dal 2024).
Esempio: il Comune X notifica nel 2025 a Beta una rettifica IMU 2020 perché, a seguito di un controllo, risulta che Beta non ha pagato l’IMU su un secondo appartamento. Beta ritiene di aver diritto all’esenzione perché quell’appartamento era sf fitto al padre ultrasettantenne (caso di assimilazione prima casa previsto dal Comune). Nel ricorso Beta dovrà evidenziare che l’atto è illegittimo perché l’immobile di via Y andava esente ai sensi dell’art. x del Regolamento comunale (all. copia), e allegare certificato storico di residenza del padre che prova la convivenza. Inoltre, potrebbe eccepire che l’avviso non menziona affatto l’istanza di esenzione presentata a suo tempo – vizio di motivazione. Se il regolamento comunale prevede adesione, Beta potrebbe anche tentare di spiegare queste cose in adesione chiedendo l’annullamento, ma se il Comune rifiuta, andrà in causa.*
Impugnare atti dell’Agenzia delle Dogane (accertamenti doganali)
Anche le controversie doganali (dazi all’importazione, IVA all’importazione, accise, ecc.) rientrano nella giurisdizione tributaria. L’atto tipico è l’avviso di rettifica o di revisione dell’accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane, con il quale si richiedono dazi non pagati o differenze su dichiarazioni doganali già fatte. Oppure l’avviso di pagamento per dazi dovuti. Tali atti sono espressamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/92 come avvisi di accertamento. Quindi il destinatario (importatore o dichiarante) può proporre ricorso alla CGT competente (di solito quella della provincia dove ha sede l’ufficio doganale). Il termine è sempre di 60 giorni.
La particolarità nelle dogane è data dal diritto unionale: l’art. 44 del Codice Doganale UE garantisce a ogni persona il diritto di ricorso contro le decisioni doganali che la riguardano. Questo ricorso può articolarsi in due fasi: una prima fase amministrativa (ricorso gerarchico in dogana) e una seconda giudiziale. L’Italia di fatto ha previsto come prima fase facoltativa il ricorso in autotutela alle Dogane (istanza di revisione in sede amministrativa) e come seconda fase il ricorso al giudice tributario. In concreto, quando si riceve un avviso di rettifica doganale, spesso è utile presentare subito un’istanza di riesame all’Autorità doganale (c.d. ricorso in dogana) entro 30 giorni: la Dogana riesamina l’accertamento e può annullarlo o modificarlo se trova errori. Questo non blocca il termine di 60 giorni per il ricorso giurisdizionale, che però in caso di risposta favorevole potrebbe non servire più.
Durante il ricorso doganale, come accennato, il pagamento dei dazi non è sospeso di diritto. L’operatore può chiedere alla Dogana di sospendere la riscossione indicando i motivi (es. evidenti errori o rischio di danno grave). La Dogana può concedere sospensione ma generalmente chiede una garanzia fideiussoria per l’importo contestato, salvo casi di difficoltà economica comprovata. Dunque, se arriva un avviso doganale per €100.000 dazi, l’importatore in ricorso dovrà in genere garantire quella somma per evitare di pagarla subito. Se poi vince, la garanzia viene svincolata; se perde, la Dogana escute la garanzia. Questo meccanismo è previsto dall’art. 45 CDU e 52 TULD.
Dal punto di vista dei motivi di ricorso, le liti doganali spesso vertono su classificazione tariffaria delle merci, origine delle merci (dazi preferenziali negati), valore in dogana, oppure su aspetti procedurali (es. mancato contraddittorio endoprocedimentale su revisione d’ufficio, tema in parte già tutelato dal Codice UE). Anche qui, il contraddittorio è ora obbligatorio per legge nazionale: quindi un avviso di revisione emesso dal 2024 senza aver inviato lo schema di atto e consentito replica in 60 gg sarà annullabile su ricorso, a meno che la Dogana invochi l’urgenza (ad es. rischi di perdita del gettito). Su questo aspetto c’è una integrazione tra principio UE (che già prevedeva contraddittorio in alcune fasi) e nuova norma interna generale.
Sentenze doganali recenti: segnaliamo che la Corte di Giustizia UE e la Cassazione sono intervenute su vari temi: ad esempio la CGUE (causa C-213/19) ha sancito l’obbligo per la Dogana di motivare adeguatamente e comunicare al contribuente gli esiti della revisione ex post, rispettando il diritto al contraddittorio; la Cassazione ha confermato che l’eventuale definitività di un avviso doganale annullato in primo grado e poi appellato non consente alla Dogana di riscuotere finché c’è appello pendente (tema delle risorse proprie UE e immediata esecutività delle sentenze, v. caso OSTP in CGUE 2023). In generale, la materia doganale è tecnica, quindi spesso è consigliabile l’assistenza di un avvocato specializzato in diritto doganale o un spedizioniere doganale con esperienza contenziosa.
Giurisdizioni superiori: appello e Cassazione
Per completezza, ricordiamo che avverso la sentenza di primo grado è ammesso appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. L’appello tributario è un riesame nel merito, quindi si possono riproporre le questioni e introdurne di nuove entro certi limiti (non nuovi motivi di ricorso mai sollevati, salvo questioni rilevabili d’ufficio come incompetenza). Il processo d’appello è analogo, con la differenza che il collegio è composto da giudici di grado superiore.
Dopo la sentenza d’appello, l’ultimo grado è il ricorso per Cassazione (entro 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello). In Cassazione si possono far valere solo motivi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione, non il merito). La Cassazione può rigettare, accogliere (annullare la sentenza di appello, in tutto o in parte) ed eventualmente rinviare ad altra CGT di secondo grado per nuovo esame.
Una novità introdotta dalla riforma del 2022 è la possibilità, su accordo delle parti, di impugnare la sentenza di primo grado direttamente in Cassazione saltando l’appello. Questa è un’ipotesi rara ma utile in casi che riguardano solo questioni di diritto: le parti (sia contribuente che ente) rinunciano all’appello e vanno subito in Cassazione, per abbreviare i tempi.
Va detto che la gran parte delle questioni pratiche si chiude in primo o secondo grado. La Cassazione è utilizzata per principi di diritto controversi. Da segnalare che le Sezioni Unite della Cassazione negli ultimi anni sono intervenute su vari temi del processo tributario (contraddittorio, integrabilità dei vizi, limiti dell’autotutela, ecc.), armonizzando orientamenti. Alcune delle decisioni citate in questa guida (es. SU 24823/2015 sul contraddittorio ante 2024, SU 30051/2024 sull’autotutela sostitutiva) hanno fatto chiarezza su aspetti importanti.
Domande frequenti (FAQ)
D: Ho ricevuto un avviso di accertamento: quanto tempo ho per fare ricorso?
R: Il termine generale è 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto. Attenzione: se la notifica avviene tramite posta, i 60 giorni decorrono dal giorno in cui ritira l’atto o gli viene consegnato. Se l’atto è notificato a mezzo PEC, conta la data di consegna nella casella PEC. Esistono sospensioni: ad esempio, il periodo 1-31 agosto non conta (sospensione feriale), e se il termine finale cade di sabato, domenica o festivo slitta al primo giorno lavorativo successivo. In caso di accertamento con adesione, la richiesta presentata entro i 60 giorni sospende il termine per impugnare di 90 giorni (o 30 giorni se l’atto era già preceduto da contraddittorio).
D: Devo pagare qualcosa entro i 60 giorni anche se faccio ricorso?
R: Sì. L’impugnazione non sospende automaticamente la riscossione. È previsto che il contribuente versi provvisoriamente un importo pari ad almeno 1/3 delle imposte accertate (oltre interessi) entro il termine di ricorso. Se non paga spontaneamente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può emettere cartella per quel terzo anche con il ricorso in corso. Il restante 2/3 viene per ora sospeso fino all’esito di primo grado. Se poi il contribuente vince, gli verrà restituito quanto pagato in più; se perde, dovrà pagare gli ulteriori 2/3 (e così via per l’appello). Per evitare di pagare subito, l’unica via è ottenere una sospensione giudiziale dell’atto (vedi dopo) oppure una sospensione amministrativa dall’ente. In mancanza, il 33% va messo in conto. L’obbligo del pagamento parziale non si applica se si aderisce prima dell’avviso (in quel caso si aspetta l’esito adesione) o se si fa acquiescenza (in quel caso si paga tutto ma con sanzioni ridotte a 1/3).
D: Posso ottenere la sospensione dell’accertamento in attesa della sentenza?
R: È possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto impugnato per tutta la durata del processo. Devi presentare un’istanza motivata dimostrando che l’esecuzione dell’avviso (cioè il pagamento immediato) ti causerebbe un danno grave e irreparabile. Ad esempio, se sei un’azienda e pagare ora ti farebbe fallire, o se sei una persona e ti porterebbe a dover vendere la casa. Devi anche evidenziare che il ricorso ha fumus boni iuris (possibilità di successo). Il giudice decide con ordinanza in tempi brevi (1-2 mesi). Se accoglie, l’atto è sospeso (non possono esigere nulla, o solo una parte) fino alla sentenza di merito. Se rigetta, puoi fare reclamo in 15 giorni alla CGT di secondo grado, ma in assenza di sospensione dovrai pagare il dovuto provvisorio (il terzo) per evitare azioni. La sospensione non viene concessa facilmente: la maggior parte delle richieste viene respinta perché non c’è un danno irreparabile (pagare dei soldi di per sé non è “irreparabile” se poi possono essere restituiti, a meno che la somma non sia davvero fuori portata). Quindi va chiesta solo in casi motivati e documentati (esibendo bilanci, situazione finanziaria, ecc.).
D: La “mediazione tributaria” è ancora obbligatoria sotto i 50.000 €?
R: No, dal 2024 è stata abolita. In passato (2012-2023) se la lite era di valore sino a 50.000 euro, bisognava presentare il ricorso come “reclamo” e aspettare 90 giorni per vedere se l’ufficio annullava o conciliava, prima di andare in Commissione. Adesso non più: per qualsiasi importo puoi proporre ricorso e depositarlo entro 30 giorni senza ulteriori attese. Quindi, ad esempio, per un avviso da €10.000 notificato nel 2025, notifichi il ricorso all’ente e lo deposi subito (non devi inserire alcuna proposta di mediazione nel testo, né aspettare 90 giorni). L’eliminazione del reclamo-mediazione è stata decisa perché spesso si trattava di un passaggio formale che ritardava la giustizia. Resta naturalmente possibile cercare un accordo durante il processo tramite la conciliazione giudiziale, ma non è più un obbligo pre-processuale. Nota: se hai presentato reclamo entro fine 2023, quello segue ancora le vecchie regole (ma oramai casi in esaurimento).
D: Ho presentato istanza di autotutela: posso evitare di fare ricorso?
R: No, non dovresti evitarlo. L’autotutela non sospende il termine di 60 giorni per impugnare. Se fai solo istanza di annullamento in autotutela e aspetti, rischi che passati i 60 giorni l’avviso diventi definitivo (anche se l’istanza è pendente). L’ente potrebbe anche non risponderti affatto o risponderti negativamente dopo mesi, e a quel punto saresti fuori tempo. Quindi, la cosa saggia da fare è: se mancano pochi giorni alla scadenza, presenta comunque il ricorso per cautela. Puoi sempre rinunciarvi in caso di esito positivo dell’autotutela (ad esempio, se l’ufficio annulla l’atto, il contenzioso si chiude). Tieni presente che ora in alcuni casi l’ufficio ha l’obbligo di procedere in autotutela (per vizi manifesti), ma non c’è garanzia assoluta. Anche con la riforma, puoi impugnare il diniego di autotutela obbligatoria se ritieni l’atto dovesse essere annullato; ma per arrivare a impugnare il diniego, devi comunque avere un giudizio aperto. Insomma, non fare affidamento esclusivo sull’autotutela.
D: Ho pagato l’avviso: posso ancora fare ricorso per farmi restituire i soldi?
R: Dipende. Se hai pagato entro 60 giorni avvalendoti della sanzione ridotta 1/3 (acquiescenza), allora hai formalmente accettato l’atto e rinunciato al ricorso. Non puoi impugnare dopo, perché il pagamento agevolato è vincolato alla rinuncia. Se invece hai pagato dopo i 60 giorni (quindi l’atto era già definitivo), anche lì non ha senso il ricorso: dovevi farlo prima; ora al più puoi solo eccepire la prescrizione se passano anni senza che ti notificassero atti, ma non puoi contestare il merito dopo che hai pagato spontaneamente e lasciato scadere i termini. L’unico caso in cui un pagamento non preclude il ricorso è se **paghi subito ma entro i 60 giorni fai comunque ricorso: ad esempio, perché volevi evitare sanzioni e interessi di mora. In teoria, uno può pagare l’intero importo e poi ricorrere chiedendo rimborso. La legge lo consente (il ricorso mirerà ad avere indietro il versato). Tuttavia, è una strategia rischiosa: in caso di sconfitta avrai anticipato soldi inutilmente; e non hai benefici (non c’è sconto sanzioni perché hai fatto ricorso, né puoi più fare adesione). Questa strada si segue solo in situazioni specifiche (es. per evitare iscrizione a ruolo di importi maggiorati, ecc.). In linea di massima, se paghi integralmente stai ammettendo il debito; salvo indicare espressamente che paghi “con riserva di ripetizione”, ma è complicato. Quindi, consigliamo: se intendi contestare, non pagare tutto subito (semmai paga il dovuto provvisorio e chiedi sospensione per il resto). Se invece decidi di pagare con sanzioni ridotte, sappi che stai chiudendo la partita.
D: Qual è la differenza tra un avviso di accertamento e una cartella esattoriale?
R: L’avviso di accertamento è l’atto con cui il Fisco o l’ente locale accerta un maggior tributo e ne chiede il pagamento. È un atto che il contribuente può contestare nel merito (dicendo “non devo pagare perché…”). La cartella esattoriale (o cartella di pagamento) è invece un atto di riscossione emesso dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate–Riscossione) per riscuotere somme già accertate e dovute. Prima del 2011, la prassi era: il Fisco faceva l’accertamento, se diventava definitivo incaricava Equitalia di emettere cartella; oggi per la maggior parte delle imposte l’accertamento stesso vale anche come titolo esecutivo dopo 60 giorni. Quindi spesso la cartella non viene emessa per accertamenti recenti, ma può essere ancora emessa per ruoli derivanti da controlli automatici, omessi versamenti, ecc. Proceduralmente, l’avviso va impugnato entro 60 giorni come spiegato; la cartella ha anch’essa 60 giorni per essere impugnata (ad es. se non preceduta da avviso, o per vizi propri). In sostanza: se ricevi un avviso, contesti la pretesa tributaria; se ricevi una cartella, di solito contesti un vizio di notifica o di calcolo, poiché il merito dell’imposta era già definito. Esempio: se non hai mai ricevuto un avviso e ti arriva cartella per IRPEF, puoi fare ricorso contro la cartella eccependo la mancata notifica dell’atto presupposto.
D: Cosa succede se perdo il ricorso in primo grado?
R: Se perdi interamente, la sentenza conferma l’accertamento. In tal caso dovrai versare quanto dovuto. Non immediatamente tutto: l’ente potrà intanto riscuotere i 2/3 dell’imposta (se non li aveva già ottenuti). Se avevi pagato il primo terzo, ti chiederanno gli altri due terzi. Le sanzioni invece normalmente rimangono “sospese” finché la sentenza non è definitiva. Se decidi di appellare la sentenza, puoi chiedere in appello la sospensione dell’esecutività della sentenza (per non pagare oltre i 2/3 nel frattempo). Se non appelli entro 60 gg, la sentenza diventa definitiva e l’ente potrà riscuotere il restante terzo e le sanzioni per intero. In caso di soccombenza, inoltre, potresti essere condannato alle spese legali dell’ente (un importo che varia in base al valore della lite, magari qualche migliaio di euro, salvo compensazione). Naturalmente, se perdi ma c’è spazio per appello, valuta con il tuo difensore. Il secondo grado potrebbe ribaltare il verdetto, ma attenzione ai costi aggiuntivi e al fatto che se perdi anche in appello le spese aumentano.
D: E se vinco il ricorso?
R: Se ottieni una sentenza favorevole (annullamento dell’atto, totale o parziale) sei vittorioso. L’ente dovrebbe prenderne atto ed eseguire: ciò significa che deve sgravare il debito o, se avevi versato qualcosa, predisporre il rimborso di quanto pagato in eccedenza. Dal 2022 le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive, quindi non occorre attendere la fine di tutti i gradi: puoi presentare istanza di rimborso immediata. Se l’ente fa appello, in passato tendeva a sospendere i rimborsi fino a fine causa; ora non dovrebbe più farlo, a pena di dover pagare interessi e spese di ottemperanza. In pratica però, è possibile che attendano la sentenza d’appello se manca poco. In caso di vittoria parziale, l’accertamento viene ridotto: ad esempio, il giudice annulla 2 rilievi su 3, quindi dovrai pagare solo per il rilievo confermato (magari con sanzione ricalcolata in proporzione). Se l’ente non esegue spontaneamente la sentenza (ad esempio non rimborsa), puoi attivare la procedura di ottemperanza presso la CGT (ossia chiedere che venga nominato un commissario ad acta che imponga il pagamento). Tieni presente che l’ente potrebbe appellare: la tua vittoria di primo grado non è definitiva finché c’è appello pendente, ma intanto tu sei protetto (l’atto è nullo e la riscossione ferma). Se vinci anche in appello, allora il discorso si chiude (salvo Cassazione, che però non sospende l’esecutività se non in casi rari).
D: Ho una piccola controversia (es. €1.500 di imposte): mi serve l’avvocato?
R: Per liti fino a €3.000 (valore del tributo, esclusi interessi e sanzioni) la legge consente di stare in giudizio da soli, senza assistenza tecnica. Puoi redigere e presentare personalmente il ricorso. Tuttavia, valuta la complessità: anche se ammesso, il fai-da-te è sconsigliato se non hai dimestichezza col diritto tributario. Potresti commettere errori procedurali o non cogliere appieno i motivi di ricorso. Considera anche che il valore si calcola per ogni atto impugnato: se impugni sanzioni e tributo insieme, il valore è la somma? In teoria no, conta solo il tributo principale (le sanzioni accessorie non contano ai fini del limite). Ad ogni modo, nulla vieta di incaricare un professionista anche per liti di modesto importo – magari concordando un onorario contenuto. Il vantaggio di fare da sé è evitare spese di difesa in cause piccole, ma ricorda che chi si difende da solo è comunque tenuto a rispettare tutte le formalità processuali come un avvocato (notifiche, depositi telematici se sceglie quella via, redazione motivi, etc.).
D: Il mio avviso è arrivato dopo che la Guardia di Finanza mi ha contestato delle irregolarità. Non dovevano aspettare 60 giorni prima di emettere l’accertamento?
R: Sì, questa è la regola del contraddittorio endoprocedimentale per i PVC. Fino al 2023, la norma (art. 12 c.7 L. 212/2000) prevedeva che dopo un PVC da verifica fiscale in loco, l’ufficio non potesse emettere avvisi prima di 60 giorni dal rilascio di quel PVC, salvo urgenza. Se violato, l’atto era nullo ma solo per le imposte “armonizzate” UE (IVA, dazi) secondo la giurisprudenza. Dal 2024 questa specifica norma è stata abrogata e sostituita dall’obbligo generale di contraddittorio per tutti gli accertamenti. Quindi oggi, ogni avviso di accertamento – salvo casi eccezionali esonerati – deve essere preceduto da una comunicazione (uno schema di atto) che anticipa al contribuente cosa gli verrà contestato e conceda almeno 60 giorni per osservazioni. Se l’ufficio emette l’avviso senza aspettare i 60 giorni (o comunque senza contraddittorio quando dovuto), l’atto è annullabile dal giudice su ricorso del contribuente. Quindi, nel tuo caso specifico: se hai ricevuto il PVC, l’Agenzia doveva attendere 60 giorni per permetterti di presentare memorie; se ha emesso prima l’avviso, potrai eccepirne la nullità (quantomeno per i tributi per cui il contraddittorio era obbligatorio secondo le regole applicabili al momento). Da gennaio 2024 comunque ogni omissione di contraddittorio è causa di annullamento se sollevata.
D: Cosa significa che la sentenza è immediatamente esecutiva?
R: Significa che non bisogna attendere il passaggio in giudicato per darle attuazione. Nel processo tributario, la regola introdotta di recente (art. 67-bis D.Lgs. 546/92) stabilisce che le sentenze di primo e secondo grado sono esecutive subito. Quindi, se il contribuente vince, ha diritto al rimborso immediato di quanto pagato in più, o allo sgravio; se vince il fisco, può riscuotere il dovuto senza aspettare l’esito dell’eventuale grado successivo. Prima invece le sentenze tributarie erano esecutive solo per la parte non sospesa ex lege (tipicamente il fisco poteva riscuotere 50% dopo primo grado, ecc., mentre per i rimborsi c’erano dubbi). Adesso la norma equipara le due parti: la parte soccombente deve eseguire subito la sentenza sfavorevole. Il contribuente vittorioso può agire se l’ente non rimborsa (giudizio di ottemperanza); il fisco vittorioso può pretendere il pagamento del residuo (fermo restando che se poi il contribuente vince in appello, avrà diritto al rimborso di quanto pagato in più). In pratica è una garanzia di tempestività. Nota: per i rimborsi da sentenza, l’Agenzia Entrate ha emanato circolari (es. circ. 22/E 2015, 17/E 2017) in cui si impegna a pagare entro 90 giorni dal deposito della sentenza definitiva; con la nuova norma, “definitiva” va intesa di grado (salvo appello con sospensione). Quindi se vinci in primo grado su un rimborso, teoricamente dovrebbero pagarti entro 3 mesi. Se non succede, attivi ottemperanza.
D: Se la controparte (Agenzia Entrate) fa appello, la mia vittoria in primo grado è sospesa automaticamente?
R: No. L’appello non sospende l’esecutività della sentenza di primo grado, a meno che la parte soccombente (in questo caso l’AE) chieda e ottenga una sospensione della sentenza dalla CGT di secondo grado. L’ente può infatti, quando presenta appello, chiedere al giudice di sospendere l’efficacia della sentenza impugnata. Ma deve provare che dall’esecuzione immediata deriverebbe un danno grave e irreparabile (cosa rara per il fisco) o che l’appello ha probabilità di successo. Se – come spesso accade – l’ente non ottiene la sospensione, deve rispettare la sentenza di primo grado anche se l’ha appellata. Ciò significa che se la sentenza ti ha dato ragione, l’ufficio dovrebbe sgravare il debito o rimborsarti, pur avendo fatto appello (salvo poi eventualmente richiedere indietro se vincerà in appello). Nella pratica, in passato molti uffici attendevano l’esito dell’appello senza dare seguito alla sentenza favorevole al contribuente; ora questo comportamento è formalmente scorretto, perché la legge dice che la sentenza è esecutiva. Il contribuente in questi casi può rivolgersi al giudice dell’ottemperanza per farsi eseguire subito la sentenza. Dall’altro lato, se il contribuente perde e fa appello, il fisco può richiedere la parte residua (2/3) senza aspettare il giudizio di secondo grado, sempre salvo che il contribuente chieda e ottenga sospensione in appello. Dunque, la regola è: la sentenza di primo grado va eseguita, l’appello di per sé non blocca (bisogna chiedere esplicitamente la sospensiva in appello).
Conclusioni
Affrontare un ricorso contro un avviso di accertamento fiscale richiede preparazione, tempestività e strategia. Dal punto di vista del contribuente (debitore), abbiamo visto come sia essenziale far valere tutti i propri diritti e garanzie: dal contraddittorio preventivo, alla puntuale indicazione dei vizi formali dell’atto, fino alle difese di merito sulle pretese tributarie. La normativa italiana offre vari strumenti per ridurre il contenzioso – adesione, acquiescenza, conciliazione – e protezioni procedurali come la sospensione e l’autotutela; allo stesso tempo, con le riforme del 2023-2025 si è cercato di rendere il processo più equo e veloce (abolendo passaggi inutili e imponendo al Fisco più dialogo preventivo).
Per un contribuente alle prese con un accertamento, il consiglio è di non attendere passivamente: leggere a fondo l’atto, eventualmente con l’ausilio di un professionista, e agire entro i termini. Se l’accertamento è corretto e si preferisce pagare con sconto, farlo entro 60 giorni (acquiescenza); se ci sono margini di trattativa, valutare l’adesione; se è infondato o viziato, preparare un ricorso ben motivato. Ogni caso fa storia a sé: per importi rilevanti o questioni complesse è quasi d’obbligo farsi assistere da un difensore esperto in diritto tributario, per massimizzare le chance di vittoria. Ma grazie alle informazioni fornite in questa guida, anche il contribuente non specialista può farsi un’idea chiara di come impugnare un accertamento fiscale, conoscendo i propri diritti e i passi da compiere.
Ricordiamo infine che la materia tributaria è in continua evoluzione: tenersi aggiornati sulle ultime normative (ad esempio i decreti attuativi della Delega Fiscale 2023 che modificheranno possibili aspetti sostanziali) e sulle pronunce giurisprudenziali significative (Cassazione e, per i tributi armonizzati, Corte di Giustizia UE) è fondamentale per una difesa efficace. Nella sezione seguente elenchiamo le principali fonti normative e di giurisprudenza citate o utili per approfondire.
Fonti e riferimenti
Normativa:
- D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546: istitutivo del processo tributario. (Art. 19 atti impugnabili; Art. 18-22 forma e termini del ricorso; Art. 12 assistenza tecnica; Art. 47 sospensione; Art. 48 conciliazione; Art. 68 riscossione frazionata; Art. 67-bis immediata esecutività sentenze; Art. 70 ottemperanza).
- Legge 27 luglio 2000 n. 212 (“Statuto del Contribuente”): contiene garanzie procedimentali (Art. 7 obbligo di motivazione e indicazione di responsabile; Art. 12 c.7 contraddittorio post-verifica – abrogato dal 2023; nuovo Art. 6-bis introdotto nel 2024 sul contraddittorio generalizzato; Art. 10-quater e 10-quinquies introdotti nel 2024 su autotutela obbligatoria e facoltativa).
- D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218: disciplina degli istituti deflativi. (Accertamento con adesione: presupposti e termine 60 gg, sospensione 90 gg, perfezionamento con pagamento, effetti sul potere di ricorso. Acquiescenza: art. 15 riduzione sanzioni a 1/3. Conciliazione giudiziale: art. 48 riduzione sanzioni al 40%/50%).
- Legge 31 agosto 2022 n. 130: riforma della giustizia tributaria (ha istituito le “Corti di Giustizia Tributaria” in luogo delle Commissioni; introdotto giudici professionali, nuove regole su prova testimoniale e giudice monocratico < €3.000).
- Decr. legislativi attuativi Delega Fiscale 2023:
- D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219: Modifiche allo Statuto contrib. (ha introdotto art. 6-bis contraddittorio obbligatorio; art. 10-quater/qunquies autotutela; abrogato art. 12 c.7 Statuto). In vigore dal 18 gennaio 2024.
- D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220: Riforma del processo tributario (ha abolito il reclamo-mediazione art. 17-bis; obbligo deposito telematico entro 30 gg; potere del giudice di proporre conciliazione; varie modifiche su spese di giudizio, testimonianza scritta, giudice monocratico etc.). In vigore dal 4 gennaio 2024.
- D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13: Riforma dell’accertamento tributario (ha previsto l’invito a definire in adesione nello schema d’atto; procedure diverse se atto soggetto a contraddittorio o no; termini adesione 30 gg ante-avviso e 15 gg post-avviso con sospensione ridotta; introdotto concordato preventivo biennale – non trattato qui). In vigore dal 22 febbraio 2024 (alcune disposizioni da atti emessi dal 30/4/24).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 & D.P.R. 633/1972: (norme sull’accertamento delle imposte dirette e IVA). Termini di decadenza accertamenti: art. 43 DPR 600 (5 anni dichiarato, 7 omesso); art. 57 DPR 633 analoghi per IVA.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472: (art. 19 sulla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di ricorso, citato per completezza).
- D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112: (convenzione riscossione – cartella esattoriale come titolo esecutivo). D.L. 78/2010 art. 29: (ha introdotto l’accertamento esecutivo senza cartella).
- Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013): art. 44 diritto al ricorso in materia doganale; art. 45 non-sospensiva automatica ma possibile con garanzia; art. 22 e 29 (procedura contraddittorio decisioni doganali).
- Legislazione locale: (es. D.Lgs. 446/97 per tributi locali; Regolamenti comunali su IMU/TARI; qui rilevanti per motivazione atti e adesione locale).
Giurisprudenza (sentenze):
- Cass., Sez. Unite 18/09/2015 n. 24823: sul contraddittorio endoprocedimentale ante 2024. Stabilì che, in assenza di norma generale, l’omissione del contraddittorio costituiva causa di nullità solo per i tributi armonizzati o dove previsto espressamente, non per altri. (Principio superato dalla norma 2024).
- Cass., Sez. Unite 22/12/2020 n. 28709: (non citata sopra, ma SU sulle nullità tributarie; ribadì che anche le nullità devono essere eccepite dal contribuente nei termini, confermando concetto di “nullità relative” in ambito tributario).
- Cass., Sez. Unite 09/12/2021 nn. 41994-41999: (sul regime della prova testimoniale nel processo tributario, prima della riforma 2022; ora superate da intervento legislatore che ha ammesso testimoni scritti).
- Cass., Sez. Unite 13/12/2022 n. 37954: (sulla qualificazione del reclamo-mediazione come condizione di procedibilità, ormai abolito dal 2024).
- Cass., ord. 17/05/2023 n. 13620: avviso con motivazione contraddittoria è nullo. La Corte ha annullato un atto che presentava due serie di motivi eterogenei e confliggenti, perché non garantiva certezza difensiva al contribuente.
- Cass., ord. 19/10/2023 n. 29141: obbligo di motivazione specifica per avvisi IMU. Ha precisato che l’avviso IMU è valido se il contribuente è messo in grado di capire il calcolo dell’imposta (es. indicazione immobili e rendite) – principi in linea con art. 7 Statuto.
- Cass., ord. 21/03/2024 n. 7620: in tema di controlli automatizzati (36-bis) ha affermato che la cartella emessa senza precedente avviso bonario è nulla per violazione del diritto di difesa. Estende tutela del contraddittorio anche a controlli formali.
- Cass., ord. 11/04/2024 n. 9348: (richiamata nel testo – non riportata sopra) conferma che l’omessa notifica dell’avviso bonario ex 36-bis rende nulla la cartella, salvo prova di regolare comunicazione (cfr. CTR Lombardia, ecc.).
- Cass., ord. 15/05/2024 n. 15980: (menzionata in tema adesione) ribadisce che solo il perfezionamento dell’adesione preclude il ricorso; se non perfezionata, l’avviso resta impugnabile.
- Cass., Sez. Unite 30/05/2024 n. 30051: legittima l’autotutela sostitutiva in peius, purché entro decadenza e senza giudicato contrario. Ha chiarito differenza con accertamento integrativo.
- Cass., sez. trib. 15/02/2025 n. 3860: sulla motivazione avvisi e autotutela (commentata da Baldoni 2025). Ha ribadito funzione della motivazione di delimitare il thema decidendum e di rendere edotto il contribuente di an e quantum debeatur; confermato obbligo di allegazione atti richiamati. Inoltre cita SU 30051/2024 sull’autotutela e conferma che in caso di parziale autotutela l’atto nuovo è impugnabile.
- CTR Campania (oggi CGT II grado) – sent. CTP Napoli 2022 cit.: ha affermato che se l’adesione non si perfeziona e si va in giudizio, tornano dovute le sanzioni intere (perdita dello sconto).
- Corte Giust. UE, causa C-682/16 (2018, Degano Trasporti): sul principio di contraddittorio nel diritto UE; ha influenzato SU 24823/2015.
- Corte Giust. UE, causa C-213/19 (2021, Commissione c. Italia): sull’obbligo di contraddittorio in materia doganale (ha condannato l’Italia per mancato rispetto in certi casi).
- Corte Giust. UE, causa C-770/22 (2023, OSTP Italy): su esecuzione sentenze tributarie riguardanti dazi UE. Ha stabilito che una sentenza nazionale che annulla dazi deve essere immediatamente eseguita (non si possono riscuotere dazi se c’è sentenza, nemmeno se appellata). Ciò rafforza l’immediata esecutorietà pro-contribuente.
Prassi e documenti utili:
- Agenzia Entrate – Sito istituzionale (schede “Contenzioso e strumenti deflativi”): contiene guide pratiche su ricorso, adesione, acquiescenza, autotutela, sospensione. Utile per modulistica fac-simile e codici tributo.
- Circolare Agenzia Entrate 19/03/2012 n. 9/E: (sulla mediazione tributaria introdotta nel 2012, ora superata).
- Circolare Agenzia Entrate 12/2016 n. 38/E: (sul nuovo accertamento esecutivo e riscossione frazionata).
- Circolare Agenzia Entrate 27/12/2022 n. 34/E: (sulle novità processuali della legge 130/2022).
- Circolare Agenzia Entrate 26/01/2024 n. 2/E: (probabile, interpretativa decreti 219-220/2023, se emanata – verificare).
- Relazioni illustrative MEF ai D.Lgs. 219/2023, 220/2023, 13/2024: spiegano ratio delle modifiche (disponibili sul sito finanze.gov).
- Note MEF (Dip. Giustizia Tributaria) gennaio 2024: chiarimenti su abrogazione reclamo-mediazione (nota 22/01/2024).
- Prontuario del difensore tributario 2025: pubblicazione privata (IPSOA, etc.) con modelli di ricorso e giurisprudenza aggiornata.
Ricorso Avviso di Accertamento: Come Impugnare un Accertamento Fiscale
Hai ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate? Ti contestano redditi non dichiarati, costi non riconosciuti o altri rilievi fiscali?
L’avviso di accertamento non è un atto definitivo: hai il diritto di presentare ricorso entro i termini di legge e difenderti. Con l’assistenza giusta, puoi ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto e ridurre l’impatto fiscale e sanzionatorio.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza in dettaglio l’avviso di accertamento e la documentazione a supporto
- 📌 Verifica la correttezza delle motivazioni, dei metodi di accertamento e delle notifiche
- ✍️ Redige il ricorso tributario nei termini previsti (60 giorni dalla notifica)
- ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento dell’atto
- 🔁 Valuta anche eventuali definizioni agevolate o conciliazioni per evitare il processo
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale
- ✔️ Specializzato nella difesa contro accertamenti fiscali e atti dell’Agenzia delle Entrate
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Un avviso di accertamento non va ignorato. Agire subito con un ricorso ben fondato può farti risparmiare migliaia di euro ed evitarti conseguenze gravi.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa fiscale comincia ora.