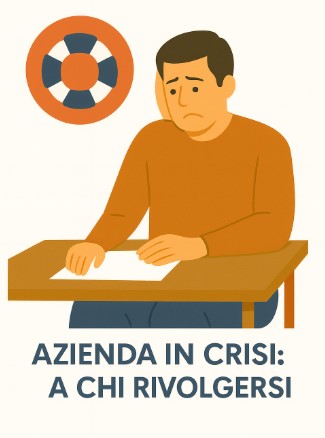Hai un’azienda in crisi e non sai da dove cominciare?
Hai accumulato debiti fiscali, ritardi nei pagamenti, conti bloccati o cali di fatturato che rendono difficile andare avanti? In questi casi è fondamentale intervenire subito, capire quali strumenti esistono per proteggere l’attività e a chi rivolgersi per trovare una soluzione concreta e su misura.
Quando si può parlare di crisi d’impresa?
– Quando non riesci più a rispettare le scadenze con banche, fornitori o dipendenti
– Quando hai esposizioni fiscali o previdenziali non gestite (cartelle, INPS, IVA arretrata)
– Quando il cash flow è insufficiente a coprire i costi fissi
– Quando hai subito un calo significativo del fatturato o della clientela
– Quando hai ricevuto segnalazioni dalla Centrale Rischi o dall’Agenzia delle Entrate
– Quando stai utilizzando capitali personali o debiti privati per tenere in piedi l’attività
A chi puoi rivolgerti se l’azienda è in crisi?
– A un avvocato esperto in diritto della crisi d’impresa, per valutare le soluzioni legali disponibili
– A un commercialista con esperienza in ristrutturazioni aziendali e risanamento del debito
– A un advisor indipendente che ti affianchi nel dialogo con banche e creditori
– A un consulente specializzato in strumenti di allerta e composizione negoziata della crisi
– A uno studio multidisciplinare che coordini aspetti fiscali, giuridici e finanziari
Quali strumenti puoi utilizzare per uscire dalla crisi?
– Il piano di risanamento attestato o l’accordo di ristrutturazione dei debiti
– La composizione negoziata della crisi (accessibile anche a microimprese)
– La transazione fiscale con Agenzia delle Entrate e INPS
– Il piano di rateizzazione o la rottamazione dei debiti fiscali e contributivi
– La liquidazione controllata, se non ci sono alternative per proseguire
– Il ricorso a fondi pubblici o incentivi per la riconversione e la ripartenza
– L’assistenza nella gestione di crisi da sovraindebitamento, anche per ditte individuali e professionisti
Cosa puoi ottenere con la giusta consulenza?
– La sospensione delle azioni esecutive e dei pignoramenti
– La ristrutturazione del debito e un piano di rientro sostenibile
– Il salvataggio dell’attività con continuità operativa
– La riduzione del debito fiscale e la tutela del tuo patrimonio personale
– La ricostruzione della reputazione aziendale e l’accesso al credito
– L’uscita ordinata dal mercato, se necessario, senza fallire e senza danni irreparabili
Attenzione: aspettare troppo può ridurre drasticamente le opzioni disponibili. Ma anche in situazioni gravi è possibile intervenire e trovare una via d’uscita, se ti affidi a professionisti competenti e agisci con tempestività.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, diritto fallimentare e ristrutturazioni aziendali ti spiega cosa fare se la tua azienda è in difficoltà, quali sono gli strumenti a disposizione e come ottenere la soluzione più adatta al tuo caso.
Hai un’azienda in crisi e non sai da dove cominciare?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a valutare subito le opzioni disponibili, evitare danni peggiori e riprendere il controllo della tua attività.
Introduzione
Un’azienda in crisi è un’impresa che attraversa gravi difficoltà economico-finanziarie, tali da mettere a rischio la sua capacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni. La normativa italiana distingue lo stato di crisi dallo stato di insolvenza: per crisi si intende una situazione di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza futura dell’impresa, manifestandosi tipicamente nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte ai debiti pianificati. L’insolvenza, invece, è lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato da inadempimenti o altri fatti esteriori rivelatori di questa incapacità. In altre parole, la crisi è una difficoltà latente (insolvenza probabile ma non ancora conclamata), mentre l’insolvenza è una difficoltà ormai sfociata in inadempimenti conclamati. Questa distinzione è cruciale perché l’ordinamento offre strumenti diversi a seconda che l’impresa sia semplicemente “in crisi” (ancora recuperabile) o già insolvente (bisognosa di misure più drastiche).
Affrontare tempestivamente lo stato di crisi è fondamentale. Molte imprese, specialmente piccole e medie, tendono a ignorare i segnali di allarme e si attivano solo quando la situazione è ormai degenerata in insolvenza irreversibile. Il legislatore italiano, recependo anche indicazioni comunitarie (Direttiva UE 2019/1023), ha introdotto obblighi di early warning e strumenti di emersione anticipata della crisi. Dal 2019 vige infatti per tutti gli imprenditori in forma societaria il dovere di dotarsi di assetti organizzativi adeguati, proprio in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale (art. 2086, comma 2 c.c.). Allo stesso modo, anche l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a monitorare il proprio stato economico-finanziario e ad intercettare eventuali squilibri (art. 3, comma 1, Codice della Crisi). Scopo di questi obblighi organizzativi è individuare precocemente segnali di allarme come: squilibri di bilancio patrimoniali o di liquidità, ritardi nei pagamenti di fornitori o dipendenti, esposizioni fiscali e contributive non sostenibili nel successivo anno, indici di settore sfavorevoli, ecc.. La presenza di tali indicatori suggerisce di attivarsi immediatamente, “rivolgendosi” – come titola questa guida – ai soggetti e agli strumenti predisposti dall’ordinamento per la gestione della crisi.
Questa guida, aggiornata a luglio 2025, fornisce una trattazione avanzata sulle soluzioni giuridiche disponibili quando un’azienda (o un imprenditore) si trova in crisi o insolvenza, dal punto di vista del debitore. Adotteremo un linguaggio tecnicamente accurato ma di taglio divulgativo, in modo da risultare utile sia ai professionisti del diritto (avvocati, commercialisti) sia agli imprenditori e ai privati cittadini coinvolti. Verranno esaminate le procedure giudiziali di regolazione della crisi d’impresa (come il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale) e le soluzioni stragiudiziali o alternative (piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, ecc.), nonché le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dedicate ai debitori “non fallibili” (consumatori, piccole imprese sotto soglia, etc.). Ampio spazio sarà dato alle novità normative e alle pronunce giurisprudenziali più recenti (Cassazione, Corti di merito) che hanno interpretato queste norme, al fine di offrire un quadro aggiornato al 2025. Troverete inoltre tabelle riepilogative per confrontare tra loro i vari strumenti, una sezione di domande e risposte frequenti, e delle simulazioni pratiche (casi esemplificativi) riferite al contesto italiano. Le fonti normative e le sentenze citate sono elencate in fondo alla guida.
In sintesi, quando un’azienda è in crisi occorre anzitutto prendere coscienza della gravità della situazione attraverso un’attenta analisi dei segnali contabili e finanziari. Quindi, il debitore deve valutare a chi rivolgersi: professionisti specializzati e organismi ad hoc possono offrire assistenza nel pianificare la strategia migliore (risanamento o liquidazione ordinata) e nell’imbastire le trattative con i creditori. L’ordinamento oggi mette a disposizione una “cassetta degli attrezzi” molto più ricca rispetto al passato, proprio per incentivare le imprese a intervenire prima che la crisi diventi insolvenza conclamata. Nei paragrafi seguenti passeremo in rassegna tali strumenti e procedure, con un approfondimento di carattere giuridico ma sempre con un occhio pratico rivolto al debitore che vi accede.
La riforma della crisi d’impresa: quadro normativo aggiornato al 2025
Negli ultimi anni l’Italia ha completamente ridisegnato la disciplina delle procedure concorsuali e di gestione della crisi d’impresa. Il vecchio impianto della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – imperniato sulla figura del fallimento – è stato superato dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, spesso abbreviato in CCII). Il Codice, emanato in attuazione della legge delega n. 155/2017, avrebbe dovuto entrare in vigore gradualmente dal 2020, ma la sua efficacia è stata differita a causa della pandemia. La riforma è divenuta pienamente operativa solo dal 15 luglio 2022. Si tratta di un cambiamento epocale: i termini “fallimento” e “fallito” sono stati eliminati dal lessico giuridico (oggi si parla di liquidazione giudiziale e debitore assoggettato), e si è adottato un approccio più incentrato sul risanamento e sulla prevenzione della crisi, in linea con la normativa UE.
Il Codice della Crisi ha già subito diversi interventi correttivi per affinare le norme e recepire le indicazioni comunitarie sopravvenute. Un primo correttivo è stato introdotto con il D.Lgs. 147/2020 (soprattutto per posticipare l’entrata in vigore e ritoccare alcuni punti alla luce dell’emergenza Covid). Successivamente, in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 (sulle ristrutturazioni preventive e insolvenza), è stato emanato il D.Lgs. 83/2022 che ha modificato vari articoli del Codice sin dal suo debutto (c.d. “Correttivo bis”). Da ultimo, dopo un anno di applicazione, il legislatore è intervenuto una terza volta con il D.Lgs. 136/2024 (Correttivo ter), in vigore dal 28 settembre 2024, per recepire pienamente la direttiva europea e risolvere alcune criticità emerse in sede applicativa. Quest’ultimo correttivo, ad esempio, ha introdotto novità in tema di adeguati assetti, procedure familiari di sovraindebitamento e altre norme di dettaglio. Complessivamente, quindi, al luglio 2025 il quadro normativo è il seguente:
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – Testo base della disciplina, aggiornato con D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024. Contiene sia le procedure di regolazione della crisi (strumenti di allerta e composizione negoziale, piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati) sia le procedure liquidatorie (liquidazione giudiziale, liquidazione controllata, etc.), oltre alle definizioni e ai princìpi generali.
- Decreto-Legge 118/2021 convertito in L. 147/2021 – Ha introdotto in via anticipata l’istituto della composizione negoziata della crisi, poi confluito nel Codice (artt. 17-25-sexies CCII).
- Legge 3/2012 (vecchia legge sul sovraindebitamento) – Formalmente abrogata dall’entrata in vigore del Codice a luglio 2022, ma ancora rilevante per le procedure pendenti avviate prima. Gran parte della giurisprudenza recente della Cassazione fa riferimento a casi disciplinati dalla L.3/2012, benché i suoi istituti siano ora trasfusi nel Codice con nomi nuovi (p.es. piano del consumatore → piano di ristrutturazione per consumatore, accordo di composizione → concordato minore, liquidazione del patrimonio → liquidazione controllata).
- Normativa emergenziale Covid (in particolare D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020) – Ha introdotto importanti misure transitorie, alcune delle quali con effetti duraturi: ad esempio la possibilità per il debitore sovraindebitato di presentare una nuova proposta entro 90 giorni se la prima veniva rigettata, oppure l’esdebitazione dell’incapiente (art. 14-quaterdecies L.3/2012) che consente al debitore persona fisica meritevole, privo di beni liquidabili, di ottenere la cancellazione dei debiti residui una tantum. Molte di queste norme transitorie sono state incorporate nel Codice della Crisi.
Oltre alle fonti normative, va tenuto conto delle pronunce giurisprudenziali che negli anni 2022-2025 hanno interpretato e chiarito vari aspetti della nuova disciplina. La Corte di Cassazione in particolare, con numerose sentenze e ordinanze, ha affrontato questioni inedite poste dal Codice e dalla legislazione sul sovraindebitamento. Ci riferiremo spesso a tali sentenze, soprattutto le più recenti, per dare conto dell’orientamento attuale sui punti controversi. Va segnalato che molte decisioni fino al 2022 fanno riferimento ancora alla legge fallimentare o alla L.3/2012, ma i principi espressi sono in larga parte estesi anche al nuovo Codice (come spesso la stessa Cassazione ha precisato). Ad esempio, la Cassazione ha ribadito nel 2023 che la nozione di “consumatore” rilevante ai fini dell’accesso alle procedure di sovraindebitamento resta quella di carattere oggettivo già affermata sotto la L.3/2012: è consumatore solo chi ha contratto debiti estranei ad attività d’impresa, quindi un ex imprenditore con debiti derivanti in gran parte da una precedente attività commerciale non potrà qualificarsi come consumatore. Su tale base, la Suprema Corte ha escluso che un imprenditore individuale cessato (cancellato dal registro imprese) possa accedere al piano del consumatore o al concordato minore per sistemare i debiti della ex attività: l’unica procedura ammissibile in tal caso è la liquidazione (ossia l’alienazione controllata dei beni). Questo è un esempio del rilievo pratico che le interpretazioni giurisprudenziali hanno assunto e che verranno evidenziate nel corso della trattazione.
Riassumendo, chi si trova oggi ad affrontare una crisi aziendale dispone di un quadro normativo moderno e articolato, in cui l’accento è posto sul salvataggio dell’impresa laddove possibile e su una gestione ordinata dell’insolvenza laddove il salvataggio non sia praticabile. Nei prossimi paragrafi illustreremo anzitutto chi può aiutare l’imprenditore in crisi (figure e organismi competenti), e poi passeremo in rassegna gli strumenti concreti: dalle soluzioni stragiudiziali (piani, accordi, negoziazione assistita) alle procedure giudiziali vere e proprie (concordati, liquidazioni), fino alle procedure speciali per il sovraindebitamento civile e delle piccole imprese. Ogni istituto sarà esaminato nei suoi tratti essenziali, con indicazione di vantaggi, limiti e recenti sviluppi giurisprudenziali.
A chi rivolgersi: professionisti e organismi di supporto al debitore
Di fronte a una situazione di crisi d’impresa, il debitore non è solo: l’ordinamento prevede una serie di figure professionali e istituzionali che possono assisterlo nel percorso di risanamento o di regolazione del debito. È importante sapere “a chi rivolgersi” fin dalle prime avvisaglie di difficoltà, per scegliere lo strumento più adatto ed evitare passi falsi. Ecco i principali attori che entrano in gioco dal lato del debitore:
- Professionisti esperti in crisi d’impresa: Avvocati e Dottori Commercialisti specializzati in diritto fallimentare e della ristrutturazione aziendale sono i primi consulenti a cui un imprenditore dovrebbe rivolgersi. Essi possono analizzare la situazione finanziaria, valutare la fattibilità di un piano di risanamento e suggerire quale procedura intraprendere. Ad esempio, un avvocato esperto potrà indicare se è preferibile tentare un accordo stragiudiziale con le banche o se invece conviene presentare domanda di concordato preventivo. Coinvolgere sin da subito un professionista aiuta anche a evitare atti di gestione che potrebbero poi essere contestati (ad es. pagamenti preferenziali suscettibili di revocatoria). Nelle procedure formalizzate, il ruolo del professionista è spesso richiesto dalla legge: si pensi al professionista indipendente attestatore del piano di risanamento (che deve essere iscritto all’albo dei gestori della crisi) o al certificatore nel concordato, figure di norma ricoperte da commercialisti o avvocati qualificati. Dunque, il primo consiglio per un imprenditore in crisi è: cercare assistenza da un consulente competente in crisi d’impresa.
- Organismo di Composizione della Crisi (OCC): Si tratta di enti istituiti presso Ordini professionali, Camere di Commercio o enti pubblici, iscritti in un apposito registro ministeriale, deputati ad assistere i debitori civili e i piccoli imprenditori nelle procedure di sovraindebitamento. L’OCC mette a disposizione del debitore un referente (gestore della crisi) che lo aiuta a predisporre il piano di ristrutturazione o l’accordo da sottoporre ai creditori, occupandosi di convocare i creditori e svolgere le attività di ausilio tecnico. Ad esempio, il consumatore sovraindebitato che voglia proporre un piano del consumatore dovrà rivolgersi a un OCC locale: il gestore redigerà la relazione attestante la fattibilità e la meritevolezza, e guiderà il debitore durante tutto l’iter in tribunale. Gli OCC sono dunque un punto di riferimento fondamentale per i debitori non fallibili (siano essi privati cittadini, professionisti o piccole imprese sotto le soglie di fallibilità) che intendano avvalersi delle procedure di composizione della crisi previste dal Codice. Va ricordato che dal 2022 l’accesso alle procedure da sovraindebitamento (ora denominate concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata) avviene di regola tramite un OCC nominato dal tribunale competente. Pertanto, se un piccolo imprenditore o un privato intende usufruire di queste soluzioni, può prendere contatto diretto con un Organismo sul territorio per essere guidato.
- Esperto indipendente per la Composizione Negoziata: La figura dell’esperto è una novità introdotta con la composizione negoziata della crisi. Si tratta di un professionista terzo, con profonda esperienza gestionale e in materia di ristrutturazioni, selezionato da una commissione apposita istituita presso le Camere di Commercio. L’esperto viene nominato su richiesta dell’imprenditore che accede alla procedura di composizione negoziata e ha il compito di facilitare le trattative tra il debitore e i creditori. Il suo ruolo è dunque simile a quello di un mediatore specializzato: analizza la situazione aziendale, individua possibili soluzioni di risanamento e conduce (o supervisiona) le negoziazioni con banche, fornitori, fisco, etc., mantenendo un approccio imparziale e riservato. L’esperto redige verbali periodici sullo stato delle trattative e al termine riferisce sull’esito (successo o insuccesso) della composizione negoziata. Importante: l’esperto non ha poteri gestori sull’azienda (l’imprenditore resta in possesso della sua impresa) ma può raccomandare eventuali misure correttive. Per ottenere la nomina di un esperto, l’imprenditore deve presentare istanza tramite la piattaforma telematica nazionale (gestita da Unioncamere) – vedremo in dettaglio più avanti questo procedimento. In sintesi, la Composizione Negoziata è “il luogo” in cui l’imprenditore in difficoltà può “rivolgersi” per tentare un risanamento assistito da un esperto, in modo confidenziale e con la possibilità di ottenere alcune tutele (come il blocco delle azioni esecutive, previa autorizzazione del tribunale). Questa figura dell’esperto si sta rivelando preziosa: al novembre 2024 si contavano quasi 2.000 istanze di composizione negoziata presentate dalle imprese, con oltre 210 aziende avviate al risanamento grazie a tale percorso e più di 10.000 posti di lavoro salvati.
- Tribunale e Sezioni specializzate: Quando si parla di procedure concorsuali giudiziali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.), il riferimento è al Tribunale competente (di regola, il Tribunale delle Imprese o sezione fallimentare del luogo dove l’impresa ha la sede principale). L’autorità giudiziaria svolge un ruolo centrale: omologa (approva) accordi di ristrutturazione e concordati, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, nomina gli organi delle procedure (curatore, commissario giudiziale, liquidatore, ecc.) e vigila sul corretto svolgimento. Dal punto di vista del debitore, “rivolgersi al tribunale” significa iniziare una procedura formale presentando una domanda (di concordato, di omologazione di un accordo, di liquidazione controllata, ecc.) e sottoporsi poi alle valutazioni dei giudici. È bene non vedere il tribunale come un “nemico”: l’attuale legislazione incentiva il debitore a fare un uso propositivo del tribunale, ad esempio depositando una domanda di concordato preventivo prenotativo (in bianco) per congelare la situazione e guadagnare tempo per un piano, oppure chiedendo l’omologazione di accordi con i creditori. I giudici hanno sviluppato prassi di favore verso soluzioni concordate e cercano – per quanto possibile – di agevolare ristrutturazioni serie. Ad esempio, una volta che l’impresa deposita una domanda di concordato o accordo, scatta il divieto di azioni esecutive individuali da parte dei creditori (automatic stay), che viene fatto rispettare dal giudice. Nel caso di procedure di sovraindebitamento, il giudice delegato può emettere il provvedimento di apertura e vietare i pignoramenti, ma spetta poi al giudice dell’esecuzione sospendere formalmente le singole esecuzioni. Ciò per dire che l’autorità giudiziaria è il perno delle procedure concorsuali e il debitore dovrà inevitabilmente interfacciarsi con essa (direttamente o tramite il proprio legale) quando sceglie la via giudiziale.
- Altri organi delle procedure: In caso di apertura di una procedura concorsuale, entrano in scena altri soggetti a cui il debitore dovrà rivolgersi o sottoporsi: il Curatore (nella liquidazione giudiziale) che amministra il patrimonio fallimentare, il Commissario Giudiziale (nel concordato preventivo) che sorveglia la gestione del debitore in pendenza di concordato, il Giudice Delegato nominato dal tribunale per vigilare sulla procedura, il Liquidatore (nel concordato liquidatorio o nella liquidazione controllata da sovraindebitamento) che liquida i beni, etc. Dal punto di vista del debitore, questi soggetti non sono propri consulenti, ma piuttosto gestori imparziali o controllori che agiscono una volta avviata la procedura. Tuttavia, è bene citarli perché il debitore in crisi deve essere consapevole che, scegliendo una procedura concorsuale, accetterà di affidare ampi poteri a tali organi. Ad esempio, in liquidazione giudiziale l’imprenditore perde l’amministrazione dei beni, che passa al Curatore; in un concordato, l’azienda resta in mano al debitore ma sotto la supervisione del Commissario e del giudice.
In definitiva, prima fase del “rivolgersi a qualcuno” consiste nel cercare assistenza qualificata (professionisti o OCC) per capire che strada intraprendere; la seconda fase, a seconda della scelta, comporterà il coinvolgimento dell’esperto (se composizione negoziata) o del tribunale e dei suoi organi (se procedura giudiziale). Nel prossimo capitolo, esamineremo anzitutto gli strumenti di risanamento stragiudiziale e alternativo alla sede giudiziaria, per poi passare alle procedure concorsuali vere e proprie.
Strumenti stragiudiziali e alternativi al processo per affrontare la crisi
Spesso il risanamento di un’azienda in difficoltà può avvenire senza passare da una procedura giudiziaria formale, attraverso accordi volontari con i creditori o piani di ristrutturazione negoziati privatamente. Questi strumenti “alternativi” presentano il vantaggio di svolgersi in modo riservato (o comunque con minore pubblicità), con minor costo e rigidità rispetto a un procedimento in tribunale, e consentono al debitore di mantenere la guida delle trattative. Di contro, non offrono tutte le tutele delle procedure giudiziali (ad es. non vi è moratoria automatica dei debiti se non in certi casi) e richiedono la disponibilità dei creditori a cooperare. Esaminiamo i principali strumenti stragiudiziali o para-giudiziali previsti dall’ordinamento italiano per la regolazione negoziale della crisi:
Piano attestato di risanamento (PAR)
Il Piano attestato di risanamento è uno strumento introdotto nel 2005 e ora disciplinato dall’art. 56 del Codice della Crisi. È un piano unilaterale predisposto dall’imprenditore in crisi o insolvenza (anche già insolvente, purché vi sia prospettiva di risanamento) con l’obiettivo di ristrutturare l’indebitamento e riequilibrare la situazione finanziaria dell’azienda, evitando l’apertura di una procedura concorsuale formale. Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente (requisiti di legge: indipendenza, iscrizione all’albo dei gestori crisi, ecc.) il quale certifica, con relazione scritta, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso. Questa figura di attestatore svolge un ruolo cruciale: la sua attestazione dà credibilità al piano verso i terzi e costituisce il presupposto per gli effetti protettivi del piano.
Caratteristiche salienti del Piano Attestato di Risanamento:
- Natura e Forma: è un accordo privato, solitamente documentato in forma scritta come piano industriale-finanziario accompagnato dalla relazione dell’attestatore. Non richiede omologazione o approvazione da parte di alcuna autorità. Tuttavia, per ottenere piena efficacia legale, il piano attestato va pubblicato nel Registro delle Imprese (depositando la documentazione completa). La pubblicazione, prevista dall’art. 56 CCII, serve a “pubblicizzare” l’esistenza del piano e a marcare la data dalla quale decorrono gli effetti protettivi.
- Presupposti soggettivi: possono avvalersene gli imprenditori commerciali assoggettabili a fallimento (liquidazione giudiziale). In teoria nulla vieterebbe a un piccolo imprenditore non fallibile di fare un piano di risanamento informale, ma il principale beneficio normativo – l’esenzione da revocatoria – è pensato per chi potrebbe fallire. Infatti, la ratio storica del piano attestato è offrire all’imprenditore fallibile uno scudo: se riesce a eseguire il piano ed evitare il dissesto, certi atti compiuti in esecuzione del piano non potranno più essere attaccati dai creditori in caso di futuro fallimento. Questo scudo (previsto originariamente nell’art. 67, co.3, lett. d) L.F. e ora ripreso dall’art. 56 CCII) consiste nell’esenzione dalle azioni revocatorie: tutti i pagamenti, garanzie e atti dispositivi compiuti in esecuzione del piano attestato non potranno essere revocati dal curatore fallimentare in un eventuale successivo fallimento dell’impresa. Ciò incentiva i terzi a concedere credito o ad accordare dilazioni al debitore nel contesto del piano, senza temere di dover restituire quanto ricevuto se poi il debitore fallisce. Inoltre, il Codice prevede che gli atti esecutivi del piano siano esenti anche da revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), salvo il caso di dolo specifico fraudolento.
- Contenuto del piano: deve delineare in modo dettagliato le strategie per superare la crisi. Tipicamente include: la situazione analitica dei debiti; le misure di ristrutturazione (es. accordi di moratoria con banche, iniezioni di capitale dai soci, cessione di rami d’azienda non strategici, riduzione costi, conversione di crediti in capitale, ecc.); proiezioni finanziarie e conto economico prospettico a medio termine; eventuali impegni di nuovi finanziatori. Il piano deve essere idoneo a garantire il riequilibrio dell’impresa e il pagamento dei creditori secondo le nuove scadenze previste. Non è richiesto il consenso di tutti i creditori – il piano può anche essere “imposto” unilateralmente, purché il debitore riesca a farsi accordare individualmente le intese necessarie (ad esempio, ottenere dalle banche una rinegoziazione fidi, dai fornitori una dilazione, etc.). In sostanza il PAR è un “piano di risanamento aziendale” cui i creditori aderiscono su base volontaria fuori dal tribunale.
- Ruolo dell’attestatore: la normativa richiede che il professionista indipendente attesti due cose fondamentali: veridicità dei dati e fattibilità del piano. La veridicità attiene alla correttezza delle scritture contabili, dei bilanci e delle situazioni patrimoniali utilizzate: il professionista deve verificarne l’attendibilità. La fattibilità invece concerne le ipotesi future: il piano deve apparire idoneo a risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria. L’attestatore dunque effettua stress test sulle previsioni di cash flow, sulla sostenibilità del debito ristrutturato, ecc., e rilascia un giudizio professionale. La sua relazione è determinante per dare fiducia ai creditori: spesso le banche acconsentono a rinegoziare i crediti solo se il piano è stato certificato da un esperto indipendente. La legge richiede che l’attestatore non sia in conflitto di interessi e possieda i requisiti previsti per i curatori/commissari (indipendenza, iscrizione albo gestori crisi). Attenzione: se il professionista rilascia un’attestazione falsa o gravemente negligente, incorre in responsabilità anche penali (falsità nelle attestazioni).
- Effetti e limiti: Il piano attestato di per sé non vincola i creditori dissenzienti (non essendo un procedimento omologato). Ciò significa che un creditore potrebbe sempre agire individualmente (pignoramenti) anche se il debitore ha un piano attestato, a meno che quel creditore abbia sottoscritto un accordo nell’ambito del piano. Per questo il piano spesso si accompagna a intese contrattuali bilaterali con i creditori principali (accordi di standstill, moratorie, nuove pattuizioni). Non c’è una moratoria legale generale: tuttavia l’imprenditore può richiedere – se ne ricorrono i presupposti – misure protettive in sede di composizione negoziata o accordo di ristrutturazione parallelo (vedremo dopo queste possibilità). Il beneficio principale del PAR, come detto, è proteggere gli atti esecutivi compiuti nel periodo di risanamento: ad es. nuova finanza iniettata sarà prededucibile in caso di successivo fallimento; la vendita di un cespite non strategico potrà essere effettuata senza timore di revocatoria fallimentare, purché a prezzi congrui certificati dall’esperto. Inoltre, dal 2021 il legislatore ha previsto che nuovi finanziamenti erogati in esecuzione del piano possano godere di esenzioni penali dal reato di bancarotta preferenziale e altri privilegi, al fine di incoraggiare investitori a sostenere il rilancio. In sostanza, il piano attestato è uno strumento flessibile e confidenziale, che tuttavia richiede di base la fiducia dei creditori chiave nel piano stesso (fiducia supportata dall’attestazione).
Il Correttivo ter 2024 ha introdotto alcune novità anche sul piano attestato. In particolare, sembra aver meglio definito i rapporti tra PAR e altre procedure: ad esempio, è ora chiarito che un piano attestato può accompagnarsi a una transazione fiscale con l’Erario, senza bisogno di un accordo di ristrutturazione giudiziale, purché l’Agenzia delle Entrate aderisca (prima vi erano dubbi sul trattamento dei debiti fiscali nel PAR). Inoltre, sono state previste comunicazioni a CONSOB qualora il piano riguardi società con titoli diffusi, e una disciplina particolare per l’informativa nelle società quotate. Ma questi dettagli vanno oltre lo scopo di questa trattazione.
In conclusione, quando utilizzare un piano attestato?: tipicamente quando l’impresa ha prospettive concrete di risanamento e vuole evitare la pubblicità e la complessità di un concordato preventivo. È ideale se il numero di creditori non è elevatissimo e se si riesce a ottenere il consenso informale delle controparti principali. Ad esempio, un’azienda manifatturiera con difficoltà di liquidità temporanea potrebbe negoziare allungamenti di pagamento con fornitori e banche e predisporre un piano di rilancio; l’attestatore certifica il tutto e i pagamenti effettuati secondo piano (es. pagare fornitori strategici per continuare l’attività) non saranno revocati in futuro. Invece, se c’è bisogno di imporre sacrifici anche ai creditori non consenzienti, il piano attestato non basta e occorre un procedimento omologato (accordo di ristrutturazione o concordato). Il piano attestato può comunque essere propedeutico: l’imprenditore può provarci in via privata e, se qualche creditore dissente, convertire la manovra in un accordo ex art.57 CCII (che richiede l’omologazione del tribunale, v. oltre).
Esempio pratico: Alfa Srl, impresa edile, ha accumulato debiti finanziari e verso fornitori per 2 milioni di euro a causa di ritardi nei cantieri. Ha però commesse in corso e un patrimonio netto positivo. Alfa elabora, con l’aiuto di un advisor, un piano su 5 anni in cui i soci apportano €200k freschi, le banche prorogano i mutui di 2 anni e i fornitori strategici accettano un pagamento dilazionato al 70% del credito. Un esperto indipendente attesta che i dati di Alfa sono attendibili e che il piano è sostenibile (alla luce del portafoglio lavori e dei tagli di costi operati). Il piano viene depositato nel Registro Imprese. Da quel momento Alfa esegue le azioni previste: paga i fornitori alle nuove scadenze, ottiene nuova finanza garantita dal socio, prosegue l’attività. Dopo 5 anni, Alfa ha onorato gli impegni e torna in bonis. Nessun creditore potrà più revocare i pagamenti ricevuti durante il risanamento perché coperti dall’esenzione del piano attestato. In questo caso il PAR ha funzionato come “salvataggio silenzioso” fuori dai tribunali.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione sono strumenti che pur nascendo da una negoziazione privata con i creditori, richiedono l’intervento (omologazione) dell’autorità giudiziaria per diventare vincolanti ed efficaci erga omnes. Previsti originariamente dall’art. 182-bis Legge Fallimentare, sono ora disciplinati dagli artt. 57-64 del Codice della Crisi. Si tratta di veri e propri accordi contrattuali tra il debitore e una parte qualificata dei suoi creditori, volti a ristrutturare l’indebitamento: tipicamente prevedono una dilazione dei termini di pagamento, una remissione parziale del debito (stralcio), la rinegoziazione di tassi e condizioni, eventuali garanzie, oppure conversione di crediti in strumenti finanziari, ecc., nell’ottica di rendere sostenibile il debito residuo. La peculiarità è che, una volta raggiunto l’accordo con una determinata maggioranza di crediti, esso viene sottoposto al tribunale per l’omologazione; con il decreto di omologa, l’accordo diviene vincolante anche per eventuali creditori dissenzienti (purché appartenenti alle categorie interessate dall’accordo).
Principali caratteristiche degli accordi di ristrutturazione:
- Soglia di adesione: La legge richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti (per valore). Significa che il debitore deve convincere creditori rappresentanti almeno il 60% dell’ammontare complessivo dei debiti ad aderire all’accordo. I restanti creditori (la minoranza <40%) restano estranei all’accordo; essi non sono vincolati dalle nuove condizioni negoziate, ma l’accordo può prevedere che saranno pagati integralmente fuori accordo. In sede di omologazione, il tribunale verifica che i creditori non aderenti non ricevano un trattamento deteriore rispetto alla prospettiva liquidatoria. In pratica devono essere pagati per intero entro i 120 giorni dall’omologazione o scadenza, oppure in misura non inferiore a quanto otterrebbero da una liquidazione (questo principio del “best interest test” è comune a concordati e accordi).
- Procedimento: Il debitore deposita ricorso al tribunale allegando il testo dell’accordo firmato dai creditori aderenti, una relazione del professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo (in particolare, attestazione che con l’accordo si assicura il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge). Se il tribunale valuta che tutto è regolare, omologa l’accordo con decreto. L’omologazione rende l’accordo efficace anche verso i terzi. Durante il periodo tra deposito e omologa, il debitore può chiedere misure protettive urgenti (sospensione delle azioni esecutive) per evitare che i creditori dissenzienti pregiudichino l’accordo. Tali misure protettive durano al massimo 4 mesi (prorogabili a 12 in casi complessi). La differenza rispetto al concordato è che non c’è voto di tutti i creditori: solo i creditori che aderiscono attivamente contano per raggiungere il 60%. Ciò semplifica la procedura quando vi è un numero ridotto di creditori chiave (ad es. solo banche). Però, a differenza del concordato, i creditori estranei non subiscono riduzioni forzate: vanno soddisfatti al 100% entro certi termini.
- Varianti speciali: Il Codice della Crisi (e prima ancora varie modifiche alla legge fallimentare) ha introdotto tipologie di accordi agevolati:
- Accordo di ristrutturazione agevolato: soglia di adesione ridotta al 30% in certi casi specifici (ad esempio se l’accordo prevede solo la dilazione di pagamento e non la falcidia, e garantisce risorse ulteriori). Questo è un istituto previsto per facilitare accordi con consenso basso, ma richiede comunque che i dissenzienti vengano pagati integralmente.
- Accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII, già art. 182-septies L.F.): consente, nel caso di debiti finanziari (verso banche, intermediari), che l’accordo sia esteso anche alle banche non aderenti, se si raggiungono elevate soglie di consenso tra banche (75% del debito finanziario). È un meccanismo di cram-down settoriale: la logica è che se la stragrande maggioranza delle banche è d’accordo sulla ristrutturazione del credito, la minoranza dissenziente viene trascinata alle stesse condizioni, per evitare opportunismi. Questo strumento è utile quando ci sono molte banche coinvolte.
- Accordo su crediti fiscali e previdenziali: dal 2022 è possibile includere anche l’Erario e gli enti previdenziali negli accordi di ristrutturazione, con la possibilità di trattare (ridurre o diluire) i loro crediti. Si parla di transazione fiscale e contributiva, che viene valutata dalle Agenzie (Entrate e Riscossione per le imposte, INPS per i contributi) secondo linee guida interne. La normativa (art. 63 CCII) permette al tribunale di omologare l’accordo anche senza l’adesione formale del Fisco se il trattamento che il piano riserva ai crediti tributari è più vantaggioso di quanto otterrebbe in caso di fallimento. Questo è un importante cambio di filosofia: prima le transazioni fiscali fallivano se il Fisco non acconsentiva; ora, per evitare potere di veto, il giudice può superare il diniego del Fisco omologando comunque, purché il piano offra al Fisco almeno il valore di liquidazione dei suoi crediti (ad es. mediante perizia sul valore di beni su cui ha ipoteche).
- Effetti: Con l’omologazione, l’accordo diventa vincolante e ha alcuni effetti protettivi. I creditori aderenti devono rispettare i nuovi termini di pagamento e non possono agire esecutivamente (l’accordo costituisce novazione parziale del credito). I creditori estranei possono agire per conto loro, ma in teoria dovrebbero essere pagati come da legge (entro 120 gg etc.), quindi se il debitore rispetta quelle scadenze anche gli estranei verranno soddisfatti. È prevista un’esenzione da revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato (similmente al piano attestato). Inoltre, la pendenza delle trattative per un accordo consente al debitore di chiedere al tribunale un provvedimento di sospensione delle azioni cautelari/esecutive per tutelare il patrimonio nelle more (come accennato). Una volta omologato, l’accordo può offrire una cornice di stabilità giuridica: se il debitore rispetta i pagamenti concordati, i creditori non possono dichiararlo fallito. In caso di inadempimento, invece, l’accordo perde efficacia e i creditori riacquistano le loro azioni (a meno che non si converta magari in concordato).
Quando usare un accordo di ristrutturazione? Di solito quando l’impresa ha debiti concentrati in pochi creditori principali (es. banche) o comunque è possibile raggiungere rapidamente l’intesa col 60% di essi, e si vuole evitare la complessità del concordato preventivo (che implica coinvolgere e far votare tutti i creditori). Gli accordi sono molto impiegati per ristrutturazioni del debito bancario di grandi aziende: ad es. società immobiliari che si accordano con i pool di banche per allungare le scadenze e vendere gli immobili a valore di mercato nel tempo. Il tribunale, con l’omologa, cristallizza l’intesa e mette al riparo l’operazione da aggressioni esterne. Rispetto a un semplice accordo privato non omologato, qui il vantaggio è che l’omologa impedisce ai dissenting creditors (minoranza) di far saltare tutto: essi dovranno attendere i pagamenti come previsto e non potranno iniziare azioni esecutive, in quanto l’accordo omologato consente al debitore di opporre il divieto ex lege (art. 48 CCII, simile al vecchio art. 182-bis co.4 LF).
Un esempio concreto: Beta Spa ha 10 milioni di debiti di cui 7 verso banche (tre istituti principali) e il resto fornitori vari. Beta elabora un piano in cui le banche accettano di ridurre il debito del 20% e riscadenzarlo in 5 anni, e la proprietà conferisce nuovo capitale. I fornitori saranno pagati integralmente ma a 6 mesi dal accordo. Beta ottiene firma di tutte e tre le banche (che rappresentano il 70% del debito totale). Predispone la relazione di un attestatore che conferma che i fornitori (creditori estranei) saranno pagati per intero e che l’accordo è sostenibile. Il tribunale omologa l’accordo. Da quel momento, Beta paga i fornitori estranei a 120 giorni dall’omologa (come promesso) e inizia a pagare le rate alle banche come da accordo. Se un fornitore provasse a pignorare nel frattempo, Beta può far valere l’accordo omologato (che vieta azioni in pendenza di adempimento). Le banche rinunciano formalmente alle azioni ipotecarie finché Beta rispetta il piano. Dopo 5 anni Beta ha ridotto la sua esposizione e l’accordo si considera adempiuto. Questo strumento ha permesso di risolvere la crisi senza passare per un concordato preventivo (che sarebbe stato più complesso, dovendo far votare anche tanti piccoli fornitori).
Da notare che nel 2023-2025 la giurisprudenza ha chiarito alcuni punti sugli accordi ex L.3/2012 (che ora possiamo riferire al concordato minore, ma i principi valgono analogamente per gli accordi di ristrutturazione): ad esempio, la Cassazione ha stabilito che se dopo l’omologazione di un accordo di composizione della crisi il piano viene modificato in fase esecutiva, tutti i creditori – anche quelli già soddisfatti – devono essere nuovamente sentiti. Ciò significa che non si possono alterare unilateralmente le condizioni pattuite in corso d’opera senza coinvolgere i creditori, pena la violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, è stato ribadito che se un accordo prevede di soddisfare solo parzialmente un creditore privilegiato, per ottenere l’omologa occorre dimostrare che quella parziale soddisfazione è per lui più favorevole rispetto alle alternative (liquidazione) – in pratica, non si può falcidiare un creditore prelatizio oltre il beneficio che avrebbe da una liquidazione, a meno che egli non consenta espressamente.
In sintesi, gli accordi di ristrutturazione sono strumenti ibridi, a metà tra il piano stragiudiziale puro e il concordato: offrono maggiore libertà negoziale e riservatezza (non c’è il contraddittorio con tutti i creditori in udienza, solo omologa), ma garantiscono efficacia legale grazie all’omologa. Sono particolarmente indicati in situazioni in cui c’è urgenza di bloccare azioni esecutive mentre si finalizza un’intesa (grazie alle misure protettive concesse dal giudice) e quando l’accordo è circoscritto a pochi creditori strategici.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
La Composizione Negoziata della crisi è uno strumento innovativo, introdotto in via d’urgenza col D.L. 118/2021 (nel pieno della pandemia) e poi stabilizzato nel Codice della Crisi agli artt. 17-25-sexies CCII. Si tratta di un percorso di negoziazione assistita da un esperto indipendente, il cui scopo è aiutare l’imprenditore a trovare soluzioni per il risanamento fuori dalle aule di giustizia, ma con alcune tutele e incentivi previsti dalla legge. La composizione negoziata si colloca nel panorama come strumento di allerta/precauzionale volontario: non è obbligatorio avviarla, ma l’imprenditore che si rende conto di trovarsi in condizioni di squilibrio o di crisi è fortemente incoraggiato a farlo, potendo beneficiare di protezioni temporanee e di supporto specialistico.
Vediamo in dettaglio come funziona e quando impiegarla:
- Presupposti di accesso: Possono accedere alla composizione negoziata tutti gli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali commerciali e anche imprenditori agricoli), di qualsiasi dimensione. Sono escluse solo le imprese soggette a discipline speciali di insolvenza (banche, assicurazioni, ecc.). Non c’è un limite minimo o massimo di fatturato: dalla microimpresa alla grande azienda, chiunque può richiedere la nomina di un esperto. L’unica condizione oggettiva è che l’impresa si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, oppure sia già in stato di crisi o insolvenza reversibile. In pratica la porta è aperta sia in caso di difficoltà incipiente (quando l’impresa non è ancora insolvente ma ha forti tensioni finanziarie), sia in caso di crisi conclamata o perfino insolvenza a patto però che vi sia ancora una chance concreta di risanamento. Se l’insolvenza è irreversibile, l’esperto potrà solo constatare l’assenza di prospettive e chiudere la composizione (infatti i dati ci dicono che circa il 35% delle composizioni viene chiuso subito per assenza di prospettive di risanamento). L’accesso è volontario e su iniziativa esclusiva dell’imprenditore: nessun creditore può attivare la composizione negoziata (a differenza di quanto era previsto per le procedure di allerta obbligatorie, poi abrogate). Questo incentiva l’imprenditore virtuoso a muoversi per tempo.
- Procedura di nomina dell’esperto: L’imprenditore deve presentare un’istanza tramite la Piattaforma Telematica Nazionale per la composizione negoziata, accessibile dal sito di Unioncamere (attiva dal 15 novembre 2021). Sulla piattaforma, dopo essersi autenticato (tramite SPID/CNS), l’imprenditore compila un modulo inserendo informazioni sull’azienda, sulle cause della crisi, sugli obiettivi sperati (es. rinegoziare il debito, trovare nuovi soci, vendere rami d’azienda, ecc.), e allega una serie di documenti (ultimi bilanci, situazione debitoria dettagliata, elenco creditori, relazione sulla situazione economica, ecc.). Viene anche richiesto di caricare un piano di risanamento ipotetico o quanto meno delle linee guida su come si potrebbe risolvere la crisi, e la cosiddetta check-list predisposta dal Ministero (un questionario volto a verificare le aree di criticità e le misure possibili). L’imprenditore può preliminarmente svolgere sempre sulla piattaforma un test pratico di autodiagnosi, inserendo alcuni dati contabili per avere un responso automatico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento. Questo test non vincola, ma serve ad orientare (esito verde, giallo o rosso). Una volta inviata l’istanza, la Camera di Commercio forma un piccolo panel che individua l’esperto adatto, pescandolo dall’Albo degli esperti tenuto dal Ministero della Giustizia (dove sono iscritti commercialisti, avvocati, consulenti con almeno 5 anni esperienza in materia concorsuale). L’esperto viene nominato entro 5 giorni da una commissione regionale, sulla base di criteri di competenza nel settore dell’impresa richiedente.
- Fase delle trattative: Accettato l’incarico, l’esperto convoca l’imprenditore a un primo incontro per esaminare la situazione. Quindi, d’intesa con l’imprenditore, convoca i principali creditori (es. banche, fornitori strategici, fisco) per avviare le negoziazioni. La legge stabilisce che tutto si svolge in modo riservato: l’apertura della composizione non è pubblica salvo che il debitore chieda misure protettive, nel qual caso l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese. L’esperto ha poteri limitati ma significativi: può richiedere al debitore di fornire documenti e informazioni, sollecitare i creditori a partecipare e a formulare proposte, e redige verbali periodici. Egli deve favorire il raggiungimento di una soluzione concordata. Alle riunioni può fare proposte o mediazioni. La durata iniziale delle trattative è di 3 mesi, prorogabili di altri 3 a discrezione dell’esperto (oltre i 6 mesi serve il consenso del debitore e dell’esperto). Il debitore, durante questa fase, mantiene la gestione ordinaria dell’impresa ma deve astenersi da atti che possano pregiudicare i creditori (ad es. non può aggravare la sua esposizione; eventuali atti straordinari devono essere comunicati all’esperto, e se li sconsiglia apertamente e il debitore li fa lo stesso, l’esperto può dimettersi chiudendo la procedura).
- Misure protettive e cautelari: Uno dei vantaggi cruciali per cui un imprenditore si rivolge alla composizione negoziata è la possibilità di ottenere una protezione temporanea dalle azioni dei creditori. Il debitore, già nella domanda iniziale o anche successivamente, può chiedere al tribunale competente la concessione di misure protettive: tipicamente si tratta del divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore per tutta la durata delle trattative (di regola 4 mesi, prorogabili). Il tribunale, verificati sommariamente i presupposti (gravità situazione e utilità di negoziare), emette un decreto di concessione della protezione, che viene pubblicato nel Registro delle Imprese. Da quel momento, nessun nuovo pignoramento può essere avviato e quelli in corso subiscono una sospensione. Attenzione: come chiarito da Cassazione, il giudice della composizione non può lui stesso dichiarare improcedibili o nulli i pignoramenti pendenti, ma spetta ai singoli giudici dell’esecuzione sospenderli su istanza parte, una volta informati del divieto. In pratica però il risultato è un automatic stay simile a quello del concordato preventivo, che congela le azioni aggressive e dà respiro al debitore mentre negozia. Si possono chiedere anche misure cautelari specifiche, ad esempio per ottenere provvedimenti urgenti sui contratti in corso (sospensione di forniture essenziali per morosità pregressa, ecc.). Le misure protettive, tuttavia, non possono eccedere 12 mesi totali. Dai dati Unioncamere risulta che la stragrande maggioranza delle istanze di composizione negoziata include la richiesta di misure protettive (circa il 74%), segno che le imprese vi ricorrono soprattutto quando hanno urgenza di bloccare i creditori (p.es. evitare un’asta immobiliare imminente o il distacco di utenze per morosità).
- Esito della composizione: La composizione negoziata non ha un esito prestabilito unico – è un percorso che può sfociare in diversi sbocchi, a seconda di ciò che le parti riescono a concordare. In particolare, entro la scadenza del periodo (massimo 6 mesi salvo proroghe straordinarie), si possono verificare varie situazioni:
- Accordo stragiudiziale con i creditori: se le trattative hanno successo, l’imprenditore e uno o più creditori possono concludere contratti o accordi bilaterali che risolvono la crisi. Ad esempio, la banca concede nuovi finanziamenti o riscadenzamenti, fornitori strategici accettano riduzioni del credito, un investitore entra nel capitale. Il tutto viene formalizzato privatamente (contratti ex art. 23 comma 1 lett. a CCII). In 22 casi (su 79 di esito positivo rilevati al 15/10/2023) si è avuta la conclusione di contratti di questo genere. Tali accordi non necessitano di omologa e rimangono riservati. La composizione negoziata si chiude dunque con un nulla di fatto giudiziario ma con un successo sostanziale: l’azienda esce dalla crisi grazie agli accordi ottenuti. Per esempio, Tizio SRL ottiene dalle banche una moratoria di 24 mesi e in parallelo cede un ramo d’azienda a un competitor; l’esperto verifica che questo risolve la crisi e redige una relazione finale positiva. La procedura si chiude e Tizio SRL prosegue l’attività risanata.
- Accordo di ristrutturazione ex art. 23 comma 1 lett. c: le parti possono decidere di formalizzare la soluzione nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti da sottoporre all’omologazione del tribunale (strumento che abbiamo descritto prima). In pratica, la composizione negoziata può fungere da trampolino per costruire un accordo 182-bis/CCII. In 30 casi su 79 di esiti positivi, si è arrivati proprio al deposito di un accordo in tribunale per l’omologa. Questo consente di coinvolgere anche eventuali creditori estranei e di dare forza esecutiva all’intesa. L’esperto in tal caso redige la relazione finale e, su richiesta del debitore, il tribunale omologa l’accordo seguendo il suo iter (nel frattempo la protezione può essere mantenuta).
- Piano attestato di risanamento: similmente, la composizione può concludersi con la messa a punto di un piano attestato (ex art. 56 CCII) attestato e pubblicato. Questo è un esito favorevole (anche se di natura diversa dall’accordo omologato). Spesso l’esperto orienta il debitore verso questa soluzione se ritiene che i creditori chiave siano collaborativi e basti una sistemazione negoziale unilaterale.
- Concordato preventivo o altre procedure: se la negoziazione evidenzia che serve coinvolgere tutti i creditori e magari imporre sacrifici anche ai dissenzienti, l’imprenditore – con la guida dell’esperto – può predisporre un concordato preventivo o un’altra procedura di insolvenza (es. concordato semplificato di cui infra). In 14 casi su 79, la composizione è sfociata nell’accesso ad altre procedure di regolazione della crisi (ad esempio concordato in continuità). In tali situazioni, il vantaggio è che l’esperto ha già raccolto informazioni e instaurato un dialogo coi creditori, quindi la procedura concorsuale parte avvantaggiata. La legge consente espressamente che l’esperto, se le trattative falliscono, suggerisca al debitore le soluzioni percorribili (compreso il concordato o la liquidazione) e lo inviti a depositare domanda entro termini brevi, beneficiando eventualmente di esenzioni di responsabilità (per dire: se il debitore segue le indicazioni e deposita concordato, non potrà essergli imputata mala gestio per aver tardato).
- Concordato semplificato per la liquidazione: Questo è uno strumento particolare, previsto dall’art. 25-sexies CCII, attivabile solo se la composizione negoziata fallisce nel trovare un accordo. Se l’esperto dichiara nella sua relazione finale che nonostante gli sforzi non è stato possibile trovare soluzioni di risanamento, ma esiste una prospettiva di liquidazione del patrimonio che possa comunque soddisfare i creditori meglio di un fallimento, allora entro 60 giorni il debitore può proporre al tribunale un concordato semplificato liquidatorio. Si chiama semplificato perché non prevede il voto dei creditori: il tribunale valuta la proposta (che deve assicurare una certa utilità a ciascun creditore rispetto alla liquidazione giudiziale) e, sentiti eventualmente i creditori in camera di consiglio, può omologarla anche senza consenso di tutti. È una sorta di via d’uscita per evitare la liquidazione giudiziale pura, consentendo al debitore di gestire la liquidazione sotto il controllo del tribunale e con eventuale prosecuzione temporanea dell’attività per massimizzare i valori. Il concordato semplificato è dunque accessibile solo come esito negativo della composizione negoziata – il legislatore l’ha voluto per incentivare i debitori a tentare comunque la negoziazione (sapendo che male che vada c’è questa ancora di salvezza). Va però sottolineato che, essendo un concordato liquidatorio senza voto, esso richiede particolare rigore: il piano deve garantire che i creditori non vengano danneggiati (si parla di soddisfacimento non inferiore al 20% per chirografari di regola, salvo esenzioni).
- Archiviazione per assenza di prospettive: come già accennato, una parte delle composizioni negoziate si chiude senza uno sbocco, semplicemente con una relazione negativa dell’esperto. Dai dati: su 405 procedure chiuse entro ott.2023, circa il 35% sono state archiviate subito per mancanza di prospettive concrete di risanamento; un altro 35% circa per conclusione negativa delle trattative (non si è raggiunto accordo); e un 10% per rinuncia del debitore. In questi casi, l’imprenditore dovrà inevitabilmente considerare le procedure concorsuali ordinarie (liquidazione giudiziale, ecc.). Va però detto che aver tentato la composizione non è tempo perso: il debitore “in buona fede” che prova la negoziazione gode di qualche beneficio, ad esempio in termini di esenzioni di responsabilità per gli amministratori (non è considerato colpevole di ritardo). Inoltre, durante la composizione, se ha rispettato le regole, non maturano determinate sanzioni (per esempio, le imprese in composizione negoziata possono accedere a dilazioni fiscali straordinarie).
- Misure premiali: Per rendere appetibile la composizione negoziata, sono previste alcune agevolazioni per chi vi accede. Ad esempio, il D.L. 118/2021 introdusse la possibilità per le parti di finanziamenti erogati durante la composizione di essere considerati prededucibili in caso di successivo fallimento (quindi chi presta denaro all’impresa in composizione sarà soddisfatto con priorità). Inoltre, il D.L. 118 sospese temporaneamente alcune cause di scioglimento societario (riduzione capitale sotto minimo) se la società era in composizione, per evitare che scattassero obblighi di liquidazione. Più di recente, la Legge 31/2023 (che ha convertito D.L.13/2023) ha previsto un’importante misura premiale fiscale: l’impresa che sta seguendo la composizione negoziata può ottenere dal Fisco un piano di rateazione straordinario fino a 120 rate mensili (10 anni) per i debiti tributari iscritti a ruolo. Normalmente la dilazione massima è 72 rate (6 anni), quindi questa è una concessione notevole riservata a chi dimostra di essere in composizione negoziata e in grave difficoltà. Ciò permette di alleggerire la pressione del Fisco durante il risanamento. Analoghe estensioni sono previste per i contributi previdenziali. Ancora, con D.Lgs. 136/2024, queste misure premiali sono state rese strutturali: oggi l’impresa in composizione negoziata può chiedere ed ottenere dal fisco piani decennali se l’esperto attesta che servono per il risanamento. Un altro incentivo: gli amministratori che avviano la composizione negoziata prima di essere insolventi conclamati, vedono attenuate eventuali responsabilità civili (perché stanno tentando di evitare il peggio). Anche sul fronte “penale”, la legge prevede una causa di non punibilità per il reato di bancarotta preferenziale nel caso di atti compiuti nell’ambito della composizione negoziata autorizzati dall’esperto (evita che dei pagamenti fatti per necessità durante le trattative siano poi considerati preferenze penalmente rilevanti, purché funzionali al piano).
In definitiva, la composizione negoziata è da considerare come il primo canale da esplorare quando un’impresa è in crisi ma non vuole arrendersi alla liquidazione: offre un contesto controllato per negoziare con i creditori, mettendo a disposizione un mediatore esperto e congelando nel frattempo le azioni esecutive. I numeri dimostrano che un numero crescente di imprese la sta utilizzando con profitto: nel solo anno 2024 vi è stato un boom di richieste (+926 istanze rispetto all’anno precedente) e l’Osservatorio riporta un tasso di successo (esiti favorevoli su procedura chiuse) del 16% circa nel 2023, in crescita col tempo. Può sembrare poco, ma va considerato che molte imprese arrivano tardi quando la situazione è disperata; quelle che la attivano per tempo hanno chance ben maggiori. Inoltre, un esito positivo in composizione negoziata spesso salva decine o centinaia di posti di lavoro (oltre 10mila lavoratori salvati finora grazie a questo strumento).
Esempio pratico: Gamma S.p.A., industria meccanica con 100 dipendenti, subisce un forte calo di liquidità per l’aumento dei costi energetici e un investimento sbagliato. Ha debiti verso banche (€5M) e fornitori (€3M). Nel 2024 si rende conto che senza un intervento finirà insolvente entro 6 mesi. Gli amministratori accedono a composizione negoziata tramite piattaforma. Viene nominato un esperto. Gamma chiede e ottiene subito misure protettive: blocca temporaneamente i pignoramenti dei fornitori insoddisfatti. L’esperto analizza e propone: vendere un impianto inutilizzato per far cassa, trovare un partner finanziario e convincere le banche a rinegoziare il debito su 7 anni. Dopo 4 mesi di incontri, le banche (grazie anche al fatto che l’esperto attesta un valore di realizzo basso in caso di fallimento) accettano di allungare le scadenze e ridurre i tassi, un investitore locale mette nuovi fondi per €1M (con cui Gamma paga i fornitori piccoli integralmente e ottiene lo sblocco delle forniture cruciali). Gli elementi dell’accordo vengono formalizzati in un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale. Gamma esce dalla procedura: i pignoramenti decadono, l’azienda continua l’attività con meno debito e più capitale. I dipendenti conservano il lavoro. Questo scenario positivo è frutto della negoziazione assistita: senza, Gamma forse sarebbe finita in fallimento con vendita all’asta degli impianti (valore di realizzo molto inferiore).
Accordi stragiudiziali informali
Accanto agli strumenti normati, non va dimenticato che esiste sempre la possibilità di una trattativa stragiudiziale “pura” con i creditori, senza attivare procedure. Un imprenditore in crisi può contattare individualmente i propri creditori (specialmente quelli principali) e cercare di convincerli a una ristrutturazione volontaria dei debiti. Ad esempio, può proporre ai fornitori un “saldo e stralcio” (pagare il 50% del dovuto subito in cambio della liberazione dal restante), oppure alle banche di prorogare le scadenze e capitalizzare gli interessi. Questi accordi privati non seguono schemi legali prestabiliti: sono semplici contratti bilaterali o plurilaterali di natura civilistica (transazioni, novazioni, patti). Il vantaggio è la massima flessibilità e riservatezza, oltre all’assenza di costi procedurali o tempi di tribunale. Tuttavia, presentano forti limiti:
- Non legano eventuali creditori non partecipanti: basta un creditore che non accetti per poter agire e magari far fallire il debitore, frustrando gli sforzi negoziali.
- Non offrono protezioni legali durante la trattativa: se un creditore firma un accordo stragiudiziale nulla impedisce a un altro di pignorare i beni del debitore nel frattempo, indebolendo la capacità di rispettare gli accordi.
- Non beneficiano di esenzioni da revocatoria: se poi l’impresa fallisce, i pagamenti fatti a taluni creditori stralciando i debiti potrebbero essere revocati dal curatore come atti di favore.
- Rischio di incoerenza e contestazioni: accordi separati con creditori diversi potrebbero essere incoerenti tra loro o generare conflitti (ad es. un creditore che scopre di aver accettato condizioni peggiori di un altro potrebbe reagire).
In pratica, gli accordi stragiudiziali informali funzionano soprattutto in situazioni semplici, con pochi creditori e magari di natura non eterogenea. Esempio: un piccolo commerciante con debiti solo verso 5 fornitori può sedersi al tavolo e proporre: “vi pago il 70% a 6 mesi, altrimenti fallisco e prendereste forse 30%”. Se tutti accettano, si formalizza un accordo privato (magari con quietanza finale a saldo e stralcio). Se l’imprenditore onora i pagamenti, la crisi è risolta. Tuttavia, si capisce che mano a mano che crescono numero e varietà di creditori, tale strada diventa impraticabile. Per questo il legislatore ha creato i succitati strumenti (accordi di ristrutturazione omologati, concordati, ecc.) che vincolano anche la minoranza dissenziente in forza di una procedura legale.
In conclusione, la trattativa libera one-to-one con i creditori è sempre possibile e spesso rappresenta il primo tentativo di ogni debitore (magari con l’assistenza di un advisor finanziario che predispone un piano e lo sottopone confidenzialmente alle banche). Se riesce, tanto meglio: si risolve la crisi senza pubblicità. Se però non riesce con tutti, il debitore deve essere pronto a “istituzionalizzare” la soluzione attraverso uno degli strumenti giuridici sopra discussi, così da superare l’opposizione di eventuali creditori recalcitranti.
Nota: Spesso, in pratica, i confini sono sfumati. Un buon professionista proverà un approccio graduale: prima contatta i creditori informando di voler trovare un accordo bonario; in parallelo magari avvia la composizione negoziata come cornice protettiva; se c’è sufficiente adesione formalizzerà un accordo 182-bis; se no ripiegherà sul concordato. L’importante per il debitore è non restare inerte: la proattività nelle trattative (formali o informali) è vista di buon occhio anche dai tribunali. Ad esempio, la Cassazione in una recente ordinanza ha sottolineato l’interesse dei creditori a partecipare e, se del caso, opporsi tempestivamente in sede di ammissione alle procedure di soluzione della crisi, proprio per evitare che un debitore in malafede le usi dilatoriamente. Ma quando invece c’è trasparenza e sforzo genuino, i giudici spesso concedono margine al debitore.
Ora che abbiamo esplorato gli strumenti “alternativi” alla giustizia tradizionale (piani attestati, accordi, composizione negoziata, trattative private), passiamo alle procedure giudiziali classiche di gestione della crisi e dell’insolvenza: in primis il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale, e poi le procedure minori per chi non può fallire.
Procedure giudiziali di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Quando la crisi aziendale non può essere risolta soltanto con accordi volontari – o quando si preferisce comunque la certezza di una soluzione sancita dall’autorità giudiziaria – occorre fare ricorso alle procedure concorsuali previste dalla legge. Queste procedure implicano l’intervento del tribunale e l’applicazione di regole formali (pubblicità legale, nomina di organi, rispetto di graduatorie di crediti, ecc.). Anche se possono sembrare più onerose, presentano vantaggi determinanti: vincolano tutti i creditori, offrono un quadro normativo stabilizzato (moratoria generalizzata, possibilità di imporre tagli ai crediti con l’approvazione a maggioranza, ecc.) e consentono di gestire situazioni complesse con trasparenza e controllo giudiziario. Dal punto di vista del debitore, scegliere una procedura giudiziale significa spesso cedere una parte del controllo (specie nella liquidazione) ma può risultare l’unica via per risolvere definitivamente l’indebitamento.
Esaminiamo le principali procedure concorsuali dal punto di vista del debitore:
Concordato Preventivo
Il concordato preventivo è storicamente la procedura attraverso cui l’imprenditore insolvente (o in procinto di insolvenza) cerca di evitare il fallimento, proponendo un accordo ai propri creditori sotto la supervisione del tribunale. Nel Codice della Crisi, il concordato preventivo mantiene questo ruolo, con qualche innovazione. Si tratta di una procedura concorsuale in senso proprio: tutti i creditori vengono coinvolti, suddivisi in classi se opportuno, e chiamati a votare una proposta di concordato formulata dal debitore stesso.
Tipologie e caratteristiche:
- Il concordato può essere in continuità aziendale (se prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, direttamente o indirettamente tramite cessione d’azienda) oppure liquidatorio (se prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione del patrimonio ai fini del pagamento dei creditori). Questa distinzione è importante perché le regole differiscono: ad esempio, un concordato puramente liquidatorio deve garantire per legge un pagamento minimo del 20% ai creditori chirografari, mentre un concordato con continuità non ha tale soglia minima (in quanto mira a salvare l’azienda e i posti di lavoro, quindi è tollerato anche un pagamento minore se la continuità apporta benefici indiretti). In ogni caso, la proposta deve assicurare che i creditori ottengano non meno di quanto avrebbero dalla liquidazione giudiziale del debitore (principio del miglior soddisfacimento).
- Iniziativa: Può proporre concordato l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza. È una procedura volontaria (a differenza della liquidazione giudiziale che può essere chiesta anche dai creditori). La domanda si presenta con ricorso al tribunale. È anche ammessa la domanda in bianco (concordato con riserva): il debitore deposita un ricorso privo di piano dettagliato ma con l’impegno a presentarlo entro un termine (fino a 120 giorni). Questo serve per proteggersi subito dai creditori mentre si perfeziona la proposta.
- Effetti dell’ammissione: Il tribunale, valutati i requisiti, ammette il debitore al concordato e nomina un Commissario Giudiziale. Da quel momento, si apre la fase di protezione: ai sensi dell’art. 54 CCII (già art. 168 L.F.), dalla data di pubblicazione del ricorso concordatario nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari né acquisire titoli di prelazione sul patrimonio del debitore. È il cosiddetto automatic stay totale. Gli eventuali procedimenti esecutivi pendenti rimangono sospesi; eventuali pignoramenti di crediti presso terzi diventano inefficaci se non è stata già fatta l’assegnazione. Questo blocco generale offre al debitore respiro e tutela la par condicio. Inoltre, i contratti in corso di esecuzione proseguono (salvo facoltà di scioglimento con autorizzazione). La gestione dell’impresa durante il concordato rimane in capo al debitore (debitor in possession), ma sotto vigilanza del commissario e con alcuni limiti sugli atti di straordinaria amministrazione (necessaria autorizzazione del giudice delegato). Se il debitore non rispetta le regole o aggrava il dissesto, il tribunale può revocare il concordato e aprire la liquidazione giudiziale d’ufficio.
- Proposta e classi: Entro i termini, il debitore deve presentare un piano concordatario corredato dalla relazione di un attestatore indipendente che certifichi la fattibilità del piano e la veridicità dei dati (analoga figura all’attestatore del PAR, ma qui nominato autonomamente dal debitore in fase di preparazione). Il piano enuncia come si intende trattare ciascuna categoria di creditori: chi viene pagato e in quale misura/tempi, chi subisce stralci, quali eventuali garanzie o asset vengono destinati. I creditori possono essere suddivisi in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei (es. una classe di banche ipotecarie, una di fornitori chirografari strategici, ecc.). La proposta può prevedere anche interventi di terzi (un assuntore che si accolla il debito, una newco, ecc.). Nei concordati in continuità spesso la proposta prevede che i creditori vengano soddisfatti col ricavato futuro della gestione (in tal caso serve specificare piani industriali, investimenti, etc.). Nei concordati liquidatori, la proposta indica quali beni saranno venduti e come ripartirne il ricavato. Spesso viene proposto ai chirografari un pagamento % a stralcio. Come detto, la percentuale ai chirografari se <20% è ammessa solo se c’è continuità aziendale; se è un puro liquidatorio, deve essere almeno 20% (a meno di cause eccezionali autorizzate). Il piano può anche prevedere moratorie fino a 2 anni per i creditori privilegiati se c’è continuità (mentre sotto L.F. c’era il limite di 1 anno; ora la Cassazione ha ammesso dilazioni più lunghe anche per piani del consumatore, purché i creditori abbiano diritto di esprimersi). Nel concordato in continuità, la legge oggi impone che i lavoratori vengano pagati integralmente (TFR e stipendi) salvo diverse intese sindacali.
- Votazione dei creditori: Una volta depositato il piano e verificata la sua ammissibilità, il tribunale apre la fase di votazione. Ogni classe di creditori aventi diritto al voto (esclusi i privilegiati che vengono soddisfatti integralmente e altri esclusi per legge) è chiamata ad esprimersi sulla proposta. Serve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza in valore, calcolata sul totale dei crediti di chi ha votato, con quorums differenti se classi). Se ci sono più classi, serve il voto favorevole della maggioranza delle classi. Esistono meccanismi di cram-down: se una classe dissente ma il tribunale ritiene la proposta conveniente per essa e almeno un’altra classe di pari rango ha detto sì, si può comunque approvare (art. 112 CCII). La votazione avviene in adunanza dei creditori o per mezzi telematici/lettera (specie se molti creditori). Il commissario raccoglie i voti e riferisce l’esito.
- Omologazione: Se i creditori approvano, il tribunale procede a omologare il concordato con sentenza, verificando legalità e fattibilità. I creditori dissenzienti rimangono comunque vincolati dalla sentenza di omologa: i loro crediti verranno trattati come da piano, anche se votarono contro. Se invece la maggioranza non si raggiunge, il concordato non è approvato e il tribunale dichiara in genere il fallimento (salvo ricorrere a eventuali ipotesi di cram-down o conversione in liquidazione controllata se piccola impresa, ecc.). Durante l’omologa i creditori possono proporre opposizioni (es. contestare la convenienza). Se omologato definitivamente, il concordato preventivo diventa il “contratto” che regola il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali. L’impresa ne esce sollevata dai debiti eccedenti quanto previsto. In caso di inadempimento successivo, i creditori possono chiedere risoluzione del concordato e eventuale fallimento.
Dal punto di vista del debitore, il concordato preventivo è una procedura impegnativa ma può essere salvifica: consente di ristrutturare pesantemente il debito anche contro il volere di una minoranza di creditori, mantenendo magari l’impresa in vita. Certo, comporta trasparenza totale (tutti i creditori vengono a conoscenza della situazione), costi (spese legali, compenso del commissario, ecc.) e la necessità di convincere almeno una larga fetta di creditori. Se l’alternativa è il fallimento, però, quasi sempre vale la pena tentare un concordato. Spesso i debitori usano lo strumento anche solo per congelare la situazione e poi trovare soluzioni alternative (ad esempio presentano un concordato in bianco e poi chiudono accordi stragiudiziali, per poi rinunciare al concordato una volta risolta la crisi con quell’escamotage – pratica non ortodossa ma talvolta usata).
La Cassazione ha negli anni affermato vari principi a tutela dei creditori nel concordato: ad esempio che i creditori privilegiati, se la proposta li paga meno del 100%, devono poter esercitare il controllo di convenienza (contestare che forse otterrebbero di più in fallimento). Con il Codice, alcune di queste regole sono state codificate. Inoltre, una pronuncia recente (Cass. Sez.Un. 8500/2021) ha chiarito che il tribunale può sindacare la fattibilità solo in termini di fattibilità giuridica, non di fattibilità economica (cioè non può respingere una proposta perché la ritiene improbabile, se però è ben attestata; solo se è proprio irrealizzabile giuridicamente la può bocciare).
Dunque, quando rivolgersi al concordato preventivo? In generale quando la crisi è già grave (insolvenza o quasi) ma c’è la volontà di evitare la liquidazione giudiziale, o perché si vuole salvare l’azienda (concordato in continuità) o perché si preferisce gestire la liquidazione in modo concordato (concordato liquidatorio che magari prevede la cessione di beni a valori migliori che in asta). Il concordato è inevitabile quando ci sono troppi creditori per gestirli con accordi stragiudiziali, o quando servono effetti erga omnes. Ad esempio, se l’impresa ha 200 fornitori chirografari e può offrire solo il 30% sul loro credito, l’unica via è il concordato: con l’approvazione a maggioranza, anche i contrari saranno obbligati ad accontentarsi del 30% (ricevendo poi l’esdebitazione sul resto).
Un aspetto delicato: il trattamento dei garanti e coobbligati. Se la società fa concordato e paga solo una percentuale ai creditori, i fideiussori personali (es. i soci garanti) restano obbligati per il resto. Il concordato infatti non libera i terzi garanti a meno che la proposta non preveda espressamente qualcosa per loro (ma di solito no). Questo implica che spesso gli imprenditori-soci garantiscono di tasca propria quell’adempimento parziale per convincere i creditori a votare sì (di fatto pagano il “dividendo” concordatario). Nelle procedure di sovraindebitamento, invece, è stato previsto (con L.176/2020) che l’accordo di composizione dei debiti di una società si estenda ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali, ma la Cassazione ha chiarito che ciò vale solo per i debiti sociali e non per quelli personali del socio. Quindi, in generale, chi presta garanzie deve muoversi in parallelo (magari presentando anch’egli un proprio concordato se persona fisica, o trovando accordi).
Liquidazione Giudiziale (già Fallimento)
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale che sostituisce il “fallimento” tradizionale. Rappresenta la soluzione liquidatoria per eccellenza: quando un’impresa è insolvente in modo irreversibile o non vi sono proposte concordatarie praticabili, il tribunale – su istanza di un creditore, del debitore stesso o d’ufficio in certi casi – apre questa procedura finalizzata a liquidare tutto il patrimonio del debitore e ripartirne il ricavato tra i creditori secondo le regole della graduatoria dei crediti.
Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale è certamente l’esito meno desiderabile, in quanto comporta la spoliazione della gestione e spesso la cessazione dell’attività. Tuttavia, va evidenziato che con la riforma sono stati introdotti meccanismi di tutela della persona del debitore, in particolare l’esdebitazione finale (la liberazione dai debiti residui onesti) e una riduzione dello stigma (non si parla più di “fallito” con i divieti correlati). Per le società, la liquidazione giudiziale comporta la loro estinzione una volta chiusa la procedura (salvo riaperture se emergono attivi).
Caratteristiche essenziali della liquidazione giudiziale:
- Presupposti: L’insolvenza del debitore assoggettabile. Sono soggetti a liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali non piccoli (quindi quelli sopra le soglie di cui all’art. 2 lett. d CCII), e le società commerciali di qualunque dimensione. Le imprese minori (attivo ≤300k, ricavi ≤200k, debiti ≤500k) sono escluse e vanno nelle procedure di sovraindebitamento. Anche gli imprenditori agricoli sono esclusi (salvo che optino per procedure sovraindebitamento). L’insolvenza va accertata dal tribunale. Di regola un creditore presenta istanza (per importi non futili), oppure un pubblico ministero in certi casi, o lo stesso debitore se vuole autodenunciarsi insolvente (pochi lo fanno). Accertata l’insolvenza (inadempimenti, protesti, pignoramenti infruttuosi), il tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.
- Effetti: La sentenza di liquidazione giudiziale provoca immediatamente la spossessamento: il debitore (persona fisica o organi della società) perde la gestione ed amministrazione dei propri beni, che passano in mano al Curatore nominato dal tribunale. Il debitore conserva la sola titolarità giuridica (nel senso che rimane proprietario finché non venduti, ma non può disporre di nulla). Gli atti dispositivi compiuti dal debitore dopo la sentenza sono nulli. Si forma una massa attiva (i beni) e una massa passiva (l’insieme dei crediti). I creditori devono presentare domanda di insinuazione al passivo entro termini stabiliti (generalmente 30-60 giorni). Tutte le azioni individuali sono bloccate (divieto ex art. 150 CCII, ex art. 51 L.F.). I crediti anteriori restano cristallizzati alla data di apertura e saranno soddisfatti solo in sede concorsuale. Gli eventuali contratti in corso potranno essere sciolti o proseguiti su decisione del curatore (con equo indennizzo per la controparte se sciolti). Insomma, l’impresa come entità economica di solito cessa la sua attività, salvo che il curatore eserciti l’azienda provvisoriamente se utile (lo può fare in vista di cessione a terzi, ad esempio).
- Organizzazione: Il tribunale nomina oltre al curatore anche un Giudice Delegato che sovrintende la procedura e un Comitato dei Creditori (3 membri rappresentativi delle varie categorie) che autorizza alcune operazioni. Il curatore redige l’inventario dei beni e lo stato passivo (elenco crediti ammessi e relative categorie: prededucibili, privilegiati, chirografari). Dopo eventuali impugnazioni, lo stato passivo diviene definitivo. Quindi il curatore procede a liquidare attivo: vendite all’asta degli immobili, cessione dell’azienda o rami (se possibile), incasso crediti, ecc. Il ricavato viene distribuito secondo le regole: prima i creditori prededucibili (ad es. spese di procedura, finanziamenti post, ecc.), poi i privilegiati (per grado) e infine i chirografari in proporzione.
- Durata: Può variare da pochi anni a molti, a seconda della complessità. Ci sono liquidazioni rapide (se poche risorse) e altre che durano decenni (in passato). Il Codice spinge per chiusure più rapide. Una volta esaurito l’attivo, il curatore presenta il rendiconto finale e si chiude la procedura.
- Esdebitazione: Una delle innovazioni più rilevanti per il debitore persona fisica (imprenditore individuale, socio illimitatamente responsabile) è la esdebitazione di diritto a fine liquidazione. Già la L.F. prevedeva che il fallito persona fisica potesse chiedere la cancellazione dei debiti residui se avesse cooperato lealmente (art. 142 L.F.), ma non era automatica. Il Codice ora dispone che l’esdebitazione del debitore persona fisica meritevole avviene in modo (quasi) automatico al termine della procedura, salvo eccezioni, liberandolo dai debiti concorsuali non soddisfatti. Inoltre, come accennato, esiste anche una forma di esdebitazione anticipata per il debitore incapiente (senza beni), però questa si applica più nel contesto sovraindebitamento. Nel fallimento classico, comunque, la liberazione dal debito residuo è oggi considerata parte integrante della fresh start: quindi il piccolo imprenditore che fallisce non resterà debitore a vita, ma potrà ripartire pulito (a patto di non aver frodato, di aver cooperato, ecc.). La Cassazione ha recentemente confermato che l’esdebitazione non può essere concessa se il debitore ha tenuto comportamenti ostativi, ma in generale tende ad interpretarla estensivamente come strumento di reinserimento.
- Conseguenze personali: Nel passato il fallito subiva sanzioni personali (divieti di ricoprire cariche, limiti ai diritti civili, ecc.). Molte di queste sono state eliminate. Rimane l’annotazione nel registro imprese e alcuni effetti ad es. sui requisiti per partecipare a gare o amministrare altre imprese in futuro, ma molto attenuati nel tempo.
In sostanza, la liquidazione giudiziale rappresenta l’extrema ratio: quando l’azienda non è più risanabile, o quando i creditori non si fidano di una proposta concordataria, allora si procede a smantellare l’impresa sotto controllo giudiziario. Dal punto di vista del debitore/imprenditore, rivolgersi volontariamente al tribunale per la liquidazione (quello che si chiamava “autofallimento”) è una scelta dolorosa ma talvolta necessaria: serve a evitare ulteriori agonie, cristallizza la situazione e avvia il percorso verso l’esdebitazione.
Si noti che se un imprenditore in crisi non prende alcuna iniziativa e lascia aggravare l’insolvenza, rischia che siano i creditori a chiederne la liquidazione giudiziale. In tal caso il controllo gli sfugge completamente. Invece, se intravede di non poter salvare l’azienda, una mossa saggia può essere quella di presentare comunque lui istanza di liquidazione (o quantomeno di non opporsi e cooperare), in modo da beneficiare di un trattamento più benevolo (ad esempio maggiore probabilità di ottenere l’esdebitazione e minori rischi penali, perché la cooperazione è un attenuante).
Esempio pratico: Delta S.n.c., piccola azienda commerciale sopra soglia, accumula €800k di debiti ed è insolvente. Nessuna proposta di concordato è fattibile. Un creditore fornitore presenta istanza di liquidazione giudiziale. Il tribunale dichiara la procedura: i due soci perdono la gestione dei beni sociali e personali relativi. Un curatore inventaria: c’è solo un magazzino e un capannone. Vende il magazzino e realizza €300k, che distribuisce tra banche ipotecarie (che ne ricavano il 50% dei loro crediti) e nulla ai chirografari. Dopo due anni, la procedura chiude, i soci ottengono l’esdebitazione (erano meritevoli) e i loro debiti residui verso fornitori vengono cancellati. L’attività ovviamente cessa. Qui la liquidazione giudiziale ha operato come “funerale ordinato” dell’impresa, e i soci possono eventualmente aprire una nuova attività senza il fardello passato.
Altre procedure speciali (cenni)
Nel sistema italiano esistono anche procedure concorsuali speciali riservate a determinati tipi di imprese in crisi:
- La Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA), applicabile a enti e imprese particolari (banche, assicurazioni, cooperative, etc.), è una liquidazione concorsuale gestita da autorità amministrative di settore più che dal tribunale. I principi sono simili alla liquidazione giudiziale ma con normative ad hoc (ad esempio Banca d’Italia per banche). Dal punto di vista del debitore, raramente l’imprenditore può “scegliere” di finirvi: sono situazioni eterodirette (es. banca insolvente viene messa in LCA dal Ministero).
- L’Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi (Legge Prodi, Marzano) è un istituto per aziende con almeno 200 dipendenti e grandi debiti, che consente, invece di liquidare subito, di tentare il risanamento o la cessione a terzi mantenendo la continuità. È famosa per casi come Alitalia, Parmalat, ILVA. Viene avviata dal Governo (Mise) e gestita da commissari straordinari. Non è attivabile su iniziativa spontanea dell’imprenditore (salvo richiesta al Ministero).
- Concordato di gruppo: Il Codice della Crisi prevede la possibilità di trattare congiuntamente la crisi di gruppi di imprese tramite procedure coordinate e piani di gruppo. Questo interessa se si hanno più società collegate insolventi: l’ordinamento consente piani e concordati unici o coordinati, con gestione unitaria di certe fasi.
Per la finalità di questa guida, ci basti sapere che tali procedure esistono, ma generalmente un imprenditore “comune” deve districarsi fra quelle ordinarie: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, ecc. Le procedure speciali (LCA, amministrazioni straordinarie) esulano dalle scelte del singolo, essendo attivate d’ufficio in circostanze specifiche.
Procedure di sovraindebitamento per soggetti non fallibili
Non tutte le situazioni di crisi riguardano società di capitali o imprenditori sopra soglia. Moltissimi casi attengono a piccoli imprenditori, professionisti, ditte individuali di dimensioni ridotte, o semplici consumatori (privati cittadini indebitati). In passato, costoro – se insolventi – non potevano fallire (erano i c.d. “non fallibili”), ma nemmeno avevano strumenti efficaci per liberarsi dai debiti, se non pagando integralmente o subendo pignoramenti a vita. Dal 2012 (Legge 3/2012) e ancor più con la riforma del 2022, il legislatore ha creato procedure ad hoc di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o insolvenza di un debitore non soggetto a liquidazione giudiziale (quindi consumatore, imprenditore minore, imprenditore agricolo, professionista, start-up innovativa, ente non commerciale). Oggi tali procedure sono disciplinate nel Codice della Crisi (artt. 65-91 CCII per la composizione negoziata della crisi da sovraindebitamento, termine un po’ fuorviante perché non è la stessa “composizione negoziata” delle imprese, ma il capitolo delle procedure minori). In generale, le procedure di sovraindebitamento conservano l’impianto della L.3/2012, con terminologia in parte nuova:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): è l’equivalente del vecchio “piano del consumatore”.
- Concordato minore (artt. 74 e ss. CCII): sostituisce l’“accordo di composizione della crisi” della L.3/2012, ed è destinato a imprenditori minori e altri soggetti non consumatori.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 e ss. CCII): prende il posto della “liquidazione del patrimonio” ex L.3/2012, ossia la procedura liquidatoria per i sovraindebitati.
- Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII): introdotta dalla L.3 nel 2020 e ora prevista dal Codice, consente al debitore persona fisica nullatenente di ottenere una volta ogni 4 anni la liberazione dai debiti senza pagare nulla, salvo il dovere di contribuire se nei 4 anni successivi sopravviene una miglior fortuna.
Vediamoli in sintesi dal punto di vista del debitore sovraindebitato:
Piano di ristrutturazione del consumatore
Il piano del consumatore (ora rinominato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è una procedura riservata esclusivamente al debitore persona fisica che abbia contratto debiti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. In altri termini, chi non è imprenditore oppure lo è stato ma i debiti per cui chiede sollievo non sono legati alla sua attività d’impresa. È pensato per famiglie sovraindebitate, lavoratori dipendenti con troppi prestiti, pensionati con debiti, ecc.
Caratteristiche:
- Accesso e condizioni: Ci si rivolge all’OCC competente (Organismo di Composizione della Crisi) presentando una proposta di piano. Il debitore deve essere meritevole, cioè non aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Questo concetto di “meritevolezza” è stato reso meno stringente nel tempo, ma ancora rileva: ad esempio, se un consumatore ha accumulato debiti al gioco in modo sconsiderato potrebbe vedersi respinta l’istanza. Il piano può essere presentato anche se il debitore possiede beni (non serve essere nullatenente; in quel caso si proporrà di liquidarne alcuni per pagare). Se il consumatore ha già in passato usato queste procedure, deve rispettare un intervallo (no se ha già ottenuto esdebitazione negli ultimi 4 anni).
- Contenuto del piano: Il piano è una proposta unilaterale del consumatore su come intende pagare (in tutto o in parte) i propri debiti. Può prevedere dilazioni, falcidie (tagli) anche rilevanti, cessione di alcuni beni per ricavare liquidità, conservazione di altri se necessari per il sostentamento, etc. Si basa sul principio che il debitore destina tutte le sue risorse disponibili (al netto di quanto serve per mantenimento suo e della famiglia) ai creditori, in modo organizzato e proporzionale, per un certo periodo di tempo, dopodiché i debiti residui sono cancellati. Ad esempio, il consumatore propone: “Pago il 20% di ogni debito in 5 anni in rate mensili, grazie al mio stipendio detratto delle spese vitali, e vendo l’automobile non necessaria per dare un ulteriore 10% up-front; dopo l’esecuzione del piano chiedo l’esdebitazione del resto”.
- Nessun voto dei creditori: Questo è il tratto peculiare – e di favore – del piano del consumatore: non richiede l’accordo dei creditori. Diversamente dal concordato e dall’accordo di ristrutturazione, qui i creditori non votano. Il tribunale omologa il piano dopo aver verificato la fattibilità e la convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria (cioè bisogna dimostrare che quel che si offre è almeno pari a quel poco che i creditori otterrebbero liquidando i beni del debitore). I creditori possono solo fare opposizione se ritengono di essere trattati ingiustamente o se il debitore non era meritevole. Ma se il giudice ritiene il piano corretto, può omologarlo anche con il dissenso di tutti i creditori. Questo rende il piano del consumatore potentissimo per chi ha redditi limitati: si può ottenere una riduzione drastica dei debiti senza dipendere dal sì delle banche o finanziarie.
- Ruolo OCC e giudice: Il Gestore della crisi nominato dall’OCC aiuta il debitore a formulare il piano e redige una relazione in cui descrive le cause dell’indebitamento, il comportamento del debitore (se ha agito con correttezza e buona fede), la fattibilità del piano e l’eventuale convenienza per i creditori. Questa relazione dell’OCC è essenziale: serve al giudice per valutare la meritevolezza e la sostenibilità. Se ad esempio emergesse che il debitore ha nascosto patrimoni o ha contratto debiti dolosamente senza prospettiva di pagarli, il giudice non ammetterà il piano. Invece, se risulta che il sovraindebitamento deriva magari da perdita del lavoro, malattia in famiglia, tassi usurari, ecc. il giudice sarà più propenso.
- Effetti: Con il deposito del piano in tribunale, il giudice può concedere misure protettive simili a quelle del concordato: sospendere le azioni esecutive dei creditori per il tempo necessario all’omologa. Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori anteriori (anche quelli che non hanno partecipato, salvo eventualmente quelli privilegiati dissenzienti su cui c’è disciplina specifica). Il debitore deve eseguire i pagamenti secondo quanto stabilito. Se li esegue, al termine ottiene l’esdebitazione, ossia la cancellazione definitiva di ogni eventuale debito residuo. Se invece non rispetta il piano, può esserne dichiarata la risoluzione e allora i creditori riacquisiscono pieni diritti (tenendo conto comunque di quanto eventualmente pagato).
- Novità giurisprudenziali: La Cassazione, come già notato, ha di recente ammesso che il piano del consumatore possa prevedere dilazioni lunghe dei crediti ipotecari o privilegiati ben oltre l’anno dall’omologa (che la legge 3/2012 indicava come limite), purché i titolari di tali crediti abbiano la possibilità di esprimersi sulla convenienza. Siccome nel piano del consumatore in teoria i creditori non votano, la Cassazione ha specificato che se la dilazione supera un anno, i creditori privilegiati devono avere la possibilità di contestare la convenienza (ossia di opporsi e farsi sentire dal giudice). Questo orientamento è stato recepito dal Codice: ora si prevede che i privilegiati possano essere “consultati” in questi casi. Altra novità: Cass. 27/11/2024 n.30529 (citata nei massimari) ha chiarito alcune questioni di ricorribilità in Cassazione dei decreti sul piano, ma sono aspetti procedurali.
Il piano del consumatore è l’ideale per chi ha un patrimonio limitato ma un certo reddito con cui offrire almeno parzialmente soddisfazione ai creditori. Esempio: un impiegato che ha 100.000 € di debiti tra carte di credito, finanziarie, bollette arretrate, può proporre di pagare 500 € al mese per 5 anni (30.000 € in totale, quindi circa il 30% dei debiti), dimostrando che è quello che può permettersi togliendo il minimo vitale per sé. Se il giudice ritiene plausibile il piano e vede che in caso di liquidazione forzata i creditori prenderebbero forse il 5% (perché il tizio non ha beni), allora quell 30% in 5 anni è conveniente e omologa. L’uomo esegue, paga 30k in 5 anni, e poi gli vengono cancellati i residui 70k di debito. Ha così una seconda chance economica.
Concordato minore
Il concordato minore è la procedura destinata ai debitori sovraindebitati non consumatori, ossia tipicamente piccoli imprenditori “sotto soglia”, imprenditori agricoli, start-up innovative, società di persone artigiane, professionisti con debiti professionali, ecc. In pratica chi avrebbe potuto usare l’accordo della L.3/2012 ora trova nel concordato minore lo strumento corrispondente. Si chiama “concordato” perché, diversamente dal piano del consumatore, richiede il coinvolgimento e l’approvazione dei creditori (anche se con certe semplificazioni rispetto al concordato preventivo delle grandi imprese).
Caratteristiche:
- Accesso: Debitore sovraindebitato non consumatore e non soggetto a liquidazione giudiziale (quindi imprenditore minore ai sensi delle soglie, oppure ex imprenditore fallibile ma cessato da oltre un anno e quindi non fallibile, oppure anche enti non profit sovraindebitati). Si attiva tramite l’OCC, simile al piano consumatore, presentando un ricorso in tribunale con proposta di concordato minore. Anche qui serve la relazione dell’OCC attestante fattibilità e convenienza.
- Contenuto della proposta: Può prevedere la ristrutturazione dei debiti in vari modi (dilazioni, stralci) e anche la liquidazione di parte dei beni, eventualmente la prosecuzione dell’attività se c’è (concordato minore in continuità). Spesso consisterà in un misto: ad esempio un artigiano propone di pagare il 40% ai chirografari in 4 anni grazie agli utili futuri del suo laboratorio, vendendo però un macchinario inutile per pagare i creditori privilegiati. Deve assicurare almeno il valore di liquidazione ai creditori dissenzienti. Non c’è la soglia fissa del 20% (che vale solo per concordato preventivo liquidatorio delle imprese maggiori).
- Ruolo dei creditori: I creditori vengono suddivisi per categorie (privilegiati vs chirografari, o ulteriori classi se opportuno) e vengono chiamati a votare sulla proposta di concordato minore. Non c’è un’adunanza formale come nel concordato grande, di solito il voto avviene per espressione scritta raccolta dall’OCC o in camera di consiglio. Serve, analogamente, la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza semplice in valore). Se l’attività è familiare o vi sono coobbligati familiari, la riforma 2024 ha disciplinato le procedure familiari: membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura congiunta. In tal caso, ad esempio marito e moglie con debiti comuni presentano un unico concordato minore familiare. Se uno dei due è consumatore e l’altro imprenditore, comunque l’intera procedura è considerata “concordato minore” e richiede quindi la maggioranza di voti dei creditori. È emerso un problema: se il consumatore da solo avrebbe potuto non far votare i creditori, unendosi col coniuge imprenditore perde questo privilegio e se i creditori bocciano la proposta, anche il consumatore vede fallire la soluzione. Questa criticità è stata discussa (Cass.22699/2023 l’ha evidenziata) e può creare disparità di trattamento. Comunque, nel caso di più debitori insieme, tutti concorrono a formare le classi di creditori unificate.
- Omologazione: Se i creditori approvano a maggioranza, il tribunale omologa il concordato minore, salvo opposizioni di eventuali dissenzienti su convenienza. Se i creditori respingono, il tribunale può lo stesso omologare se ritiene la proposta conveniente per i creditori (ci sono dei meccanismi di cram-down anche qui, se il dissenso è irragionevole). Cassazione per analogia ha sostenuto che il giudice non può omologare in mancanza di voto favorevole del consumatore in procedura familiare, se il consumatore viene “trascinato” in voto ed è l’unico dissenziente, ma questo è un caso peculiare. In generale, senza approvazione dei creditori la domanda di concordato minore viene rigettata e il debitore può ripiegare sulla liquidazione controllata.
- Effetti: Con l’ammissione, scattano le misure protettive (blocco dei creditori come negli altri casi). Con l’omologa, il piano concordatario diventa vincolante per tutti i creditori anteriori. Il debitore lo esegue sotto vigilanza dell’OCC o di un liquidatore nominato (se c’è da liquidare beni). Al termine, ottiene l’esdebitazione per la parte non pagata.
- Differenze vs concordato preventivo: Il concordato minore è più snello: si svolge in camera di consiglio, con minori formalità, e tipicamente con l’assistenza dell’OCC invece che di un commissario giudiziale. Le spese sono minori. È pensato per dimensioni ridotte. Non vi sono azionisti di grandi società di mezzo, quindi la procedura è molto simile a quella consumer, ma con il voto.
In sintesi, il concordato minore è lo strumento per dire: “Cari creditori, vi propongo questo piano, vi chiedo di fidarvi e approvarlo; se la maggioranza di voi ci sta, il giudice lo rende obbligatorio per tutti”. Può essere visto come l’analogo del concordato preventivo ma su scala ridotta e con ausilio OCC.
Esempio: Marco è un giovane artigiano che ha chiuso l’attività, con debiti 100k (20k banca con ipoteca su piccolo laboratorio, 30k fornitori, 10k fisco, 40k vari). Non è consumatore perché i debiti sono dell’attività. Presenta concordato minore proponendo: vende il laboratorio (valore 50k) e con quel ricavato paga la banca ipotecaria (20k) e il resto pro quota ai privilegiati (fisco) e parte ai chirografari; inoltre, offre di pagare con il suo nuovo lavoro dipendente 200 €/mese per 4 anni (circa 10k) da distribuire ai chirografari (che così ricevono forse un 30%). Totale payout ipotetico ai chirografari: 30%. I creditori votano: la banca è soddisfatta (prende 100% del suo 20k, vota sì), il fisco prende 50% del suo 10k (ma meglio che zero, tende a votare sì se rispetta linee guida), i fornitori chirografari prendono 30% (forse alcuni scontenti ma preferiscono questo a un’incerta liquidazione). Si raggiunge la maggioranza, il giudice omologa. Marco esegue: vende il bene, paga, poi versa i 200 al mese. Ottenuto ciò, a fine 4 anni, il giudice lo libera dai debiti residui. Se invece i creditori avessero bocciato, Marco avrebbe dovuto optare per la liquidazione controllata (dove vendendo il bene la banca prende tutto e gli altri quasi zero).
Liquidazione controllata del sovraindebitato
La liquidazione controllata è la procedura che consente di liquidare tutti i beni del debitore sovraindebitato sotto supervisione del tribunale, in modo simile a un fallimento ma su scala minore e con alcune tutele aggiuntive per la persona del debitore. Vi accedono i debitori non fallibili in stato di insolvenza che non abbiano altre soluzioni (o non le vogliano). È l’equivalente della liquidazione del patrimonio ex L.3/2012.
Caratteristiche:
- Chi può chiedere: Il debitore stesso di regola, su istanza all’OCC/Tribunale. Prima, sotto L.3, solo il debitore poteva attivarla; oggi il Codice prevede che anche i creditori o il PM possano chiedere la liquidazione controllata di un debitore civile, ma in pratica è raro (il creditore di un non fallibile di solito pignora beni specifici piuttosto che avviare una procedura concorsuale generale). La Cassazione ha confermato che i creditori comunque hanno interesse a opporsi all’ammissione di un debitore a queste procedure se ne contestano i presupposti, e possono impugnare l’apertura in reclamo e in Cassazione (come visto nel caso Cass. 22616/2023: il creditore può far reclamo contro l’apertura della liquidazione e, se rigettato, fare ricorso straordinario in Cassazione). Quindi i creditori partecipano e vigilano.
- Effetti: Con l’apertura della liquidazione controllata (che il tribunale dichiara con decreto) il patrimonio del debitore diventa oggetto di liquidazione da parte di un Liquidatore nominato (che è spesso un professionista nominato dall’OCC o dal tribunale). Il debitore persona fisica conserva gli strumenti di lavoro indispensabili e i beni di stretta necessità per la vita (inviolabili). Tutto il resto viene venduto per pagare i creditori. Anche qui c’è uno stop alle azioni esecutive individuali (tutti concorrono nella procedura). I creditori presentano le loro domande di partecipazione (insinuazione). Si forma uno stato passivo. La procedura è semplificata rispetto al fallimento: c’è il giudice, c’è un liquidatore, non sempre un comitato creditori formale. I tempi dovrebbero essere più rapidi. Al termine della liquidazione, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione per liberarsi dai debiti rimasti (e questa è concessa con più facilità rispetto a prima, salvo comportamenti dolosi). La Cassazione nel 2025 ha precisato aspetti di dettaglio: ad esempio, ha deciso che il credito dell’OCC che ha assistito il debitore prima dell’apertura della liquidazione non può essere pagato con prelazione sul ricavato di beni ipotecati, perché non è considerato un costo della procedura ma un debito anteriore (Cass. 14401/2025). Ciò per dire che anche in queste procedure valgono regole su chi si paga prima e chi dopo.
In pratica, la liquidazione controllata è da scegliere quando il debitore sovraindebitato non ha alcuna possibilità di offrire un piano sostenibile ai creditori. Ad esempio, una persona sommersa di debiti e senza reddito proporzionato per un piano farà prima a liquidare quei pochi beni che ha e chiedere l’esdebitazione. Anche se i creditori prenderanno poco o nulla, almeno la posizione viene chiusa e il debitore può ripartire pulito (dopo l’esdebitazione). Un esempio tipico: un ex piccolo imprenditore con 300k debiti, che possiede solo una casa modesta. Vende la casa in liquidazione controllata, i creditori prendono una percentuale bassa e poi lui è esdebitato. Se avesse subìto pignoramenti uno alla volta forse avrebbe perso la casa comunque e restare con debiti residui, invece così li azzera legalmente.
Una nota: Cass. 11448/2025 ha stabilito che il decreto che nega l’apertura della liquidazione (ad esempio perché il debitore è in malafede) non è ricorribile per Cassazione, in quanto non definitivo. Ciò significa che se un giudice rigetta l’istanza di liquidazione per inammissibilità, il debitore non può fare ricorso in Cassazione contro quel provvedimento, perché potenzialmente può ripresentare richiesta o usare altre vie (non è giudizio decisorio su diritti, dice la Cassazione). Quindi conviene preparare bene la domanda iniziale, perché non c’è un terzo grado facile.
Esdebitazione dell’incapiente
Un istituto notevole introdotto nel 2020 e confermato dal Codice (art. 283 CCII) è l’esdebitazione del debitore incapiente. È destinata al debitore persona fisica sovraindebitato che non ha alcun patrimonio liquidabile né redditi pignorabili, cioè non può offrire nulla ai creditori. In passato costoro rimanevano intrappolati a vita (povertà e debiti). Ora, la legge consente a queste persone di ottenere la cancellazione dei debiti subito, senza pagare nulla ai creditori, come misura di solidarietà sociale, a patto che:
- Il debitore sia meritevole (non deve aver frodato i creditori, né colpa grave nello stato di indigenza).
- Non deve aver ottenuto altra esdebitazione simile nei precedenti 4 anni.
- Non deve sopraggiungere nei successivi 4 anni una utilità rilevante (es. vincita, eredità, aumento reddito significativo): se ciò accade, il debitore ha l’obbligo di pagare comunque i creditori con queste nuove risorse, altrimenti l’esdebitazione è revocata.
In pratica, è un fresh start integrale per i cosiddetti nullatenenti onesti. Si presenta istanza al tribunale tramite OCC, allegando documenti che provano lo stato di indigenza. Il tribunale verifica e concede l’esdebitazione. Per 4 anni il debitore resta sorvegliato: se non gli capita alcuna fortuna economica, i debiti restano cancellati definitivamente; se invece entro 4 anni ottiene soldi, devono essere destinati pro quota ai vecchi creditori fino a concorrenza dei loro crediti (al netto di quanto serve alla vita e di un incentivo 10% che può tenere). Trascorsi 4 anni, eventuali nuove risorse sopraggiunte non sono più toccate.
Questa misura riconosce che quando una persona è insolventissima e senza beni, tenere i debiti in vita è inutile per i creditori e dannoso per la dignità umana: meglio darle modo di ripartire da zero, confidando che possa reinserirsi produttivamente.
Esempio: Lucia, consumatrice, ha 50k di debiti ma è disoccupata, vive in affitto, nulla di intestato. Non può pagare nulla. Può chiedere esdebitazione incapiente: il giudice gliela concede. Dopo 2 anni trova lavoro ma a stipendio modesto: non essendo un colpo di fortuna eccezionale, lei non deve nulla ai creditori (lo stipendio sarà pur teoricamente pignorabile per 1/5, ma i debiti sono cancellati – bisogna coordinare la norma con eventuali crediti alimentari etc, ma in linea di massima i creditori non possono più pignorarle nulla perché il credito è estinto). Se invece entro 4 anni avesse vinto 100k€, ecco che quell’importo andrebbe in gran parte girato ai vecchi creditori, riaprendo in qualche modo il caso.
Tabelle riepilogative degli strumenti di gestione della crisi
Di seguito presentiamo alcune tabelle riassuntive che confrontano i vari strumenti e procedure discussi, evidenziandone i destinatari, la natura (giudiziale vs stragiudiziale), le condizioni principali e i benefici/effetti per il debitore. Questi schemi aiutano a comprendere a colpo d’occhio quale via può essere appropriata in funzione della situazione del debitore.
Tabella 1: Confronto tra soluzioni stragiudiziali e concordate
| Strumento | Chi può usarlo | Necessità di consenso creditori | Intervento del tribunale | Vantaggi per il debitore |
|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Imprese in crisi/insolvenza fallibili (società, ditte sopra soglia) | Non votano (accordo privato, ma serve adesione implicita di creditori chiave) | No omologa (solo pubblicazione). Eventuale controllo giudiziario ex post (in caso di fallimento per esenzione revoche) | – Riservatezza (nessuna pubblicità di procedura) – Flessibilità nei contenuti – Esenzione da revocatoria per atti in esecuzione del piano – Mantiene fiducia banche (piano asseverato) |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) | Imprese fallibili (anche in continuità) | 60% del credito deve aderire (dissenzienti <40% vincolati se omologa) | Sì, omologa dal tribunale. Possibile giudice anche in caso di cram-down fiscale. | – Moratoria legale dalle azioni (su richiesta) – Vincolo anche per dissenzienti (omologa erga omnes) – Stralcio debiti con efficacia esecutiva – Transazione fiscale possibile (riduzione debiti fiscali) |
| Concordato preventivo (art. 84+ CCII) | Imprese fallibili insolventi o in crisi (società o ditte sopra soglia) | Voto di creditori in classi, richiesta maggioranza >50% crediti votanti (cram-down possibili) | Sì, ammissione + omologa in tribunale. Commissario e GD nominati. | – Stay automatico di tutte le azioni esecutive – Possibilità di imporre tagli e dilazioni anche a chi vota no (se maggioranza sì) – Possibilità di conservare azienda (concordato in continuità) – Esdebitazione finale per imprenditore individuale |
| Composizione negoziata (D.L.118/21 conv.) | Qualsiasi imprenditore iscritto, incl. PMI e grandi imprese, anche se già insolventi (ma reversibile) | Negoziato volontario: creditori non votano formalmente, accordi bilaterali possibili | No omologa. Solo eventuale decreto misure protettive e omologa se sfocia in accordo o concordato. | – Esperto indipendente che facilita accordo – Protezione temporanea dai creditori (sospensione pignoramenti) – Incentivi fiscali (rate fino 10 anni) – Accesso a concordato semplificato se fallisce negoziazione – Riservatezza (procedura confidenziale se possibile) |
| Accordo stragiudiziale informale | Qualsiasi debitore (impresa o privato) | Totale: serve accordo con tutti i creditori coinvolti (nessun vincolo per chi non firma) | No. (Può al più essere scrittura privata) | – Completamente confidenziale – Tempi rapidi, zero burocrazia – Personalizzabile caso per caso (ma senza protezioni legali) |
Tabella 2: Procedure di sovraindebitamento (debitori non fallibili)
| Procedura sovraindebitamento | Destinatari | Ruolo creditori | Effetti per debitore | Esdebitazione |
|---|---|---|---|---|
| Piano del consumatore (art. 67 CCII) | Persona fisica consumatore (debiti civili) | No voto – creditori non decidono, possono solo fare opposizione | – Stop azioni esecutive (dall’ammissione) – Pagamenti secondo piano (rate, stralci) anche oltre 1 anno per ipotecari (ammesso con tutele) – Annullamento debiti residui a fine piano | Sì, al termine del piano, automaticamente con l’omologa completa (salvo revoca se inadempimento) |
| Concordato minore (art. 74 CCII) | Debitore non fallibile non consumatore (es. piccolo imprenditore, professionista) | Sì voto – serve maggioranza crediti >50% (o classi). Creditori in assemblea virtuale via OCC. | – Misure protettive disponibili (sospensione azioni) – Vincolante per tutti i creditori se omologato (dissenzienti compresi) – Possibile continuità aziendale (se imprenditore vuole proseguire) | Sì, a fine pagamento piano residuo liberato (come esdebitazione concorsuale). Persona fisica ottiene esdebitazione residui se ha adempiuto concordato. |
| Liquidazione controllata (art. 268 CCII) | Qualsiasi debitore non fallibile insolvente (consumatore o no) | No voto (è procedura liquidatoria). Creditori partecipano presentando domande e sono soddisfatti pro-quota sui beni liquidati. | – Spossessamento beni (tranne impignorabili) – Liquidatore realizza attivo e paga creditori in ordine privilegi – Sospensione pignoramenti individuali | Sì, debitore persona fisica può ottenerla a chiusura (se cooperato lealmente). Debitore onesto liberato dai debiti insoddisfatti. |
| Esdebitazione incapiente (art. 283 CCII) | Persona fisica nullatenente e senza reddito pignorabile, meritevole | Nessun ruolo (creditori informati, ma non c’è da votare) | – Cancellazione immediata di tutti i debiti senza alcun pagamento – Obbligo per debitore di dichiarare migliorìe economiche entro 4 anni e destinarle a creditori (sopravvenienze rilevanti) | Già consiste nella totale esdebitazione immediata. (Revocabile se dolo o se arrivano attivi non segnalati nei 4 anni) |
Domande frequenti (FAQ) sulla gestione della crisi d’impresa
D: Cosa si intende esattamente per “azienda in crisi”?
R: In ambito giuridico per crisi si intende lo stato di difficoltà economico-finanziaria che, pur non essendo ancora insolvenza, rende probabile che l’impresa diventi insolvente se non si interviene. Si manifesta spesso con flussi di cassa prospettici insufficienti a far fronte ai debiti in scadenza. Non è necessario essere già in default su pagamenti: anche tensioni di liquidità e squilibri patrimoniali gravi qualificano la “crisi”. Ad esempio, se un’azienda non riesce più a ottenere credito e prevede di non poter pagare fornitori tra qualche mese, è in stato di crisi. L’insolvenza invece è già l’incapacità attuale di pagare debiti scaduti (p.es. stipendi o rate non pagate, pignoramenti in corso). Quindi “azienda in crisi” indica una situazione pre-fallimentare in cui però vi è ancora margine di manovra per evitare l’insolvenza conclamata.
D: Quali sono i segnali di allarme che l’imprenditore deve monitorare?
R: Il Codice della Crisi e l’art. 2086 c.c. impongono di dotarsi di assetti organizzativi adeguati anche per rilevare tempestivamente i segnali di crisi. I principali red flag sono: squilibri di bilancio (perdite rilevanti, patrimonio netto che si erode, liquidità scarsa rispetto al circolante), indebitamento eccessivo (ad esempio utilizzo costante oltre il fido di conto, aumento giorni medi di pagamento a fornitori), ritardi nei pagamenti obbligatori (stipendi arretrati, rate leasing saltate, imposte non versate: il Codice menziona debiti fiscali e previdenziali scaduti significativi), previsioni di insolvenza a 12 mesi – se il piano finanziario prevede che senza interventi tra 6-12 mesi mancheranno fondi per onorare le obbligazioni, è un segnale forte. Inoltre esistono indicatori indici elaborati dal CNDCEC: ad esempio rapporto oneri finanziari/ricavi, indice di liquidità, ecc., il cui superamento suggerisce squilibrio. Un altro segnale: il reiterato ricorso a soluzioni straordinarie (svendere cespiti per fare cassa, chiedere in continuazione proroghe ai fornitori). Il legislatore inizialmente aveva previsto anche soglie automatiche (p.es. debiti oltre certi importi verso Fisco o INPS): oggi non c’è una attivazione automatica, ma restano parametri utili. In breve, cassa insufficiente, margini negativi, debiti scaduti, allungamento tempi di incasso/pagamento sono spie di crisi.
D: Ho una piccola azienda artigiana e temo di non farcela più: a chi devo rivolgermi per primo?
R: Per prima cosa, conviene rivolgersi a un professionista esperto di crisi (un commercialista o avvocato con esperienza in procedure concorsuali) per esaminare la situazione. Il professionista analizzerà i numeri e vi dirà se la crisi è affrontabile con un piano di risanamento oppure se l’insolvenza è troppo avanzata. In parallelo, potete contattare un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) sul vostro territorio. Gli OCC offrono una prima consulenza informativa gratuita e possono consigliarvi su quali procedure di sovraindebitamento potete accedere (se siete sotto le soglie di fallibilità). L’OCC poi vi affiancherà se decidete di presentare un piano del consumatore, un concordato minore o liquidazione controllata. Se invece la vostra azienda è sopra soglia e fallibile, il vostro consulente potrà suggerirvi di attivare la Composizione Negoziata nominando un esperto: per farlo dovrete passare attraverso la piattaforma telematica gestita da Unioncamere. In pratica: primo step consigliato è sempre il confronto con un advisor (consulente di crisi), il quale vi indirizzerà agli strumenti opportuni e vi aiuterà a contattare gli organismi competenti (Tribunale, OCC, Camera di Commercio per composizione negoziata).
D: In cosa consiste la Composizione Negoziata? È diversa dalla procedura di sovraindebitamento?
R: Sì, sono cose diverse. La Composizione Negoziata è una procedura assistita da un esperto rivolta ad imprese iscritte al registro imprese (in genere società e ditte, anche medio-grandi). Serve a negoziare con creditori fuori dal tribunale, pur con alcune protezioni legali (blocco temporaneo dei creditori autorizzato dal giudice). Non prevede il voto dei creditori in assemblea né un piano imposto, ma punta a far raggiungere accordi volontari o soluzioni concordate (ad esempio un accordo di ristrutturazione, o se fallisce un concordato semplificato). È un percorso confidenziale e volontario. Invece le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, ecc.) sono vere e proprie procedure concorsuali minori, rivolte a debitori non fallibili (spesso persone fisiche, piccoli imprenditori) e gestite dal tribunale su ricorso, normalmente con l’ausilio di un OCC. Lì c’è un piano o accordo che viene omologato dall’autorità e vincola i creditori anche senza il loro consenso (nel piano del consumatore non votano proprio; nel concordato minore votano). Diciamo che la composizione negoziata è più simile a una mediazione assistita in cui il debitore resta protagonista e cerca un’intesa con i creditori, mentre le procedure di sovraindebitamento sono come dei mini-concordati o mini-fallimenti su misura dei piccoli debitori. Un’azienda potrebbe attivare prima la composizione negoziata per tentare una soluzione informale; se non funziona ed è non fallibile, può poi ripiegare su un concordato minore o liquidazione controllata. Viceversa, un debitore privato (consumatore) o un artigiano sotto soglia non userà la composizione negoziata (che non è pensata per lui, anche se in teoria un’impresa individuale potrebbe accedervi) ma andrà direttamente dal OCC per un piano del consumatore o concordato minore.
D: Ho troppi debiti personali (carte revolving, prestiti, affitto arretrato). Posso liberarmene con la legge “anti-suicidi” senza pagare nulla?
R: Dipende dal tuo profilo e dalla tua situazione economica. La cosiddetta legge “anti-suicidi” è la L.3/2012 (oggi integrata nel Codice) sulle procedure da sovraindebitamento. Se sei un consumatore (debiti privati, non d’impresa) e hai qualche capacità di pagamento, puoi proporre un piano del consumatore: offri ai creditori un pagamento parziale in base alle tue possibilità (magari vendendo beni superflui e/o con rate sostenibili dal tuo stipendio) e il giudice può omologarlo senza bisogno che i creditori siano d’accordo. Pagata la parte dovuta, il resto dei debiti viene cancellato. Quindi non è esatto “senza pagare nulla”: devi destinare tutto quello che ragionevolmente puoi, al netto di quanto ti serve per vivere dignitosamente. Se però non hai proprio nulla – né redditi né beni – e il tuo sovraindebitamento non deriva da colpe gravi o frodi, allora puoi valutare l’esdebitazione dell’incapiente. Questa procedura ti libera dai debiti senza pagare nulla, immediatamente, purché tu resti “povero” anche nei 4 anni successivi. Se invece in quei 4 anni ti arriva qualche entrata straordinaria (es. una vincita, una donazione consistente, un lavoro ben retribuito), dovrai avvisare i creditori e pagarli fino a concorrenza di ciò che hai ricevuto, altrimenti rischi la revoca della cancellazione dei debiti. È una sorta di “fresh start” per chi è in miseria totale. Quindi, riassumendo: se hai zero possibilità economiche, puoi chiedere esdebitazione totale subito (ma ricordati che se la tua fortuna cambia entro 4 anni dovrai contribuire); se hai qualche capacità, meglio fare un piano del consumatore offrendo ciò che puoi – anche fosse il 5-10% dei debiti – ed ottenere l’omologa, cancellando poi il resto una volta completato il pagamento parziale. In entrambi i casi devi passare tramite l’Organismo di Composizione della Crisi sul territorio.
D: Un piccolo imprenditore (es. commerciante) può essere dichiarato fallito?
R: Dipende dalle dimensioni economiche della sua impresa. Se è un imprenditore sotto le soglie di legge (impresa minore con attivo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000), non è assoggettabile a liquidazione giudiziale (fallimento). Ciò significa che nemmeno i creditori possono chiederne il fallimento in tribunale. Le uniche soluzioni concorsuali per lui sono quelle da sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata). Se invece il commerciante ha superato anche solo una di quelle soglie negli ultimi esercizi, allora formalmente potrebbe essere dichiarato insolvente dal tribunale su richiesta (cioè “fallito”, nel linguaggio previgente). Esempio: un negoziante con 800k di debiti, attivo 400k – è sopra soglia, quindi se non paga i creditori potrebbero chiederne la liquidazione giudiziale. Da notare: se un piccolo imprenditore sotto soglia si ostina a non pagare i debiti, i creditori rimangono individualmente insoddisfatti salvo pignorargli beni; potrebbe capitare che alcuni tentino strategie per farlo rientrare comunque (ad es. dimostrare che le soglie erano superate, o se ha cessato l’attività da poco entro l’anno potrebbero provare a far fallire comunque appellandosi all’art. 10 L.F. previgente se applicabile). Ma in linea di massima la legge ha voluto evitare i costi di una procedura concorsuale per micro imprese. Piuttosto, spinge quel debitore verso un concordato minore (dove paga qualcosa) o una liquidazione controllata volontaria.
D: I debiti fiscali (IVA, tasse) e i contributi si possono tagliare con queste procedure?
R: Sì, è possibile ma con alcune condizioni. Un tempo le imposte e contributi erano “intoccabili” nei concordati, oggi non più. Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, il debitore può proporre una transazione fiscale: ad esempio pagare solo il 50% del debito IVA, oppure dilazionare i contributi senza sanzioni. L’Agenzia delle Entrate valuterà la proposta. Con le riforme recenti, se il Fisco rifiuta ma l’offerta del piano è migliore di quel che il Fisco prenderebbe dal fallimento, il tribunale può omologare il concordato lo stesso, cram-down fiscale. Quindi in sostanza i debiti fiscali si possono stralciare parzialmente, ma almeno bisogna dimostrare che quella è la soluzione più vantaggiosa (non è consentito offrire meno di quanto deriverebbe dalla vendita dei beni su cui il Fisco ha privilegio, ad esempio). Nelle procedure da sovraindebitamento, parimenti, si possono includere i debiti fiscali e contributivi nelle proposte. Ad esempio, un piano del consumatore può prevedere il pagamento parziale di cartelle esattoriali. È richiesto il parere dell’ente (Agenzia Riscossione) ma non vincola il giudice: se il giudice ritiene equa la proposta e vede che il Fisco non perderebbe di più che altrove, può omologare anche senza adesione. Quindi sì, IVA, IRPEF, INPS possono essere ridotti e diluiti. Eccezione: l’IVA almeno il principio è di tutela perché è un tributo comunitario (in passato i giudici erano restii a falcidiare IVA); però la legge oggi consente di includerla nelle transazioni fiscali. Tendenzialmente ti faranno comunque pagare qualcosa, magari l’intero capitale IVA dilazionato e taglio di interessi e sanzioni. Nei debiti contributivi, simile. Ma la risposta breve: le procedure concorsuali attuali permettono la ristrutturazione dei debiti verso Erario e enti previdenziali, cosa impensabile fino a pochi anni fa, purché la proposta sia seria e verificata. Ci sono anche norme che consentono piani di rateazione straordinaria (fino 10 anni) se stai facendo composizione negoziata.
D: Quanto tempo ci vuole per chiudere una procedura di concordato o accordo?
R: I tempi variano molto in base alla procedura e complessità:
- Un accordo di ristrutturazione può essere veloce – se c’è già l’intesa con le banche, in un paio di mesi si può depositare e forse omologare in altri 2-3 mesi (specie con creditori non numerosi). Diciamo 4-6 mesi in media, ma se ci sono opposizioni si allunga.
- Un concordato preventivo richiede più passaggi: presentazione, ammissione, votazione, omologa. Tra preparazione e tutto spesso passa 1 anno. Se è concordato in bianco, c’è un periodo iniziale (fino a 6 mesi per presentare piano). Poi dal deposito piano al voto qualche mese, e dall’esito voto all’omologa altri mesi (soprattutto se ci sono cause di opposizione da decidere). Realisticamente 12-18 mesi per ottenere l’omologa definitiva non sono strani. Dopodiché c’è la fase di esecuzione che può durare anni (se il piano prevede pagamenti rateali ad esempio). La procedura formalmente si chiude quando il commissario (poi liquidatore eventualmente) attesta che il piano è eseguito. Esempio: Concordato con pagamento 30% in 5 anni – la procedura resterà aperta durante quei 5 anni sotto sorveglianza.
- Una composizione negoziata ha tempi brevi per definizione: durata standard 3-6 mesi, prorogabile un po’ ma l’obiettivo è di arrivare a qualcosa entro pochi mesi. Può risolversi anche prima se trovate subito un accordo.
- Un piano del consumatore spesso si risolve in meno di un anno: dipende dall’intasamento dei tribunali, ma essendo procedure camerali a volte nel giro di 4-6 mesi hai l’omologa. Poi se prevede pagamenti dilazionati, l’esecuzione dura quanto le dilazioni (ma l’omologa in sé ottiene l’effetto sospensivo sui creditori).
- Una liquidazione giudiziale (fallimento) può durare diversi anni (media in Italia era 5-7 anni; il Codice prova a ridurre tempi).
- Una liquidazione controllata sovraindebitato di solito è più rapida: se c’è un solo immobile da vendere, magari in un anno/due si chiude. Se ci sono tante piccole cose, può prendere 2-3 anni.
Riassumendo:
- Procedure negoziate (comp. negoziata, accordi fuori tribunale) → qualche mese.
- Procedure concordatarie giudiziali → circa 1 anno per l’omologa, poi qualche anno per completare attuazione se pagamenti rateali.
- Procedure liquidatorie → 2-5 anni per la chiusura, a seconda dell’attivo.
D: Durante una procedura, devo continuare a pagare i debiti correnti?
R: Dipende dalla procedura.
- Nella composizione negoziata, finché non hai misure protettive, dovresti pagare ciò che riesci per non aggravare la posizione (ad esempio pagare fornitori essenziali, stipendi, etc.). Se ottieni misure protettive dal tribunale, sei autorizzato a sospendere i pagamenti verso i creditori pregressi per la durata del concordato (non ti possono obbligare a pagarli). Tendenzialmente però in quel periodo dovresti comunque pagare per intero le forniture e servizi necessari correnti (che diventano debiti prededucibili).
- Nel concordato preventivo, dal momento del deposito del ricorso è vietato pagare debiti anteriori (salvo autorizzazioni per fornitori strategici). I debiti sorti durante il concordato (massa concorrente) vanno pagati regolarmente, altrimenti ti blocchi – ma molti costi li pagherà il commissario se necessario (es. ti autorizzano a usare liquidità per materie prime ecc.). Comunque, i crediti anteriori restano congelati fino all’omologa, e poi li pagherai nelle misure previste dal piano. Quelli successivi all’apertura sono in prededuzione e li devi pagare di solito integralmente (es. affitti di immobile azienda durante concordato vanno saldati, se no il locatore chiederà di uscire).
- Nell’accordo di ristrutturazione in trattativa, se hai chiesto la sospensione ex art.54 CCII, puoi non pagare le rate scadute di chi rientra nell’accordo. Ma con chi è fuori devi continuare a onorare (o saranno liberi di agire).
- Nel piano del consumatore o concordato minore, quando presenti la domanda puoi chiedere la sospensione delle azioni e pagamenti. Di solito smetti di pagare i creditori inseriti nel piano (anche perché li pagherai secondo la proposta omologata). I debiti non toccati dal piano (ad es. se hai un debito alimentare verso figli, o un mutuo ipotecario che vuoi mantenere) dovresti continuarli. In sede di omologa, il giudice spesso sospende le rate dei mutui su beni destinati a liquidazione ecc.
- Nella liquidazione controllata/giudiziale, i debiti anteriori si cristallizzano: tu come debitore non ne paghi più alcuno (ci pensa il liquidatore col ricavato vendite). I debiti successivi non ne puoi contrarre (perché l’attività cessa salvo esercizio provvisorio gestito dal curatore).
In sintesi: una volta entrato in una procedura concorsuale ordinaria, cessi di pagare i debiti passati (divieto di pagamento preferenziale) e paghi solo quelli previsti dal piano omologato o dalla legge. Durante le trattative preliminari invece può essere opportuno pagare almeno i fornitori indispensabili e le utenze per mantenere l’azienda in funzione. Ad esempio, in comp.neg., l’esperto spesso consiglia di pagare i fornitori critici per non interrompere la produzione, e magari sospendere i pagamenti a banche e creditori finanziari finché si tratta la ristrutturazione. Ogni caso fa strategia a sé, concordata col professionista e l’eventuale esperto.
D: Se faccio una procedura di sovraindebitamento, i miei soci o coobbligati sono automaticamente liberati?
R: No, la regola generale è che la liberazione dei debiti vale solo per il debitore che ha proposto la procedura. I coobbligati (fideiussori, condebitori solidali, soci garanti) restano obbligati per intero, salvo diverse disposizioni. Ad esempio, se Tizio fa un piano del consumatore e paga il 50% dei suoi debiti, il fideiussore che aveva garantito quei debiti nei confronti della banca rimane tenuto a pagare l’altro 50% (non è protetto dal piano di Tizio). Questo è esplicitamente previsto nel Codice. Un’eccezione è stata introdotta (art. 88 CCII) per il caso di socio illimitatamente responsabile: se una società di persone fa un concordato minore, l’omologazione estende gli effetti ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Ciò significa che i creditori sociali non possono poi agire per la parte falcidiata sui patrimoni personali dei soci illimitati (Cass.22715/2023 lo ha confermato, precisando però che vale solo per debiti sociali, non per quelli personali dei soci). Quindi in un s.n.c., se la società risolve i suoi debiti al 30% con concordato minore, i creditori sociali non possono pretendere il restante 70% dai soci. Però questo è un caso circoscritto. Se parliamo di normali garanzie, p.es. coniuge garante, quell’obbligazione rimane (a meno che anche il garante entri in una procedura sua). Nel concordato preventivo di società di capitali, ugualmente i garanti terzi restano obbligati. In pratica le procedure non liberano i terzi. È buona norma quindi coordinarsi: se hai un garante per un debito grosso, può essere opportuno includerlo nello stesso percorso (ad es. moglie e marito indebitati insieme fanno un procedura familiare congiunta). Oppure il garante deve negoziare a parte col creditore la propria liberazione (magari pagando una quota extra). Nel sovraindebitamento familiare, come detto, se i membri della famiglia accedono congiuntamente, presentano un unico piano o concordato e lì i debiti comuni vengono regolati insieme. Ma se un solo coniuge fa la procedura sui debiti cointestati, l’altro ne rimane responsabile per l’intero (meno quanto pagato dal coniuge nella procedura).
D: Cosa succede se non riesco a rispettare il piano concordatario o del consumatore dopo l’omologa?
R: Se, dopo l’omologazione, il debitore non adempie agli obblighi presi, la procedura può venire revocata o risolta. Nel concordato preventivo, i creditori o il commissario possono chiedere la risoluzione del concordato al tribunale se il debitore è inadempiente o se diventa incapace di eseguire il piano (art. 119 CCII). La risoluzione comporta che i creditori riacquistano per intero i loro crediti originari (detratto ciò che hanno eventualmente già incassato) e tipicamente segue la conversione in liquidazione giudiziale (cioè il fallimento). Nelle procedure di sovraindebitamento, similmente:
- Nel piano del consumatore, se non paghi secondo il piano, i creditori possono chiedere la revoca dell’omologa e l’inefficacia delle esenzioni ottenute. Oppure possono insinuarsi in una successiva liquidazione controllata se decidi di ripiegare.
- Nel concordato minore, c’è una norma analoga di risoluzione per inadempimento, con possibilità per i creditori di far valere i crediti residui. Dato che in sovraindebitamento non c’è l’istituto del fallimento, semplicemente i creditori tornano liberi di agire esecutivamente sui beni del debitore (che a quel punto non è più protetto). Il debitore potrebbe eventualmente chiedere l’apertura di una liquidazione controllata come ultima spiaggia.
La Cassazione ha precisato che, nel caso di accordo di composizione ex L.3 (simile al concordato minore), se in corso di esecuzione il debitore modifica la proposta (ad esempio vuole allungare i tempi o ridurre ulteriormente importi) occorre sentire di nuovo tutti i creditori, anche quelli già soddisfatti. Questo per dire che alterare il piano concordato unilateralmente non è possibile: serve il consenso o quantomeno un nuovo controllo del giudice su base di nuove audizioni. Quindi, se ti accorgi che non riesci a rispettare il piano, la cosa corretta è tornare in tribunale prima di diventare inadempiente, e chiedere una modifica del piano (che però richiederà approvazione). Il Codice consente ad esempio di presentare un nuovo concordato minore se quello iniziale “salta”, ma serve il nulla osta del giudice. C’era una norma transitoria (L.176/2020) che permetteva al debitore sovraindebitato di presentare una nuova proposta entro 90 giorni se la prima veniva bocciata o revocata, purché lo chiedesse entro l’udienza di omologa. Cassazione 34133/2024 ha chiarito che questo beneficio dei 90 giorni vale solo se richiesto prima o al più in sede di omologa della prima procedura, non dopo. Dunque, in generale, il mancato rispetto del piano comporta la perdita dei benefici (niente più esdebitazione) e i creditori possono tornare a esigere per intero. Meglio evitare ciò formulando piani realistici fin dall’inizio (non promettere più di quanto si possa mantenere).
D: Quali sono i costi di queste procedure? Posso permettermelo se sono già indebitato?
R: I costi possono variare. Ci sono:
- Costi fissi di giustizia (marche, contributo unificato se dovuto – ad es. concordato preventivo ha contributo unificato, sovraindebitamento no o ridotto).
- Compensi dei professionisti: il gestore OCC ha diritto a un compenso stabilito per legge (di solito alcune migliaia di euro a seconda dell’attivo/passivo) – però spesso viene pagato all’esito della procedura con prededuzione, cioè prende prima dei creditori sul ricavato. Il debitore sovraindebitato di solito anticipa solo una parte di spese vive. L’OCC può chiedere un fondo spese (es qualche centinaio di euro) all’inizio. Idem nella comp. negoziata l’esperto ha un compenso, ma è in parte a carico camerale se PMI, o comunque modulato.
- Parcella dell’avvocato o commercialista che ti assiste: quella va discussa col professionista; molti sanno che trattano con clienti in difficoltà e prevedono pagamenti rateali o in percentuale del risultato.
- Nel concordato preventivo ci sono spese più alte: devi pagare il commissario, il liquidatore eventuale, e queste somme sono prededucibili e vengono soddisfatte prima dei creditori (riducendo quindi la torta disponibile). Tipicamente in un concordato il 5-10% dell’attivo potrebbe andare a spese procedurali. Però, se il concordato ha successo, di solito queste spese sono già contabilizzate nel piano.
- Per un piano del consumatore: costi limitati alla relazione OCC (es qualche migliaio di euro) e al tuo avvocato se ne hai uno (facoltativo ma consigliabile). Esistono convenzioni con alcune associazioni di consumatori o servizi di consulenza legale low-cost per questi casi. Inoltre, il giudice a volte può disporre l’esonero dal pagamento di certe spese per i debitori in grave difficoltà (patrocinio a spese dello Stato se rientri nei limiti di reddito, anche se su concorsuali c’è dibattito).
In generale, affrontare una procedura comporta investire un minimo: ma è paragonabile a investire in una “cura” per guarire dai debiti. Ad esempio, se hai 100k di debiti e con 3k di spese tra OCC e avvocato riesci a fare un piano pagandone 30k e cancellando 70k, direi che è un ottimo ritorno sull’investimento. Quindi, sebbene all’inizio possa sembrare un costo, va visto come parte della soluzione. L’importante è rivolgersi a professionisti onesti che quantificano chiaramente le loro competenze. Fare un concordato “fai da te” per risparmiare può portare a errori disastrosi e costare molto di più. Molti OCC e Camere di Commercio offrono anche orientamento gratuito pre-procedura.
Inoltre, nella composizione negoziata, se sei micro-impresa sotto certi limiti puoi rivolgerti all’OCC anziché alla piattaforma, e alcuni costi dell’esperto sono coperti da fondi pubblici del Ministero (questo per evitare che microimprese rinuncino per costi).
D: Come incide la crisi d’impresa sulla mia posizione di amministratore/socio? Rischio sanzioni o responsabilità?
R: Dipende molto da come viene gestita. Se l’amministratore si attiva per tempo e segue le regole delle procedure, in genere riduce il proprio rischio di responsabilità. Ad esempio:
- Responsabilità civile verso i creditori sociali: se hai tardato a portare i libri in tribunale aggravando il buco, i creditori potrebbero farti causa per quella differenza (azione da mancata richiesta tempestiva di fallimento). Ma se tu attivi una procedura in tempo (concordato o liquidazione), dimostri diligenza e questo riduce il margine di colpa. Inoltre, durante la composizione negoziata, la legge prevede che certi obblighi (riduzione capitale sociale, cause di scioglimento) siano sospesi, per proteggere gli amministratori che tentano il risanamento. E la Legge 147/2021 ha introdotto esimenti: gli atti compiuti in attuazione di un piano o di una comp. negoziata non costituiscono mala gestio. Anche la valutazione di un eventuale fallimento successivo può essere più clemente se il cda ha provato soluzioni.
- Responsabilità penale: qui occorre stare attenti. Ci sono reati tipici in crisi: bancarotta semplice o fraudolenta, preferenze ai creditori particolari (bancarotta preferenziale). Usare le procedure correttamente aiuta: ad esempio, pagare un fornitore invece di un altro poco prima di fallire di solito è bancarotta preferenziale; ma se lo fai perché eri in concordato autorizzato dal giudice a pagare quel fornitore essenziale, allora quell’atto è lecito. La composizione negoziata ha introdotto una causa di non punibilità per atti autorizzati dall’esperto o dal tribunale in quel contesto. Quindi seguire le regole protegge gli amministratori. Al contrario, continuare ad aggravare il dissesto sperando in un miracolo può esporre a accuse di bancarotta (ad esempio distrazione di beni se vendi sotto costo per prendere tempo, ecc.).
- Sanzioni personali: nel vecchio fallimento, il fallito imprenditore subiva restrizioni (divieto di ricoprire cariche societarie, etc. per qualche tempo). Oggi questo è in parte attenuato: nel concordato preventivo nessuna interdizione scatta; nel fallimento (liq. giudiziale) c’è l’annotazione e potenziali preclusioni (non potrà essere amministratore di altra società almeno finché non esdebitato, perché avrebbe difficoltà a ottenere fiducia). Ma diciamo non ci sono più pene automatiche come il ritiro del passaporto ecc.
- Soci di Srl: in sé non rispondono dei debiti sociali, a meno abbiano prestato garanzie. Però, se hanno finanziato la società in crisi impropriamente, potrebbero subire l’azione di restituzione (postergazione). Ma partecipando attivamente a un concordato (ad es. con apporto di finanza esterna per migliorare la proposta) sicuramente limitano scenari peggiori.
In sostanza, affrontare la crisi in modo trasparente e nel rispetto delle procedure previene gran parte dei guai legali personali. Invece fuggire o occultare aggrava posizioni. Va menzionato infine che se la crisi degenera in insolvenza irreversibile e finisce in liquidazione giudiziale, l’amministratore potrebbe essere chiamato a rispondere di azione di responsabilità promossa dal curatore se ha violato i doveri (art. 2486 c.c.: amministratori che hanno aggravato il dissesto rispondono verso i creditori per il deficit aumentato). Ma se l’amministratore ha attivato per tempo assetti adeguati e procedure di composizione, difficilmente gli verrà imputato quell’aggravamento. Cass. 2022 su questo è stata chiara: l’obbligo di attivarsi tempestivamente è cruciale per non incorrere in colpa grave.
Esempi pratici di gestione della crisi (casi simulati)
Esempio 1 – Sovraindebitamento del consumatore: Maria, ex dipendente, ha accumulato €80.000 di debiti personali: prestiti al consumo, carte di credito, bollette arretrate, e un debito IRPEF. Ora è pensionata con €1.000 al mese. Non possiede casa (vive in affitto) né altri beni di valore. Con questi introiti, pagare integralmente è impossibile; al contempo, i creditori (finanziarie e Agenzia Entrate Riscossione per €10k di IRPEF) la perseguitano con lettere minacciose e una finanziaria ha ottenuto un decreto ingiuntivo. Opzione: Maria si rivolge all’OCC della sua città. Con l’aiuto del gestore, elabora un piano del consumatore: propone di versare €300 al mese per 5 anni ai creditori (in totale €18.000, che rappresenta circa il 22% del debito), suddivisi proporzionalmente tra tutti. Trattiene €700/mese per vivere (soglia di mantenimento). Non ha beni da liquidare. L’OCC redige la relazione: spiega che l’indebitamento è dovuto in parte a spese mediche e al mantenimento di un figlio disoccupato – Maria non ha colpe gravi, ha ridotto al minimo le spese familiari e non ha precedenti. Valuta che se i creditori facessero esecuzioni, non otterrebbero granché: il quinto pignorabile della pensione è circa €200/mese, quindi in 5 anni al massimo ricaverebbero €12.000, meno della proposta. Dunque il piano dà più soddisfazione. Il giudice, considerata la meritevolezza e la convenienza, omologa il piano. Le finanziarie e l’ADER sono vincolate: sospendono ogni azione. Maria paga puntualmente €300 al mese all’OCC che li ripartisce ai creditori come da piano. Dopo 5 anni ha versato €18.000; il giudice la dichiara esdebitata dal residuo di €62.000. Lei riparte da zero, i creditori hanno ottenuto il meglio possibile data la sua situazione. Se Maria, invece, fosse stata totalmente priva di capacità di pagamento (poniamo pensione di sola sociale €500 senza margine), avrebbe potuto tentare l’esdebitazione incapiente subito: ottenere la cancellazione dell’€80k di debiti senza esborso, rimanendo sotto osservazione per 4 anni. In caso di miglioramento reddituale, avrebbe dovuto onorare i creditori fino a concorrenza.
Esempio 2 – Concordato preventivo in continuità: Alfa S.p.A. produce componenti auto. Ha 50 dipendenti. A causa di crisi del settore e errori gestionali, accumula €5 milioni di debiti (banche €2M, fornitori €1,5M, fisco €0,5M, altri €1M) a fronte di attivo €4M (capannone €2M, macchinari €1M, crediti €1M). È insolvente: fatica a pagare stipendi e fornitori, le banche hanno revocato gli affidamenti. Ma ha ordini in corso e know-how valido. Soluzione proposta: i dirigenti, con un advisor finanziario, definiscono un piano di risanamento aziendale: chiusura di una linea improduttiva, licenziamento di 10 addetti (utilizzando un fondo di garanzia per TFR), vendita di un immobile non strategico per €1M, ingresso di un investitore che apporta €500k per il 60% delle quote, conversione a capitale di €500k di crediti fornitori strategici (che accettano di diventare soci minoritari), stralcio del 50% degli altri debiti chirografari, pagamento integrale dei debiti fiscali in 4 anni (usando transazione fiscale), pagamento delle banche con nuova linea a 7 anni (moratoria 1 anno). Si valuta che in caso di fallimento i creditori chirografari prenderebbero forse 20%. L’azienda deposita domanda di concordato preventivo in continuità: la proposta prevede di soddisfare i chirografari al 50% in 5 anni (20% garantito da vendita immobile, 30% con utili futuri), i privilegiati (Erario) al 100% in 4 anni senza interessi (transazione fiscale), le banche ristrutturate fuori dal concordato tramite accordo (ma si considera come classe separata con pagamento integrale su 7 anni). Il tribunale ammette Alfa al concordato e nomina un commissario. Fornitori e altri creditori votano: grazie anche al lobbying dell’advisor che spiega che con fallimento vedrebbero briciole, la maggioranza vota sì. Alcuni piccoli fornitori (20%) votano no, ma sono vincolati dall’approvazione della maggioranza. Il tribunale omologa. Un opponente contesta che il 50% ai chirografari è troppo poco, ma il giudice rigetta l’opposizione dimostrando che il ricavato liquidatorio (capannone venduto, etc.) avrebbe pagato solo il 20%, quindi il 50% è conveniente. Si esegue il piano: l’investitore immette €500k (liquidità prededucibile che finanzia il rilancio), l’immobile viene venduto e frutta €1M per pagare i creditori iniziali. L’azienda, liberata da metà dei debiti e con nuova governance, torna redditizia e in 5 anni paga tutte le rate concordatarie. A fine piano, Alfa S.p.A. è ancora attiva, con debiti ridotti ai soli finanziamenti nuovi. I vecchi soci hanno perso parte controllo ma hanno evitato il fallimento. I creditori hanno preso 50% invece di 20%. I dipendenti hanno mantenuto il posto (salvo 10 in esubero che però hanno avuto TFR garantito e Naspi). Se i creditori non avessero approvato il piano, Alfa sarebbe andata in fallimento con probabilissima cessazione, licenziamento collettivo e recuperi modesti per i creditori.
Esempio 3 – Liquidazione controllata di un imprenditore minore: Beta è un ex imprenditore edile individuale. Ha chiuso l’attività nel 2023, con debiti per €400.000 (di cui €150k verso banche con garanzie ipotecarie su un terreno di sua proprietà, €100k fornitori, €50k dipendenti, €100k fisco). Non è fallibile (sotto soglie). Beta non ha liquidità né prospettive di pagare i creditori; possiede solo un terreno (valore stimato €200k) e due vecchi mezzi da cantiere (valore €30k). Percorso: Beta si rivolge a un OCC e avvia una liquidazione controllata. Il tribunale apre la procedura e nomina un liquidatore. Vengono sospesi i pignoramenti avviati da alcuni fornitori. Il liquidatore vende il terreno per €180k e i macchinari per €30k = ricavato €210k. Distribuzione: prima si pagano le spese di procedura (€15k a liquidatore e OCC, prededucibili). Restano €195k. I crediti privilegiati (dipendenti e fisco) hanno prelazione generale: dipendenti €50k (TFR e stipendi) ricevono 100%; Erario €100k riceve circa 80k (80%). Rimangono circa €65k. I crediti ipotecari sulla vendita del terreno: la banca ipotecaria aveva credito €150k, ma il terreno vale 180k; tuttavia prima vanno soddisfatti privilegi generali su quell’attivo – in realtà i privilegi generali (dipendenti/fisco) hanno prelazione su mobiliare ma non su immobiliare se ipoteca anteriore. Supponiamo l’ipoteca fosse iscritta prima, allora banca prende €150k (fino a capienza). In pratica, la banca ipotecaria prenderà tutto il ricavato del terreno al netto delle spese su quell’attivo. Fornitori chirografari restano a bocca asciutta. Al termine, Beta rimane con €400k – €195k = €205k di debiti impagati. Beta chiede esdebitazione: avendo cooperato e non commesso irregolarità, il giudice gliela concede. I creditori chirografari non hanno ottenuto nulla, ma i loro crediti sono ora estinti per legge; la banca e il fisco hanno preso una parte e per il saldo non possono pretendere oltre da Beta. Beta dunque “riparte pulito” (pur avendo perso il terreno e beni). Se Beta, invece di liquidazione, avesse provato un concordato minore offrendo magari di pagare 50k totali ai chirografari vendendo i mezzi, sarebbe stato inutile perché i beni non coprivano nemmeno i privilegi. In questi casi di insolvenza completa, la liquidazione è la via giusta e l’esdebitazione la vera salvezza del debitore onesto.
Esempio 4 – Composizione negoziata e concordato semplificato: Gamma S.r.l. (settore ristorazione, 10 addetti) dopo il COVID ha accumulato €600k debiti (banche 200k, fornitori 200k, affitti 50k, debiti fiscali 150k) e ha 50k di cassa, fatturato in ripresa ma non sufficiente a rimborsare i debiti nei tempi. Attività ancora potenzialmente redditizia, ma serve ridurre il debito e ristrutturare. Gamma tenta la composizione negoziata: tramite la piattaforma viene nominato un esperto. Chiede misure protettive e ottiene lo stop ai pignoramenti (alcuni fornitori avevano avviato decreti ingiuntivi). L’esperto aiuta a stendere un piano: propone alle banche di allungare i mutui di 5 anni, ai fornitori di accettare il 60% a saldo, al proprietario del locale di ridurre il canone del 20%. Dopo 3 mesi di trattative, nessun accordo formale viene raggiunto: le banche vogliono rientrare subito, troppi fornitori dicono no allo stralcio. L’esperto nella relazione finale conclude che “non è stato possibile trovare un accordo idoneo, ma esiste comunque un patrimonio liquidabile e un’attività cessabile che in concordato potrebbe dare una soddisfazione migliore rispetto alla liquidazione giudiziale”. In altre parole, consiglia un concordato semplificato per liquidazione (ex art. 25-sexies). Gamma, entro 60 giorni, presenta in tribunale una proposta di concordato semplificato liquidatorio: propone di vendere l’azienda (o i beni) e distribuire il ricavato, stimando di poter pagare il 30% ai chirografari. Non c’è voto dei creditori; il tribunale fissa udienza, sente alcuni creditori opponenti (qualcuno lamenta che potrebbe avere di più vendendo “a pezzi” – ma il giudice valuta che l’offerta di un compratore unico per l’azienda in funzionamento rende di più del fallimento). Alla fine omologa il concordato semplificato. Un liquidatore nominato vende l’azienda come ramo d’esercizio per €300k ad un investitore (che rileva anche i 10 dipendenti mantenendo i livelli occupazionali). Il liquidatore paga i creditori privilegiati (fisco) e i chirografari intorno al 30%. Gamma S.r.l. viene poi cancellata. I soci escono senza nulla ma senza strascichi di debiti. Questo scenario, frutto del nuovo strumento, ha evitato la lunga trafila del fallimento e magari la dispersione degli assets (l’azienda venduta intera come going concern ha massimizzato il valore). Certo, Gamma ha perso la propria attività, ma in una modalità più ordinata e con parziale soddisfazione dei creditori. Se Gamma avesse cercato subito un concordato preventivo liquidatorio, avrebbe dovuto passare per il voto dei creditori, il che quasi sicuramente sarebbe fallito vista la poca soddisfazione offerta. Invece, grazie alla composizione negoziata (pur fallita) ha potuto accedere a questa scorciatoia concorsuale senza voto.
Fonti e Riferimenti Normativi/Giurisprudenziali
AvvocatiCartelleSattoriali, “Piano Attestato di Risanamento 2025: come funziona” (Maggio 2025) – approfondisce l’istituto del PAR: inquadramento storico, art. 56 CCII definizione di crisi/insolvenza per accesso anche se insolvente purché recuperabile, ambito soggettivo (solo imprenditori fallibili, imprese minori di fatto escluse da benefici revocatoria), effetti protettivi (esenzione revoche), requisiti di forma e attestazione. Utile per capire differenze con altre procedure e come collocare il PAR nel sistema.
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – Art. 2, comma 1 (Definizioni di crisi, insolvenza, sovraindebitamento); Art. 56 (Piani attestati di risanamento); Art. 65-91 (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento); Art. 2086 c.c. (Obbligo adeguati assetti per rilevare la crisi).
D.L. 118/2021 conv. in L.147/2021 – Introduzione composizione negoziata della crisi; art. 2 (Piattaforma telematica e nomina esperto); art. 6 (misure protettive in composizione negoziata); art. 11 (concordato semplificato per liquidazione).
D.Lgs. 83/2022 – Correttivo al CCII recependo Dir. UE 2019/1023.
D.Lgs. 136/2024 – Correttivo ter (in vigore 28/9/2024), novità su definizioni e procedure familiari, adeguati assetti, transazione fiscale rafforzata, ecc.
Cassazione Civile, Sez. I, 26/07/2023 n. 22699 – Chiarisce nozione di consumatore e imprenditore per procedure sovraindebitamento: l’ex imprenditore con debiti da attività cessata non è consumatore e può accedere solo a liquidazione (no concordato minore). Conferma orientamento oggettivo: qualificazione in base alla natura dei debiti.
Cassazione Civile, Sez. III, 26/07/2023 n. 22715 – Rapporti tra giudice sovraindebitamento e giudice esecuzioni: il giudice della procedura ex L.3/2012 (oggi CCII) può solo disporre il generale divieto di iniziare o proseguire esecuzioni, ma i singoli provvedimenti di sospensione/improcedibilità dei pignoramenti spettano al giudice dell’esecuzione, il quale informato del divieto deve sospendere ex art. 623 c.p.c.. Pronuncia rilevante per coordinamento misure protettive.
Cassazione Civile, Sez. I, 26/07/2023 n. 22616 – Legittimazione del creditore a opporsi all’apertura di liquidazione ex L.3/2012: i creditori hanno interesse e possono fare reclamo contro il decreto di apertura, e ricorso in Cassazione avverso la decisione sul reclamo. Conferma che il creditore può contestare i presupposti di ammissione alla procedura di sovraindebitamento se lesivo dei suoi diritti (es. procrastina esecuzioni, rischio esdebitazione parziale).
Cassazione Civile, Sez. I, 23/12/2024 n. 34150 – In tema di piano del consumatore: è ammissibile prevedere una dilazione ultrannuale (>1 anno) per il pagamento di crediti privilegiati, derogando al limite di cui all’art. 8 co.4 L.3/2012, purché si dia ai creditori privilegiati diritto di voto o comunque voce sulla convenienza. Se la dilazione è infrannuale, invece, il creditore non può contestare la convenienza né serve voto. Pronuncia che recepisce orientamenti del 2019 e li applica a L.3/2012 e Codice.
Cassazione Civile, Sez. I, 23/12/2024 n. 34133 – Sull’art. 4-ter D.L.137/2020 conv. L.176/2020: la facoltà per il debitore sovraindebitato di presentare una nuova proposta entro 90 gg in caso di diniego di omologa si applica ai procedimenti pendenti al 25/12/2020, ma va esercitata entro l’udienza di omologazione della prima procedura. Se tale udienza è già avvenuta, l’istanza di termine suppletivo è inammissibile. Quindi niente “seconda chance” se la richiesta arriva tardiva.
Cassazione Civile, Sez. I, 30/04/2025 n. 11448 – Il provvedimento che dichiara inammissibile l’apertura della liquidazione del patrimonio ex L.3/2012 (ad esempio per mancanza requisiti) non è ricorribile per Cassazione ex art.111 Cost., poiché privo di definitività (non preclude altra istanza). Quindi il debitore non può fare ricorso straordinario se gli viene negata l’apertura; dovrà semmai ripresentare domanda correggendo i difetti o appellare se possibile in altro modo.
Unioncamere – Osservatorio sulla composizione negoziata (dati al 15/10/2023): 1003 istanze presentate, 405 chiuse: 35% chiuse per assenza prospettive risanamento, 35% per trattativa fallita, ~11% per rinuncia debitore; esiti positivi in 79 casi (22 contratti conclusi, 30 accordi ex art.23 lett.c omologati, 14 altre procedure attivate, 11 domande omologa accordi ex art.23 co.2 lett. b). Tasso di successo ~16%. (Fonte: News Angela Randazzo, Diritto della Crisi).
Unioncamere Comunicato 14/11/2024 – Dalla partenza (nov 2021) quasi 2.000 adesioni alla composizione negoziata; +926 istanze in più a nov 2024 rispetto anno prima; 210 imprese avviate a risanamento (vs 83 un anno prima);oltre 10.000 posti di lavoro salvati; l’85,7% imprese coinvolte sono società di capitali, media 64 addetti e €13 milioni fatturato. Dati evidenziano crescente ricorso e efficacia dello strumento per imprese di dimensione PMI significativa.
Azienda in Crisi: A Chi Rivolgersi
La tua impresa sta affrontando difficoltà economiche? Fatturato in calo, debiti in aumento, conti bloccati o creditori sempre più pressanti?
Molte aziende attraversano momenti critici, ma non tutte sanno che esistono strumenti legali per uscire dalla crisi senza chiudere. Con il giusto supporto puoi evitare il fallimento, ristrutturare i debiti e rilanciare la tua attività.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la situazione economica, finanziaria e debitoria della tua azienda
- 📌 Valuta le soluzioni più adatte: composizione negoziata, piano di ristrutturazione, liquidazione controllata
- ✍️ Predispone istanze, piani e documentazione per accedere alle procedure di risanamento previste dalla legge
- ⚖️ Ti rappresenta davanti al tribunale e nelle trattative con creditori, fornitori e banche
- 🔁 Ti accompagna nel percorso di rilancio, anche con accordi stragiudiziali o gestione della crisi da sovraindebitamento
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto delle crisi d’impresa e procedure di risanamento
- ✔️ Specializzato nell’assistenza a PMI in difficoltà economica
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Se la tua azienda è in crisi, non aspettare che sia troppo tardi. Esistono strumenti concreti per risanare, rinegoziare e ripartire.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua ripresa inizia oggi.