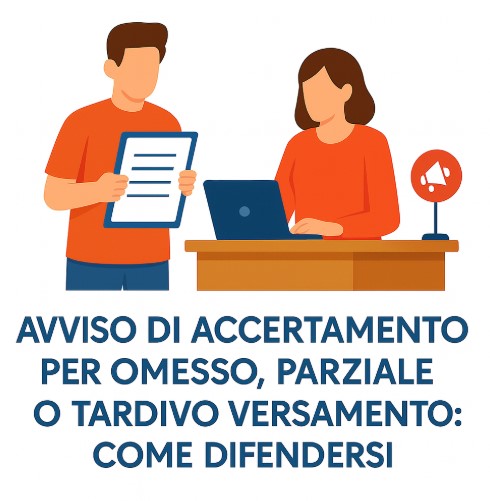Hai ricevuto un avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento di imposte? L’Agenzia delle Entrate ti contesta di non aver pagato tutto l’importo dovuto nei termini previsti, e ti chiede ora il versamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni? Se ritieni l’accertamento ingiusto, sproporzionato o se hai una giustificazione valida, puoi difenderti e tutelare la tua posizione.
Quando l’Agenzia può emettere un avviso per versamenti omessi o tardivi?
– Quando non hai versato, in tutto o in parte, l’IVA, l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP o le ritenute
– Se hai versato in ritardo rispetto alla scadenza prevista, anche di pochi giorni
– Se ci sono errori nei codici tributo o negli F24, che rendono il pagamento irregolare
– In caso di compensazioni non spettanti, che riducono impropriamente l’imposta da pagare
– Se l’Agenzia rileva mancati versamenti da dichiarazione o da controllo automatizzato
Cosa può contenere l’avviso di accertamento?
– L’indicazione dell’imposta non versata
– Il calcolo degli interessi di mora
– Le sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento (fino al 30% dell’imposta)
– L’invito al pagamento entro termini ristretti
– L’avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà con iscrizione a ruolo e riscossione coattiva
Come puoi difenderti da un avviso di accertamento per omesso versamento?
– Verifica attentamente se l’imposta risulta effettivamente non pagata o se c’è un errore formale
– Controlla se hai effettuato il pagamento, ma è stato registrato con codice errato o anno d’imposta sbagliato
– Se l’importo è stato versato in parte, puoi contestare la sanzione piena e chiedere la sua riduzione
– Dimostra, se possibile, che il mancato versamento è dovuto a cause non imputabili a te
– Se sei ancora nei termini, valuta di ravvederti spontaneamente, pagando con sanzioni ridotte
– Se l’avviso è viziato o illegittimo, puoi presentare memorie difensive o ricorso tributario
Cosa puoi ottenere con una difesa tempestiva e documentata?
– L’annullamento dell’avviso, se il versamento è stato effettuato correttamente
– La correzione dei dati di versamento presso l’Agenzia
– La riduzione delle sanzioni in caso di pagamento parziale o di lieve ritardo
– La possibilità di rateizzare l’importo dovuto, evitando il blocco dei conti o il pignoramento
– La sospensione della riscossione, in caso di contestazione fondata
Attenzione: un semplice errore materiale, come un codice tributo sbagliato o un F24 compilato male, può generare un accertamento fiscale con sanzioni. Ma in molti casi si può risolvere tutto con una memoria scritta, una correzione formale o un ravvedimento.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in accertamenti per omessi versamenti e contenzioso fiscale ti spiega come difenderti se l’Agenzia delle Entrate ti contesta un versamento non effettuato, in parte o in ritardo, e come evitare sanzioni ingiuste.
Hai ricevuto un avviso e vuoi sapere se puoi contestarlo? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a verificare i pagamenti, correggere gli errori e difenderti da sanzioni improprie.
Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per omesso, parziale o tardivo versamento di imposte è una situazione impegnativa che può riguardare privati, imprenditori e professionisti. In termini semplici, significa che il Fisco contesta al contribuente di non aver versato affatto, aver versato solo in parte o aver versato in ritardo alcune somme dovute a titolo di tasse o imposte, e pertanto gli notifica un atto ufficiale con cui richiede il pagamento del dovuto, più sanzioni e interessi. Dal punto di vista del debitore, è fondamentale sapere come reagire, quali strumenti di tutela sono disponibili e quali sono i passi da seguire per evitare di pagare somme non dovute o per gestire correttamente il debito fiscale.
Questa guida – aggiornata a luglio 2025 – offre un approfondimento avanzato in materia di accertamenti tributari, pensato per avvocati tributaristi, consulenti fiscali ma anche contribuenti informati. Adotteremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, spiegando i concetti tecnici in modo comprensibile e fornendo riferimenti normativi, giurisprudenziali e prassi aggiornate. Saranno trattati sia gli strumenti di difesa nel merito (ricorsi alle Corti di Giustizia Tributaria) sia le procedure di riscossione coattiva attivabili in caso di mancato pagamento, in egual misura, con un’attenzione particolare alle tutele del debitore. Inoltre, troverete tabelle riepilogative dei principali termini e limiti, esempi pratici e una sezione di Domande & Risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni.
Importanza di agire tempestivamente: l’avviso di accertamento è un atto impugnabile entro termini perentori (60 giorni dalla notifica, salvo sospensioni), trascorsi i quali diventa definitivo. Se ignorato, può portare rapidamente a misure esecutive come cartelle di pagamento, fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti. D’altro canto, esistono strumenti per ridurre le sanzioni (come l’adesione o l’acquiescenza) o per dilazionare il pagamento. Conoscere i propri diritti – ad esempio il diritto a una motivazione chiara dell’atto, o le soglie oltre le quali scattano ipoteche e pignoramenti – può fare la differenza tra subire passivamente la pretesa fiscale e ottenere ragionevoli concessioni o l’annullamento dell’atto in caso di vizi.
Nei paragrafi che seguono, inizieremo definendo cosa sia un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento e quali sono le basi legali della contestazione. Passeremo poi alla fase pre-contenziosa, spiegando il ruolo delle comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”) e del ravvedimento operoso. Quindi affronteremo le strategie difensive vere e proprie: dagli istituti deflattivi (come l’istanza di autotutela, l’accertamento con adesione, l’acquiescenza) al ricorso in giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie dal 2023), illustrando il procedimento e le novità normative (ad esempio l’abolizione dal 2024 del reclamo/mediazione obbligatorio, i termini accelerati per le sospensive, ecc.). Successivamente, ci concentreremo sulle procedure di riscossione coattiva in caso di mancato pagamento: dalla notifica della cartella (o dell’intimazione immediata) fino alle misure come fermi, ipoteche e pignoramenti, con i rispettivi limiti di legge e le pronunce giurisprudenziali più recenti a tutela del contribuente. Infine, verranno presentate alcune FAQ – Domande frequenti, con risposte concise, e una raccolta di Fonti normative e giurisprudenziali a supporto dei contenuti esposti.
Nota: Le informazioni fornite sono riferite esclusivamente al sistema tributario italiano e allo stato della normativa e della giurisprudenza a luglio 2025. Eventuali future riforme (come l’attuazione della Delega Fiscale 2023) potrebbero apportare ulteriori modifiche, che saranno segnalate ove già previste. Ora entriamo nel vivo della questione, iniziando dalla natura di un avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento e dal contesto normativo di riferimento.
Che cos’è un avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento
Un avviso di accertamento tributario è l’atto formale con cui l’Amministrazione finanziaria (ente impositore, tipicamente l’Agenzia delle Entrate) comunica al contribuente una pretesa fiscale determinata, a seguito di attività di controllo. Nel caso specifico di omesso, carente o tardivo versamento, l’avviso di accertamento contesta al contribuente di non aver versato affatto, oppure di aver versato solo in parte, oppure di aver versato in ritardo importi dovuti in base alle dichiarazioni fiscali o ad altri obblighi di legge, entro le scadenze previste. In altre parole, non si tratta di una rettifica della base imponibile o di un’imposta sconosciuta (come negli accertamenti per maggior reddito non dichiarato), bensì di un’accusa di mancato pagamento di imposte dichiarate o liquidate. L’avviso quantifica le somme non versate e vi aggiunge le relative sanzioni amministrative pecuniarie e interessi.
È importante distinguere le tre fattispecie:
- Omesso versamento: il contribuente non ha effettuato il pagamento di un tributo entro la scadenza prevista, né integralmente né parzialmente. Esempio tipico: Tizio presenta la dichiarazione dei redditi indicando un saldo IRPEF da versare di €10.000 ma non versa nulla. Oppure: Caio, sostituto d’imposta, trattiene le ritenute ai dipendenti ma non le riversa all’Erario. In tali casi si configura un omesso versamento dell’imposta dovuta.
- Versamento parziale (carente): il contribuente effettua un pagamento inferiore al dovuto. Ad esempio, doveva versare €10.000 ma per errore o mancanza di liquidità ne versa solo €4.000; restano €6.000 non versati (carente). Oppure effettua compensazioni in F24 non spettanti, versando di fatto meno del dovuto. Il versamento parziale, in termini sanzionatori, è equiparato all’omissione per la parte non versata.
- Versamento tardivo: il contribuente versa sì l’importo dovuto, ma oltre la scadenza prevista dalla legge. Ad esempio paga l’IRAP dovuta con 30 giorni di ritardo, oppure versa l’acconto IVA alcuni mesi dopo. In questi casi l’imposta principale è stata assolta, ma in ritardo. L’Amministrazione contesterà il ritardato versamento, che configura una violazione sanzionabile pur se il tributo è stato infine pagato.
Dal punto di vista del contenuto dell’avviso, omissione, carenza o ritardo attivano lo stesso meccanismo sanzionatorio, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (norma cardine in materia di sanzioni sui versamenti). Tale articolo stabilisce le seguenti sanzioni amministrative per il contribuente:
- Se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione ridotta dell’1% per ogni giorno di ritardo. (Questa fattispecie copre i cd. “ravvedimenti brevissimi” spontanei, ma nell’avviso di accertamento vero e proprio normalmente il termine è abbondantemente scaduto, quindi questa soglia rileva più che altro in fase di ravvedimento operoso, come vedremo).
- Se il versamento è eseguito dal 16º al 90º giorno dopo la scadenza, si applica una sanzione fissa del 15% dell’importo non versato.
- Se il versamento è eseguito oltre il 90º giorno dalla scadenza (o non eseguito affatto), si applica una sanzione del 30% dell’importo non versato. Questa è la situazione tipica richiamata negli avvisi di accertamento per omesso/carente versamento: decorso inutilmente il termine di 90 giorni, la sanzione piena è il 30%.
Queste percentuali valgono per i tributi erariali principali (IRPEF, IRES, IVA, ritenute, IRAP, ecc.). Per altri tributi o contributi possono esservi previsioni particolari, ma in generale il 30% costituisce la sanzione standard per gli omessi versamenti di imposte. Da notare che la norma prevede già sanzioni ridotte per i ritardi entro 90 giorni, incentivando il contribuente a regolarizzare spontaneamente in breve tempo. Trascorsi 90 giorni, il comportamento è equiparato all’omissione totale ai fini sanzionatori.
Oltre alla sanzione proporzionale, l’avviso liquiderà anche gli interessi moratori sul tributo non versato, calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino alla data di pagamento (o fino alla notifica dell’atto, a seconda delle norme). Il tasso d’interesse è stabilito annualmente (per il 2025 è ad esempio il 2%, in aumento dal tasso legale precedente), ma questo aspetto attiene più alla quantificazione del dovuto che al diritto di difesa.
Un punto cruciale, specialmente per i versamenti omessi ripetuti, è come si applicano le sanzioni in caso di pluralità di violazioni. Ogni scadenza non rispettata rappresenta, in linea di principio, una violazione a sé stante, sanzionata autonomamente. Ad esempio, se un contribuente non versa l’IVA dovuta per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, ha commesso tre omissioni distinte, ciascuna punibile con il 30% dell’importo non versato. Non si applica in questi casi il cosiddetto “cumulo giuridico” previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 per violazioni formali o sostanziali della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi. La Cassazione ha infatti chiarito che gli omessi o tardivi versamenti, riguardando imposte già liquidate, danno luogo a sanzioni autonome per ciascun mancato pagamento, senza riduzioni per continuazione. In particolare, con l’ordinanza n. 19972 del 12/07/2023 la Suprema Corte (Sez. V) ha ribadito che l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 impone sanzioni proporzionali e autonome per ogni omesso versamento, escludendo la possibilità di applicare un’unica sanzione globale per più versamenti omessi nello stesso periodo. D’altra parte, se le omissioni riguardano periodi d’imposta differenti, potrebbe astrattamente applicarsi il cumulo previsto dall’art. 12 co.5 D.Lgs. 472/97 (unica sanzione base aumentata fino al triplo per violazioni della stessa indole in più anni), ma questo richiede che tutte le violazioni vengano contestate contestualmente. Nella pratica del controllo automatizzato, però, gli omessi versamenti vengono contestati man mano che emergono (spesso con atti distinti per anno), quindi la questione del cumulo giuridico è di rado invocabile dal contribuente in questi casi. In ogni caso, l’onere di eccepire l’eventuale applicazione di una sola sanzione per continuazione spetta al contribuente in sede di impugnazione, ed è un argomento tecnico da valutare con cura legale (come vedremo, alcune pronunce di merito hanno talora riconosciuto un’unica sanzione per più omissioni d’imposta annuali concomitanti, ma la Cassazione tende a una linea restrittiva).
Esempio pratico: Mario Rossi presenta la dichiarazione IVA per l’anno 2023 con un debito d’imposta di €50.000, ma non versa nulla. Inoltre, non versa nemmeno le ritenute IRPEF operate sui dipendenti nel corso del 2023 (supponiamo €10.000 di ritenute certificate e non pagate). L’Agenzia delle Entrate, tramite i controlli automatizzati incrociando la dichiarazione IVA e il modello 770 dei sostituti d’imposta, rileva queste mancate entrate. Verranno presumibilmente emessi: (a) un avviso di liquidazione/accertamento per omesso versamento IVA 2023 di €50.000, con sanzione 30% (€15.000) più interessi; (b) un avviso di accertamento (o atto di contestazione sanzioni) per omesso versamento ritenute 2023 di €10.000, con sanzione 30% (€3.000) più interessi. Mario si troverà dunque dinanzi a due atti, ciascuno riferito a un tributo diverso, ognuno con la propria sanzione del 30%. Non verrà emessa un’unica sanzione globale sul totale €60.000, poiché le due omissioni riguardano obblighi diversi; né verrebbe considerata “continuazione” l’omissione reiterata mensilmente delle ritenute, in quanto ogni mese costituisce un’omissione autonoma. In compenso, Mario avrebbe potuto (prima di ricevere l’accertamento) ravvedersi e pagare spontaneamente riducendo le sanzioni, oppure attendere il primo sollecito bonario che gli avrebbe consentito di pagare con sanzione ridotta al 10% (come vedremo a breve).
Va evidenziato che l’avviso di accertamento per omesso/tardivo versamento non è preceduto da un “processo verbale” o da un accesso fiscale come accade negli accertamenti da verifica in azienda. Spesso è l’esito di controlli automatizzati sulla base delle dichiarazioni stesse del contribuente (c.d. controllo ex art. 36-bis DPR 600/1973 per imposte sui redditi, e art. 54-bis DPR 633/1972 per IVA), oppure di controlli formali (art. 36-ter DPR 600/1973) o incroci di banche dati (ad esempio: modello 770 vs versamenti F24). In altre parole, il Fisco confronta quanto dichiarato o certificato con quanto effettivamente versato: se trova un delta negativo (versato meno del dovuto), attiva la procedura di recupero.
Base normativa: L’avviso richiama tipicamente, oltre all’art. 13 D.Lgs. 471/97 sulle sanzioni, le norme che impongono il versamento dell’imposta (ad es. gli articoli del DPR 600/73 o 602/73 per le imposte sui redditi, del DPR 633/72 per l’IVA, etc.), nonché le disposizioni procedurali introdotte dal D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010 in tema di “accertamento esecutivo”. Infatti, dal 2011 in poi, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per imposte erariali sono anche titoli esecutivi, contenendo un’intimazione di pagamento entro il termine per ricorrere (60 giorni), decorsi i quali, in mancanza di ricorso, l’avviso vale come una cartella esattoriale per attivare la riscossione. Su questo torneremo dettagliatamente più avanti.
Riassumendo, l’avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento è un atto impositivo immediatamente esecutivo con cui il Fisco contesta un debito tributario non pagato nei termini, quantificando imposta, sanzioni e interessi e intimandone l’adempimento. Si differenzia dagli avvisi di accertamento “classici” (per maggiori imponibili o violazioni dichiarative) perché non introduce una nuova pretesa impositiva basata su elementi extra-dichiarativi, ma formalizza il recupero di importi che il contribuente stesso aveva dichiarato (o doveva dichiarare) come dovuti ma che non sono entrati nelle casse erariali. Ciò non toglie che la difesa del contribuente possa svilupparsi su vari fronti – contestando ad esempio errori dell’Ufficio nel calcolo, eccependo cause di non punibilità, o facendo valere vizi formali dell’atto – come vedremo nelle sezioni successive.
Normativa di riferimento e presupposti legali
Affrontare un avviso di accertamento richiede di inquadrarlo nelle disposizioni normative pertinenti. Ecco un riepilogo delle principali fonti normative italiane e principi legali che entrano in gioco nel caso di omessi o tardivi versamenti:
- Art. 13 D.Lgs. 471/1997: è la norma fondamentale che sanziona i ritardi e le omissioni di versamento delle imposte. Come già esposto, prevede l’1% al giorno fino a 15 giorni, il 15% dal 16º al 90º giorno, e il 30% oltre il 90º giorno. Questa sanzione si applica “se il contribuente non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dovuti… entro il termine previsto”. È una sanzione di natura amministrativa tributaria, non penale (le sanzioni penali per omesso versamento sono altra materia, disciplinate dal D.Lgs. 74/2000, di cui diremo più avanti a parte). L’articolo 13 va letto in combinato con l’art. 12 D.Lgs. 472/1997, che regola il cumulo giuridico delle sanzioni: quest’ultimo articolo però esclude espressamente dal cumulo alcune violazioni come quelle sui versamenti già liquidati, ragione per cui – come confermato dalla Cassazione – ogni versamento omesso fa storia a sé quanto a sanzione.
- D.Lgs. 472/1997, articoli 5 e 6: contengono i principi generali delle sanzioni tributarie. In particolare l’art. 5 sancisce il principio del “favor rei” (applicazione della sanzione più favorevole se la normativa cambia) e l’art. 6 enuncia alcune cause di non punibilità. Di rilievo per l’omesso versamento è l’art. 6, comma 5, che prevede: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. La forza maggiore, intesa in senso rigoroso, può esonerare dalle sanzioni amministrative (non dall’obbligo d’imposta) se l’inadempimento è dovuto a eventi imprevedibili e fuori dal controllo del contribuente che gli hanno impedito di pagare. Ad esempio, una calamità naturale che distrugga l’azienda e la contabilità prima della scadenza dei versamenti potrebbe configurare forza maggiore. La giurisprudenza, tuttavia, è molto severa nel riconoscere la forza maggiore: difficoltà finanziarie o ritardi nei pagamenti da parte dei clienti (o dello Stato, nel caso di appalti pubblici) di regola non sono considerati forza maggiore, in quanto rientrano nel rischio d’impresa e non eliminano del tutto la volontà dell’imprenditore. La Cassazione (sent. n. 11111/2022) ha ad esempio escluso che la crisi di liquidità causata dai ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione configuri forza maggiore, richiamando il principio (anche penale) per cui “le difficoltà economiche impreviste non hanno effetto scriminante”. Ciò significa che il contribuente, per evitare le sanzioni, deve provare eventi davvero eccezionali (es: un impedimento legale assoluto, un fatto coercitivo esterno); la normale mancanza di fondi non basta. Sul punto torneremo parlando delle possibili strategie difensive (invocare forza maggiore in ricorso è possibile, ma l’onere probatorio è elevato e l’accoglimento raro).
- Artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992 (come modificati dalla L.130/2022): disciplinano rispettivamente gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario e il termine per ricorrere. L’avviso di accertamento rientra tra gli atti impugnabili (art.19, co.1, lett. a) D.Lgs. 546/92) e deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica (art.21). Dal 2023 le Commissioni Tributarie si chiamano Corti di Giustizia Tributaria (di primo e secondo grado), ma la sostanza del diritto di ricorso non è cambiata, salvo l’eliminazione dal 2023/2024 del tentativo obbligatorio di reclamo-mediazione per le liti sotto una certa soglia di cui parleremo. Importante: il termine di 60 giorni per il ricorso può essere sospeso di 90 giorni se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione (art.6, co.3 D.Lgs. 218/1997), e sospeso ferialmente dal 1° al 31 agosto. Ciò significa che, ad esempio, per un avviso notificato il 10 luglio, i 60 giorni scadrebbero il 8 settembre, ma con la sospensione feriale diventano il 8 ottobre; se inoltre presento istanza di adesione prima di ricorrere, i 60 giorni iniziano a decorrere dopo 90 giorni dalla richiesta di adesione (salvo chiusura anticipata della procedura). Di questi dettagli procedurali terremo conto nella sezione sui ricorsi.
- Statuto del Contribuente (L. 212/2000): diverse disposizioni dello Statuto rilevano. In primis l’art. 7 impone che ogni atto dell’Amministrazione finanziaria sia motivato, indicando “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” su cui si basa, e che se l’atto richiama altri documenti (es. un processo verbale della Guardia di Finanza) questi siano allegati o già conosciuti dal contribuente. La mancanza di motivazione o l’omessa allegazione di documenti essenziali comporta la nullità dell’atto. Nel contesto di un omesso versamento, la motivazione di solito consiste in una descrizione dell’origine del debito (es: “dall’esame della dichiarazione Modello Redditi 2024 presentata il… risulta un importo a saldo IRPEF di € X non versato entro il termine di legge”) e nel calcolo di sanzioni e interessi. Se tale motivazione è contraddittoria, incomprensibile o insufficiente, la difesa potrà eccepirne il difetto. Ad esempio, una motivazione meramente apparente – che non spiega a cosa si riferisce la richiesta – rende l’atto nullo. La Cassazione (ord. n. 13620/2023) ha confermato che un avviso con motivazione contraddittoria è invalidante. Inoltre, se l’atto rinvia per relationem a un documento (ad es. “come da comunicazione di irregolarità n…”) senza allegarlo o senza che sia già stato notificato, si viola l’art.7 Statuto. Pertanto, un avviso che cita un precedente avviso bonario deve assicurarsi che il contribuente ne abbia copia; diversamente, potrebbe essere annullato per difetto di motivazione. Altre norme dello Statuto rilevanti: l’art. 3 (irretroattività e efficacia temporale delle norme tributarie, utile se ci sono stati cambi di legge sulle sanzioni applicabili), l’art. 6 (che tra le altre cose prevede l’obbligo di comunicazione degli esiti del controllo automatizzato al contribuente, i famosi avvisi bonari, salvo che “il mancato pagamento risulti dalla dichiarazione”, vedi art.6 co.5: in passato ci si chiedeva se l’ufficio fosse obbligato a inviare l’avviso bonario prima di iscrivere a ruolo; la Cassazione ha poi chiarito che per gli omessi versamenti da dichiarazione l’avviso bonario è dovuto solo se vi è una liquidazione d’ufficio in senso stretto, mentre se il debito risulta dallo stesso dichiarante l’iscrizione a ruolo può avvenire anche senza preavviso). Infine, l’art. 17-bis Statuto (introdotto nel 2011) riguardava il reclamo/mediazione tributaria obbligatoria per liti di modesta entità: a fine 2022 tale istituto è stato reso facoltativo (come accennato, dal 2023-24 il reclamo non è più un passaggio obbligato, potendo il contribuente ricorrere subito; tuttavia resta possibile utilizzare la mediazione per evitare il giudizio, se lo si desidera).
- D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972: contengono la disciplina dell’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA. In particolare, art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72 regolano i controlli automatizzati delle dichiarazioni: la norma prevede che, se dal controllo emerge un’imposta o maggiore imposta dovuta o un minor credito, l’esito sia comunicato al contribuente (il c.d. avviso bonario) per evitargli sanzioni piene se paga nei 30 giorni. Art. 36-ter DPR 600/73 riguarda invece i controlli formali. Perché è importante? Perché l’atto che ci occupa spesso scaturisce proprio da queste procedure. Ad esempio, per le imposte dichiarate e non versate, il caso tipico è un controllo automatizzato ex art.36-bis: esso confronta l’imposta dichiarata con i versamenti registrati, e se trova un omesso versamento genera una segnalazione. La legge (D.Lgs. 462/1997) prevede che in tal caso l’Agenzia invii una comunicazione di irregolarità, con sanzioni ridotte a 1/3 (10% anziché 30%) se il contribuente paga entro 30 giorni dal ricevimento. È un passaggio di “compliance” che esamineremo tra poco. Va detto però che questo passaggio non è sempre obbligatorio: secondo la norma (art. 2 D.Lgs.462/97), l’avviso bonario segue il controllo automatizzato delle dichiarazioni. Se il mancato versamento risulta dalla dichiarazione stessa, formalmente c’è comunque un controllo automatico. La Cassazione ha però affermato che il mancato invio dell’avviso bonario non vizia la successiva cartella o accertamento, salvo specifiche eccezioni, perché non incide sul diritto di difesa (in sostanza, l’avviso bonario non è un atto impugnabile e non costituisce presupposto procedimentale obbligatorio se il debito è certo). Dunque l’assenza di un avviso bonario pregresso non potrà essere eccepita come motivo di nullità dell’accertamento, anche se potrà essere citata eventualmente in ottica di equità (ad esempio per chiedere la non applicazione di sanzioni in caso di errore scusabile, qualora l’Ufficio non abbia avvisato per tempo).
- D.P.R. 602/1973: è il “Testo Unico della riscossione delle imposte dirette”, rilevante per la fase successiva all’accertamento, ovvero la riscossione coattiva. Contiene norme sui ruoli, sulle cartelle di pagamento, sulle misure cautelari ed esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) e sui rapporti con il processo esecutivo civile. In un contesto di omesso versamento, alcune norme cruciali sono: l’art. 14 (formazione del ruolo e affidamento all’Agente della Riscossione), l’art. 25 (notifica delle cartelle entro certi termini decadenziali, ad esempio 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per i ruoli da controlli automatizzati – come la cartella per omesso versamento di imposte dichiarate), l’art. 50 (necessità di intimazione ad adempiere almeno 5 giorni prima di procedere ad esecuzione se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella/avviso), l’art. 57 (limiti alle opposizioni esperibili contro la cartella e gli atti dell’esecuzione: ad es. contro la cartella per motivi di merito bisogna fare ricorso tributario, mentre davanti al giudice dell’esecuzione sono ammesse solo opposizioni per vizi della procedura esecutiva – questa distinzione di giurisdizione è fonte di contenzioso, come vedremo), e soprattutto gli articoli pignoramento e tutele del debitore: art. 72-bis (pignoramento presso terzi semplificato da parte di AdER), art. 72-ter (limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni da parte di AdER), art. 76 (limiti all’espropriazione immobiliare, ad es. divieto di pignorare l’unico immobile abitativo non di lusso del debitore e soglia minima di debito €120.000 per pignorare immobili), art. 77 (facoltà di iscrivere ipoteca sopra €20.000), art. 86 (fermo amministrativo dei veicoli). Queste norme saranno dettagliate nella sezione sulla riscossione coattiva. Vale la pena sin d’ora ricordare che, con il D.L. 78/2010 (art.29), è stato modificato il DPR 602/73 introducendo la regola per cui gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate devono contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di ricorso, anche a titolo provvisorio in caso di ricorso, senza necessità di cartella: in pratica si è “concentrata la riscossione nell’accertamento”. Ciò ha reso ancora più interconnesse la fase di accertamento e quella di riscossione.
- D.Lgs. 218/1997: disciplina gli istituti deflattivi del contenzioso, in particolare l’accertamento con adesione e l’acquiescenza. Nel nostro contesto: l’accertamento con adesione è solitamente applicabile agli avvisi “classici” (maggiori imponibili), ma può teoricamente applicarsi anche a un omesso versamento se c’è margine di discutere sull’importo o sulle sanzioni. L’art. 6 comma 2 prevede che, in caso di adesione, le sanzioni si riducono a 1/3 del minimo (nel nostro caso il minimo coincide col 30%, quindi diverrebbe 10%). Tuttavia, spesso negli omessi versamenti c’è poco da “negoziare”, essendo importi oggettivi; l’adesione può però essere utile se il contribuente intende ottenere la rateazione più lunga prevista in adesione (fino a 8 rate trimestrali) e la riduzione delle sanzioni. L’acquiescenza (art.15 D.Lgs. 218/97) invece consiste nel pagamento entro 60 giorni senza ricorso, con riduzione delle sanzioni del 1/3 (quindi pagamento del 100% dell’imposta + 2/3 della sanzione + interessi). Questa opzione è rilevante: ad esempio, se un avviso chiede €10.000 di imposta e €3.000 di sanzioni, facendo acquiescenza si pagheranno €10.000 + €2.000 di sanzioni (più interessi) anziché €10.000 + €3.000. Più avanti analizzeremo quando conviene aderire o fare acquiescenza.
- Norme penali tributarie (D.Lgs. 74/2000, art. 10-bis e 10-ter): qui usciamo dall’ambito amministrativo, ma è doveroso un cenno. L’omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importi superiori a €150.000 annui è reato (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000), così come l’omesso versamento di IVA superiore a €250.000 annui (art. 10-ter). Tali soglie e reati sono il frutto di modifiche legislative (il DL 158/2015 ha alzato le soglie a 150k e 250k). Questi reati scattano se, entro determinati termini (ad es. il versamento IVA dovuto al 27 dicembre dell’anno successivo), permane l’omissione oltre soglia. Attenzione: la presenza di un procedimento penale non blocca il procedimento amministrativo di accertamento e riscossione, e viceversa. Sono binari paralleli: uno mira alla sanzione penale (multa e possibile reclusione), l’altro al recupero del tributo e sanzioni amministrative. In sede di difesa, però, se l’inadempimento è dovuto a crisi di liquidità, quel tema potrebbe emergere sia come esimente amministrativa (forza maggiore) sia come elemento nel giudizio penale (assenza di dolo se la crisi è realmente insuperabile). La giurisprudenza penale e amministrativa sul punto spesso dialogano: p.es., la Cassazione penale ha talora assolto imprenditori che hanno provato di aver pagato dipendenti e fornitori anziché il Fisco per necessità improrogabili, ravvisando in casi estremi la forza maggiore; ma sono orientamenti minoritari. Nella difesa dell’avviso di accertamento, comunque, eventuali rilievi penali non incidono direttamente: il giudice tributario non disapplica la sanzione amministrativa perché c’è un procedimento penale in corso. Semmai, se il contribuente ha pagato il debito tributario prima della sentenza penale, ciò potrà essere una causa di non punibilità penale (per i reati ex art. 10-bis e 10-ter il pagamento integrale del debito prima del dibattimento estingue il reato). Ma questo esula dallo scopo principale di questa guida; basti sapere che sopra certe soglie l’omesso versamento diventa anche affare penale e occorre quindi gestire la situazione con ancora maggiore attenzione (con l’ausilio contestuale di un tributarista e di un penalista se necessario).
Tutto quanto sopra fornisce il contesto legale nel quale ci muoviamo quando esaminiamo un avviso di accertamento per mancato versamento. Nella prossima sezione, vedremo cosa accade prima dell’emissione di un avviso: quali comunicazioni il contribuente può ricevere (ad esempio l’avviso bonario) e come può intervenire per evitare di arrivare alla notifica dell’atto impositivo vero e proprio. Capire la fase pre-contenziosa è utile perché, talvolta, un contribuente che agisce per tempo può risolvere il problema con costi molto inferiori, evitando sanzioni piene e contenziosi.
Fase pre-accertamento: comunicazione di irregolarità e ravvedimento operoso
Prima di trovarsi di fronte a un formale avviso di accertamento immediatamente esecutivo, il contribuente che ha omesso o ritardato un pagamento viene spesso coinvolto in una fase “preventiva” o bonaria di interlocuzione con il Fisco. Questa fase pre-accertamento ha due protagonisti principali: da un lato l’istituto del ravvedimento operoso (iniziativa spontanea del contribuente per sanare il ritardo), dall’altro le comunicazioni di irregolarità (anche dette avvisi bonari) che l’Agenzia delle Entrate invia a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni. Analizziamo brevemente entrambi:
Ravvedimento operoso prima dell’accertamento
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997, da non confondere con l’art.13 del 471/97 sulle sanzioni) è la facoltà riconosciuta al contribuente di sanare spontaneamente una violazione commessa, beneficiando di sanzioni ridotte proporzionalmente alla tempestività del ravvedimento. Nel caso di omessi o tardivi versamenti, il ravvedimento permette di pagare l’imposta dovuta, gli interessi maturati e una sanzione ridotta come segue (aggiornato alle modifiche normative degli ultimi anni):
- Ravvedimento entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo (in pratica 1/10 dell’1% giornaliero) per i primi 14 giorni. Questa forma di ravvedimento super-breve comporta una sanzione molto contenuta (ad es. 5 giorni di ritardo = 0,5% di sanzione).
- Ravvedimento dal 15º giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione fissa al 1,5% (1/10 del 15%).
- Ravvedimento oltre 30 giorni ma entro 90 giorni: sanzione 1,67% (1/9 del 15%) se entro 90 giorni; in realtà le modifiche intervenute col DLgs 158/2015 hanno introdotto frazioni diverse, ma semplificando: entro 90 giorni la sanzione può essere ridotta ad 1/9 del minimo, cioè 3,33% se il minimo fosse 30% (ma qui minimo 15% fino al 90° giorno, quindi 1/9 di 15% = ~1,67%).
- Ravvedimento oltre 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo: sanzione ridotta a 1/8 del minimo; siccome oltre 90 giorni il minimo è 30%, 1/8 di 30% = 3,75%.
- Ravvedimento oltre l’anno ma entro due anni: sanzione 4,29% (1/7 del 30%).
- Ravvedimento oltre due anni: sanzione 5% (1/6 del 30%).
- Ravvedimento dopo constatazione (purché prima di formale contestazione o avviso): sanzione 6% (1/5 del 30%).
(NB: le percentuali precise possono variare leggermente a seconda dell’interpretazione delle frazioni, ma l’idea è che più tardi ci si ravvede, minore lo “sconto”.)
Perché parliamo di ravvedimento? Perché il contribuente che si accorge di non aver pagato può attivarsi prima che il Fisco glielo contesti, pagando il dovuto con sanzioni ridottissime. Ciò evita del tutto l’emissione di avvisi bonari o accertamenti (salvo che l’ufficio non li abbia già emessi). Ad esempio, se Tizio non ha versato il saldo IRPEF il 30 giugno, ma se ne accorge e il 20 luglio versa l’imposta con sanzione 1,5%, non riceverà alcun avviso (il suo F24 tardivo verrà registrato e la posizione sanata). Il ravvedimento è possibile finché non venga notificato un atto di liquidazione o accertamento relativo a quella violazione. Quindi, se ancora non vi è arrivato nulla, potete ravvedervi. Se invece è già stata notificata una comunicazione di irregolarità o un avviso, non è più ammesso ravvedersi su quegli importi (bisognerà seguire le vie ordinarie: pagamento con sanzioni intere o contenzioso).
Per completezza segnaliamo che la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha introdotto un ravvedimento speciale per violazioni riferite a dichiarazioni fino al 2021, con sanzione ridotta a 1/18, pagabile in 8 rate. Ma si trattava di misura eccezionale, con domanda entro il 31 marzo 2023. Ad oggi (luglio 2025) tale opportunità non è più attivabile, ma è un esempio di come a volte il legislatore concede sanatorie per chi vuole regolarizzare. Attualmente, il regime ordinario di ravvedimento resta quello sopra descritto, ormai molto flessibile (dal 2015 è possibile ravvedersi anche dopo anni, finché l’ufficio non contesta).
Comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”)
Se il contribuente non si ravvede e resta inerte, l’Agenzia può attivarsi tramite i controlli automatizzati. Quando da tali controlli risultano differenze (ad es. dichiarato non versato), l’iter standard prevede l’invio di una comunicazione al contribuente, detta comunemente “avviso bonario” o comunicazione di irregolarità.
L’avviso bonario non è un atto impositivo definitivo, ma un invito a regolarizzare. Esso contiene l’indicazione delle somme dovute (imposta non pagata, sanzione ridotta e interessi) e concede generalmente 30 giorni di tempo per pagare (o per segnalare all’ufficio eventuali errori). Se il contribuente paga entro 30 giorni, la sanzione è ridotta a 1/3 di quella piena (nel caso di omesso versamento: 10% anziché 30%). Inoltre, non dovrà subire ulteriori conseguenze. Se invece il contribuente non paga né risponde all’avviso bonario, dopo 30 giorni l’ufficio potrà iscrivere a ruolo gli importi (con sanzione piena) ed emettere una cartella, oppure – come spesso avviene negli ultimi anni per imposte erariali – emettere direttamente un avviso di accertamento esecutivo.
Termini: gli avvisi bonari seguono un cronoprogramma definito: ad esempio, per le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024 (redditi 2023), il controllo automatizzato avviene entro un anno e l’eventuale comunicazione di irregolarità dovrebbe essere emessa di regola entro il termine di notifica della cartella, cioè entro il 31 dicembre 2026 (terzo anno successivo alla presentazione). Spesso l’Agenzia cerca di inviarle molto prima, entro pochi mesi dall’elaborazione della dichiarazione. Addirittura, normative interne prescrivono l’emissione delle comunicazioni ex art.36-bis entro 9 mesi dalla fine dell’anno di presentazione. Se l’avviso bonario viene emesso oltre i termini previsti per la liquidazione, potrebbe considerarsi decaduto e non dovuto. La Cassazione ha, per esempio, affermato che una comunicazione inviata tardivamente (es. a ottobre 2022 per una dichiarazione 2020 che doveva essere liquidata entro il 2021) è niente affatto dovuta e il contribuente potrebbe non pagare le somme in essa richieste, eccependo la decadenza in sede di eventuale cartella. Tuttavia, occorre cautela: l’ufficio spesso rispetta i termini o giustifica eventuali slittamenti con proroghe normative (ad esempio, negli anni del Covid i termini di notifica delle cartelle sono stati prorogati di 14 mesi per il 2018 e 12 mesi per il 2019). In sintesi, quando ricevete un avviso bonario, controllate la data della vostra dichiarazione e se la comunicazione è arrivata molto in ritardo potreste avere un appiglio formale per contestarla.
Contenuto di un avviso bonario: di solito indica l’anno d’imposta di riferimento, il tipo di controllo (automatizzato art.36-bis), la differenza riscontrata (p.es. “dichiarazione IRPEF: saldo dovuto €X, versato €0, differenza €X”) e il nuovo conteggio: imposta €X, sanzioni ridotte al 10% €0,1X, interessi €Y, totale €Z. Viene allegato un bollettino o un modulo per pagare, oppure un preavviso che l’addebito avverrà su F24 telematico precompilato. Importante: l’avviso bonario non è impugnabile in Commissione Tributaria, salvo casi eccezionali (in passato si discuteva se impugnarlo per far valere errori e bloccare la successiva cartella; la giurisprudenza prevalente nega l’autonoma impugnabilità degli avvisi bonari, poiché non sono atti impositivi definitivi). Quindi il contribuente, se rileva inesattezze, deve piuttosto segnalarle all’Ufficio (ad esempio tramite un’istanza di rettifica in autotutela o presentando documenti) entro i 30 giorni, oppure attendere la cartella/accertamento e impugnare quello.
Effetti del mancato adempimento: Se entro 30 giorni dall’avviso bonario non avviene il pagamento (né il contribuente fornisce chiarimenti validi all’ufficio che portino all’annullamento in autotutela della richiesta), allora:
- per le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ritenute) l’Agenzia, decorsi 30 giorni, iscrive a ruolo le somme dovute (ora con sanzione piena del 30%). A questo punto può avvenire l’iscrizione a ruolo e la formazione di una cartella di pagamento, che verrà poi notificata dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). La cartella conterrà imposta, interessi e sanzione 30%, al netto di quanto (eventualmente) versato dopo l’avviso bonario. Oppure, in alternativa alla cartella, l’Agenzia Entrate può emettere un Avviso di Accertamento immediatamente esecutivo con intimazione, ai sensi dell’art.29 DL 78/2010, che funge da titolo per la riscossione coattiva senza passare dalla cartella. Questa seconda opzione è diventata la prassi per gli atti emessi dal 1° ottobre 2011 in poi, relativi a imposte dal periodo d’imposta 2007 in poi. In altre parole, oggi quando non paghi un avviso bonario, è probabile che dopo qualche mese ti arrivi direttamente un “avviso di accertamento esecutivo” (il protagonista della nostra guida) invece di una cartella tradizionale. Nel caso di tributi locali o altri enti, spesso si prosegue ancora con la cartella esattoriale.
- per contributi previdenziali o altre entrate, la procedura può variare (ad es. l’INPS invia avvisi di addebito immediatamente esecutivi senza passare da cartella; i Comuni per IMU/TARI emettono avvisi di accertamento esecutivi anch’essi; ma ci concentriamo sulle imposte statali).
Omesso versamento rilevato senza avviso bonario: non sempre un omesso versamento passa per l’avviso bonario. Ad esempio, se parliamo di ritenute non versate ma dichiarate nel modello 770, spesso l’Agenzia invia comunque una comunicazione ex art.36-bis analogamente (se dal 770 risultano €10.000 di ritenute dovute e dai versamenti F24 ne risultano solo €5.000, l’avviso bonario chiederà i restanti €5.000 + sanzione ridotta al 10% + interessi). Ma potrebbe anche succedere che, per ragioni di urgenza o di importo elevato, l’ufficio proceda direttamente con un atto di contestazione sanzioni o accertamento senza passare dall’avviso bonario, specie se ritiene che la comunicazione bonaria non sia obbligatoria. In passato, la legge prevedeva espressamente che per gli esiti dei controlli automatizzati l’avviso bonario fosse sempre inviato tranne alcuni casi. Oggi, dopo varie modifiche, la comunicazione preventiva rimane prassi consolidata e doverosa per trasparenza (Statuto art.6, co.5), ma la mancata ricezione di un avviso bonario non blocca il recupero. La Cassazione 2024, citata prima, ha ribadito che se il contribuente omette di pagare un importo risultante dalla sua dichiarazione, la cartella successiva è legittima anche se non era stato inviato alcun avviso bonario, perché l’obbligo di avviso scatta per gli esiti da liquidazione che non emergono dal mero confronto con la dichiarazione. Nel dubbio, comunque, l’Agenzia quasi sempre manda la comunicazione, perché incentivare il contribuente a pagare con sanzione ridotta conviene anche all’Amministrazione (incassa prima e riduce il contenzioso).
Diritti del contribuente in questa fase: il contribuente può:
- Chiedere chiarimenti o segnalare errori all’Agenzia: ad es., se pensa di aver pagato ma magari il pagamento non è stato associato correttamente, può inviare copia del versamento. Oppure se c’è un errore di calcolo nell’avviso bonario, può farlo presente (anche tramite il suo cassetto fiscale o contattando l’ufficio). Spesso l’avviso bonario stesso indica i contatti per assistenza. Se l’ufficio riconosce l’errore, può annullare in autotutela la comunicazione o correggerla.
- Rateizzare l’importo: le somme da avviso bonario sono rateizzabili fino a 20 rate trimestrali (5 anni) se l’importo è elevato. In genere: importi fino a €5.000 -> max 8 rate trimestrali; oltre €5.000 -> max 20 rate trimestrali. La richiesta di rateazione va fatta entro 30 giorni dalla comunicazione. Rateizzare non evita le sanzioni, ma almeno diluisce il pagamento.
- Non pagare e aspettare la cartella/accertamento: è una scelta rischiosa ma talvolta fatta per guadagnare tempo (la cartella spesso arriva molti mesi dopo). Tuttavia, questo comporta che la sanzione sale al 30% pieno e che poi bisognerà eventualmente impugnare la cartella o l’accertamento. Se il contribuente ha intenzione di contestare nel merito la pretesa (ad esempio ritiene di avere un credito d’imposta in compensazione non considerato, o di aver diritto a una riduzione), potrebbe scegliere di non pagare l’avviso bonario e far valere tutto in sede di ricorso sulla cartella. Importante: il pagamento dell’avviso bonario preclude in parte la possibilità di ricorrere poi sulle medesime somme (perché pagando si “acquista” quietanza ma implicitamente si riconosce il debito). Quindi chi vuole fare causa spesso non paga l’avviso bonario. C’è però un rovescio: impugnare l’avviso bonario direttamente non è possibile, e impugnare la cartella in quanto conseguenza di un bonario tardivo o errato è possibile ma limitato a vizi formali o di merito del debito. Non si potrà eccepire in giudizio che “avrei dovuto pagare il 10% di sanzione anziché il 30% se mi davano più tempo”, perché il mancato adempimento nei 30 giorni fa perdere l’agevolazione automaticamente.
In conclusione su questa fase bonaria, è sempre consigliabile: a) verificare se si può ravvedere subito per ridurre al minimo le sanzioni; b) se arriva un avviso bonario, valutarlo attentamente: se la pretesa è corretta e si hanno le risorse, conviene pagare nei 30 giorni per risparmiare (sanzione al 10%); se la pretesa è dubbia o errata, contattare l’ufficio entro 30 giorni presentando documenti o chiedendo correzione; c) se si decide di non pagare, prepararsi alla fase successiva (accertamento/cartella) con la consapevolezza che si pagherà di più se poi la si perde, ma magari si guadagna tempo o si punta a far annullare l’atto per vizi o ragioni sostanziali.
Nei prossimi paragrafi entriamo nel cuore delle strategie difensive formali e sostanziali quando ormai l’avviso di accertamento (o la cartella) è arrivato. Immaginiamo quindi che, superata la fase bonaria o in assenza di essa, vi sia stato notificato un Avviso di Accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate per omesso/tardivo versamento. Cosa contiene esattamente questo atto? Quali opzioni ha il contribuente entro i 60 giorni? Vediamolo.
Caratteristiche dell’Avviso di Accertamento Esecutivo e intimazione di pagamento
Un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate oggi è quasi sempre un “avviso di accertamento esecutivo”, in forza della normativa introdotta dal 2010/2011. Questo significa che l’atto combina in sé sia la funzione di accertamento (cioè la fissazione del tributo dovuto e delle eventuali sanzioni) sia la funzione di titolo per la riscossione coattiva (simile a una cartella esattoriale). Analizziamo le caratteristiche principali di tale avviso esecutivo:
- Intimazione ad adempiere: L’avviso riporta espressamente un’intimazione a pagare entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni) le somme in esso indicate. Questa formula, di solito contenuta verso la fine dell’atto, è prevista dall’art.29, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2010. Esempio di formulazione: “Ai sensi dell’art.29 DL 78/2010 si intima il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notifica del presente avviso, avvertendo che, in caso di tempestivo ricorso, è fatto obbligo il pagamento a titolo provvisorio delle somme determinate dall’art.15 del DPR 602/73”. Tradotto: se non fai ricorso, devi pagare tutto entro 60 giorni; se fai ricorso, devi comunque pagare una parte a titolo provvisorio (vedremo poi quanto). Questa intimazione evita la successiva notifica di una cartella: scaduti i 60 giorni, l’Agente della Riscossione potrà agire direttamente. Pertanto l’avviso esecutivo è un titolo esecutivo idoneo per il pignoramento, senza bisogno di passare per un giudice.
- Soglia temporale di applicazione: la regola degli avvisi esecutivi si applica agli atti riguardanti imposte sui redditi, IVA, IRAP per periodi d’imposta dal 2007 in poi, se emessi dal 1° ottobre 2011. Quindi, un avviso per IRPEF 2006 emesso nel 2010 non era esecutivo (seguiva la vecchia prassi: avviso e poi cartella); un avviso per IRPEF 2018 emesso nel 2023 è invece esecutivo. Ormai, nel 2025, la quasi totalità degli avvisi rientra in questo regime. Anche gli atti dei Comuni per IMU/TASI, etc., a partire dal 2020 possono essere direttamente esecutivi (per legge 160/2019).
- Contenuto: L’avviso specifica dettagliatamente che cosa viene richiesto e perché. Nel caso di omesso versamento, come detto, la motivazione consisterà nell’indicare che dal controllo risulta non versato l’importo X relativo a [tale imposta, periodo…], e quindi vengono irrogate le sanzioni ex art.13 D.Lgs.471/97 e calcolati interessi. Il corpo dell’atto conterrà:
- I dati del contribuente (nome, CF/P.IVA, domicilio fiscale) e dell’ufficio emittente.
- La descrizione dei fatti: es. “dalla dichiarazione Modello Redditi 2022 presentata in data … risulta un importo a debito di €10.000 per imposta IRPEF saldo 2021. Dai versamenti effettuati emerge un mancato pagamento di tale importo entro la scadenza del …” ecc.
- Le ragioni giuridiche: es. “violazione dell’art. 17 DPR 435/2001 (omesso versamento saldo imposte) sanzionata dall’art.13 D.Lgs.471/97”.
- L’eventuale riferimento a una comunicazione di irregolarità precedente (spesso viene citato il numero dell’avviso bonario e la sua mancata definizione).
- Un prospetto di calcolo delle somme dovute: imposta, sanzione, interessi (con indicazione dei periodi di calcolo e dei tassi di interesse applicati), e spese di notifica. Questo prospetto è importante per verificare eventuali errori.
- L’intimazione di pagamento entro 60 giorni e l’indicazione delle norme che ne danno il fondamento (DL 78/2010).
- L’indicazione delle modalità di impugnazione: l’avviso deve chiarire che è impugnabile presso la Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni, specificare se è ammesso il reclamo/mediazione (fino al 2022 era obbligatorio sotto €50.000, ora non più; alcuni avvisi nel 2023-24 ancora lo citavano, ma la legge 130/2022 lo ha reso facoltativo), e riportare eventualmente l’organo giurisdizionale competente. Spesso c’è una dicitura tipo: “Il presente atto può essere impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [Provincia], entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi del D.Lgs.546/92. Ai sensi dell’art.17-bis D.Lgs.546/92, per le controversie di valore non superiore a €50.000 era previsto l’istituto del reclamo-mediazione; a decorrere dal 2023 tale istituto non costituisce più condizione di procedibilità, potendosi tuttavia esperire su base volontaria”.
- L’invito all’adesione: spesso contestualmente l’avviso invita, in alternativa al ricorso, a presentare istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni (se applicabile) per definire in via amministrativa, sospendendo i termini di ricorso.
- Le firme: l’atto deve essere sottoscritto dal capo ufficio o da un suo delegato (anche in forma digitale se notificato via PEC). Un avviso privo di sottoscrizione o con firma illeggibile senza indicazione del funzionario delegato può essere nullo per difetto di sottoscrizione autorizzata – la Cassazione è rigorosa su questo.
- Notifica: l’avviso di accertamento viene notificato normalmente via PEC per i soggetti obbligati ad averla (imprese, professionisti) oppure a mezzo posta raccomandata A/R per persone fisiche non titolari di P.IVA. Se via PEC, l’atto viene firmato digitalmente e inviato come allegato .p7m, di cui va verificata l’autenticità. Se via posta, arriva un plico raccomandato (anche senza busta, come “atto giudiziario”) contenente l’originale o la copia conforme dell’atto. La notifica può essere effettuata anche tramite messo comunale o ufficiale della riscossione in casi particolari. È essenziale controllare quando la notifica è avvenuta (data di consegna PEC o data di ricevuta di ritorno) perché da lì decorrono i 60 giorni per agire. Anche eventuali vizi di notifica (es. notifica a indirizzo PEC errato, o a soggetto non legittimato a ricevere) possono essere fatti valere in giudizio.
- Esecutività e frazionamento del pagamento in caso di ricorso: come accennato, se fai ricorso, l’avviso diventa esecutivo solo parzialmente, secondo le regole del “pagamento frazionato” previste dall’art. 15 DPR 602/1973 (che rispecchiano l’art. 68 D.Lgs.546/92). In pratica:
- Durante il ricorso di primo grado, sono dovuti comunque 1/3 delle imposte accertate (oltre agli interessi legali su tale terzo) entro 60 giorni. Le sanzioni amministrative sono sospese automaticamente fino alla decisione di primo grado.
- Se il contribuente perde in primo grado, deve integrare il versamento fino a 2/3 delle imposte (inclusi interessi) dopo la sentenza di C.G.Tr. di primo grado. In caso di vittoria parziale, paga quanto stabilito dal giudice, comunque non oltre i 2/3.
- Se perde anche in secondo grado (C.G.Tr. di secondo grado), deve versare tutto il residuo dovuto secondo la sentenza.
- Se poi vince in Cassazione o ottiene una riduzione, l’eccedenza pagata va rimborsata con interessi.
- Possibilità di pagamento o rateazione entro 60 giorni: il contribuente, ricevuto l’avviso, può decidere di pagare integralmente entro 60 giorni, beneficiando in tal caso della riduzione delle sanzioni ad 1/3 (come da art.15 D.Lgs.218/97, acquiescenza). Oppure, se non riesce a saldare in un’unica soluzione, può chiedere all’Agenzia delle Entrate (all’ufficio locale) una rateizzazione delle somme dovute nell’avviso. La legge (art.15-ter DPR 602/73, introdotto nel 2016) consente la dilazione anche per gli avvisi accertamento: fino a 8 rate trimestrali se l’importo è sotto soglia, o fino a 16 rate trimestrali (quattro anni) se l’importo dovuto supera €50.000 e il contribuente prova una situazione di difficoltà economica. In pratica:
- Importi fino a €50.000: massimo 8 rate trimestrali (2 anni).
- Importi sopra €50.000: l’ufficio può concedere fino a 16 rate (4 anni) con necessità di documentare lo stato di difficoltà (di solito tramite certificazione dell’indice di liquidità corrente).
- Eccezionalmente, la legge permette più di 16 rate se c’è adesione (48 rate in rari casi) ma per gli avvisi standard il limite è 16. Recenti provvedimenti hanno ulteriormente esteso la possibilità di rate: dal 2023, la soglia di rateizzazione “automatica” (senza bisogno di documenti) è stata elevata a €120.000 e il numero massimo di rate è salito a 20 trimestrali (5 anni). E dal 2024 sono state introdotte norme (Delega Fiscale attuativa) per cui chi ha ottenuto rateazione e paga regolarmente può evitare azioni esecutive e non è segnalato come inadempiente.
- Per ottenere la rateazione, bisogna presentare istanza all’ufficio delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (ossia entro il termine di pagamento). La presentazione dell’istanza di rateazione non sospende il termine di impugnazione, ma se l’istanza viene accolta e si perfeziona un piano di rate, generalmente il contribuente rinuncia a ricorrere (perché rateizzare è un’ammissione del debito). Viceversa, se intende comunque contestare, di solito non chiede la rateazione all’AdE (anche perché se ricorre, come detto, non deve pagare subito tutto, solo 1/3 delle imposte).
- Attenzione: se si ottiene la rateazione dell’avviso e poi non si pagano le rate, si decade dal beneficio e l’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile, con possibile intervento dell’Agente della Riscossione. La decadenza scatta se non si pagano 2 rate consecutive nel caso di avvisi (per le cartelle ora è dopo 8 rate non pagate anche non consecutive, ma per gli avvisi credo resti la regola 2 rate).
- La rateizzazione congela le sanzioni ridotte applicate: se è concessa in sede di adesione/acquiescenza, si paga la sanzione ridotta (1/3) dilazionata. Se invece la rateazione viene chiesta dopo aver presentato ricorso (pagando 1/3), in genere non è l’ufficio Entrate a gestirla ma l’Agente della Riscossione con le regole ordinarie sulle cartelle (72 rate ecc. di cui diremo poi).
Riassumendo la sezione: un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento appare come un documento molto completo, che motiva la pretesa, intima il pagamento e informa sui diritti di difesa. È essenziale leggere con estrema attenzione ogni sua parte, verificare la correttezza formale (motivazione, firme, riferimenti normativi, calcoli) e prendere nota di tutte le date (notifica, scadenza 60 giorni, ecc.). In caso di dubbi sulla correttezza dell’atto (errori di persona, calcoli errati, ecc.), il contribuente può tentare un’istanza di autotutela all’ufficio (chiedendo lo sgravio dell’atto se effettivamente viziato) ma, salvo errori palesi riconosciuti dall’ente, ciò non sospende i termini: bisogna comunque prepararsi a impugnare l’atto entro 60 giorni se non si ottiene un annullamento spontaneo immediato.
Nel prossimo capitolo, passeremo in rassegna le strategie di difesa possibili dal punto di vista del contribuente/debitore: quando conviene accettare e chiudere (magari ottenendo sanzioni ridotte), quando invece è opportuno presentare ricorso (e su quali motivazioni basarlo), come chiedere la sospensione dell’atto per evitare l’esecuzione durante il processo, e quali sono le procedure (prima e dopo il ricorso) che possono risolvere la controversia (es. adesione, conciliazione, autotutela). In altre parole, come difendersi attivamente da un avviso di accertamento ritenuto illegittimo o infondato, o come gestire al meglio un avviso comunque dovuto ma magari oppressivo nelle modalità di riscossione.
Come difendersi: strumenti deflattivi e ricorso tributario
Una volta notificato l’avviso di accertamento esecutivo, il contribuente ha di fronte a sé una scelta cruciale: accettare e pagare (magari con sanzioni ridotte e/o a rate) oppure contestare l’atto nelle sedi opportune (tentando di farlo annullare o ridurre). Analizzeremo entrambe le vie, partendo dagli strumenti “deflattivi” del contenzioso (che possono evitare di andare in giudizio o quantomeno ridurre l’oggetto del contendere) e poi concentrandoci sul ricorso in senso stretto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
Autotutela: chiedere all’ufficio di annullare o correggere l’atto
L’autotutela è il potere/dovere della Pubblica Amministrazione di correggere i propri atti errati o illegittimi, anche in assenza di un ricorso. In materia tributaria, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’ente che ha emesso l’avviso (Agenzia Entrate – Direzione Provinciale competente), esponendo i motivi per cui ritiene l’atto sbagliato e chiedendone l’annullamento totale o parziale.
Quando è utile l’autotutela? In caso di errori evidenti dell’ufficio: ad es. scambio di persona (avviso intestato al soggetto sbagliato), doppia imposizione palese (due avvisi per la stessa imposta), errori di calcolo aritmetico macroscopici, pagamento in realtà già effettuato e non riconosciuto (dimostrabile allegando ricevute), intervenuta prescrizione/decadenza incontestabile (ad es. avviso notificato oltre i termini legali), o altre cause di nullità immediatamente riscontrabili (mancanza di motivazione, atto non firmato, ecc.). In tali situazioni, a volte l’ufficio riconosce l’errore e annulla in autotutela l’accertamento, evitando così il contenzioso.
Limiti dell’autotutela: Non sospende i termini di ricorso né quelli di pagamento. L’ufficio non è obbligato ad accogliere l’istanza, e un rifiuto o silenzio su di essa non sono impugnabili (a meno che l’istanza sia stata presentata per evitare un contenzioso già pendente su questioni nuove, ma entriamo nel complesso). Quindi, se mancano pochi giorni alla scadenza del termine di ricorso, non bisogna aspettare oltre una risposta dall’ufficio: si presenti comunque il ricorso (specificando magari che si è richiesta autotutela). Un eventuale accoglimento successivo dell’autotutela renderà il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere, senza pregiudizio. Se invece l’ufficio ignora l’istanza, l’unica via resta il contenzioso.
In sintesi, vale la pena tentare l’autotutela se si ravvisa un motivo semplice e oggettivo per cui l’avviso è sbagliato. Ad esempio: “Ho la prova che quel versamento l’ho fatto, e ve la allego, per favore annullate la sanzione”. Oppure: “L’avviso è stato notificato oltre i termini di decadenza, come da voi stessi ammesso nella data, quindi va annullato”. In molti casi però l’autotutela non viene accettata se il motivo è controverso o interpretativo; l’ufficio tende a lasciare che decida il giudice. Dunque, autotutela sì, ma senza illudersi: parallelamente prepararsi al ricorso se necessario.
Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è uno strumento di “mediazione” tra contribuente e ufficio che consente, prima di andare in causa, di trovare un accordo sull’accertamento, con benefici di sanzioni ridotte. Solitamente si applica a verifiche complesse su imponibili, ma può essere utilizzato anche per avvisi relativi a omessi versamenti, se ci sono elementi di discussione sull’an o sul quantum.
Procedura: il contribuente, entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento, può presentare un’istanza di adesione (se nell’avviso non era preceduta da invito). In alternativa, spesso l’avviso stesso contiene un invito a presentarsi per adesione. L’istanza sospende il termine di ricorso per 90 giorni. Entro tale periodo, l’ufficio convoca il contribuente per un contraddittorio. Nel contraddittorio, si discute l’atto e si può giungere a un accordo. Se c’è accordo, si redige un atto di adesione firmato da entrambe le parti, e il contribuente entro 20 giorni paga la prima rata. Le sanzioni vengono automaticamente ridotte a 1/3 del minimo previsto (nel nostro caso, 1/3 di 30% = 10%). Inoltre, è possibile rateizzare in 8 rate trimestrali (o 16 se importo oltre 50k) l’importo concordato.
Applicabilità negli omessi versamenti: onestamente, se l’unica questione è “non hai pagato €X”, c’è poco su cui trattare. L’adesione potrebbe riguardare ad esempio:
- la riduzione delle sanzioni per particolari circostanze (ma la legge prevede già 1/3, difficilmente l’ufficio scende sotto il minimo legale se l’importo era dovuto),
- la verifica di crediti in compensazione vantati dal contribuente ma non riconosciuti nell’avviso (es. il contribuente sostiene di avere un credito d’imposta che copriva quel debito),
- la discussione su eventuali cause di non punibilità (forza maggiore) o elementi di fatto (es. l’ufficio ha considerato omesso un versamento che in realtà è stato effettuato su un altro codice tributo: situazioni da ricalcolare).
In realtà, per i meri omessi versamenti, spesso l’adesione viene usata dal contribuente per prendere tempo (90 giorni di sospensione) e poi magari pagare con sanzioni ridotte se l’ufficio si mostra disponibile. C’è da dire che se il contribuente vuole solo la sanzione ridotta, può ottenerla comunque con l’acquiescenza (1/3) senza passare dall’adesione. L’adesione ha senso se c’è una questione di merito su cui si può transare: es. ridurre un importo contestato.
Esempio: contributore Alfa riceve avviso per omesso versamento IVA €100.000 + sanzioni €30.000. Alfa in istanza di adesione porta prove che in realtà un credito IVA di €20.000 non era stato considerato. L’ufficio riconosce che ha diritto a compensare quel credito, quindi l’imposta dovuta scende a €80.000. Si concorda un atto di adesione per €80.000 di imposta e sanzioni 1/3 del 30% sul non versato (quindi €8.000 di sanzione). Alfa paga il tutto a rate in due anni. Ecco un caso in cui l’adesione ha ridotto l’imposta e le sanzioni.
Vantaggi: sospende i termini di ricorso, evita il contenzioso, sanzioni ridotte, rateazione possibile e nessun pagamento immediato a parte la prima rata in caso di accordo. Svantaggi: se non si raggiunge l’accordo, si è solo perso tempo (però i 90 gg erano sospesi, quindi non fa danno) e si va in giudizio. Se l’ufficio convoca tardivamente, potrebbe far scorrere inutilmente il tempo (ma di solito è solerte in questi casi per chiudere).
Acquiescenza e riduzione delle sanzioni
L’acquiescenza consiste nel non impugnare l’avviso di accertamento e pagare integralmente entro 60 giorni dalla notifica. In cambio, la legge (art. 15, co.1, D.Lgs. 218/97) riconosce il beneficio della riduzione delle sanzioni ad 1/3 di quelle irrogate. Nell’ambito degli omessi versamenti, significa che invece di pagare la sanzione del 30%, si paga il 10%. Questo è lo stesso livello di sanzione dell’adesione, ma qui non c’è bisogno di accordo: è sufficiente pagare. L’acquiescenza comporta anche la rinuncia al ricorso e alla richiesta di eventuale rimborso (bisogna attestare di non aver già impugnato e di rinunciare a impugnare).
Quando conviene? Se il contribuente riconosce la propria responsabilità e non ha appigli validi di difesa, oppure se l’avviso presenta sì qualche dubbio ma il rischio del contenzioso appare elevato e si preferisce chiudere con lo sconto. Ad esempio: Beta riceve un avviso per €5.000 di IRAP non versata + €1.500 di sanzioni. Non ha scusanti valide (ha dimenticato di pagare), e l’atto è corretto. Beta può presentare ricorso solo per tentare di prendere tempo, ma probabilmente pagherà comunque e con il 30% di sanzione, più spese di giudizio. Invece, pagando subito con acquiescenza, versa €5.000 + €1.000 di sanzione (1/3 di 1.500 ≈ 500, quindi totale €5.500) entro 60 gg, risparmiando €500 e chiudendo la questione senza ulteriori aggravi.
Procedura pratica: di solito l’avviso contiene un “modello F24 precompilato” con importi ridotti del 1/3 per il pagamento in acquiescenza entro la scadenza. In caso non ci sia, il contribuente può calcolare il dovuto (anche sul sito AdE spesso c’è il calcolatore), versare e inviare all’ufficio una comunicazione di avvenuto pagamento con rinuncia al ricorso (non obbligatoria, ma opportuna). Se l’avviso comprende più violazioni, l’acquiescenza può essere parziale limitata ad alcune di esse (ma attenzione: se il debito è indivisibile o se impugni anche solo una parte, in teoria perdi lo sconto sulle altre – tema complesso, conviene decidere univocamente). La norma prevede espressamente che l’acquiescenza non si applica se il contribuente ha già presentato ricorso; dunque decidere prima di ricorrere.
Rapporto acquiescenza vs ravvedimento: talvolta i contribuenti chiedono: “posso ravvedermi dopo aver ricevuto l’avviso per pagare con sanzione minore di 1/3?”. No, il ravvedimento è precluso dopo notifica di avviso. L’unica riduzione possibile è 1/3 con acquiescenza (o 1/3 con adesione). Quindi se l’avviso è arrivato a sanzione 30, l’offerta massima che potete ottenere è pagare sanzione 10 con acquiescenza. Non c’è modo di scendere a 5 o 3,3% come era prima: quell’opportunità era solo prima che arrivasse l’atto.
Considerazione strategica: facendo acquiescenza, il contribuente rinuncia formalmente a qualsiasi contestazione futura su quell’atto (non potrà poi presentare istanze di rimborso, né appellarsi a eventuali condoni ad hoc – salvo se la legge li prevede anche per chi ha pagato). Quindi è una scelta da ponderare: se c’è anche solo una chance di ottenere annullamento in giudizio, forse vale la pena tentare il ricorso. Se invece la pretesa è chiara e dovuta e l’obiettivo è solo ridurre il danno, l’acquiescenza è la via migliore.
La sospensione della riscossione (sospensiva in giudizio)
Se il contribuente decide di impugnare l’avviso di accertamento, egli può chiedere al giudice tributario una sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, in attesa della decisione di merito. Questa richiesta (istanza di sospensione cautelare) è fondamentale per proteggersi da azioni esecutive immediate da parte dell’Agente della Riscossione mentre pende la causa.
Requisiti: secondo l’art. 47 D.Lgs. 546/92, la sospensione può essere concessa quando ricorrano due condizioni: fumus boni iuris (ossia il ricorso non è pretestuoso, esistono validi motivi in diritto e in fatto, in una valutazione sommaria) e periculum in mora (ossia il contribuente subirebbe un danno grave e irreparabile dall’esecuzione dell’atto durante il tempo del processo). In parole semplici: devi convincere il giudice che hai buone ragioni di vincere e che se nel frattempo ti pignorano beni, subisci un danno serio.
Procedura: l’istanza di sospensione va di norma presentata nel ricorso stesso (o con atto separato notificato alle parti e depositato, ma ormai col processo telematico, si segnala nel ricorso introduttivo). La Corte di Giustizia Tributaria fissa un’udienza breve per discutere la sospensiva. Grazie alla riforma del 2022, i tempi si sono molto accorciati: l’udienza deve essere fissata entro 30 giorni dalla domanda (prima erano 180 giorni!). Quindi, attualmente, se presenti un ricorso e chiedi la sospensiva, ti aspetti un’udienza nel giro di un mese o poco più. All’udienza (spesso in camera di consiglio, senza formalità) il giudice valuta gli elementi e emette un’ordinanza. Se concede la sospensione, l’esecutività dell’avviso è bloccata (totalmente o parzialmente) fino alla decisione di merito. Se nega, l’agente può procedere oltre (anche se si può riprovare in appello eventualmente).
Effetti della sospensione: in caso di sospensiva concessa, l’Agenzia Entrate-Riscossione non può intraprendere o proseguire azioni esecutive per i tributi sospesi. Inoltre, solitamente viene sospeso l’obbligo di pagare il 1/3 provvisorio. Ad esempio, se ottieni sospensione totale dell’atto, non devi pagare neanche il terzo iniziale finché non c’è la sentenza di primo grado. Attenzione però: se la sospensione riguarda solo una parte (si può chiedere sospensione parziale), devi pagare il resto.
Casi tipici: i giudici tributari concedono la sospensiva ad esempio se: a) il contribuente versa in gravi difficoltà economiche e l’esecuzione lo manderebbe in rovina (periculum); b) ci sono motivi di impugnazione molto seri (es. evidente decadenza, errore macroscopico dell’ufficio – fumus). Il danno irreparabile può essere anche non patrimoniale: ad esempio, pignorare il conto di un’azienda può bloccarne l’attività irreversibilmente. Bisogna documentare: presentare bilanci, attestare la situazione finanziaria, etc.
Novità: con la riforma 2022, non solo hanno ridotto i tempi per decidere la sospensiva, ma è stata introdotta anche la possibilità di appello cautelare contro l’ordinanza (prima c’era, ma ora il termine è 15 giorni) e il dovere di priorità di trattazione di queste istanze. Quindi la tutela cautelare è più efficiente di un tempo.
In relazione all’avviso esecutivo: ricordiamo che, senza sospensiva, l’Agente della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso, può procedere a misure coattive anche se hai presentato ricorso. Può riscuotere la parte non protetta (in genere il 50% delle imposte accertate + interessi, secondo i limiti di legge, e comunque non le sanzioni, che sono sospese ex lege fino a primo grado). Però di fatto Equitalia (AdER) spesso aspetta l’esito della sospensiva o dei 60gg. Esempio: avviso notificato il 1 marzo, ricorso con sospensiva il 20 aprile, udienza sospensiva il 20 maggio; se il giudice rigetta la sospensione, da quel momento AdER potrebbe attivarsi subito (pignoramento, fermo, ecc.) per il 50% delle imposte. Ecco perché ottenere la sospensione è cruciale: sospendere quell’esecutività significa che nulla sarà dovuto o pignorabile finché non arriva la sentenza di primo grado (o un’eventuale revoca della sospensiva, se cambiano le circostanze).
In conclusione su questo punto: quando si propone ricorso avverso un avviso di accertamento esecutivo, chiedere la sospensione è altamente consigliato (a meno che il debito sia modesto e non vi crei problemi pagare il terzo nel frattempo). È una tutela del debitore per prevenire danni spesso molto gravi (basti pensare al blocco di un conto aziendale). E grazie alle nuove norme, la sospensiva arriva in tempi rapidi, riducendo la finestra di incertezza.
Motivi di ricorso contro un avviso di accertamento per omesso versamento
Affrontiamo ora il cuore della difesa nel merito giuridico: su quali basi contestare l’avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. I motivi di ricorso possono variare dal merito fiscale stretto (ad esempio: “non dovevo pagare questa imposta perché avevo un credito valido”) a motivi procedurali/formali (es: “atto notificato oltre i termini; atto privo di motivazione; vizio di notifica; ecc.”). Elenchiamo i principali motivi invocabili, distinguendo tra vizi formali/procedurali e contestazioni sostanziali:
1. Decadenza o prescrizione dei termini: un classico motivo è sostenere che l’accertamento è stato emesso tardivamente, oltre i termini perentori previsti dalla legge, e quindi è nullo. Ad esempio, per un omesso versamento relativo all’anno d’imposta 2019 (dichiarazione presentata nel 2020), il termine ultimo per notificare un accertamento era il 31 dicembre 2025 (quinto anno successivo, perché per imposte dichiarate dal 2016 in poi è 5 anni). Se l’avviso fosse stato notificato nel 2026, sarebbe decaduto. Analogamente, se si trattasse di un ruolo da controllo automatizzato, il termine era il 31 dicembre 2023 per notifica cartella. La verifica dei termini è essenziale: se l’atto arriva fuori tempo, è un motivo di ricorso vincente al 100%. Bisogna però far attenzione alle eventuali proroghe (es. periodi Covid) e al “doppio binario” della notifica (fa fede la consegna a posta, non la ricezione). Il giudice tributario accoglie la decadenza se provata la data tardiva. Attenzione: diversa dalla decadenza è la prescrizione del credito tributario (10 anni di regola), che può maturare se l’avviso è definitivo e non riscosso per lungo tempo. Nel ricorso contro l’avviso, di solito non si parla di prescrizione (non è ancora formato il titolo definitivo), ma può emergere in fasi di riscossione.
2. Errata applicazione di norme sostanziali: si contesta che il tributo richiesto non era dovuto, o non in quella misura. Ad esempio: “L’Agenzia mi chiede IRAP, ma io non ero soggetto ad IRAP”; oppure “mi chiedono una tassa che era stata abrogata per quell’anno”. Nel contesto di omessi versamenti, spesso non c’è molto da dire sul tributo in sé (lo aveva dichiarato il contribuente); tuttavia potrebbero esserci ragioni come: l’importo era coperto da un credito non riconosciuto; oppure c’era una norma di esonero o proroga (es. il contribuente poteva versare più tardi per via di una sospensione termini, ad esempio zone terremotate con proroga dei pagamenti; se l’ufficio non l’ha considerata, quell’importo non è formalmente “omesso” ma solo differito). Un caso particolare: se l’atto riguarda sanzioni per tardivo versamento, a volte si discute se il contribuente avesse un giustificato motivo. Tecnicamente la legge non prevede “causa di non punibilità” generica salvo la forza maggiore, ma i ricorsi spesso adducono “errore scusabile”, “incertezza normativa” o situazioni analoghe per chiedere l’annullamento o la riduzione della sanzione. Ad esempio: “In quell’anno vi erano istruzioni contraddittorie sulla scadenza, ho versato in buona fede in ritardo di 10 giorni seguendo un’indicazione ministeriale poi smentita”. A volte, i giudici di merito, invocando i principi generali, possono annullare la sanzione se effettivamente l’errore era scusabile (anche se formalmente non c’è norma ad hoc).
3. Vizio di motivazione dell’atto: come discusso, se l’avviso non motiva adeguatamente, cioè non spiega il perché della pretesa o lo fa in modo illogico/contraddittorio, si può ricorrere chiedendo l’annullamento per difetto di motivazione. Nel nostro contesto, esempi: l’avviso non indica quali versamenti sarebbero omessi, limitandosi a dire “non hai pagato” senza riferimenti – questo sarebbe “motivo apparente”. Oppure riporta cause confuse (es. dice sia che non hai versato sia che hai compensato indebitamente, senza chiarire). La Cassazione ha più volte annullato avvisi con motivazioni contraddittorie. Altro vizio: la mancata allegazione di documenti richiamati. Se l’avviso dice “visto il PVC della Gdf” e non allega copia del PVC (né risulta notificato prima), la motivazione per relationem è incompleta e può portare all’annullamento. Nel nostro caso di omessi versamenti, spesso l’atto richiama una precedente comunicazione di irregolarità: se il contribuente quell’avviso bonario non l’ha mai ricevuto, potrebbe eccepire che l’accertamento ne fa riferimento come noto mentre non lo era. Di solito però gli avvisi di accertamento replicano integralmente i dati, quindi è rarissimo riuscire a far annullare per questo; più facile se l’atto rimanda a un allegato mancante (es. prospetto di calcolo non allegato).
4. Vizio di notifica: se l’atto non è stato notificato correttamente (es. inviato alla PEC sbagliata, o a un indirizzo dove non risiede più il contribuente, o consegnato a persona non legittimata), si può ricorrere eccependo la nullità della notifica. Questo motivo va invocato subito nel ricorso (altrimenti si “sanerebbe” col ricorso stesso, secondo alcuni), ed è un po’ delicato: bisogna provare il vizio. Ad esempio, PEC: se l’Agenzia ha usato un indirizzo PEC non risultante dai registri, la notifica è nulla. Oppure se via posta, consegnata a un portiere che però era assente delegato, ecc. Spesso tuttavia il giudice potrebbe considerare sanato il vizio se il ricorso è stato comunque presentato (segno che l’atto è venuto a conoscenza). Ci sono molte pronunce su queste finezze. Un vizio grave sarebbe la mancata notifica affatto: ma se non fosse stato notificato non sapresti del debito finché non appare in cartella. In tali casi, in genere, non ricorri contro l’avviso (che ignoravi) ma contro la cartella eccependo la nullità dell’atto presupposto non notificato. In questa guida però assumiamo che l’avviso l’hai ricevuto.
5. Carenza di legittimazione o autorizzazione: raramente, si contesta che chi ha firmato l’atto non aveva potere di farlo. Ad esempio, se l’avviso non è firmato da un dirigente legittimo (c’è stata battaglia legale anni fa sui “dirigenti decaduti” dell’Agenzia Entrate). O se l’ufficio emittente non era competente territorialmente (di solito irrilevante, salvo casi di trasferimento di domicilio non aggiornato). Anche la mancata indicazione del responsabile del procedimento era un vizio (previsto dallo Statuto art.7): la giurisprudenza oscillava sul considerarlo causa di nullità o meno, ma dopo il DL 32/2019 tale omissione è stata sanata come irregolarità non invalidante. Quindi oggi se nell’avviso non c’è scritto il nome del responsabile procedimento, non è più un motivo vincente.
6. Violazione di norme procedurali: ad esempio, “l’ufficio non mi ha inviato l’invito al contraddittorio obbligatorio prima dell’emissione”. Nel contesto di controlli automatizzati e omessi versamenti, non vige un obbligo generale di contraddittorio preventivo (che invece esiste per accertamenti IVA da verifiche, in base a diritto UE, o in altre situazioni). Quindi difficilmente questo motivo si applica qui. Un’eccezione: se fosse un tributo diverso, come un diritto doganale, la mancanza di contraddittorio potrebbe avere peso. Ma per l’Agenzia Entrate su omessi versamenti, la prassi non prevede colloqui prima: c’è l’avviso bonario come strumento di confronto. Anche eventuali errori nel computo degli interessi (norme sulle %), se contestati, rientrano nelle “violazioni di legge”. O ancora, l’applicazione della sanzione piena senza considerare attenuanti: ad esempio, se il contribuente ha pagato spontaneamente prima dell’accertamento (anche se in ritardo) e l’ufficio gli applica comunque il 30% intero, si potrebbe eccepire la mancata applicazione del ravvedimento se era ancora possibile (ma se ha pagato prima dell’atto, l’atto non doveva proprio uscire se ravvedimento corretto…). Oppure, invocare l’art. 6, co.5 Statuto: “non sanzionabile chi ha commesso violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza normativa”. Ad esempio, una confusione normativa sulle scadenze. Se convincente, il giudice può annullare la sanzione.
7. Forza maggiore / cause di non punibilità: come discusso, forza maggiore vera e propria (evento imprevedibile e inevitabile) esclude la punibilità (art.6 co.5 D.Lgs.472/97). Quindi il contribuente può far valere in ricorso, come motivo di annullamento delle sanzioni, di aver omesso il versamento per cause di forza maggiore. Deve provare l’evento e il nesso causale stringente. Esempi portati in giudizio: gravi calamità, congelamento dei conti da parte di terzi, malattia improvvisa gravissima del titolare nell’imminenza delle scadenze, ecc. La giurisprudenza, come detto, è severa: ha escluso situazioni come la crisi di liquidità dovuta ai mancati pagamenti della P.A.. Però qualche CTR ha accolto nei casi limite (es. imprenditore colpito da infarto durante le scadenze, prova che non poteva delegare nessuno in quel frangente). Quindi è un motivo che si può tentare se ci sono elementi forti, conscio che in Cassazione poi difficilmente passeranno (Cass. 11111/2022, già citata, ha cassato una CTR Veneto che aveva annullato per forza maggiore una sanzione, ripristinandola).
Un’altra causa di non punibilità (anche se non testuale) è l’adempimento di un ordine autoritativo: es. se un provvedimento del Governo aveva sospeso i versamenti (pensiamo ai decreti Covid che li rinviavano) e poi la norma è stata in parte annullata o interpretata restrittivamente e vi contestano il ritardo. In tali casi si può dire che avete agito in base a norma primaria o a comunicazioni ufficiali, quindi la sanzione sarebbe ingiusta. A volte l’Agenzia stessa vi rinuncia in autotutela.
8. Errori di calcolo negli importi: banalmente, l’ufficio potrebbe aver sbagliato a sommare gli importi, ad applicare il tasso d’interesse, o a conteggiare le sanzioni ridotte. Questi errori aritmetici vanno ovviamente contestati: “il totale richiesto è errato, è inferiore (o superiore) a quello corretto”. Se superiore, chiederete l’annullamento parziale per la parte eccedente; se inferiore (cioè hanno chiesto meno del dovuto) ovviamente non lo contesterete, ma sappiate che l’ufficio poi in giudizio non può aggravare la pretesa oltre quanto indicato (principio di cristallizzazione dell’atto impugnato).
9. Applicazione di sanzioni in violazione del principio del ne bis in idem o di altre garanzie: ipotesi rara ma ad esempio: se per il medesimo fatto vi è già stata una sanzione a altro titolo. Nel nostro caso di omesso versamento, non viene in mente un doppio binario (penale e amministrativo coesistono, ma la Cassazione ha detto che non è bis in idem punire penalmente e amministrativamente perché scopi diversi). Se però fosse ad es. un omesso versamento sanzionato due volte (es. Agenzia Entrate e Agenzia Dogane su due normative): potrebbe essere un tema.
In pratica, come strutturare il ricorso? Conviene enucleare tutti i motivi che si riscontrano. Spesso, un ricorso ben fatto contro un avviso di omesso versamento potrebbe dire:
- in via pregiudiziale: nullità dell’atto per tardività (decadenza) o nullità per difetto di motivazione;
- in subordine: illegittimità della sanzione per forza maggiore / errore scusabile;
- in ulteriore subordine: eccessività degli interessi calcolati;
- e comunque: chiedere la riduzione sanzione al minimo in caso di rigetto (ex art.7 D.Lgs.472/97, discrezionalità del giudice di ridurre la sanzione se appare manifestamente eccessiva, anche se difficilmente ne ha margine trattandosi di minimo edittale).
Va sottolineato che il giudice tributario decide nel merito: può cioè riquantificare il debito. Non è come il giudice amministrativo che annulla o meno: il giudice tributario può dire “il contribuente ha ragione solo su metà delle somme, quindi riduco imposta e sanzioni di conseguenza”. Può anche annullare solo la sanzione e confermare l’imposta. Ad esempio, se accoglie la tesi della forza maggiore, risulterà: imposta dovuta, ma senza sanzione. Ci sono casi in cui i giudici di merito, considerando la situazione eccezionale (tipo un’alluvione che ha colpito l’azienda), hanno annullato le sanzioni e mantenuto i soli interessi e imposte.
Documentazione: il ricorrente deve allegare tutto ciò che serve a provare le sue affermazioni: ricevute di pagamento eseguito (se ne aveva), copia di normative se utile, certificati medici se invoca cause di forza maggiore, bilanci se invoca danno grave, corrispondenza con l’ufficio (es. un’email in cui un funzionario gli diceva “aspetti a pagare” – succede raramente ma chissà).
Nell’ottica del debitore, ogni elemento utile a suscitare nel giudice il convincimento che la sanzione sia ingiusta o eccessiva va presentato. Anche se la controparte (Agenzia Entrate) di solito su omessi versamenti ha un margine discrezionale nullo – gli impiegati non possono “perdonare” la sanzione salvo autotutela forza maggiore riconosciuta dall’alto – il giudice può avere una visione equitativa. Dunque allegare, ad esempio, che quell’anno l’azienda era sotto usura di una banca dati, o era nel mezzo di una pandemia che ha confuso le scadenze, ecc., può influire. Ad ogni modo, la difesa va calibrata caso per caso.
Il giudizio tributario: svolgimento e esito
Tralasciando i dettagli procedurali (redazione del ricorso, notifica via PEC, costituzione telematica su SIGIT, pagamento contributo unificato se dovuto – che per cause su tributi di valore rilevante c’è, ma non entriamo nel tecnico minore), ricordiamo i punti salienti:
- Primo grado in Corte Giustizia Tributaria di primo grado: dopo eventuale sospensiva, si arriva a trattazione di merito (oggi possibile anche con trattazione scritta o udienza da remoto). Il contribuente può depositare memorie aggiuntive fino a 10 giorni prima. L’Agenzia si difende con memoria entro 60 giorni dal ricorso. Poi decisione.
- Appello alla Corte Giustizia Tributaria di secondo grado: sia contribuente che Agenzia, se soccombenti in tutto o in parte, possono appellare entro 60 giorni dalla notifica sentenza di primo grado (o 6 mesi se non notificata). In appello, le regole di pagamento frazionato proseguono: in caso di esito sfavorevole al contribuente nel primo grado, questi come detto deve pagare 2/3 delle imposte, ma se appella può chiedere di sospendere anche l’esecutività della sentenza di primo grado (cioè sospendere l’obbligo di pagare quei 2/3 in attesa dell’appello, art.52 c.2 D.Lgs.546/92). Le Corti di secondo grado ora decidono spesso in formazione collegiale e abbastanza spedita (c’è anche la possibilità di appello “rinforzato” con giudice monocratico in liti piccole, introdotta nel 2022, ma non complichiamo).
- Cassazione: poi eventuale ricorso per Cassazione su punti di diritto. Qui però discende dall’interesse giuridico: raramente per un omesso versamento c’è questione di diritto di particolare novità, di solito sono questioni di fatto o interpretazione consolidata (decadenza, motivazione, ecc.). Cassazione decide definitivamente sul diritto, e se accoglie spesso rimette a giudice di rinvio per quantificazione. Attenzione: la pendenza in Cassazione non sospende il pagamento del dovuto dopo secondo grado, salvo rarissime ipotesi di sospensione ex art. 62 bis D.Lgs.546 (se c’è pericolo grave e il ricorso appare fondato – succede di rado). In pratica, se perdi in secondo grado, l’AdER ti chiederà tutto il restante (o procederà in esecuzione) senza aspettare la Cassazione. Quindi a quel punto, se vuoi evitare l’esecuzione, devi pagare e semmai sperare di riavere indietro se vincerai in Cassazione.
Conciliazione in corso di causa: segnaliamo che, oltre all’adesione prima del processo, esiste la conciliazione giudiziale (art.48 D.Lgs.546/92 e seguenti) in cui, durante il giudizio di primo o secondo grado, contribuente e ufficio possono accordarsi su una cifra per chiudere la lite. Comporta sanzioni ridotte al 40% (in primo grado) o 50% (in appello) e pagamento dell’importo concordato. Potrebbe essere utile se emergono elementi nuovi o se il contribuente, dopo aver iniziato il ricorso, riesce a convincere l’ufficio di una sua parte di ragione e viceversa. Nel contesto di omessi versamenti, la conciliazione può servire per esempio a “spalmare” il pagamento con sanzione ridotta (ma oramai la sanzione era già 1/3 in acquiescenza, in conciliazione primo grado è 40% = sconto minore), oppure per concordare su quali annualità applicare cumulo sanzioni unico se in discussione più anni, ecc. La conciliazione va formalizzata con accordo omologato dal giudice.
Costi e benefici del contenzioso: un avvocato tributarista o difensore abilitato (dottore commercialista iscritto al registro, ecc.) è necessario per cause oltre €3.000 di valore. Quindi va considerato il costo professionale. Il contributo unificato per cause di valore elevato può essere qualche centinaio di euro. Se si vince, in teoria si possono chiedere le spese di giudizio a carico dell’Agenzia, ma spesso vengono compensate o date in parte. D’altro canto, non fare nulla comporta pagare l’intero 30% di sanzioni. Si pensi ad un debito grande: per €100.000, 30% sanzione è €30.000. Andare in giudizio, anche spendendone 5-10 mila di spese legali, se c’è una buona chance di annullare la sanzione (ad es. per forza maggiore o altro) conviene. Inoltre, durante il processo, come detto, si guadagna tempo e magari nel frattempo possono intervenire sanatorie fiscali (nel 2023 c’è stata la definizione agevolata liti pendenti, ad esempio, che permetteva di chiudere i giudizi tributari con sconto sanzioni e interessi se la materia era di un certo tipo). Lo Stato periodicamente var varando condoni: chi ha contenziosi aperti può aderire; chi ha già pagato in acquiescenza no. Questo fattore pragmatico talora incide: molti nel 2023 non hanno definito acquiescentemente atti in attesa di vedere se spuntava una “rottamazione quater” o simili.
Abbiamo dunque esplorato come difendersi attivamente da un avviso di accertamento per omesso versamento, combinando strumenti amministrativi (autotutela, adesione, rateazione) con la difesa processuale vera e propria (ricorso, sospensiva, motivi di impugnazione).
Nella prossima sezione passeremo a trattare l’altro scenario: cosa accade se, nonostante tutto, il debito rimane e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione attiva le procedure coattive. Questo riguarda sia chi ha lasciato scadere l’avviso senza reagire, sia chi sta perdendo nel contenzioso (o non ha ottenuto sospensioni) e deve fronteggiare le azioni esecutive. Approfondiremo dunque le procedure di riscossione coattiva, i loro limiti e le difese specifiche del debitore in quella fase (dai piani di rateazione alle opposizioni esecutive).
Riscossione coattiva: cosa succede se non si paga (ruoli, cartelle, fermi, ipoteche, pignoramenti)
Trascorsi i termini di pagamento di un avviso di accertamento senza che il contribuente abbia né pagato né ottenuto una sospensione giudiziale, il debito tributario diventa esigibile forzatamente. La pratica passa quindi dall’ente impositore (Agenzia Entrate) all’Agente della Riscossione, ovvero Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) – l’ente pubblico economico che dal 2017 ha preso il posto di Equitalia. In questa fase si entra nel campo della riscossione coattiva, regolata in gran parte dal DPR 602/1973 e, per aspetti non disciplinati, dal codice di procedura civile. Analizziamo i vari passi e strumenti:
Dal ruolo alla cartella, o attivazione diretta dell’esecuzione
Se l’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo (come quelli emessi dall’Agenzia Entrate dal 2011 in poi), la procedura è la seguente: trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento (o ricorso), l’ufficio incarica AdER di riscuotere. Questo avviene tramite l’iscrizione a ruolo delle somme dovute (il ruolo è l’elenco dei debiti da riscuotere) e l’affidamento del carico all’Agente della Riscossione. Tuttavia, a differenza del passato, non viene notificata una cartella di pagamento se l’avviso conteneva già l’intimazione ex art.29 DL 78/2010. In pratica l’avviso stesso vale cartella. Dunque l’Agente può passare subito alle misure cautelari/esecutive passati 60 giorni.
Nei fatti, l’AdER invia spesso una comunicazione di presa in carico o un sollecito prima di agire, ma non è strettamente obbligatoria (è più un atto di cortesia o una strategia per incassare senza procedere). La legge richiede invece, come accennato, che se tra la notifica dell’atto e l’inizio dell’esecuzione passano più di 1 anno, l’AdER debba notificare un’intimazione di pagamento (art.50 DPR 602/73) e attendere 5 giorni. Esempio: avviso notificato a marzo 2022, rimasto insoluto; a luglio 2023 AdER vuole pignorare: poiché >12 mesi, deve prima notificare un Intimazione al contribuente (un avviso formale che dice “paga entro 5 giorni o procederemo”). Se anche questa è ignorata, si procede.
Se invece la pretesa è contenuta in una cartella di pagamento (ad esempio cartella derivante da avviso bonario non pagato, o cartella per tributi locali), allora la cartella stessa, dopo 60 giorni dalla notifica, consente di avviare l’esecuzione. In quel caso, se passano più di 1 anno, servirà anch’essa l’intimazione 5 gg prima di pignorare.
In questa guida, consideriamo in generale la situazione in cui AdER ha il compito di riscuotere un certo importo per conto dell’ente impositore. A quel punto AdER ha a disposizione vari strumenti:
- Misure cautelari (senza giudice):
- Fermo amministrativo di beni mobili registrati (es. autoveicoli).
- Iscrizione di ipoteca su beni immobili.
- Misure esecutive (espropriazione forzata):
- Pignoramento mobiliare presso il debitore (ad es. sequestrare beni materiali – oggi raro).
- Pignoramento immobiliare (espropriazione della casa o altri immobili).
- Pignoramento presso terzi, ossia di crediti del debitore verso terzi: tipicamente conti correnti in banca, stipendi/salari/pensioni presso il datore di lavoro o ente pensionistico, affitti presso inquilini, ecc. Questo è di gran lunga lo strumento più usato dall’AdER, perché è efficiente: se il debitore ha soldi in banca o un flusso di reddito regolare, è facile agganciarlo.
Ogni strumento ha le sue condizioni e limiti di legge, vediamoli uno per uno, spiegando come il debitore può difendersi o attenuarne gli effetti.
Fermo amministrativo di veicoli
Il fermo amministrativo è disposto dall’AdER iscrivendo un vincolo sul veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il veicolo fermato non può circolare né essere radiato o demolito, e di fatto resta inutilizzabile legalmente (se lo usi, rischi sanzioni e sequestro). Scopo: spingere il debitore a pagare, dato che gli viene negato l’utilizzo dell’auto. Non è un’espropriazione (l’auto resta tua) ma è una misura cautelare coercitiva.
Limiti di importo: non c’è una soglia di legge specifica (in teoria AdER potrebbe fermare per qualunque importo), ma prassi interne evitano fermi per debiti irrisori. Ad esempio, Equitalia in passato non faceva fermi sotto circa €500-800; AdER oggi di solito non procede per debiti minori di €1.000. Inoltre, per debiti fino a €1.000 la legge (D.L. 112/2019) prevede che non si avvii alcuna azione esecutiva o cautelare prima di 120 giorni da una comunicazione di sollecito. Quindi, se il tuo debito totale con AdER è inferiore a 1.000, in genere sei al riparo da misure (fino al cumulo di nuovi debiti). Sopra €1.000, il fermo è possibile. Nella pratica, AdER tende a usare il fermo per debiti medio-piccoli, diciamo da €1.000 a qualche migliaio, quando il pignoramento immobiliare sarebbe sproporzionato e il pignoramento presso terzi magari infruttuoso. Per debiti elevati spesso scattano ipoteca o pignoramenti diretti.
Procedura e garanzie: prima di iscrivere il fermo, l’Agente deve notificare al contribuente una Comunicazione preventiva di fermo (detta anche preavviso di fermo). In essa sono indicati i dettagli del debito, il veicolo che verrà sottoposto a fermo (di solito individuato tramite il PRA, incrociando i tuoi debiti con i tuoi beni), e si concedono 30 giorni per pagare o presentare osservazioni. Questa comunicazione è fondamentale: se manca, il fermo è impugnabile e annullabile quasi automaticamente (violazione art.86 DPR 602/73). Se entro 30 giorni non succede nulla, AdER può iscrivere il fermo al PRA.
Esenzioni: L’unico caso di esenzione previsto dalla legge per fermo è se il veicolo è strumentale all’attività di impresa o professionale del debitore. Ad esempio, l’unico furgone di un artigiano con cui svolge il lavoro, o l’auto di un agente di commercio usata per le visite ai clienti. In tali casi, presentando idonea documentazione (es. attestazione che quell’auto è vincolata all’attività lavorativa), si può evitare il fermo o ottenerne la cancellazione se già iscritto. Questa è una tutela importante: la ratio è che il fermo non deve impedire al contribuente di produrre reddito col suo lavoro, se quell’auto è necessaria. Va detto che la definizione di “strumentale” è stretta (ad es. l’auto generica di un professionista non sempre è riconosciuta come strumentale se potrebbe farne a meno, ma in pratica molti provano a far valere questa clausola). Alcune normative regionali integrano queste tutele e la giurisprudenza è intervenuta per esempio per i veicoli cointestati (dove il fermo incide anche sul co-intestatario non debitore: purtroppo la giurisprudenza ne ha confermato la legittimità, con possibile rivalsa del co-intestatario sul debitore).
Effetti pratici: un’auto fermata non può circolare, ed è un grosso disagio se è la tua autovettura quotidiana. Continui a pagarne bollo e assicurazione senza poterla usare. Dopo il fermo, molti debitori corrono a pagare (o chiedere rateazione). Di per sé AdER non porta via fisicamente l’auto: la differenza col pignoramento mobiliare è che non vengono a sequestrartela immediatamente. Però se vieni fermato a un controllo, risulta il fermo e sono guai amministrativi.
Come togliere il fermo: l’unica via ordinaria è pagare il debito per intero oppure ottenere una rateizzazione. Pagato il debito, AdER entro 20 giorni rilascia il provvedimento di cancellazione del fermo e lo comunica al PRA per la registrazione. Se ottieni una dilazione, AdER su richiesta rilascia un provvedimento di sospensione del fermo (non cancellazione finché non finisci di pagare). In realtà, di solito AdER se il fermo è già iscritto, prima di revocarlo pretende almeno una parte del pagamento (es. le prime rate versate) come garanzia. Ma formalmente, con la rateizzazione concessa, dovrebbero astenersi da misure.
Impugnazione del fermo: il preavviso di fermo è un atto impugnabile in Commissione Tributaria (Corte Giust. Trib.) entro 60 giorni se riguarda tributi (se riguardasse multe stradali, la competenza è del giudice ordinario). I motivi possono essere: il debito sottostante non dovuto o prescritto, la mancata notifica degli atti precedenti (es. mai notificato l’accertamento né la cartella), il mancato invio del preavviso stesso, il vizio nel procedimento. Dopo l’iscrizione, il contribuente può impugnare il fermo (provvedimento di iscrizione) o anche l’estratto di ruolo per far valere le sue ragioni. Ad esempio, Cass. SU n.19704/2015 ha ammesso che se non ti hanno notificato la cartella, puoi impugnare l’estratto di ruolo (che è un documento che vai a chiedere in AdER per vedere i tuoi debiti) e chiedere l’annullamento di cartella e fermo. In generale, le Commissioni Tributarie spesso annullano fermi se c’è anche un solo vizio procedurale, perché l’ente di riscossione tende poi a rifare la trafila piuttosto che appellare. Quindi il fermo va contrastato subito se il debito è contestabile. Se però il debito è effettivamente dovuto e l’iter regolare, il giudice non potrà che confermare la legittimità del fermo (ricordiamo che la soglia minima non prevista per legge non è un motivo: se ti hanno fermato per 300€, non c’è norma che lo vieta; puoi far leva sulla sproporzione, ma giuridicamente non c’è divieto espresso).
Proporzionalità: un principio generale, affermato anche in giurisprudenza, è che le misure esecutive devono essere proporzionate all’entità del debito. AdER in genere lo rispetta: per 2-3 mila euro non ti ipoteca casa, preferisce il fermo auto; per 50 mila € magari ipoteca un immobile ma non pignora la Panda; per 500 mila € pignora immobili e conti e non si accontenta di un fermo su una moto. Se c’è una palese sproporzione (es. fermo di tre auto di lusso per un debito di €1.500), il contribuente può lamentare l’abuso di diritto. Non sempre questo trova accoglimento, ma è un argomento di equità.
In sintesi: Il debitore di fronte a un preavviso di fermo ha 30 giorni per muoversi: o paga/rateizza, o contesta se ci sono motivi validi. Se subisce il fermo, può ancora pagare per toglierlo o attendere e magari combinare con un pignoramento successivo (ma allora è tardivo reagire). Spesso il fermo spinge a trovare un accordo (rate). Quindi come difesa diremmo: non trascurare un preavviso di fermo, perché dopo quell’auto ti sarà inutilizzabile.
Ipoteca sugli immobili
L’ipoteca esattoriale è la seconda misura cautelare. AdER può iscrivere ipoteca su uno o più immobili di proprietà del debitore a garanzia del credito. L’ipoteca rende l’immobile gravato: se il debitore cerca di venderlo, il compratore vedrà l’ipoteca e difficilmente comprerà senza che il debito sia estinto; se il debitore lo ipoteca per un prestito, la banca dovrà tener conto dell’ipoteca AdER preferenziale. Inoltre, l’ipoteca è solitamente preludio (necessario) per un eventuale pignoramento immobiliare successivo.
Soglia di importo: qui la legge è chiara: AdER può iscrivere ipoteca solo per debiti complessivi ≥ €20.000. (In passato la soglia era 8.000, poi alzata a 20.000 nel 2012). Ciò significa che se il tuo debito totale con AdER è ad esempio €18.000, non possono ipotecare alcun immobile. Questo limite di €20.000 vale per la somma dei ruoli per cui si procede, non per ciascun atto. Quindi se hai tre cartelle da 8k, 7k, 6k (tot.21k), in teoria possono ipotecare perché superi 20k. Ma se ne hai solo da 10k+5k (tot.15k), no. La soglia è rigida: ipoteca sotto 20k è nulla e impugnabile.
Procedura: Anche per l’ipoteca è richiesto un preavviso: la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con elenco dei debiti e degli immobili target, concedendo 30 giorni per pagare o opporsi. Se entro 30 gg non si paga né contesta, AdER richiede l’iscrizione ipoteca alla Conservatoria. Dopo l’iscrizione, in teoria AdER non è obbligato a notificare l’avvenuta ipoteca (perché c’era già il preavviso), ma in pratica spesso invia un estratto di ruolo aggiornato o un atto di comunicazione. Ad ogni modo, il contribuente può scoprire l’ipoteca facendo una visura ipotecaria.
Effetti: l’ipoteca vincola l’immobile a garanzia del debito per un importo di regola pari al doppio del debito (per coprire anche interessi futuri e spese). Non toglie il possesso al proprietario (che può continuare ad abitarci o percepire affitti), ma ne limita la commerciabilità: vendere una casa ipotecata significa che il compratore dovrà accollarsi o pretendere la cancellazione dell’ipoteca pagando il debito.
Prima casa: caso particolare e frequente. La legge (art.76 DPR 602/73) impedisce il pignoramento della prima e unica casa di abitazione non di lusso, ma non vieta l’ipoteca su di essa se il debito ≥ €20.000. Quindi, sì, l’AdER può ipotecare anche la vostra prima casa (purché non abbiate altre case e non sia A/8 o A/9, cioè categorie di lusso), anche se poi non potrà espropriarla finché resta “prima e unica abitazione”. Ciò può sembrare illogico, ma la Cassazione ha stabilito che è legittimo: l’ipoteca è una garanzia e può gravare anche su beni non espropriabili. Dunque non sorprendetevi: molti scoprono ipoteca sulla loro casa di residenza pur avendo letto che “la prima casa è impignorabile”. È impignorabile (non la metteranno all’asta), ma l’ipoteca ce la possono mettere eccome. L’unica tutela è che quell’ipoteca rimarrà lì come “spada di Damocle” finché non avete altre proprietà o finché il debito resta sopra soglia: se in futuro compraste un altro immobile o perdeste i requisiti di prima casa (es. spostate la residenza altrove), quell’immobile tornerebbe pignorabile.
Durata ipoteca: dura 20 anni e rinnovabile. Se pagate il debito o viene annullato, AdER deve procedere alla cancellazione (di solito su istanza vostra e con atto di assenso alla cancellazione, spesso a vostre spese notarili, purtroppo).
Cancellazione dell’ipoteca: pagando integralmente il debito, si chiede l’assenso e si cancella. Domanda: se il debito scende sotto €20.000 (es. perché avete pagato un po’), devono cancellarla? La legge non lo dice esplicitamente, ma c’è giurisprudenza che sostiene di sì: una CTR (Pescara, 2022) ha statuito che se il debito residuo scende sotto soglia, l’ipoteca non può mantenersi e va rimossa. AdER non concorda, affermando che conta il momento dell’iscrizione. Però ci sono casi di ricorsi vinti su questa base. Quindi se ad esempio con saldo e stralcio o rottamazione avete ridotto il debito a 10k, potete fare istanza di autotutela per cancellazione, citando pronunce a favore. Prepararsi però all’eventuale necessità di ricorso se rifiutano.
Impugnazione dell’ipoteca: analogamente al fermo, il provvedimento di iscrizione ipotecaria e il preavviso sono impugnabili in Commissione Tributaria entro 60 giorni. Motivi tipici: debito sotto €20.000 (facilmente vincente: ipoteca nulla), mancata notifica del preavviso (anche vincente: vizio procedura), prescrizione del credito sottostante, immobile in comproprietà (si può eccepire che ipotecare la quota del debitore è eccessivo rispetto al debito, ma di solito lo fanno per tutto l’immobile, generando prelazione su eventuale vendita), vizi del ruolo come solito (cartella mai notificata, ecc.). Se l’ipoteca è su prima casa unica: pur non vietata, alcuni hanno provato a contestarla come abuso di diritto se sproporzionata (ad esempio ipotecare casa di alto valore per debito modesto). Non c’è un orientamento uniforme, ma qualche giudice potrebbe valutare l’eccesso di garanzia in relazione al principio di proporzionalità. In generale però la linea è: ipoteca su prima casa è legittima se debito≥20k; puoi solo contestare eventuali errori procedurali.
Nota bene: l’ipoteca esattoriale non richiede un titolo giudiziario come per i creditori privati (che per ipotecare un tuo bene devono avere una sentenza o mutuo registrato). AdER la iscrive in base al ruolo, credito privilegiato. Quindi non c’è il passaggio in tribunale, tu puoi solo reagire dopo col ricorso tributario.
Impatto sul debitore: psicologicamente, scoprire un’ipoteca sulla propria casa è pesante. Anche se non te la tolgono subito, sai che c’è un vincolo. Se volessi vendere, devi prima risolvere col Fisco. Frequentemente, i debitori in questa situazione cercano di rateizzare il debito: la rateazione però non comporta la cancellazione dell’ipoteca durante il pagamento (AdER di solito la mantiene fino all’ultima rata pagata, per garanzia). Quindi se contavi di vendere l’immobile per pagare il debito a rate, sappi che l’ipoteca resterà e andrà comunque liberata a fine pagamento – complicando la vendita.
In sintesi: come difesa, non ignorare un preavviso di ipoteca. Se puoi, paga o fai un piano. Se non puoi e il debito è contestabile, proponi ricorso per bloccarla (chiedendo magari sospensione anche al giudice). Se l’ipoteca è già iscritta, valuta se ci sono vizi per impugnarla e farla togliere. E ricorda i 20k: è un limite fondamentale da monitorare (a volte, se sei a ridosso, basta pagare qualcosa per scendere sotto e prevenire ipoteca).
Pignoramento ed espropriazione forzata
Il pignoramento è l’atto tipico dell’esecuzione forzata: si tratta di sottrarre coattivamente beni o crediti al debitore per soddisfare il credito. Nel contesto della riscossione tributi, AdER può effettuare pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, come un creditore qualsiasi, ma con alcune procedure agevolate (niente bisogno di decreto ingiuntivo perché ha già il ruolo come titolo esecutivo, ecc.). Esaminiamo i tipi:
- Pignoramento mobiliare presso il debitore: AdER potrebbe mandare l’Ufficiale della riscossione (una figura analoga all’ufficiale giudiziario) presso la tua sede/abitazione e inventariare beni (mobili, attrezzature, merce) per poi venderli. Nella pratica attuale, è rarissimo. È oneroso e spesso infruttuoso (in casa trovano beni di scarso valore rivendibile). Si usa giusto contro imprese che hanno magazzino di merci di valore o macchinari, se altre vie falliscono. Il debitore comunque ha poche difese specifiche: può far presente se i beni sono impignorabili per legge (es. oggetti necessari alla vita quotidiana, art. 514 c.p.c., come letti, frigo, abiti, che l’esattore deve lasciare) o se appartengono a terzi (ma occhio: serve prova, altrimenti li considerano tuoi). Non scendiamo oltre perché, ripetiamo, è poco comune oggi che AdER faccia pignoramento in appartamento per tasse.
- Pignoramento immobiliare: è la procedura per espropriare e vendere all’asta un immobile. Condizioni rigorose: la legge (art.76 DPR 602/73) pone quattro paletti fondamentali:
- Debito ≥ €120.000: se il debito totale è sotto 120k, AdER non può procedere a espropriare immobili. (Questo limite è stato introdotto nel 2013 per equità).
- Valore complessivo degli immobili del debitore > €120.000: novità dal 2021, se il contribuente possiede immobili di valore catastale totale non superiore a 120k, non si procede. Ciò tutela chi possiede solo un piccolo appartamento di basso valore – non glielo espropriano neanche se il debito supera 120k, finché quell’immobile resta di modesto valore totale. Se invece uno ha due case da 60k (tot 120k), come si computa? Il comma 5-bis introdotto parla di valore complessivo >120k: se esattamente 120, dubbi, ma direi in claris: deve superare.
- Dev’essere stata iscritta ipoteca da almeno 6 mesi sugli immobili e il debitore non deve aver pagato nel frattempo. Quindi l’iter è: ipotecano (dopo preavviso), attendono minimo 6 mesi; se ancora debito insoluto, allora valutano pignoramento. Se uno in quei 6 mesi chiede rateizzazione o paga parzialmente, di solito blocca la mossa successiva. Questa regola crea dunque un “cuscinetto” temporale.
- Divieto di pignorare l’unico immobile di proprietà a uso abitativo dove risiede il debitore (non di lusso) – la famosa clausola “prima casa impignorabile” introdotta dal 2013. In parole semplici: se hai una sola casa, ci abiti come residenza e non è accatastata A/8 o A/9, AdER non può pignorarla e venderla. Se hai due immobili, anche se uno è la tua residenza, la protezione cade (non è più “unico immobile” e quindi anche la prima casa potrebbe essere colpita). Se hai un’abitazione e un magazzino, comunque hai due immobili, quindi la tua abitazione torna pignorabile (anche se probabilmente preferiranno aggredire l’altro bene prima).
Procedura di pignoramento immobiliare: se i requisiti sono soddisfatti, AdER notifica un Atto di pignoramento immobiliare al debitore e lo trascrive nei registri immobiliari. Questo atto include un’ingiunzione a non alienare l’immobile e dichiara l’avvio dell’esecuzione. Contiene l’indicazione del Tribunale competente per la vendita. Dopodiché, AdER deposita un’istanza di vendita al Tribunale; il Giudice dell’Esecuzione nomina un perito stimatore, un custode etc., e si svolge la procedura d’asta come per un qualsiasi pignoramento immobiliare privato. Dunque, mentre per fermo/ipoteca AdER agisce in autonomia, per vendere la casa deve passare dal Tribunale. Questo significa che i tempi si allungano (anche anni) e c’è vigilanza giudiziaria.
Difese/opposizioni: il debitore, una volta notificato il pignoramento, può:
- Opporsi in via giudiziale. Qui si entra in un terreno misto: tradizionalmente, le opposizioni all’esecuzione (art.615 c.p.c. per contestare il diritto di procedere, art.617 c.p.c. per vizi atti esecutivi) in materia di riscossione spettano al Giudice dell’Esecuzione (Tribunale) se si contesta atti dell’esecuzione successivi alla notifica della cartella/avviso. Ad esempio, se sostieni che la casa era impignorabile perché unica abitazione, questa è opposizione all’esecuzione (contesti il diritto di AdER a eseguire in quel caso). Negli ultimi anni c’è stata incertezza di giurisdizione: alcune Cassazioni dicevano che pure queste questioni vanno al giudice tributario (perché inerenti obblighi fiscali). Però le Sezioni Unite 2016 (sent. n. 13913/2017, credo) hanno chiarito che gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella sono fuori giurisdizione tributaria. Quindi, in pratica:
- Se vuoi contestare la regolarità e legittimità del pignoramento in sé (es. casa impignorabile ex art.76, mancata intimazione 5 gg se era obbligatoria, ruolo mai notificato ecc.), dovresti rivolgerti al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale civile con un’opposizione ex art.615 c.p.c..
- Se invece volessi ancora discutere il merito del tributo (tipo “non dovevo quelle imposte”), quel treno è perso: dopo 60 gg dall’atto impositivo definitivo non puoi più farlo in esecuzione (il credito ormai è irretrattabile come importo, salvo rarissime eccezioni).
- Spesso, per prudenza, alcuni fanno “doppio binario”: un ricorso al tributario e un’opposizione al Tribunale, e vedono chi si dichiara competente. Ma orientamento SU dice: giudice tributario per questioni fino a cartella, giudice esecuzione per atto di pignoramento in poi, soprattutto se esecuzione già avviata.
Che fare dunque? Esempio: AdER pignora casa che è unica abitazione non di lusso – ciò viola art.76. Questo è un ottimo motivo di opposizione all’esecuzione; va presentata al Tribunale entro le tempistiche strettissime (20 giorni dall’atto, secondo l’art.617 c.p.c. per opposizione atti esecuzione, ma essendo vizio di diritto all’esecuzione alcuni dicono 615 senza termine predefinito finché esecuzione pendente). Il debitore chiederà subito la sospensione al giudice dell’esecuzione, evidenziando che la casa è impignorabile. In casi così netti, la sospensione viene concessa e l’esecuzione estinta. Se invece uno contesta roba meno chiara, il giudice valuterà.
Altri motivi possibili: mancata intimazione 5 giorni se era dovuta (art.50, se >1 anno da cartella); pignoramento eseguito oltre termini di prescrizione (se il credito, magari congelato, è molto vecchio – ma su tributi la prescrizione è 10 anni dall’esigibilità); oppure se l’importo per cui si procede è inferiore a 120k (cioè magari debito originario era 130k ma hai pagato un po’ e sceso a 110k, potrebbero non dover proseguire). Su quest’ultimo scenario: se a seguito di pagamenti parziali il debito scende sotto soglia, secondo logica AdER dovrebbe fermarsi, ma se ha già pignorato potrebbe essere contestato come “è venuta meno condizione di procedibilità”.
In opposizione, solitamente, il debitore può far valere:
- Motivi di merito del debito solo se non li ha mai potuti far valere prima per vizi di notifica: es. “Non mi hanno mai notificato la cartella né l’avviso, scopro ora il debito dalla procedura”. In tal caso puoi contestare l’esecuzione perché difetti di titolo (il ruolo non è definitivo, mancando notifica atti presupposti). Anche qui, meglio averlo sollevato in commissione appena saputo via estratto di ruolo. Comunque, il giudice dell’esecuzione potrebbe valutare la validità del titolo, ma spesso su questioni del genere rinvia alla sfera tributaria. Cass. SU 2017 diceva: se hai perso il ricorso tributario (cioè non l’hai proposto nei termini) il credito è irretrattabile, ma se c’è nullità insanabile (tipo atto mai notificato) puoi far valere come difesa in esecuzione.
Sospensione e convergenza con ricorso tributario: Se il debitore aveva un contenzioso tributario in corso e il pignoramento parte prima della sentenza (può succedere se non ha ottenuto sospensiva), può trovarsi a dover agire su due fronti. È possibile chiedere la sospensione anche al giudice dell’esecuzione per aspettare l’esito tributario, ma di solito se non c’era sospensiva tributaria, il giudice ordinario è restio a fermare in attesa (a meno di evidenti ragioni). Come detto, a volte prudentemente si tenta duplici azioni.
Cosa succede se la casa è venduta: se l’esecuzione non viene fermata e si arriva all’asta, la casa viene aggiudicata, il ricavato viene usato per pagare il debito (AdER è creditore privilegiato, in genere prende prima). Se rimane surplus va al debitore. Spesso però case all’asta vanno a meno del valore di mercato, quindi il debitore ci perde patrimonio e magari deve ancora qualcosa se il ricavato non copre tutto (in quel caso AdER può proseguire su altri beni per il residuo).
Riassunto difensivo: un debitore deve assolutamente evitare di arrivare al pignoramento immobiliare, se possibile. Quindi:
- sfruttare ipoteca come campanello d’allarme (quei 6+ mesi prima che passino ad asta).
- fare di tutto per rateizzare prima (anche all’ultimo, AdER prima di depositare istanza vendita spesso accetta ancora di rateizzare – col nuovo DL 2023, se chiedi rate dopo pignoramento, possono sospendere la vendita con l’ok di AdER).
- se proprio arriva l’atto di pignoramento, verificare subito i requisiti: debito tot, numero immobili, ecc. Se c’è qualche vizio (prima casa unica, soglia, intimazione mancante, prescrizione), depositare immediatamente opposizione in Tribunale chiedendo sospensione d’urgenza.
- se non ci sono vizi e la procedura è regolare e il debito effettivo, purtroppo rimane la possibilità di saldo in extremis: la legge consente al debitore di chiedere di poter vendere privatamente prima dell’asta per pagare, o di saldare fino all’ultimo (fino al decreto di trasferimento si può chiudere saldando e si estingue esecuzione). C’è anche l’istituto della conversione del pignoramento (art.495 cpc) che ti permette di sostituire al bene pignorato una somma in deposito – in pratica pagare a rate il dovuto in tribunale, ma per i tributi è poco pratico perché serve garantire tutto e il giudice può dare max 18 rate mensili).
Spesso la minaccia del pignoramento spinge i debitori a trovare soldi (mutui da parenti ecc.) per evitare l’asta – dal punto di vista di AdER è proprio quell’obiettivo.
Pignoramento presso terzi (conti, stipendi, etc.)
Questa è la forma di esecuzione più comunemente usata perché più semplice: AdER sa (tramite accesso alla banca dati dell’Anagrafe dei conti e altre fonti) dove il debitore ha conto corrente, se percepisce uno stipendio o pensione, se è creditore di qualcuno (ad es. fitti attivi, rimborsi, ecc.). Può quindi inviare un atto di pignoramento presso terzi ai soggetti terzi debitori o custodi di somme del contribuente.
Procedura semplificata ex art. 72-bis DPR 602/73: per crediti verso banche o datori di lavoro, AdER può notificare un atto di pignoramento contestualmente al terzo e al debitore, senza passare prima dal giudice. L’atto intima al terzo di pagare direttamente ad AdER le somme (entro certi limiti) invece che al debitore. In pratica:
- Pignoramento del conto corrente: AdER notifica alla banca e per conoscenza a te un atto ex art.72-bis. Appena la banca riceve l’atto, blocca il conto fino a concorrenza del debito. Dopo 60 giorni dalla notifica, in mancanza di opposizioni, la banca deve versare ad AdER l’importo pignorato (il tuo credito verso la banca, ossia il saldo, viene girato).
- Pignoramento dello stipendio/pensione: AdER notifica al tuo datore di lavoro/ente pensionistico di trattenere una parte della busta paga e versarla ad AdER. Di solito l’atto specifica la quota pignorata e l’obbligo per il datore di accantonare mensilmente fino a soddisfo del debito.
Il codice di rito (art.545 c.p.c.) e l’art.72-ter DPR 602/73 stabiliscono limiti a tali pignoramenti per proteggere il debitore:
- Conti correnti: se sul conto affluiscono stipendi/pensioni, la legge tutela un importo pari al triplo dell’assegno sociale (~3×€460 = ~€1.380) come impignorabile se vi è accredito successivo all’atto, e per le somme già depositate di stipendio, impignorabile la parte equivalente all’ultimo stipendio ricevuto prima del pignoramento. In parole semplici: su un conto di un lavoratore dipendente, devono lasciargli almeno uno stipendio mensile; su conti non legati a stipendio non c’è minimo importo tutelato, tranne se il saldo è modesto (c’è giurisprudenza che applica analogia assegno sociale su conti generici, ma non di legge).
- Stipendi e salari: le regole (art.72-ter e 545 cpc) prevedono:
- Se lo stipendio/pensione netto è inferiore o uguale a circa €1.000 (precisamente l’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, che nel 2025 è intorno a €690 + 50% ≈ €1.035), non si può pignorare nulla. C’è una soglia minima vitale impignorabile su pensioni pari all’assegno sociale + 1/2 (per pensioni; per stipendi a dire il vero la norma parlava solo di pensioni per minimo vitale, ma la giurisprudenza l’ha estesa agli stipendi di importo minimo).
- Per stipendi fino a €2.500 netti: pignorabile 1/10 (10%).
- Tra €2.500 e €5.000: pignorabile 1/7 (~14%).
- Oltre €5.000: pignorabile 1/5 (20%).
- Questi limiti sono per i pignoramenti esattoriali; per crediti alimentari o alimenti diversi esistono altri parametri, ma concentriamoci sui tributi. AdER in genere indica al datore le percentuali giuste. Ad esempio, se prendi €1.800 al mese, AdER chiederà 1/10 (€180) al datore, che te li tratterrà in busta e li invierà.
- Esempio: Tizio ha stipendio €3.000 netti, AdER gli pignora 1/7 ≈ €428 mensili. Caio ha pensione €800, è sotto soglia minima, AdER non può toccarla. Sempronio ha conto in banca con €10.000 risparmi, AdER notifica e blocca €10.000 (poiché non stipendi, li può bloccare quasi tutti, salvo forse lasciargli €~1.380 se interpretano la norma come per tutti i conti).
Procedura: Il pignoramento presso terzi deve essere notificato al debitore oltre che al terzo – la Cassazione ha sancito che anche in quello esattoriale, serve notifica al debitore, non solo al terzo. Dunque se AdER blocca un tuo conto senza che tu abbia ricevuto copia dell’atto, c’è vizio (anche se di solito te lo notificano contestualmente). Dopo la notifica, hai quei 60 giorni in cui potresti fare opposizione prima che la banca versi – ma in pratica raramente serve, perché se il debito è dovuto, difficilmente un giudice sospenderà un pignoramento su conto (a meno di vizi di forma come notifica mancante o importo eccessivo).
Difese del debitore: poche: essenzialmente, se c’è un vizio di notifica degli atti presupposti o prescrizione, etc., puoi fare opposizione all’esecuzione al giudice ordinario come detto. Ad esempio: se ti bloccano €50.000 sul conto e tu non hai mai saputo di dover quei soldi perché non ti notificarono l’avviso, puoi rivolgerti al giudice (o anche in Commissione per far annullare il ruolo in via di autotutela giudiziaria). Spesso, la strategia è: negoziare con AdER una rateazione anche in questa fase. Quando ti pignorano il conto, di solito i soldi rimangono lì congelati per un po’ (fino a 60 gg). Puoi contattare AdER e proporre: “datemi una dilazione e sbloccate il conto”; AdER se concede la rateazione, sospende il pignoramento (non è automatico, ma per prassi lo fa su richiesta, a seguito di DL 83/2015 art.19). Dunque, se hai un business, è essenziale liberare i conti. Spesso AdER è più disponibile a dilazionare quando hai già un pignoramento in essere, perché vede che se stringe troppo rischia di far fallire e incassare zero. Con le nuove norme di luglio 2022, la decadenza da rateazione scatta dopo 8 rate non pagate (non più 5), quindi c’è margine di errore maggiore.
Impugnazioni particolari: se il pignoramento è viziato (ad es. prellevano oltre il quinto, o su pensione minima), devi rivolgerti al giudice ordinario con opposizione a atti esecutivi (entro 20 gg) per farlo ridurre. O segnalare all’AdER, che a volte aggiusta se c’è errore.
Da sapere: pignoramento di indennità di fine rapporto (TFR): considerato come stipendio, pignorabile nei limiti di 1/5. Pignoramento di affitto: se affitti un appartamento, AdER può notificarlo all’inquilino e questi dovrà pagare il canone (fino a concorrenza debito) all’AdER invece che a te.
Concorso di pignoramenti: per legge, sullo stipendio/pensione non puoi avere più di 1/5 pignorato per crediti ordinari, ma tributi e alimenti possono aggiungersi. In totale però non oltre 50% dello stipendio (c’è norma generica). AdER se arriva dopo un pignoramento bancario, troverà forse già il conto bloccato da altri; se trova stipendio già pignorato da banca, può cumularsi fino ai limiti di 1/5+1/5? La legge non chiarissima, ma tendenzialmente se c’è già un pignoramento del quinto per alimenti, AdER può prendersi un altro quinto per tributi (diversa natura).
Conclusione sulla riscossione coattiva: dal punto di vista del debitore, la fase esecutiva è critica: i margini di difesa strettamente giuridica si riducono, bisogna puntare su eventuali vizi procedurali (nullità notifiche, decadenze, impignorabilità, ecc.) e/o trovare soluzioni negoziali (rateazione, saldo e stralcio se proposto dal legislatore: es. rottamazioni). È importantissimo conoscere i propri diritti: sapere che la prima casa non può essere venduta, che sotto 20k non possono ipotecare, che su stipendio prendono al massimo un quinto, ecc., permette di non farsi prendere dal panico e valutare la situazione.
Ad esempio, se ti bloccano il conto e tu sai che per legge devono lasciarti almeno il minimo vitale se è stipendio, potrai con calma far valere quell’aspetto invece di credere di essere totalmente azzerato. O se ricevi preavviso ipoteca e hai debito 18k, sapendo della soglia 20k, potrai scrivere all’AdER che l’atto è illegittimo e probabilmente eviterai l’iscrizione.
Infine, citiamo la possibilità di ricorrere a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o di fallimento: se i debiti tributari (e altri) sono insostenibili, il debitore privato può valutare di attivare una procedura ex L.3/2012 (ora Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) per proporre un piano di ristrutturazione anche dei debiti fiscali. È una via complessa, da percorrere con consulenti specializzati, ma in alcuni casi consente di bloccare le azioni esecutive e ottenere anche stralci dei debiti con l’omologazione del tribunale (ad esempio, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio). Tuttavia, queste procedure sono fuori dall’ambito strettamente tributario, ma è bene sapere che esistono come extrema ratio per chi è sommerso dai debiti.
Passiamo ora, per concludere la nostra guida, a una sezione di Domande e Risposte frequenti, che ricapitolerà in forma breve molti punti trattati, fornendo un riferimento rapido per i dubbi più comuni di contribuenti e professionisti.
Domande frequenti (FAQ)
D.1: Ho ricevuto un avviso di accertamento per omesso versamento. Cosa devo fare subito?
R: Verifica anzitutto la data di notifica (quando decorrono i 60 giorni per agire) e l’importo totale richiesto. Leggi attentamente la motivazione per capire a cosa si riferisce il mancato pagamento. Se si tratta effettivamente di un importo da te dichiarato e non versato, valuta se hai le risorse per pagare entro 60 giorni con sanzioni ridotte a 1/3 (ottenendo lo sconto di legge). In alternativa, puoi chiedere una rateizzazione all’Agenzia Entrate (fino a 8 rate trimestrali, o 16 se importo > 50.000 € con prova di difficoltà). Se invece ritieni l’avviso errato o ingiusto, prepara un ricorso entro 60 giorni: per farlo è consigliabile affidarsi a un avvocato tributarista o professionista abilitato, che individui i motivi di impugnazione (vizi di notifica, decadenza, ecc.). Puoi anche presentare un’istanza di autotutela all’ufficio per segnalare errori palesi (non sospende però i termini di ricorso). Se decidi di ricorrere, inserisci anche l’istanza di sospensione per bloccare la riscossione durante il processo. In sintesi: non ignorare l’atto. Se non fai nulla, dopo 60 giorni diventerà definitivo e l’Agente della Riscossione potrà attivarsi con misure esecutive.
D.2: Quali sono i termini di decadenza per un avviso di accertamento da omesso versamento?
R: Dipende dal tipo di imposta e dall’anno. Per le imposte sui redditi e IVA relative a dichiarazioni presentate, il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Esempio: dichiarazione dei redditi 2020 presentata nel 2021 → termine accertamento 31/12/2026. (Fino ai periodi d’imposta 2015 era il quarto anno, poi esteso a cinque dal 2016 in poi). Se si trattasse di omessa dichiarazione (non il nostro caso tipico, ma per completezza) il termine è il 31 dicembre del settimo anno. Per le cartelle da controllo automatizzato, i termini di notifica erano il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione (quarto anno per controllo formale). Inoltre, ci sono state delle proroghe straordinarie (ad es. per i carichi 2018 e 2019 prorogati causa Covid). Quindi va verificato anno per anno. In generale, se ricevi un avviso oltre il quinto anno (dichiarazione regolarmente presentata) è verosimilmente decaduto e potrai far valere la decadenza in ricorso (è uno dei motivi più forti di annullamento). Attenzione: conta la data di spedizione/notifica dell’atto, non quando ti è arrivato. Quindi se l’ufficio dimostra di aver consegnato alle Poste il 30 dicembre (anche se tu l’hai ricevuto a gennaio successivo), è nei termini (principio del “doppio binario” della notifica). Viceversa, se la spedizione è avvenuta in ritardo, l’atto è nullo.
D.3: L’Agenzia delle Entrate doveva mandarmi prima l’avviso bonario? Non l’ho mai ricevuto: posso contestare l’accertamento per questo?
R: La normativa prevede che, in caso di difformità nei versamenti rilevate dal controllo automatizzato, l’Agenzia invii una comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) per consentire il pagamento con sanzione ridotta. Tuttavia, la mancata ricezione dell’avviso bonario non rende nullo l’accertamento successivo. La Cassazione ha chiarito che l’avviso bonario non è un atto impugnabile e la sua omissione non incide sul diritto di difesa quando comunque c’è la possibilità di ricorrere contro l’atto finale. Quindi non puoi ottenere l’annullamento dell’accertamento solo perché non ti è arrivato il preavviso. Potrai semmai lamentare la perdita della chance di pagare con sanzione ridotta al 10%, ma giuridicamente non c’è norma che imponga di annullare l’atto per questo. Diverso è se l’avviso bonario c’è stato ma è stato notificato tardivamente: in tal caso potevi ignorarlo perché decaduto, e se l’hai eventualmente pagato potresti chiedere rimborso (ma se non hai pagato e ti arriva la cartella, potrai contestare la cartella in quanto basata su atto decaduto, anche se questo scenario è complicato da spiegare qui). In sintesi: l’AdE dovrebbe mandare l’avviso bonario, ma se non lo fa hai comunque la possibilità di difenderti in sede di accertamento. Non puoi chiedere l’annullamento di quest’ultimo solo per la mancanza del bonario.
D.4: Omesso versamento e omessa dichiarazione: differenza ai fini sanzionatori e difensivi?
R: Sono due violazioni diverse. L’omesso versamento presuppone che tu abbia presentato la dichiarazione (o certificato le ritenute) ma non abbia versato quanto dichiarato dovuto. L’omessa dichiarazione è non aver proprio presentato la dichiarazione fiscale obbligatoria. Nel primo caso, la sanzione è quella del 30% sull’importo non versato, e l’accertamento verte sul recupero di quell’imposta dichiarata. Nel secondo caso, l’ufficio effettua un accertamento d’ufficio per determinare l’imposta evasa (spesso presumendola) e applica sanzioni ben più elevate (dal 120% al 240% dell’imposta evasa, ex art.1 D.Lgs.471/97) oltre a possibili profili penali se l’imposta evasa supera certe soglie. Qui trattiamo omesso versamento, quindi presumiamo la dichiarazione c’è. La difesa nell’omessa dichiarazione riguarda contestare la quantificazione del reddito/imposta fatta d’ufficio, ecc., ed è molto diversa. Se invece erroneamente l’ufficio ti contestasse omessa dichiarazione mentre tu l’avevi presentata, dovresti far valere che non c’è evasione di base imponibile ma solo un omesso pagamento: ciò ridurrebbe drasticamente sanzioni e termini (un avviso per omessa dichiarazione ha termini più lunghi e sanzioni maggiori). Insomma, verifica sempre di che violazione ti accusano. Se è solo omesso versamento, le argomentazioni difensive saranno quelle viste (forza maggiore, errori di calcolo, ecc.). Se fosse anche contestata un’imposta maggiore non dichiarata, allora l’ambito è più ampio: potresti dover difendere il merito dell’imposizione (non solo perché non hai pagato, ma se veramente dovevi quella maggiore imposta).
D.5: Posso invocare la “crisi di liquidità” o altre cause per evitare le sanzioni?
R: La crisi di liquidità di per sé (es. mancanza di fondi perché clienti insolventi o calo di fatturato) non esonera dalle sanzioni secondo la giurisprudenza prevalente. La legge prevede solo la forza maggiore come esimente (evento imprevedibile e inevitabile che ti impedisce di pagare). Ad esempio, un grave evento naturale, un impedimento legale assoluto, una malattia improvvisa che ti ha reso impossibile operare pagamenti potrebbero rientrare nel concetto di forza maggiore. Ma difficilmente la semplice mancanza di denaro (pur incolpevole) viene considerata tale: la Cassazione ha detto che non è forza maggiore il fatto che la P.A. ritardi i pagamenti dovuti all’azienda, generando illiquidità, né le generiche difficoltà economiche. Alcune Commissioni di merito talvolta annullano sanzioni se il contribuente prova di aver dovuto scegliere se pagare stipendi ai dipendenti o le imposte in un contesto drammatico, ma sono eccezioni. Puoi comunque provarci: in ricorso evidenziare di aver subito circostanze eccezionali (es: furto o truffa che ti ha sottratto la liquidità per pagare le imposte, emergenza sanitaria grave, ecc.) e chiedere quantomeno la disapplicazione della sanzione per mancanza di colpevolezza (art.6 co.5 D.Lgs.472/97). È un tasto da premere soprattutto se non hai altri motivi, sperando nella clemenza del giudice tributario. Ricorda però che il tributo (imposta + interessi) dovuto non viene meno: al massimo otterresti di non pagare la sanzione del 30%. In parallelo, valuta anche l’istituto del ravvedimento operoso: se la crisi era temporanea e ora hai i mezzi, pagando spontaneamente prima dell’accertamento potevi ridurre da te la sanzione (ad esempio a 3,75% se entro un anno). Dopo l’avviso, rimane solo lo sconto 1/3 con acquiescenza.
D.6: Ho deciso di fare ricorso: devo comunque pagare qualcosa nel frattempo?
R: Sì, in generale se ricorri senza ottenere sospensione, devi versare una parte del tributo. Nello specifico, presentando ricorso l’esecuzione è frazionata: non devi pagare subito le sanzioni (quelle sono sospese ex lege fino alla sentenza di primo grado), ma resti tenuto a pagare il 1/3 delle imposte accertate + interessi legali su tale terzo entro 60 giorni. Se vinci anche parzialmente in primo grado, il giudice ridetermina cosa pagare. Se perdi, dopo la sentenza di primo grado devi integrare il versamento fino a 2/3 dell’imposta. Queste sono le regole di art.68 D.Lgs.546/92. Tuttavia, puoi chiedere al giudice tributario la sospensione totale dell’atto impugnato, e se la ottieni non dovrai pagare neanche quel 1/3 fino all’esito del giudizio. Spesso i contribuenti ricorrenti chiedono e ottengono la sospensiva se il pagamento del terzo causerebbe un danno (ad es. per importi grandi). Se la sospensiva viene negata, l’AdER potrebbe attivarsi per riscuotere quel terzo non versato, quindi in pratica conviene pagarlo per evitare azioni. In sintesi: presentare ricorso non sospende automaticamente il pagamento, salvo che tu ottenga un provvedimento di sospensione dal giudice. Ricorda però che le sanzioni nell’avviso esecutivo sono automaticamente non esigibili finché pende il primo grado, quindi almeno su quelle c’è sollievo temporaneo. Nel dubbio, chiedi al tuo legale di presentare istanza di sospensione e di monitorare eventuali richieste di pagamento provvisorio da AdER.
D.7: La “prima casa” è davvero intoccabile? Cosa può succedere se ho debiti fiscali e possiedo solo la casa di abitazione?
R: La normativa protegge la prima ed unica casa di abitazione non di lusso dal pignoramento (vendita forzata). Ciò significa che l’Agenzia Entrate-Riscossione non può metterla all’asta per soddisfare il suo credito, a condizione che: sia l’unico immobile di proprietà del debitore, egli vi risieda anagraficamente, e non sia accatastato in categorie di lusso (A/8, A/9). Se anche uno solo di questi requisiti manca, la protezione cade. Ad esempio, se possiedi due immobili (anche un piccolo terreno oltre alla casa), la tua abitazione non è più “unica” e quindi può essere pignorata (in teoria preferiranno l’altro immobile, ma legalmente potrebbero entrambi). Attenzione però: la legge non vieta l’ipoteca sulla prima casa. Dunque AdER può iscrivere ipoteca sulla tua abitazione anche se è l’unica (purché il debito superi €20.000), e quell’ipoteca resterà finché non paghi, impedendoti di venderla facilmente. L’ipoteca è un “pegno” sul bene, anche se non seguita da esecuzione finché la casa resta impignorabile. Inoltre, se perdi i requisiti (es. compri un’altra casa, o sposti la residenza), quell’immobile ipotecato potrà essere messo all’asta. Quindi la prima casa è al sicuro dall’esproprio solo finché rimane unica e abitata. Riassumendo:
- No pignoramento di prima casa unica: AdER non può avviare esecuzione forzata (asta) sulla tua casa di residenza se non hai altri immobili e il debito è tributario. Questo è un divieto assoluto introdotto nel 2013. Quindi non rischi di essere sfrattato per debiti fiscali in quella condizione.
- Sì ipoteca: AdER può comunque vincolarla con ipoteca oltre €20.000 di debito. Troverai un’ipoteca iscritta che non comporta effetti immediati per il possesso, ma ti crea preoccupazione e va cancellata pagando.
- Se perdi i requisiti (non più unica casa, ecc.), la protezione cade e AdER, rispettati gli altri limiti (debito >120k, ipoteca da 6 mesi, ecc.), potrebbe procedere. In pratica, se possiedi solo la tua casa, AdER punterà su altre leve (fermo auto, pignorare stipendio/pensione, ipotecare la casa per pressione). Dovresti in questo scenario cercare di risolvere il debito tramite rate o definizioni, perché anche se non possono venderti la casa, il debito rimane e può crescere con interessi. Inoltre, se in futuro avrai un altro immobile o eredità, potranno colpirli. Infine, se pensassi di vendere la casa volontariamente per liberarti del debito, l’operazione va fatta con accortezza: vendere l’unica casa per sottrarla alla garanzia pubblica può configurare reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs.74/2000) se il debito supera €50.000. Quindi non è consigliabile vendere la prima casa per “farla franca”: rischi conseguenze penali. Meglio negoziare con AdER soluzioni legittime.
D.8: Ho un’attività e temo il pignoramento del conto corrente aziendale: cosa posso fare?
R: L’Agenzia Entrate-Riscossione ha il potere di pignorare i conti correnti bancari (aziendali o personali) tramite notifica alla banca ex art.72-bis DPR 602/73. Quando la banca riceve l’atto, congela immediatamente i fondi fino a concorrenza del debito. Per evitare questo scenario:
- Monitora la tua posizione debitoria: tramite il cassetto fiscale o l’estratto di ruolo di AdER, cerca di sapere se hai carichi pendenti e se stanno per scadere termini. Spesso il pignoramento conto arriva dopo che non hai pagato né ricorso su avvisi/cartelle.
- Se hai pendenze significative, considera di chiedere una rateizzazione prima che arrivi il pignoramento. Una volta con un piano di rate attivo e in regola, AdER generalmente non procede con azioni esecutive.
- Se ricevi atti pre-esecutivi (es. intimazione di pagamento) dopo 60gg da cartella, prendili come ultimi avvisi prima dell’azione.
- In emergenza, se scopri che il conto è stato bloccato (pignoramento notificato), hai circa 60 giorni prima che la banca versi i soldi ad AdER. In tal periodo, puoi contrattare con AdER: presentare istanza di rateazione straordinaria anche dopo il pignoramento. Spesso AdER, se concederà la dilazione, invierà una comunicazione alla banca di sospendere il pignoramento (c’è base normativa per ciò). Dovrai magari versare qualche rata subito.
- Come difesa legale: puoi fare opposizione all’esecuzione solo se ci sono vizi (ad es. cartella mai notificata, pignoramento eccedente i limiti – ma su conto aziendale i limiti non si applicano, riguardano persone fisiche). L’opposizione però non sospende automaticamente e potrebbe non fare in tempo.
- Valuta di tenere liquidità minima sui conti esposti: se prevedi problemi, alcuni spostano fondi su conti di terzi o altre forme. Occhio però: trasferimenti anomali possono essere revocabili o considerati dolosi se fatti per sfuggire a riscossione. Le società a volte cambiano banca o operano in contanti, ma ciò può avere altre controindicazioni legali/fiscali.
- In definitiva, la strada più efficace è prevenire: se sai di avere un debito e incassi su un certo conto, e non riesci a definire a breve, magari apri un altro conto su cui sposti le operazioni quotidiane (lasciando sul vecchio conto giusto il necessario). Così se pignorano quello noto, trovano poco. Attenzione però: AdER ha accesso all’Anagrafe conti, quindi sa tutti i conti intestati a te. Spostare su altro conto a te intestato non nasconde. Diverso è se utilizzi conti di terzi (ma ciò è sconsigliabile e potenzialmente illecito se serve a frodare i creditori).
- Infine, se l’azienda ha pagamenti da clienti in corso, AdER può pignorare anche quelli (notificando ai tuoi clienti di pagare a loro e non a te). Non comune, ma possibile. Anche qui, l’unico scudo è risolvere con rate o definizioni.
In sintesi: anticipa le mosse di AdER. Appena percepisci rischio, cerca accordo (rateazione), oppure riduci la giacenza sui conti noti. E ricorda che un pignoramento conto, se ti blocca operatività, è motivo per chiedere con urgenza al giudice tributario la sospensione (se avevi un ricorso pendente) mostrando che ti impedisce di pagare stipendi/tasse correnti: a volte può convincere il giudice a sospendere tutto.
D.9: Cosa succede se faccio finta di niente e non pago neanche dopo l’accertamento definitivo?
R: In assenza di qualsiasi tua reazione, lo scenario tipico è: trascorsi 60 giorni dall’accertamento esecutivo, il debito viene affidato all’Agente della Riscossione. Nei mesi successivi, l’AdER ti invierà probabilmente una comunicazione (come un sollecito cumulativo o un’intimazione di pagamento se è passato tempo) per rammentare il debito. Dopodiché, avvierà le procedure coattive descritte:
- Se possiedi un’auto/moto e il debito non è minuscolo, ti notificheranno un preavviso di fermo e poi bloccheranno il veicolo.
- Se hai immobili e il debito supera 20.000 €, ti notificheranno un preavviso di ipoteca e poi iscriveranno ipoteca sugli immobili.
- Contestualmente o in alternativa, pignoreranno il conto corrente e/o lo stipendio/pensione: quindi potresti trovarti il conto bancario bloccato e/o vedere decurtata una quota fissa dalle tue entrate mensili.
- Se il debito è molto elevato (oltre 120.000 €) e hai patrimonio immobiliare importante, a lungo termine (dopo almeno 6 mesi da ipoteca) potrebbero procedere con pignoramento immobiliare e mettere all’asta alcuni beni (salvo tua prima casa unica, che come detto è protetta dall’asta).
- Tutte queste azioni comportano aggravi di costi (compensi di riscossione, spese di procedura) che si aggiungono al debito. Inoltre, gli interessi di mora continuano a maturare.
- Nel frattempo, potresti ricevere divieti/limitazioni: ad esempio, se hai partita IVA, potresti trovarti iscritto a ruolo come inadempiente e ciò potrebbe precluderti certificazioni di regolarità fiscale (Durc fiscale) per appalti pubblici, rimborsi, ecc. Il tuo codice fiscale risulta con debiti a ruolo – questo non è pubblico, ma se chiedi rateizzazioni o simili, viene fuori.
In pratica, “fare finta di nulla” porta a un crescendo di provvedimenti: prima misure minori (solleciti), poi fermi/ipoteche (cautelari), infine pignoramenti (esecutivi) sui vari beni. Questo processo può svolgersi nell’arco di pochi mesi o anche anni, a discrezione di AdER e in base alla tua situazione (possono aspettare che il debito maturi con altri carichi o approfittare di quando individueranno liquidità). Quindi ignorare non fa sparire il problema, anzi lo aggrava. Spesso incontrerai difficoltà: conto bloccato all’improvviso, impossibilità di utilizzare l’auto, prelievo forzoso sullo stipendio. A quel punto sarai costretto comunque a intervenire (magari quando il conto è bloccato corri a rateizzare per sbloccarlo). Meglio agire prima: cercare di trovare un accordo (rate), o valutare procedure concorsuali se i debiti sono insostenibili. In ultima analisi, se sei nullatenente (niente redditi né beni) potresti resistere alle azioni (non possono prendere ciò che non hai), ma il debito rimarrebbe e con il tempo è difficile rimanere totalmente fuori dal sistema (basta un conto o un’auto e ti colpiscono). Senza contare che oltre certe soglie e casi, c’è il rischio penale (omesso versamento IVA >250k, ritenute >150k) indipendentemente dalla riscossione. Quindi ignorare può portare anche a denunce penali se rientri in quelle fattispecie (ad esempio, non pagare €300k di IVA dichiarata espone al reato ex art.10-ter D.Lgs.74/2000, punibile con reclusione, a prescindere dagli atti amministrativi). In sintesi: non pagare e sperare che cada nel dimenticatoio è un approccio sbagliato. Meglio affrontare attivamente la situazione, con gli strumenti legali a disposizione.
D.10: Posso sperare in qualche sanatoria o “rottamazione” del debito?
R: Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata dei debiti fiscali. Ad esempio:
- Le “rottamazioni delle cartelle” (definizione agevolata dei ruoli) nel 2016-2017 (rottamazione 1 e 2), nel 2018 (rottamazione-ter) e nel 2023 (rottamazione-quater) hanno permesso di pagare i carichi iscritti a ruolo (cartelle) senza sanzioni e interessi di mora, in forma dilazionata. Se il tuo debito rientrava in quelle edizioni e hai presentato domanda, potresti averne beneficiato. Ad esempio, la rottamazione-quater (L.197/2022) ha consentito di definire i ruoli 2000-2017 con stralcio totale di sanzioni e interessi, e i ruoli 2018-2020 pagando solo imposta + 5% di sanzioni interessi.
- Ci sono stati stralci automatici di mini debiti: nel 2021 sono stati annullati i ruoli fino a €5.000 risalenti agli anni 2000-2010 per contribuenti sotto certi redditi; nel 2023 sono stati stralciati i debiti fino a €1.000 affidati a ruolo prima del 2015.
- Per gli avvisi bonari non ancora a ruolo, la L.197/2022 ha previsto una definizione agevolata (c.d. “ravvedimento speciale”) pagando l’imposta + sanzioni ridotte a 1/18, entro 2023.
- Inoltre, la stessa legge ha introdotto la definizione delle liti pendenti: se hai un ricorso in corso, puoi chiuderlo pagando una percentuale del dovuto (da 100% a 5% a seconda se avevi vinto in primo/secondo grado).
- Guardando avanti, il governo periodicamente valuta sanatorie nelle Leggi di Bilancio. Aggiornato a luglio 2025, non c’è certezza di nuove rottamazioni imminenti, ma la tendenza storica mostra che ogni 4-5 anni qualche condono appare.
Se speri in una sanatoria, la strategia può essere: mantenere il debito “in vita” (non farlo diventare irreversibile, ad esempio presentando ricorso e prendendo tempo) finché non esce una norma di definizione. Ad esempio, chi aveva ricorso aperto ha potuto aderire alla definizione liti con sconti. Chi aveva cartelle non pagate ha aderito a rottamazione per togliere sanzioni. Attenzione: affidarsi solo a questa speranza è rischioso, perché potresti accumulare more e azioni esecutive nel frattempo. Comunque, se esce una rottamazione 2026 o simili, di solito conviene aderire perché abbatte sanzioni e interessi.
In conclusione, sì, c’è una possibilità ciclica di sanatorie fiscali, ma non sono garantite e hanno finestre temporali specifiche e condizioni. Meglio considerarle un bonus se capitano, ma nel frattempo gestire il debito come se dovessi pagarlo. Se appare un condono, allora approfittane subito. Ad esempio, se oggi hai cartelle in sospeso e uscisse “Rottamazione-quinto”, presentando domanda potresti pagare solo il tributo senza sanzione. Tieni d’occhio le Leggi di Bilancio e decreti fiscali di fine anno, dove tipicamente compaiono queste norme.
D.11: Cosa devo fare se ricevo un preavviso di fermo o ipoteca?
R: Un preavviso di fermo ti informa che tra 30 giorni il tuo veicolo sarà bloccato se non paghi il debito indicato. Un preavviso di ipoteca avvisa che tra 30 giorni sarà iscritta ipoteca sugli immobili elencati. In entrambi i casi, hai quelle settimane di tempo per agire:
- Controlla se l’importo del debito indicato è corretto e se sono stati notificati gli atti presupposti (cartelle, avvisi) regolarmente. Se noti errori (debito già pagato, atto mai notificato, ecc.), puoi presentare istanza di sospensione/correzione all’AdER e contestualmente valutare un ricorso al giudice tributario per far sospendere l’azione (il preavviso di fermo è impugnabile subito, idem il preavviso d’ipoteca).
- Se il debito è effettivamente dovuto, approfitta del preavviso per cercare una soluzione: ad esempio chiedi una rateizzazione all’AdER. Se la ottieni entro i 30 giorni, il fermo/ipoteca non verranno eseguiti. Anche pagare integralmente ovviamente evita la misura. Fai attenzione alle soglie: se il debito totale è < €1.000, in realtà non dovrebbero fare il fermo (potresti ricordarglielo nella risposta); se < €20.000, non possono ipotecare (se ti hanno mandato preavviso ipoteca per 15k, è illegittimo, segnalalo e impugna se necessario).
- Se il veicolo ti serve per lavoro ed è l’unico strumento, rispondi al preavviso di fermo dichiarando la strumentalità del mezzo (allega documenti: visura che l’auto è aziendale o affermando che la usi esclusivamente per lavoro). Spesso questo evita il fermo su quell’auto specifica (magari lo sposteranno su altro bene se c’è).
- In ogni caso, non ignorare: se lasci decorrere i 30 giorni senza fare nulla, il fermo o l’ipoteca saranno iscritti trascorso quel termine. Dopo, rimuoverli sarà più macchinoso (dovrai pagare o ricorrere con atti già compiuti).
- Se pensi di vendere l’auto o casa per pagare i debiti, il preavviso è segnalato nei registri? Non ancora: il preavviso di fermo non è pubblicità legale, e il preavviso di ipoteca neppure. Però sappi che vendere l’auto dopo aver ricevuto preavviso può configurare tentativo di sottrazione (difficile per un’auto, ma in teoria se la vendi a un familiare per non farla fermare…). Meglio risolvere col creditore. Per la casa, vendere dopo preavviso ipoteca è possibile (poiché ipoteca non è ancora iscritta, l’acquirente formalmente prenderebbe bene libero), ma anche qui c’è il rischio di contestazioni ex art.11 D.Lgs.74/2000 se fatto per frodare il Fisco. Quindi sconsigliato senza accordo col Fisco (e l’acquirente serio vorrà che tu sistemi il debito prima).
In sintesi, usate quei 30 giorni saggiamente: pagate, rateizzate o impugnate. È un’ultima chiamata prima della “sanzione patrimoniale”.
D.12: Dopo quanti mesi/anni dall’omesso pagamento arriva la cartella o l’accertamento?
R: Non c’è un tempo fisso per tutti i casi, ma possiamo delineare tempistiche comuni:
- Per i controlli automatizzati (imposte dichiarate e non versate) spesso l’Agenzia invia l’avviso bonario entro 6-12 mesi dalla scadenza. Ad esempio, se non paghi il saldo IRPEF di giugno, potresti ricevere comunicazione di irregolarità tra l’autunno dello stesso anno e la primavera dell’anno seguente. Se non paghi il bonario, la cartella (o l’accertamento esecutivo) viene emessa di solito l’anno successivo. Comunque, per legge, la cartella da controllo aut. deve arrivare entro il 3° anno successivo alla dichiarazione. Esempio pratico: saldo IRPEF 2019 non pagato – comunicazione entro 2021, cartella entro fine 2022. Nel periodo Covid alcune sono slittate al 2023.
- Per le ritenute non versate (da CU e 770), similmente: l’incrocio può generare un avviso bonario entro un annetto dalla scadenza annuale, e poi cartella.
- Se l’ufficio opta per saltare il bonario e fare direttamente un avviso di accertamento esecutivo, in genere lo fa comunque entro 2-3 anni dal fatto. Ad esempio, contributo omesso nel 2022, avviso entro 2024-2025. Il termine ultimo è sempre la decadenza quinquennale, ma in tanti casi agiscono prima.
- Una volta formatasi la cartella o l’accertamento esecutivo, la palla passa ad AdER. AdER tipicamente non agisce immediatamente allo scadere dei 60 giorni, ma segue le sue scadenze di lavorazione e priorità. Può inviarti un primo sollecito anche dopo 4-6 mesi. Le azioni esecutive in senso stretto (fermi, pignoramenti) possono partire da pochi mesi dopo la scadenza fino a qualche anno. Molto dipende dall’importo (debiti piccoli vengono spesso tenuti in stand-by a spera che arrivino condoni, ecc., debiti grandi sono attenzionati prima) e dalla disponibilità di informazioni (se sanno che hai stipendio e conto, magari procedono presto sul conto, se non trovano niente, aspettano).
- C’è anche da dire che tra 2020 e 2021 c’è stata una sospensione generalizzata della riscossione per la pandemia; dopodiché AdER dal 2022 ha ripreso a inviare milioni di atti. Quindi se il tuo omesso pagamento è di anni recenti, potresti risentire di backlog: es. gente che non ha pagato nel 2018 ha ricevuto cartella solo nel 2021-22 per via dei rinvii.
- Dunque, non c’è una regola fissa se non il termine di decadenza come limite massimo.
In pratica molti contribuenti riferiscono: “dimenticato F24 a giugno, ad ottobre mi è arrivato l’avviso bonario; non l’ho pagato, a marzo successivo mi è arrivata la cartella”. Oppure: “dopo 2 anni mi è arrivato direttamente l’avviso di accertamento con intimazione”. Se non arriva nulla per più di 3-4 anni, può darsi che l’ufficio abbia trascurato (e ciò giocherebbe a tuo favore per la decadenza). Ricorda però che in caso di dichiarazione infedele o omessa, i termini sono più lunghi (5 o 7 anni), quindi potresti veder arrivare atti anche tardivi.
D.13: Perché devo pagare le sanzioni se in fondo ho solo pagato in ritardo quello che comunque era dovuto? Non c’è modo di farmele togliere del tutto?
R: Le sanzioni per tardivo/omesso versamento hanno natura punitiva-deterrente: servono a far rispettare le scadenze fiscali. Dal tuo punto di vista, può sembrare un aggravio ingiusto (“non ho rubato, ho solo ritardato”), ma il legislatore le ritiene necessarie per evitare che tutti ritardino i pagamenti (ottenendo così un credito di fatto senza interessi). Le vie per non pagarle o ridurle sono:
- Ravvedimento operoso: se agisci spontaneamente prima che il Fisco contesti, la sanzione scende enormemente (anche all’1,67% o 3,75% a seconda del ritardo) e in alcuni casi con ravvedimento speciale era anche meno. Quindi la scelta migliore è sempre ravvedersi appena possibile.
- Adesione/acquiescenza: se arriva l’atto ufficiale, pagare subito dà lo sconto 2/3 (paghi solo 1/3 sanzione).
- Definizioni agevolate: condoni/rottamazioni spesso abbuonano le sanzioni interamente (paghi solo la tassa). Queste però dipendono da leggi straordinarie.
- Ricorso: il giudice tributario non può disapplicare la legge per bontà sua. Però può annullare le sanzioni se trova un motivo giuridico (es. errore scusabile, forza maggiore, vizio formale, ecc.). Può anche, in sede di merito, applicare l’art.7 D.Lgs.472/97 e ridurre la sanzione se ritiene la misura eccessiva rispetto alle circostanze, ma essendo la sanzione minima fissata per legge al 30%, c’è dibattito se il giudice possa scendere sotto. In genere, senza una causa giuridica, no.
- Autotutela dell’ufficio: in casi estremi (es. calamità naturali in cui hanno poi sospeso i termini, ecc.), l’ente creditore può decidere di annullare o ridurre sanzioni. Ma è raro e su direttive centrali.
- Sgravio per forza maggiore: come detto, se provi di essere stato oggettivamente impossibilitato a versare (caso limite), potresti convincere il giudice ad annullare la sanzione per mancanza di colpa.
Quindi, tolte situazioni speciali, un minimo di sanzione dovrai quasi sempre pagarlo. Almeno l’1/10 (ravvedimento brevissimo) o 1/3 (adesione) come previsto dalla legge. Totalmente zero si può ottenere solo se proprio dimostri che non avevi alcuna volontà/colpa (es. eri in coma durante la scadenza e nessuno poteva provvedere – casi rarissimi).
Può sembrare duro, ma il sistema è concepito così: chi paga in ritardo paga pegno. D’altronde, pensa se non ci fossero sanzioni: molti farebbero i furbi a pagare quando capita, tanto male che va c’è solo interesse legale. Invece con il 30% in agguato, conviene indebitarsi con la banca piuttosto che col Fisco. Questo in teoria… poi la realtà è che tante PMI, pressate da mille costi, finivano per omettere versamenti contributivi e IVA per sopravvivere, e infatti il legislatore ha alzato soglie penali e introdotto definizioni per dare respiro. Ma l’impianto sanzionatorio resta.
Questa sezione FAQ ha toccato molte questioni pratiche. Si chiude così la nostra guida. In conclusione, dal punto di vista del debitore di fronte a un avviso di accertamento per omesso/tardivo versamento, il consiglio generale è: essere proattivi e informati. Conoscere i propri diritti (termini, limiti alle azioni, possibilità di riduzione sanzioni) aiuta a prendere le decisioni giuste, che sia pagare, rateizzare o ricorrere. Non aspettare passivamente l’aggravarsi della situazione: se il debito è legittimo ma non hai liquidità, chiedi una dilazione; se ritieni il debito non dovuto, impugna entro i termini; se ricevi atti esecutivi, reagisci subito (non c’è spazio per “guadagnare tempo” oltre certi limiti).
Affrontare questi problemi può essere complesso, quindi fatti assistere da professionisti: avvocati tributaristi sanno come contestare gli atti o negoziare con AdER, e commercialisti sanno valutare se le pretese sono corrette. Anche rivolgersi agli uffici dell’Agenzia può talvolta portare a soluzioni (alcuni errori si risolvono con una semplice segnalazione). In ultima analisi, il sistema tributario italiano, pur rigido nelle regole, offre vari strumenti al contribuente per difendersi e diluire l’impatto dei debiti fiscali: sta a noi utilizzarli con tempestività e cognizione di causa.
Fonti utilizzate e riferimenti normativi
Legge 130/2022: riforma giustizia tributaria (rinomina Commissioni in Corti Giustizia Trib., giudice monocratico <€3k, testimonianza scritta ammessa, reclamo-mediazione non obbligatorio dal 16/9/2022, sospensiva in 30gg).
Normativa:
D.P.R. 29/09/1973 n.602: Artt. 50 (intimazione 5gg oltre 1 anno), 72-bis (pignoramento presso terzi semplificato), 72-ter (limiti pignorabilità stipendio/pensione), 76 (limiti espropriazione immobiliare: soglia €120k, impignorabilità abitazione principale), 77 (ipoteca: soglia €20k), 86 (fermo amministrativo).
D.Lgs. 18/12/1997 n.471: Art. 13 (sanzioni omesso/tardivo versamento: 15% entro 90gg, 30% oltre 90gg).
D.Lgs. 18/12/1997 n.472: Art. 6, c.5 (non punibilità per forza maggiore); Art. 12 (cumulo giuridico sanzioni, co.5 violazioni stessa indole in più periodi d’imposta); Art. 7 (criterio del favor rei e frazionamenti ravvedimento).
D.Lgs. 31/12/1992 n.546: Art. 19 (atti impugnabili: avviso accertamento, cartella, fermo, ipoteca…), Art. 21 (60gg per ricorso), Art. 47 (sospensione dell’atto impugnato: ridotto termine decisione 30gg dal 2022); Art. 68 (pagamento frazionato in pendenza di giudizio: 1/3 dopo primo grado, ecc.).
Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente): Art. 7 (obbligo di motivazione e indicazione responsabile procedimento); Art. 6, c.5 (comunicazione esiti controlli automatici, avvisi bonari; e forza maggiore ripresa da D.Lgs.472).
Avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento? Fatti Difendere da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché non hai versato un’imposta, l’hai versata in ritardo o solo in parte?
Ti contestano sanzioni elevate, interessi e imposte ancora dovute?
L’omesso, parziale o tardivo versamento di imposte è una delle contestazioni più comuni, ma non sempre è corretta o fondata. In molti casi si tratta di errori materiali, F24 non contabilizzati o pagamenti respinti. Con l’assistenza giusta puoi difenderti e ridurre le sanzioni.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Verifica l’effettivo avvenuto pagamento o la reale omissione contestata
- 📌 Controlla eventuali errori formali nei versamenti o nei codici tributo usati
- ✍️ Redige memorie difensive, istanze in autotutela o ricorso tributario
- ⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia e, se necessario, davanti alla Commissione Tributaria
- 🔁 Ti assiste nel ravvedimento operoso o nella richiesta di rateizzazione delle somme dovute
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e regolarizzazioni fiscali
- ✔️ Specializzato in difesa da avvisi per omessi versamenti e sanzioni collegate
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Un avviso per omesso, parziale o tardivo versamento non va ignorato, ma può essere contestato, spiegato o sanato, evitando sanzioni e iscrizioni a ruolo.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa fiscale comincia da qui.