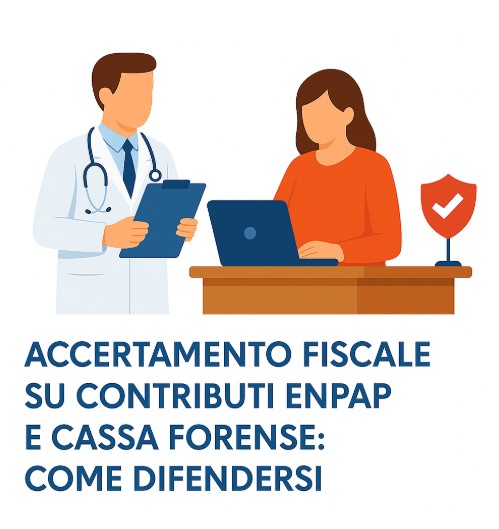Hai ricevuto un accertamento fiscale su contributi versati all’ENPAP, alla Cassa Forense o a un’altra cassa previdenziale professionale? L’Agenzia delle Entrate ti contesta la deducibilità dei contributi o ti accusa di non averli dichiarati correttamente? In questi casi è importante sapere cosa può effettivamente essere contestato, quali sono i tuoi diritti e come puoi difenderti.
Quando può scattare un accertamento sui contributi previdenziali?
– Se hai dedotto i contributi in modo errato nella dichiarazione dei redditi
– Se l’Agenzia rileva che hai portato in deduzione contributi non obbligatori
– Se hai omesso di dichiarare contributi ricevuti a rimborso
– Se hai ricevuto compensi professionali su cui non risulta il versamento dei contributi
– Se hai dichiarato contributi doppi o versati in anni diversi da quelli indicati
Cosa può contestare il Fisco?
– Che hai dedotto contributi non obbligatori (es. facoltativi, volontari o integrativi)
– Che hai portato in deduzione contributi già dedotti in altri periodi d’imposta
– Che hai dedotto contributi non effettivamente versati entro il termine previsto
– Che hai dedotto importi eccedenti rispetto a quelli consentiti dalla legge
– Che non hai dichiarato nel quadro RR o RE i dati richiesti per il corretto calcolo contributivo
Come difendersi da un accertamento su ENPAP, Cassa Forense o altre casse?
– Recupera le ricevute di pagamento, MAV, F24 o estratti conto previdenziali
– Verifica se i contributi sono obbligatori, facoltativi o misti
– Dimostra, con la documentazione, che l’importo dedotto è stato effettivamente versato e nel periodo corretto
– Controlla se l’importo è stato riportato nella sezione giusta della dichiarazione (quadro RP, RE, RR o LM)
– Se c’è un errore formale, valuta se puoi ancora ravvederti con una dichiarazione integrativa
– Se l’accertamento è fondato su presunzioni o calcoli errati, presenta memorie difensive o ricorso tributario
Cosa puoi ottenere con la giusta difesa?
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento, se i contributi sono legittimi
– La riclassificazione dei contributi da non deducibili a deducibili
– L’esclusione di sanzioni, se dimostri buona fede o errore materiale
– La possibilità di regolarizzare spontaneamente, se ancora nei termini
Attenzione: i contributi previdenziali obbligatori versati alle casse professionali sono deducibili integralmente, ma solo se effettivamente versati e indicati correttamente. Un errore nella compilazione può portare a contestazioni fiscali gravi, ma difenderti è possibile.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa dei liberi professionisti ti spiega come reagire a un accertamento su contributi ENPAP, Cassa Forense, o altre casse, cosa verificare e come tutelarti legalmente.
Hai ricevuto una contestazione su contributi previdenziali dedotti in dichiarazione? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso e ti diremo come difendere le tue deduzioni e rispondere all’accertamento senza errori.
Introduzione
L’accertamento fiscale relativo ai contributi previdenziali dovuti alle casse professionali – in particolare ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) e Cassa Forense (cassa previdenziale degli avvocati) – è un tema di grande attualità e importanza. Negli ultimi anni, l’interazione tra fisco e previdenza privata si è intensificata: l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati delle dichiarazioni dei redditi con quelli comunicati (o non comunicati) agli enti previdenziali, segnalando eventuali discrepanze. Ciò può dar luogo a accertamenti e richieste di pagamento sia in ambito tributario (maggiori imposte dovute per deduzioni non spettanti o redditi non dichiarati) sia in ambito previdenziale (contributi ENPAP o Cassa Forense non versati).
Questa guida – aggiornata a luglio 2025 – fornisce un’analisi approfondita di come difendersi da tali accertamenti, dal punto di vista del debitore (il professionista tenuto al versamento). Utilizzeremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, adatto sia ai professionisti del diritto (avvocati, consulenti) sia ai privati e imprenditori interessati. Verranno esaminate tutte le tipologie di accertamento rilevanti, inclusi gli aspetti penali eventualmente connessi, e l’interazione tra il contenzioso tributario e quello previdenziale. In appendice troverete un elenco delle fonti normative e giurisprudenziali citate, incluse le più recenti sentenze di Cassazione (e, ove significativo, pronunce di merito di Commissioni Tributarie e Tribunali).
Struttureremo la trattazione in sezioni tematiche, con tabelle riepilogative dei punti chiave e un formato domande e risposte per chiarire i dubbi più frequenti. Saranno proposte anche simulazioni pratiche, cioè esempi di casi concreti e possibili strategie difensive, sempre riferite al contesto italiano. L’obiettivo è offrire una panoramica completa e avanzata, che metta in grado il lettore di orientarsi nella materia complessa degli accertamenti fiscali e previdenziali sui contributi dovuti alle casse professionali, e di individuare gli strumenti di tutela più efficaci.
Le casse previdenziali professionali: Cassa Forense ed ENPAP
Prima di addentrarci negli accertamenti, è utile inquadrare brevemente cosa sono e come funzionano i contributi dovuti alle casse previdenziali professionali nel nostro ordinamento, concentrandoci su Cassa Forense ed ENPAP.
Cassa Forense è la cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati, regolata originariamente dalla Legge n.576/1980 (riformata poi dalla Legge n.247/2012). L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione in modo effettivo e continuativo. Anche il solo possesso del titolo di avvocato e l’iscrizione all’albo, con contemporaneo esercizio di attività professionale autonoma, fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Cassa – a nulla rilevando che il soggetto svolga anche un lavoro da dipendente. In pratica, se un avvocato ha redditi derivanti da attività legale (anche saltuaria), è tenuto a iscriversi e versare i contributi previdenziali alla Cassa Forense, anche qualora sia contemporaneamente lavoratore subordinato altrove. L’obbligo contributivo scatta in presenza di reddito professionale di qualsiasi entità, salvo alcune esenzioni temporanee previste per legge (ad esempio, nei primi anni di attività sotto una certa soglia di reddito).
ENPAP è l’ente previdenziale dei professionisti psicologi (istituito ai sensi del D.Lgs. 103/1996). Analogamente, sono obbligatoriamente iscritti ad ENPAP tutti gli psicologi iscritti all’albo che esercitino attività libero-professionale, anche se contestualmente lavorano come dipendenti. L’obbligo non si limita ai titolari di partita IVA: anche lo psicologo che svolge prestazioni autonome occasionali (ad es. come co.co.co.) deve iscriversi e versare ad ENPAP i relativi contributi previdenziali.
Tipologie di contributi dovuti: sia Cassa Forense che ENPAP prevedono diverse categorie di contributo:
- un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF (cioè il reddito derivante dall’esercizio della professione, al netto delle spese deducibili). Ad esempio, per gli avvocati il contributo soggettivo è fissato in una percentuale (variabile nel tempo, recentemente intorno al 14%) del reddito professionale IRPEF dichiarato, con un minimo obbligatorio annuale (dovuto anche in assenza di reddito o con reddito bassissimo). Per gli psicologi ENPAP, il contributo soggettivo è pari al 10% del reddito professionale netto, anch’esso con un minimo annuale da versare.
- un contributo integrativo calcolato sul volume d’affari IVA (fatturato) e tipicamente addebitato al cliente in aggiunta alla parcella. Nel caso degli avvocati, si tratta del 4% indicato in fattura (rivalsa previdenziale) da versare alla Cassa Forense. Anche per gli psicologi è previsto un contributo integrativo (nella misura del 2% o 4% a seconda delle norme ENPAP). Importante: il contributo integrativo, essendo scaricato sull’utente finale (cliente), non incide sul reddito imponibile del professionista; di conseguenza non è deducibile dal reddito ai fini IRPEF.
- un contributo di maternità o di solidarietà, generalmente di importo fisso annuale, dovuto da tutti gli iscritti indipendentemente dal reddito, destinato a finanziare indennità di maternità/paternità o altre prestazioni assistenziali della cassa. Ad esempio, Cassa Forense richiede un contributo maternità (circa €70–€80 annui negli ultimi anni).
Oltre a questi, le casse possono prevedere contributi volontari (es. contributo modulare volontario per incrementare la pensione, riscatti di laurea, ricongiunzioni di periodi assicurativi). Tali versamenti facoltativi sono anch’essi deducibili dal reddito ai fini fiscali, tranne diversa indicazione per chi si trova in regimi fiscali agevolati (vedi oltre).
Regime fiscale dei contributi: i contributi previdenziali obbligatori versati alle casse professionali sono integralmente deducibili dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR (DPR 917/1986). Ciò vale sia per i contributi obbligatori (soggettivo, maternità, integrativo minimo se dovuto) sia per gli eventuali contributi volontari versati per incrementare la posizione previdenziale (riscatti laurea, retrodatazioni, ecc.). L’ordinamento incentiva quindi il versamento regolare dei contributi, riconoscendo un beneficio fiscale: ogni euro versato alla cassa riduce il reddito imponibile (fatta eccezione per il contributo integrativo, come sopra detto). Si noti che tale deducibilità opera in base al principio di cassa: conta il periodo d’imposta in cui il contributo è effettivamente pagato. Ad esempio, i contributi 2024 versati entro il 31 dicembre 2024 saranno deducibili dal reddito 2024 (dichiarazione 2025); se versati in ritardo nel 2025, potranno essere dedotti solo nel periodo d’imposta 2025.
Caso particolare – Regime forfettario: i professionisti in regime fiscale forfettario (o flat tax) beneficiano anch’essi della deduzione dei contributi, ma con modalità diverse. Nel quadro LM della dichiarazione dei redditi, il reddito forfettario (calcolato applicando al fatturato il coefficiente di redditività) può essere abbattuto dai soli contributi obbligatori versati nell’anno. I contributi volontari facoltativi non riducono il reddito forfettario, e possono eventualmente essere dedotti a parte nel rigo degli oneri deducibili solo se c’è capienza di altri redditi tassati ordinariamente. Inoltre, se i contributi obbligatori eccedono il reddito forfettario (caso non infrequente per redditi molto bassi), l’eccedenza deducibile può essere riportata solo nel rigo RP (oneri deducibili da reddito complessivo) ma ciò richiede la presenza di redditi imponibili IRPEF ordinari. In sintesi, un professionista in regime forfettario che abbia unicamente reddito forfettario non trae beneficio fiscale da contributi versati oltre il limite del suo reddito determinato forfettariamente. Ad esempio, un giovane avvocato forfettario con €5.000 di reddito imponibile forfettario e €3.800 di contributi versati, potrà dedurre solo €5.000 – il reddito sarà abbattuto interamente a zero, ma i restanti €800 di contributi non daranno luogo ad un “bonus” o credito d’imposta.
È utile tenere a mente queste regole fiscali perché molti accertamenti nascono proprio da errori o comportamenti riguardanti la deduzione dei contributi o la mancata corrispondenza tra reddito dichiarato al fisco e reddito comunicato alla cassa. Di seguito vedremo i principali casi.
Tipologie di accertamento fiscale sui contributi previdenziali
Quando parliamo di “accertamento fiscale sui contributi” possiamo riferirci a diverse ipotesi, accomunate dal fatto che vi è un controllo e una pretesa di pagamento collegata a contributi previdenziali obbligatori. Possiamo distinguere due macro-categorie: (A) gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate in ambito tributario, che possono avere riflessi sui contributi; (B) gli accertamenti (o verifiche) degli enti previdenziali privatizzati stessi (ENPAP, Cassa Forense), volti a recuperare contributi non dichiarati o non versati. Esaminiamo separatamente le due categorie, tenendo presente però che spesso sono intrecciate.
A. Accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e riflessi sui contributi
L’Amministrazione finanziaria effettua ordinariamente controlli sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, segnalando difformità o incongruenze. Nel contesto che ci occupa, gli accertamenti fiscali possono riguardare due situazioni principali: (1) indebite deduzioni o errori relativi ai contributi previdenziali nella dichiarazione dei redditi; (2) omissione o sotto-dichiarazione di redditi professionali, con conseguente evasione sia di imposte sia di contributi.
(1) Accertamenti per indebita deduzione di contributi: trattandosi di oneri deducibili, i contributi previdenziali possono essere oggetto di verifica. Un caso tipico è la deduzione di contributi non versati. Ad esempio, un avvocato potrebbe aver portato in deduzione nella dichiarazione dei redditi un importo di contributi dovuti ma che in realtà non ha versato entro l’anno (violando il principio di cassa). In un controllo formale, l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati dei versamenti effettuati alle casse (spesso comunicati dagli enti stessi o rilevabili dalle ricevute) e, se scopre che l’importo dedotto non risulta pagato nell’anno di riferimento, emette un avviso di accertamento recuperando la maggiore imposta dovuta. In pratica, l’importo indebitamente dedotto viene riaggiunto al reddito imponibile IRPEF e tassato, con sanzioni e interessi. Come difendersi? In questi casi la difesa nel merito è difficile se effettivamente il pagamento non è avvenuto: la norma prevede la deducibilità solo per contributi effettivamente versati. Tuttavia, il contribuente potrà verificare se magari il versamento è avvenuto entro i termini di presentazione della dichiarazione (caso in cui, in sede di dichiarazione integrativa, si potrebbe rimediare) oppure se c’è stato un errore di imputazione. Diversamente, ci si può concentrare su aspetti procedurali: ad esempio controllare che l’avviso di accertamento sia stato correttamente notificato, motivato e emesso entro i termini di decadenza previsti (di norma il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Nel prosieguo parleremo dei termini e decadenze, rilevanti anche per i contributi.
Un’altra ipotesi è la deduzione di somme non deducibili per legge: ricordiamo ad esempio che il contributo integrativo non è deducibile. Se un professionista, per errore, include anche il 4% integrativo fra gli oneri deducibili, il controllo fiscale rettificherà la dichiarazione, con recupero d’imposta. Anche qui, essendo una violazione oggettiva, l’unica difesa possibile è eventualmente dimostrare che la somma in questione non fosse un contributo integrativo, oppure che sia già stata tassata altrove (ma trattandosi di spese dedotte, questo scenario non si presenta). In genere, per errori del genere conviene valutare il ravvedimento operoso (correzione spontanea) appena ci si accorge dell’errore, per ridurre sanzioni, piuttosto che attendere l’accertamento.
(2) Accertamenti per redditi non dichiarati (evasione fiscale): qui l’Agenzia delle Entrate contesta al professionista un maggior reddito professionale rispetto al dichiarato. Questo può avvenire con vari metodi di accertamento: analitico (singoli ricavi non fatturati scoperti, ad esempio tramite verifica bancaria), induttivo (gravi irregolarità contabili che portano a stimare forfettariamente i ricavi) o sintetico (redditometro, ossia stima del reddito in base alle spese sostenute). Qualunque sia la tecnica, se l’esito è un maggior reddito accertato, scattano due conseguenze: da un lato, il professionista deve pagare le maggiori imposte (IRPEF, addizionali, IVA se pertinente); dall’altro, essendo emerso un reddito professionale sul quale non sono stati versati contributi, l’ente previdenziale competente (ENPAP o Cassa Forense) vorrà recuperare i contributi dovuti su quel reddito.
La procedura prevede un coordinamento tra fisco e ente previdenziale: una volta divenuto definitivo l’accertamento fiscale, l’Agenzia Entrate trasmette gli esiti all’ente previdenziale, che procede a ricalcolare i contributi dovuti. In realtà, l’invio può avvenire anche prima della definitività: per legge l’Agenzia è tenuta a comunicare all’INPS gli accertamenti che incidono sul reddito imponibile contributivo (la norma citata in materia è l’art. 1, comma 1, D.L. 78/2010, applicata in generale ai lavoratori autonomi). Ad esempio, se Tizio (psicologo) aveva dichiarato €20.000 di reddito e ne vengono accertati €30.000, l’ENPAP, venutone a conoscenza, emetterà un avviso di addebito o iscriverà a ruolo i contributi sulla differenza (€10.000) al netto di quanto eventualmente già pagato, più sanzioni e interessi.
Tabella – Esempio di accertamento fiscale con riflessi previdenziali:
Dati: Caio, avvocato, dichiara reddito 2020 di €50.000. In seguito a verifica bancaria, nel 2023 l’Agenzia scopre compensi non dichiarati per €20.000. Emette accertamento per maggior IRPEF su €20.000.
Effetti fiscali: Caio paga le imposte evase (circa €6.600 tra IRPEF 43% e addizionali) + sanzioni tributarie (normalmente 90% dell’imposta evasa) + interessi.
Effetti previdenziali: L’Agenzia comunica l’esito alla Cassa Forense. Caio avrebbe dovuto versare su quei €20.000 ulteriori contributi soggettivi (14% ≈ €2.800) e integrativi (4% ≈ €800) nel 2021. La Cassa procederà a richiedergli €2.800 di contributi soggettivi evasi (il 4% integrativo, essendo rivalsa, di solito viene richiesto al cliente in fattura; se Caio non l’ha addebitato allora, la Cassa può comunque esigere il minimo integrativo dovuto). A tali contributi si applicano sanzioni (vedremo oltre: ad es. sanzione del 30% se adesione, oppure ordinaria più alta se accertamento contestato) e interessi di mora dal 2021. Caio riceverà dunque un avviso di pagamento dall’Agente della Riscossione o un decreto ingiuntivo dalla Cassa per l’importo previdenziale. Dovrà pagarlo oppure opporsi davanti al giudice del lavoro.
Notiamo quindi che l’accertamento fiscale può far scattare un “doppio binario” di contenzioso: tributario per le imposte e previdenziale per i contributi. Approfondiremo in seguito come si coordinano questi due piani (ad esempio, cosa accade se si impugna l’accertamento fiscale: l’ente previdenziale può riscuotere nel frattempo?).
B. Accertamenti degli enti previdenziali (Cassa Forense, ENPAP)
Indipendentemente dall’intervento del fisco, le casse professionali svolgono autonomamente attività di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte dei propri iscritti. In particolare:
- Cassa Forense richiede ogni anno agli avvocati di compilare e inviare il Modello 5, ossia la comunicazione obbligatoria dei redditi professionali IRPEF e del volume d’affari IVA relativi all’anno precedente. Su tale base, la Cassa calcola i contributi dovuti (oltre ai minimi già eventualmente pagati) e verifica la corrispondenza con quanto dichiarato al fisco. Se l’avvocato omette di inviare il Mod. 5 o lo invia indicando redditi inferiori a quelli dichiarati al fisco, la Cassa può attivare un procedimento di accertamento contributivo. Dal 2021 il nuovo Regolamento Unico della previdenza forense (art. 63) prevede che, in caso di mancato adempimento dichiarativo, l’ufficio della Cassa invii all’iscritto una lettera di contestazione (raccomandata A/R all’ultimo domicilio professionale noto) invitandolo a regolarizzare. Se l’iscritto non risponde o non sana la situazione, la Cassa procederà con un accertamento formale e l’irrogazione di sanzioni amministrative. In passato, prima di questa formalizzazione regolamentare, la giurisprudenza aveva già affermato che la Cassa Forense, in quanto ente che irroga sanzioni per omessa dichiarazione, deve seguire la procedura della Legge n.689/1981, la quale richiede la preventiva contestazione dell’addebito all’interessato (artt. 13 e 14 L.689/81). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9310/2022, ha confermato che una cartella esattoriale emessa dalla Cassa per sanzioni da omessa comunicazione è invalida se non preceduta dalla contestazione all’iscritto. Dunque, un avvocato che si veda recapitare direttamente una cartella per contributi e relative sanzioni da omessa dichiarazione, senza aver prima ricevuto alcuna comunicazione, potrà far valere tale vizio nel ricorso (vedi oltre, sezioni difensive).
- ENPAP analogamente richiede agli psicologi iscritti di dichiarare annualmente il reddito professionale (tramite un modello online). In caso di omissione o discrepanza con i dati fiscali, ENPAP attiverà un accertamento. Spesso l’ente invia un sollecito bonario o un preavviso di addebito, dopodiché può procedere o con l’iscrizione a ruolo delle somme dovute (e l’emissione di una cartella esattoriale tramite Agenzia Entrate-Riscossione) oppure, talvolta, direttamente con un ricorso per decreto ingiuntivo avanti al tribunale civile (sezione lavoro) per ottenere un titolo esecutivo. Entrambe le strade sono consentite dalla legge. Nel caso ENPAP, è frequente l’uso del ruolo esattoriale; tuttavia, la pronuncia del Tribunale di Tivoli n.563/2021 ci offre un esempio di opposizione a decreto ingiuntivo ENPAP. In quella vicenda, ENPAP aveva agito in via monitoria per recuperare contributi relativi a vari anni, basandosi sui redditi auto-dichiarati dal professionista (che poi non aveva versato quanto dovuto). Il professionista si era opposto contestando tra l’altro la prescrizione per gli anni più remoti. Il Tribunale gli ha dato parzialmente ragione, ritenendo che alcune lettere inviate dall’ENPAP non avessero interrotto la prescrizione perché spedite a un vecchio indirizzo, e ha quindi dichiarato prescritti i crediti contributivi anteriori al quinquennio precedente all’unica lettera valida. Ciò ha comportato lo sgravio di parte delle somme e la revoca parziale del decreto ingiuntivo.
Dall’esempio emerge che le casse possono attingere ai dati fiscali per effettuare controlli. In particolare, Cassa Forense (ente privatizzato ex D.Lgs. 509/94) ha facoltà per legge di richiedere “in ogni momento” ai competenti uffici fiscali le informazioni sulle dichiarazioni dei redditi e IVA dei propri iscritti. Lo ha ribadito la Cassazione: i dati acquisiti dal fisco possono essere legittimamente utilizzati in qualsiasi momento e posti a base delle cartelle per recuperare i contributi dovuti e non versati, al posto dei dati omessi dall’iscritto. Questo significa che anche a distanza di molti anni, se la Cassa scopre (per es. incrociando archivi) che un iscritto nel 2015 non comunicò nulla ma dal fisco risultava un reddito, potrà emettere cartella per i contributi 2015 non pagati. Come vedremo però, subentra il limite della prescrizione, salvo il caso di omessa dichiarazione che sospende il decorso (ne parliamo a breve).
Sanzioni e interessi: quando l’ente previdenziale accerta un’omissione contributiva, usualmente oltre alla somma capitale (contributi evasi) vengono richiesti:
- Interessi di mora: calcolati dal giorno in cui il contributo sarebbe stato dovuto (ad es., 31 dicembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito) fino al pagamento. Il tasso è spesso quello legale o un tasso stabilito dai regolamenti della Cassa. Ad esempio ENPAP applica interessi per ritardato pagamento; Cassa Forense pure (storicamente, tasso legale o di poco superiore).
- Sanzioni amministrative: distinte dagli interessi, rappresentano una “multa” per l’inadempimento. La disciplina è nei regolamenti interni ma deve rispettare i principi della L.689/81 (sanzioni civili amministrative). Per omessa o infedele comunicazione reddituale, Cassa Forense prevedeva una sanzione fissa (es: € 500) poi modificata in importi diversificati; dal 2021 le sanzioni sono state armonizzate e ridotte se l’iscritto si attiva spontaneamente. Ad esempio, se l’avvocato invia il Mod.5 in ritardo di pochi mesi, la sanzione può essere ridotta (una frazione del contributo minimo). Se la comunicazione manca del tutto finché la Cassa non la contesta, la sanzione piena può essere qualche centinaio di euro. Discorso diverso per le sanzioni sui contributi non versati: solitamente sono percentuali dell’importo evaso. Cassa Forense, ad esempio, prevede che se l’iscritto aderisce all’accertamento comunicato dalla Cassa e paga i contributi dovuti, la sanzione è ridotta al 30% dei contributi non versati. Ciò somiglia all’“accertamento con adesione” del fisco: collaborazione premiata con sanzione ridotta. Viceversa, se l’iscritto non aderisce e si arriva a cartella o causa, la sanzione può arrivare al 100% dei contributi evasi (raddoppiando quindi l’esborso). ENPAP, dal canto suo, nel Regolamento Sanzioni stabilisce per ritardi oltre 90 giorni una sanzione pari a 1/5 del contributo soggettivo minimo (circa €156), ma se il ritardo è molto lungo e dovuto a omesso versamento, possono applicarsi sanzioni crescenti fino a un massimo (spesso il 100% del dovuto, in analogia con INPS).
In ogni caso, le sanzioni previdenziali non hanno natura penale ma amministrativa, e non si cumulano con eventuali sanzioni tributarie (ognuna ha campo proprio). È fondamentale verificare, quando si riceve un avviso dalla Cassa, la corretta applicazione delle sanzioni secondo i regolamenti vigenti all’epoca dell’omissione e l’eventuale possibilità di fruire di riduzioni (spesso, pagando entro tot giorni dalla contestazione la sanzione è diminuita).
Ricapitolando: gli accertamenti delle casse si concretizzano in atti come:
- Comunicazioni di irregolarità (inviti a regolarizzare, avvisi bonari);
- Provvedimenti di accertamento e contestazione sanzioni (ad es. verbali di accertamento o delibere del Consiglio di Amministrazione della Cassa);
- Cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione (ADER) su richiesta della Cassa, che hanno valore di ingiunzione e contengono contributi, interessi e sanzioni;
- Avvisi di addebito con valore esecutivo (strumento che ha sostituito la cartella per l’INPS dal 2011, e che alcune casse, se autorizzate, possono utilizzare direttamente; Cassa Forense tuttavia usa ancora le cartelle ruoli, mentre per ENPAP non risulta un “avviso di addebito” proprio – i ruoli ENPAP sono riscossi con cartella standard);
- Decreto ingiuntivo ottenuto dall’ente previdenziale presso il tribunale competente, che se non opposto diviene titolo esecutivo giudiziario. Questa via è stata percorsa talvolta da Cassa Forense in passato e da ENPAP (come nel caso di Tivoli citato). Il vantaggio per l’ente è che, se l’ingiunzione non viene opposta entro 40 giorni, si forma un giudicato con efficacia di cosa giudicata, e la prescrizione del credito contributivo diventa decennale ex art.2953 c.c. (perché basata su titolo giudiziario definitivo). Questo aspetto è importante anche per i debitori: non opporre un decreto ingiuntivo della Cassa entro i termini significa precludersi la contestazione del merito e far decorrere da allora un nuovo termine di prescrizione decennale (diversamente dalla cartella esattoriale, che non essendo provvedimento giurisdizionale non converte la prescrizione breve, come vedremo).
Abbiamo quindi delineato i possibili atti e situazioni. Nel prossimo capitolo vedremo come difendersi, cioè quali strumenti ha a disposizione il professionista per tutelarsi, sia sul piano procedurale (ricorsi, opposizioni, ecc.) sia sul piano sostanziale (eccezioni di prescrizione, errori, difetti dell’atto, ecc.), senza dimenticare le possibili soluzioni transattive o deflattive del contenzioso.
Difendersi dagli accertamenti: strumenti e strategie
Affrontare un accertamento fiscale o contributivo richiede innanzitutto di identificare la natura dell’atto ricevuto e la sede in cui far valere le proprie ragioni. Bisogna distinguere:
- Gli avvisi di accertamento tributari (dell’Agenzia delle Entrate) vanno impugnati davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica. La difesa in questo caso riguarda il merito fiscale (imposte, deduzioni) e l’accertamento del reddito.
- Le cartelle di pagamento o avvisi di addebito per contributi previdenziali vanno impugnati con ricorso in opposizione al Giudice del Lavoro (Tribunale in funzione di giudice del lavoro) entro 40 giorni dalla notifica. Questo perché si tratta di crediti previdenziali (anche se di enti privatizzati, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, sezione lavoro, trattandosi di obblighi previdenziali obbligatori). La norma di riferimento è l’art. 24, co.5 del D.Lgs. 46/1999. In tale giudizio l’ente previdenziale è convenuto-opposto, ma ha l’onere di provare il titolo del credito, mentre l’opponente può sollevare eccezioni di merito e di forma (ad es. prescrizione, pagamento già effettuato, errori di calcolo).
- I decreti ingiuntivi ottenuti dalla Cassa vanno anch’essi opposti in Tribunale (lavoro) entro 40 giorni, altrimenti divengono definitivi e non più contestabili.
Spesso il contribuente si trova coinvolto in entrambi i fronti contemporaneamente: ad esempio, avviso di accertamento dell’Ade per maggior reddito e, qualche mese dopo, cartella di ADER per contributi Cassa Forense correlati. In tal caso occorre attivarsi su entrambi i binari con due ricorsi separati, coordinando le difese. È utile in questa sede parlare delle principali strategie difensive e motivi di opposizione che il professionista-debitore può adottare.
Eccezione di prescrizione del credito contributivo
La prescrizione è spesso l’arma principale nelle mani del debitore in materia previdenziale. Essa estingue il diritto di credito se trascorre un certo periodo senza che sia stato richiesto (o senza atti interruttivi validi). Occorre però fare attenzione, perché la disciplina ha avuto evoluzioni e peculiarità:
- Contributi a Cassa Forense: attualmente (dal 2012) il termine di prescrizione è decennale. Ciò a seguito dell’art. 66, comma 1, della Legge 247/2012 (riforma forense), che ha escluso l’applicazione della prescrizione quinquennale prevista dalla L.335/1995 alle contribuzioni dovute alla Cassa Forense. In altri termini, per gli avvocati la legge speciale ha ripristinato il termine ordinario di 10 anni, ritenendo non applicabile la regola generale dei 5 anni introdotta nel 1995 per i contributi pensionistici. La Cassazione ha chiarito che tale norma non ha effetto retroattivo interpretativo, ma si applica ai crediti non prescritti al momento della sua entrata in vigore (febbraio 2013) e a quelli successivi. Dunque, un contributo Cassa Forense relativo ad anni fino al 2012 già caduto in prescrizione quinquennale non risorge; viceversa, per i contributi dal 2013 in poi (o ancora pendenti a quella data), il termine è 10 anni. Inoltre, Cassa Forense ha (e aveva anche prima) una regola interna per cui la prescrizione decorre dalla data di invio della comunicazione reddituale da parte dell’iscritto (Mod.5), e non inizia proprio a decorrere in caso di omessa comunicazione. La ratio è ovvia: se l’avvocato non dichiara nulla, la Cassa non ha modo di conoscere il credito, quindi il tempo non corre finché l’obbligo dichiarativo non viene adempiuto, fosse pure con anni di ritardo. Questo principio, affermato dalla Cassazione già nel 2007 e confermato più volte, comporta che un avvocato che non ha mai inviato il Mod.5 per un certo anno non possa eccepire la prescrizione indipendentemente dal tempo trascorso: per far scattare il termine deve almeno inviare (anche tardivamente) la dichiarazione dei redditi a Cassa Forense, oppure può sperare che la Cassa acquisisca i dati dal fisco e glieli contesti (in tal caso sarà la contestazione stessa ad “attivare” il decorso?). In realtà, secondo la Cassazione, l’omissione dichiarativa è considerata un evento interruttivo continuo – la prescrizione non inizia affatto. Solo l’invio dei dati fa partire i 10 anni. Quindi, per chi ha omesso di comunicare redditi del 2010, ad esempio, la Cassa potrebbe teoricamente richiedere i contributi anche nel 2025 e oltre, perché per quel 2010 il termine non è mai decorso (questo sotto la vigenza della regola decennale attuale; quando vigeva il quinquennio, l’analisi era la stessa ma su 5 anni). Esempio: avv. Alfa non ha inviato il Mod.5 per l’anno reddito 2011. Nel 2024 la Cassa scopre dall’Agenzia Entrate che nel 2011 Alfa aveva reddito €30.000. Poiché omessa comunicazione, la Cassa può esigere i contributi 2011 (soggettivo ~14% e integrativo) + interessi dal 2012 + sanzioni. Alfa non potrà invocare la prescrizione quinquennale, perché per il 2011 non è mai iniziata a decorrere (omessa dichiarazione), e nel frattempo la L.247/2012 ha portato il termine a 10 anni. Tuttavia, essendo trascorsi oltre 10 anni dal 2013, si pone un dubbio: la L.247 ha efficacia da 2013, quindi contributi 2011 sarebbero andati prescritti il 31/12/2016 se si applicava la L.335? Ma la Cassa sosterrà che al 2013 quel credito era inesigibile per decorrenza di termini? Non necessariamente: la giurisprudenza in passato oscillò, ma la L.247/2012 appunto ha “definitivamente superato il contrasto” dando 10 anni. Dunque nel nostro esempio, la Cassa nel 2024 è ancora nei 10 anni dal 2013, e Alfa dovrà pagare.*
- Contributi ENPAP e altre casse (ex D.Lgs.103/96): qui vale la regola generale della L.335/1995, art.3 co.9, ossia prescrizione quinquennale per i contributi obbligatori. ENPAP stesso, nel proprio regolamento, conferma il termine di 5 anni. A differenza di Cassa Forense, non risulta una norma speciale che sospenda il decorso in caso di omessa comunicazione. Ciò implica che per gli psicologi il termine decorre dal momento in cui il contributo era dovuto (di solito fine anno successivo al reddito) o dalla scadenza di pagamento prevista. Ad esempio, i contributi sul reddito 2017 erano esigibili nel 2018; se ENPAP non li ha richiesti né l’iscritto ha ricevuto atti interruttivi, dal 1° gennaio 2024 sarebbero prescritti (5 anni compiuti). Atti interruttivi tipici sono: solleciti scritti inviati con raccomandata, intimazioni, cartelle notificate. Nel citato caso Tribunale di Tivoli, ENPAP spedì varie raccomandate: il giudice ne ha considerata valida solo una (quella all’indirizzo giusto) e da quella ha calcolato che tutto ciò che era precedente di oltre 5 anni era prescritto. Quindi, se un professionista ha periodi lontani di mancato pagamento, è opportuno analizzare se vi siano stati interventi interruttivi: ad esempio, l’invio di PEC o raccomandate dall’ente che il debitore magari ha ignorato. Se l’ente ha dormito per più di 5 anni, quei crediti possono essere dichiarati prescritti su eccezione di parte (il giudice non li considera d’ufficio nei decreti ingiuntivi, ma se opposti o se l’ente agisce ex novo, la prescrizione può essere rilevata d’ufficio data la natura pubblicistica – come sostiene la Cassazione).
Attenzione: c’è da tener presente che la prescrizione dei contributi previdenziali non si “allunga” a 10 anni neppure se la cartella non viene impugnata. Su questo punto vi è stata evoluzione giurisprudenziale importante. Prima alcune sentenze di Cassazione (es. n.4338/2014) ritenevano che la mancata opposizione di una cartella nei 40 giorni trasformasse la pretesa in definitiva e facesse scattare l’art.2953 c.c. (prescrizione decennale del diritto riconosciuto con sentenza passata in giudicato). Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione n.23397/2016 hanno risolto il contrasto stabilendo che un atto amministrativo divenuto definitivo per mancata impugnazione (cartella, avviso di addebito, ordinanza-ingiunzione) non equivale a un giudicato e dunque non comporta la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale. L’art.2953 c.c. si applica solo a sentenze passate in giudicato o provvedimenti giudiziari equiparati, non analogicamente ad atti amministrativi. Dunque, se la Cassa (o l’INPS) notifica una cartella e il debitore non fa opposizione entro 40 giorni, l’importo diventa definitivamente dovuto (non più contestabile nel merito), ma resta soggetto a prescrizione quinquennale (o decennale se previsto ex lege, come per CF) decorrente dalla data in cui la cartella è divenuta definitiva o dalla data di eventuali atti successivi. Ciò è stato ribadito da Cass. civ. sez. Lav. n.14690/2021: “anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale […] trascorsi 5 anni viene meno l’obbligo di versare i contributi”.
In pratica, l’ente non può dormire a tempo indeterminato solo perché ha emesso una cartella non opposta: deve comunque attivare procedure esecutive o solleciti entro 5 anni, altrimenti la pretesa si estingue. Questo principio è fondamentale per il debitore: può capitare che uno non abbia fatto ricorso in tempo contro la cartella, ma se l’ente/ADER non si fa vivo per 5 anni, si potrà eccepire la prescrizione quando magari inizierà il pignoramento. Ad esempio, se ENPAP notifica cartella nel 2017 e il professionista non ricorre, ma poi nessuno cerca di riscuotere fino al 2023, al primo atto di esecuzione (pignoramento) nel 2023 egli potrà opporsi all’esecuzione sostenendo che il credito si è prescritto a fine 2022.
Riassumendo:
- Per avvocati (Cassa Forense): prescrizione 10 anni (dall’invio mod.5 o illimitata se mai inviato) per crediti dal 2013 in poi. Prima, 5 anni per crediti 1996–2012 se dichiarati, o sospesa se omesso.
- Per psicologi (ENPAP) e in genere altre casse (commercialisti, ingegneri, etc. salvo eccezioni legislative analoghe a CF): prescrizione 5 anni dal momento in cui il contributo doveva essere pagato, salvo interruzioni.
- In nessun caso la mancata impugnazione di cartella allunga la prescrizione (a meno che diventi decreto ingiuntivo non opposto: quello sì ha forza di giudicato decennale).
L’eccezione di prescrizione va formulata chiaramente nel ricorso (in sede di opposizione) o anche oralmente in udienza se ci si difende. Il giudice, se riconosce decorso il termine, dichiarerà il credito (o la parte di esso) estinto e annullerà l’atto impugnato in relazione a tale parte. È buona norma calcolare con precisione le date: la prescrizione si interrompe con atti idonei notificati al debitore, e da ogni interruzione ricomincia a decorrere ex novo per intero (5 o 10 anni). Nel caso ENPAP di Tivoli, si è discusso se le lettere a indirizzo sbagliato valessero come interruttive: il giudice ne ha validata solo una e ha applicato il quinquennio retroattivo da quella data.
Vizi procedurali e di notifica
Un’altra linea di difesa è verificare se l’ente o l’Agenzia hanno rispettato tutte le regole procedurali. Esempi:
- Omessa notifica o notifica irregolare: se l’accertamento fiscale o la cartella non sono stati notificati correttamente, l’atto è tamquam non esset. A volte il contribuente viene a conoscenza di un debito solo tramite un estratto di ruolo o un pignoramento, perché magari la cartella era stata notificata ad un vecchio indirizzo, o con errori. In tali casi si può fare opposizione “tardiva” deducendo di averne avuto conoscenza solo ora per vizio di notifica (in ambito tributario, la notifica nulla consente di impugnare quando si ha conoscenza effettiva). In ambito lavoro, analogamente, se il decreto ingiuntivo non fu notificato a dovere, i 40 giorni decorrono dal momento in cui lo si apprende (es. da un’ingiunzione di pagamento). Le eccezioni di nullità della notifica devono però essere fondate su violazioni serie (esempio: notifica a indirizzo sbagliato, o a mezzo PEC non conforme alle regole, ecc.). Nel dubbio, meglio impugnare comunque e far valere il vizio in giudizio, piuttosto che ignorare l’atto.
- Mancata preventiva contestazione (nel caso di sanzioni): come evidenziato, per Cassa Forense la Cassazione ha sancito che la cartella contenente sanzioni per omessa dichiarazione è illegittima se non c’è stato l’atto di contestazione antecedente. Questo argomento va sfruttato quando ricorre: se l’avvocato riceve direttamente cartella con “sanzione omessa comunicazione € xyz”, e non gli era mai stata comunicata prima la violazione, potrà eccepire violazione degli artt.13-14 L.689/81 e del diritto di difesa, chiedendo l’annullamento della sanzione. Spesso, in via derivata, ciò invalida l’intera cartella (perché può mancare una base fondamentale). Ad ogni modo, dopo la pronuncia del 2022 e l’introduzione dell’art.63 Regolamento 2021, la prassi della Cassa ora include l’avviso: è meno probabile che manchi, ma non impossibile (potrebbe perdersi o essere inviato a indirizzo errato).
- Difetto di motivazione o di indicazione dei presupposti: un avviso di accertamento fiscale deve contenere i motivi, gli elementi su cui si basa. Se riferito a contributi, ad esempio, la mancata esplicitazione di quali contributi e di quale annualità sono contestati potrebbe renderlo nullo. Analogamente, una cartella deve indicare l’origine del debito (anno, tipo contributo, sanzione). Se arriva una cartella indecifrabile (es. solo un importo globale “ENPAP contributi”), si può contestare la motivazione insufficiente chiedendo l’annullamento per impossibilità di esercitare appieno la difesa. Di solito però ADER allega un dettaglio degli enti creditori e periodi.
- Errata quantificazione: vale la pena sempre ricontrollare i calcoli. Potrebbero esservi errori nell’importo del contributo dovuto (es: applicata percentuale sbagliata, o non considerato che avevate già versato il minimo). Se individuati, vanno evidenziati nel ricorso con eventuale documentazione (ricevute pagamenti effettuati). Il giudice può rideterminare il dovuto eliminando la parte non corretta.
- Violazione dei termini di decadenza: oltre alla prescrizione (che è termine lungo di diritto sostanziale), vi sono termini di decadenza per l’accertamento. Ad esempio, l’Agenzia Entrate deve notificare gli avvisi entro il 31/12 del quinto anno successivo (salvo sospensioni, condoni, ecc.). Per i contributi, i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo in alcuni casi sono indicati dal D.Lgs.46/99 (v. art.25: entro fine anno successivo a quello in cui il credito è affidato). Senza entrare nel tecnicismo, conviene verificare se tra il sorgere dell’obbligo e la notifica della cartella sono passati più anni del dovuto. Spesso però, il limite “forte” è la prescrizione, mentre la decadenza può essere sanata se l’atto è stato comunque notificato entro i 5 anni.
- Difetto di giurisdizione o incompetenza: in genere, come visto, la giurisdizione è ben delineata (tributaria vs lavoro). Può accadere che vi sia incertezza su quale giudice adire: ad esempio, cartelle “miste” con dentro sia imposte sia contributi. In tal caso si deve fare doppio ricorso separando le parti. Un errore da evitare: non impugnate mai una cartella di contributi in Commissione Tributaria! Verrebbe dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Viceversa, non portate l’Agenzia Entrate davanti al giudice del lavoro. In caso di dubbio (cartella con IRPEF e gestione separata INPS insieme, per dire), vanno impugnate entrambe le parti nei rispettivi giudici.
Difese di merito: non debenza, errori sullo status
Oltre ai vizi formali, il debitore può far valere circostanze di merito sostanziale per negare il debito:
- Non ero tenuto a iscrivermi / contribuire: ad esempio, un avvocato potrebbe sostenere di non aver esercitato la professione in quell’anno, e quindi contestare la debenza dei contributi minimi. In passato, l’iscrizione alla Cassa Forense era obbligatoria solo per chi esercitava “con carattere di continuità” (art.22 L.576/80) e c’erano esoneri sotto certi redditi. Dal 2012 la legge 247 ha reso l’iscrizione obbligatoria per tutti gli iscritti all’albo con attività, abolendo il concetto di continuità legato al reddito. Dunque questa difesa ha perso rilevanza, se non in casi peculiari (es. l’avvocato era sospeso dall’albo o aveva comunicato cessazione attività, ecc.). Per ENPAP, similmente, uno psicologo potrebbe dire: ero dipendente full-time e non ho esercitato privatamente. Ma se ha emesso anche una sola fattura, l’ente lo inquadrerà come soggetto obbligato (non esistono esoneri per contemporanea iscrizione INPS, a differenza di alcune casse come ENPAM per medici dipendenti SSN, dove c’è parziale esonero). Nel caso di Tivoli, l’obbligato aveva eccepito forse di non dover nulla: il giudice ha ribadito che l’obbligo scatta comunque in presenza di reddito autonomo, anche con lavoro subordinato.
- Errore sul reddito imponibile: può capitare che l’ente chieda contributi su un reddito X, ma il professionista eccepisca che quel reddito non era soggetto (magari era reddito estero esente, o reddito non professionale). Ad esempio, se un anno si è incluso nel modello 5 un reddito che poi l’Agenzia ha ritenuto non tassabile, l’iscritto potrebbe chiedere la rettifica alla Cassa e il rimborso contributi eventualmente versati in eccedenza. Le casse di solito allineano l’imponibile a quello fiscale, quindi se un accertamento fiscale abbatte il reddito, anche i contributi vanno rideterminati. Attenzione però: se il fisco concede un condono o una definizione agevolata (pagando meno imposte senza accertare il reddito vero), la Cassazione ha ritenuto che ciò non vincola l’ente previdenziale, il quale potrebbe pretendere contributi sull’intero reddito originariamente accertato salvo prova contraria (vedi infra definizione agevolata).
- Pagamenti già eseguiti/Compensazioni: bisogna documentare eventuali pagamenti che l’ente non ha contabilizzato. Ad es., se avevate rateizzato e pagato alcune rate, ma la cartella pare richiedere l’intero, fornite ricevute al giudice. Riguardo la compensazione, va chiarito: non è ammessa la compensazione unilaterale tra debiti contributivi e crediti fiscali o viceversa, salvo esplicita previsione di legge. Ad esempio, non potete autonomamente “compensare” un credito IRPEF risultante dal 730 con contributi dovuti alla Cassa Forense: i modelli F24 in genere non permettono l’utilizzo di crediti erariali per pagare causali contributi di casse privatizzate. Nel 2021 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune causali per versare i contributi di casse professionali tramite F24, ma sempre con soldi effettivi, non incrociando con crediti tributari. Un’importante eccezione recente è la prevista compensazione dei crediti per patrocinio a spese dello Stato con debiti verso casse previdenziali: la Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha autorizzato gli avvocati che vantano crediti liquidati per gratuito patrocinio a compensarli con i contributi dovuti (fino al 30 aprile 2023). Dunque, se rientrate in quel caso (siete avvocati con crediti da decreto di liquidazione non pagati dallo Stato e debiti contributivi), informatevi su tale opportunità: potrebbe risolvere il debito senza esborso, tramite modulistica dedicata. Al di fuori di questo, eventuali crediti verso la Cassa (ad esempio aver versato doppio, o rimborsi) possono essere usati per compensare debiti futuri solo con accordo dell’ente. In giudizio, comunque, se c’è un credito certo verso lo stesso ente, lo si può eccepire in compensazione legale secondo Codice Civile (ma servono requisiti di liquidità ed esigibilità).
- Sgravio o annullamento in autotutela: se dopo la notifica dell’accertamento/cartella emergono errori evidenti, si può presentare istanza di autotutela all’ente o all’Agenzia chiedendo l’annullamento totale o parziale. Ad esempio, dimostrando che non si era iscritti alla cassa in quell’anno (caso raro se obbligatorio) oppure che il reddito contestato in realtà non era imponibile per un errore palese. L’autotutela non sospende i termini di ricorso, quindi va eventualmente fatta parallelamente al ricorso.
Strumenti deflattivi e soluzioni alternative
Non sempre la via del contenzioso è la migliore: esistono modalità per definire le pendenze con sconti o per diluire il pagamento:
- Accertamento con adesione (ambito fiscale): se ricevete un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate (per imposte o per deduzioni contestate), potete valutare l’adesione: consiste nel discutere con l’ufficio e trovare eventualmente un accordo sul quantum dell’imponibile. L’adesione comporta la riduzione delle sanzioni fiscali ad 1/3. Per i contributi previdenziali correlati, un accordo sull’imponibile produce automaticamente il ricalcolo dei contributi: l’ente adeguerà la sua pretesa al reddito concordato. Dunque, se col fisco concordate un reddito leggermente inferiore a quello inizialmente accertato, pagherete contributi sul reddito ridotto.
- Definizione agevolata delle liti tributarie: misura straordinaria come quella del 2023 (DL 119/2018, ripresa nella L.197/2022) che consente di chiudere le cause pendenti pagando una percentuale dell’imposta. In tal caso, non c’è un accordo sul imponibile (si paga ad esempio il 20% delle imposte e la lite finisce senza accertare chi avesse ragione). La Cassazione ha stabilito (sentt. nn.21541 e 23301/2019, 950/2021) che questa definizione non vincola l’ente previdenziale: il giudice del lavoro, se il contribuente oppone l’avviso di addebito contributi dopo aver definito la lite fiscale, deve valutare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva senza limitarsi alla proporzione pagata. In pratica, aderire alla definizione fiscale non estingue automaticamente i contributi sulla parte condonata. Il suggerimento di alcuni (anche all’interno della magistratura) sarebbe di “ragionevolezza”, ovvero far pagare la stessa percentuale anche all’ente (es: 20% dei contributi), ma attualmente la legge non lo prevede. Quindi, chi chiude col fisco con un forte sconto potrebbe trovarsi comunque a dover discutere con la Cassa l’esistenza del reddito. Strategia possibile: fornire al giudice del lavoro le prove (presuntive) raccolte dal fisco e cercare di dimostrare che in realtà il reddito non esisteva o era minore, altrimenti si rischia di dover pagare il 100% contributi su una base fiscale su cui si è pagato magari solo il 20% di tasse.
- Rottamazione delle cartelle (Definizione agevolata ruoli): negli ultimi anni ci sono state varie edizioni (rottamazione-ter, quater, stralcio mini debiti) che riguardano anche i ruoli per contributi previdenziali privatizzati. Ad esempio, la rottamazione-quater (L.197/2022) consente di estinguere i debiti a ruolo 2000-2017 pagando solo il capitale e interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. I contributi rientrano? Sì, quelli affidati all’ADER entro 2017. Le sanzioni da omesso versamento contributi iscritte a ruolo possono essere condonate (mentre resta dovuto il contributo). Quindi, se avete una cartella Cassa Forense 2016, con contributi €5.000 e sanzioni €5.000, con la definizione agevolata paghereste €5.000 + interessi modesti, risparmiando la sanzione. Attenzione: vanno presentate le domande entro i termini fissati dalla legge (per la quater era 30/6/2023) e pagate le rate dovute puntualmente, pena decadenza. Al momento (luglio 2025) si parla di possibili nuove edizioni, ma nulla di certo; monitorate le normative finanziarie annuali.
- Rateazione e piani di rientro: se il debito è fondato ma non si riesce a pagare in unica soluzione, si può chiedere la rateazione. L’Agente della Riscossione consente rate fino a 72 rate mensili (6 anni) senza dover dare prova per debiti fino a €120.000, e piani più lunghi (fino 10 anni) con comprovata difficoltà. Anche la Cassa Forense prevede la possibilità di rateizzare in sede amministrativa i contributi dovuti (ad esempio, i contributi minimi possono essere rateizzati in 6 rate se richiesto entro l’anno). Se siete già in causa, potete provare a transare con l’ente un pagamento dilazionato: spesso, se non ci sono dubbi sul dovuto, le casse preferiscono incassare a rate che rischiare di perdere tutto.
- Sospensione della riscossione: se impugnate l’accertamento o la cartella, potete chiedere al giudice una sospensione dell’esecutività, dimostrando il periculum (danno grave e irreparabile se doveste pagare subito). Ad esempio, se vi pignorano la casa per contributi in contestazione, chiedete d’urgenza la sospensione. In ambito tributario, si presenta istanza di sospensione in Commissione entro 30 giorni dal ricorso. In ambito lavoro, si può chiedere al giudice dell’opposizione con separata istanza o nelle conclusioni del ricorso. La sospensione è discrezionale e temporanea (fino alla sentenza di primo grado). Se negata, resta la via di chiedere rateazione all’ADER per evitare le azioni esecutive durante il processo.
Aspetti penali correlati
L’inadempimento contributivo in sé (ovvero non pagare i propri contributi previdenziali obbligatori da professionista) non costituisce reato. Diversamente dall’ambito lavorativo subordinato, dove il datore che non versa le ritenute ai dipendenti oltre €10.000 annui commette reato (art. 2, D.Lgs. 276/2000), il libero professionista che omette i contributi a proprio carico subisce solo conseguenze civili (sanzioni, interessi, ecc.), ma non penali. Pertanto, un avvocato o psicologo insolvente verso la propria Cassa non rischia di per sé denunce penali.
Tuttavia, situazioni collegate possono avere rilievo penale:
- Se l’omissione contributiva si accompagna a evasione fiscale di rilevante entità, quest’ultima potrebbe configurare reati tributari. Ad esempio, se un professionista occulta ricavi per decine di migliaia di euro (superando le soglie di punibilità: €50.000 di imposta evasa per dichiarazione infedele, oppure €150.000 di ricavi non dichiarati, ecc.), allora vi sarà un procedimento penale tributario. In quel contesto, l’omesso pagamento dei contributi non è oggetto diretto dell’imputazione, ma sarà una conseguenza del medesimo fatto (occultare ricavi). Di solito, ai fini penali interessa il dolo di evadere le imposte; il movente di risparmiare anche i contributi può essere presente ma non è autonomamente sanzionato. In ogni caso, se si arriva a un patteggiamento o condanna, spesso tra le condotte riparatorie si considera positivamente anche aver sanato la posizione contributiva, perché denota resipiscenza.
- Se il professionista ha anche dipendenti o collaboratori, e omette di versare i contributi previdenziali dei dipendenti (trattenuti dalle buste paga), allora sì che si configura il reato ex art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983: omesso versamento di ritenute previdenziali. È punito con la reclusione fino a 3 anni o multa, ma solo per importi superiori a €10.000 annui. Sotto tale soglia scatta solo una sanzione amministrativa pecuniaria. Il reato è integrato dalla semplice condotta omissiva oltre il tetto, salvo che il datore versi quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o diffida dell’INPS. Per l’imprenditore che versi in crisi di liquidità c’è stato dibattito sull’assenza di dolo; ad oggi la Cassazione ritiene comunque punibile l’omissione anche in caso di difficoltà economica, salvo la prova di una assoluta impossibilità di adempiere.
- Falsificare documenti per evitare contributi potrebbe configurare reati. Ad esempio, produrre una falsa attestazione di regolarità contributiva (DURC) è reato di falso. Oppure, in sede di controllo fiscale, esibire ricevute di versamento contributi contraffatte per ottenere la deduzione costituirebbe uso di atto falso o truffa ai danni dello Stato se si traducesse in indebito rimborso fiscale. Per fortuna sono casi estremi e sconsigliabili.
In conclusione, il vero rischio penale concreto per i professionisti attiene più all’evasione fiscale che non all’evasione contributiva in sé. Ciò non significa che l’obbligo contributivo sia “facoltativo”: al contrario, il sistema prevede sanzioni civili pesanti e preclude vari benefici a chi non è regolare (niente pensione futura finché non versa, niente coperture assistenziali, etc.). Ma almeno non si rischiano sanzioni detentive.
Interazione tra contenzioso tributario e previdenziale
Come anticipato, capita spesso che un medesimo fatto – l’aver omesso di dichiarare dei redditi – generi due procedimenti: uno innanzi al giudice tributario per le imposte, l’altro innanzi al giudice del lavoro per i contributi correlati. Questo doppio binario pone problemi di coordinamento:
- Se il contribuente impugna l’accertamento fiscale (davanti alla Commissione Tributaria) contestando l’esistenza dei maggiori redditi, l’ente previdenziale può nel frattempo pretendere i contributi? La risposta è no, in base all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1999: se l’accertamento fiscale è impugnato, l’iscrizione a ruolo dei contributi è eseguita solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice. La Cassazione (sent. n.8379/2014) ha specificato che l’“accertamento” cui si riferisce la norma può essere anche quello dell’Agenzia delle Entrate e non solo dell’INPS, e che non serve che l’INPS (o cassa) sia a conoscenza del ricorso tributario per far scattare il divieto. Significa: se pende un ricorso in Commissione Tributaria contro l’avviso di accertamento, l’INPS o la cassa professionale non possono emettere avviso di addebito o cartella per i contributi su quel reddito, salvo ottenere dal giudice un provvedimento esecutivo (cosa in pratica inesistente, perché il giudice tributario non ordina mai di pagare provvisoriamente i contributi). Se l’ente previdenziale viola questo stop e notifica ugualmente la richiesta, il contribuente può fare opposizione lamentando la violazione dell’art.24 co.3 D.Lgs.46/99, chiedendo l’annullamento dell’avviso di addebito perché prematuro. Diversi tribunali di merito hanno accolto eccezioni del genere dichiarando nullo l’avviso emesso in pendenza del giudizio tributario. Altri giudici invece ritengono che, pur annullando l’atto per prematurità, possano comunque esaminare nel merito la pretesa contributiva (specie se nel frattempo il processo tributario si è definito). Comunque, messaggio pratico: se siete in causa col fisco, state attenti a eventuali cartelle contributi parallele: avete un forte argomento per farle sospendere e annullare, richiamando l’art.24 co.3.
- Se il giudizio tributario si conclude con un accertamento definitivo del reddito (ad esempio sentenza passata in giudicato che conferma o ridetermina il maggior reddito), allora l’ente previdenziale potrà procedere a riscuotere i contributi su quanto stabilito. Se invece il contribuente vince in toto nel merito fiscale (reddito aggiuntivo annullato), viene meno la base per i contributi: in un’eventuale causa lavoro pendente, esibendo la sentenza tributaria, otterrà il rigetto della pretesa contributiva (o l’annullamento dell’avviso, perché il credito non sussiste). C’è da dire che spesso le casse attendono l’esito del primo grado tributario, prima di incardinare la loro azione, proprio per non dover gestire rimborsi dopo. Ma non è obbligatorio: potrebbero emettere la cartella e poi, se il contribuente vince in Commissione, fare marcia indietro. Ecco perché conviene impugnare l’atto della cassa comunque e chiederne la sospensione fino all’esito fiscale.
- Come accennato, in caso di definizione agevolata delle liti (pagamento percentuale), la questione è spinosa. Esempio: Tizio ha in Cassazione una causa fiscale su €100.000 di redditi non dichiarati. Aderisce alla definizione 2023 pagando il 5% (€5.000) perché aveva già vinto in secondo grado. Finisce lì col fisco. A questo punto l’ENPAP potrebbe richiedergli i contributi su €100.000 (circa €10.000) sostenendo che la definizione non prova che quei €100.000 non c’erano. Tizio oppone in tribunale dicendo: “ho chiuso col fisco, quindi anche i contributi dovrebbero ridursi del 95%”. La Cassazione, come visto, non è di questo avviso: il giudice del lavoro dovrebbe invece entrare nel merito e valutare se quei €100.000 fossero reddito vero in base alle prove presuntive raccolte, senza farsi influenzare dal fatto che il fisco ha accettato meno per transigere. Questa situazione è delicata: di fatto il contribuente si trova a dover “rifare” il processo del merito del reddito davanti al giudice del lavoro. Con una difficoltà: quel giudice non è specializzato in tributi e potrebbe tendere ad convalidare l’operato dell’Agenzia, magari senza l’adeguato contraddittorio tecnico (ad esempio sull’applicazione di presunzioni tributarie). Ci sono critiche in dottrina su questa impostazione. Purtroppo è la linea giurisprudenziale corrente. Quindi, se pensate di definire col fisco, valutate l’impatto previdenziale: conviene se l’abbattimento è enorme e magari i contributi, essendo percentuali più basse dell’IRPEF, pesano meno. Nel caso di Tizio, pagare €5.000 al fisco ma poi doverne pagare €10.000 alla cassa è paradossale. Si potrebbe cercare, una volta chiusa col fisco, di negoziare con l’ente previdenziale (alcune casse hanno facoltà di transigere), oppure sperare di convincere il giudice a seguire l’approccio equitativo (applicare stesso 5% anche ai contributi). C’era un precedente della Corte d’Appello Venezia 385/2016 in tal senso, ma non è garantito.
- Caso inverso, molto più raro: il contribuente non impugna l’accertamento fiscale, ma impugna l’avviso contributivo sperando di discutere lì il merito del reddito. Questa strada è sbarrata: il giudice del lavoro non può rimettere in discussione un avviso di accertamento fiscale che è definitivo perché non impugnato. L’art.24 co.3 D.Lgs.46/99 di cui sopra permette di bloccare la riscossione se c’è un ricorso fiscale pendente, ma se uno non ha fatto ricorso affatto, quell’accertamento è definitivo e il reddito accertato va considerato reale. Non a caso l’orientamento giurisprudenziale costante è che l’omessa impugnazione dell’accertamento fiscale rende incontestabile la pretesa anche ai fini contributivi (salvo la sola verifica di prescrizione o errori di calcolo). Dunque, non pagate le imposte sperando poi di sfangarla sui contributi: se volete contestare, contestate prima di tutto il fisco nei termini.
In sintesi, la migliore tutela per il contribuente è cercare di coordinare le difese e possibilmente mantenere unità di strategia: se si ha ragione sul merito (ad es. reddito non dovuto), è bene portare avanti la battaglia in sede tributaria sino in fondo, e nel frattempo congelare il fronte contributivo. Se invece si punta a chiudere con una mediazione o definizione, cercare di minimizzare i danni sul fronte contributivo (magari includendo nel verbale di mediazione un riconoscimento esplicito di un certo imponibile previdenziale). Purtroppo, la legge non prevede un processo unico che risolva insieme imposte e contributi – sarebbe logico in teoria, ma nel nostro ordinamento i due ambiti restano separati.
Domande frequenti (FAQ)
D: Ho ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per redditi non dichiarati, su cui dovrò pagare IRPEF. Nella lettera c’è scritto che verranno informati anche gli enti previdenziali: cosa devo aspettarmi da Cassa Forense/ENPAP?
R: In caso di maggior reddito accertato, l’ente previdenziale riceverà comunicazione dall’Agenzia delle Entrate e potrà richiedere i contributi dovuti su quel maggior reddito. Può farlo emettendo un avviso di addebito (INPS) o iscrivendo a ruolo le somme con emissione di cartella (Cassa Forense, ENPAP). L’importo comprenderà il contributo percentuale dovuto (soggettivo, integrativo) più sanzioni e interessi per omesso versamento. Prima di attivarsi, però, la Cassa deve attendere che l’accertamento fiscale diventi definitivo oppure che scadano i termini di ricorso senza impugnazione. Se lei ha già fatto ricorso in Commissione Tributaria, la Cassa non può riscuotere nel frattempo. Se invece l’accertamento viene definito (per adesione o perché decorso il termine), allora può aspettarsi entro qualche mese la notifica della cartella o avviso per contributi. Sarà opportuno a quel punto verificare l’esattezza del calcolo e della prescrizione eventualmente maturata su annualità remote. Potrà anche valutare la rateizzazione del dovuto se l’importo è elevato.
D: Ho un contenzioso aperto col fisco su redditi professionali; intanto mi è arrivata una cartella dall’INPS (Gestione Separata) per contributi su quello stesso reddito. Posso bloccarla?
R: Sì. Come spiegato, l’art. 24 D.Lgs.46/99 vieta all’ente previdenziale di procedere in riscossione se l’accertamento fiscale corrispondente è sub iudice. Le suggeriamo di presentare ricorso in opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella, eccependo la violazione di tale norma e chiedendo l’annullamento della cartella per prematurità. Alleghi la documentazione del ricorso tributario pendente (ricevuta di deposito, ecc.). In parallelo, può segnalare la pendenza all’ente (INPS) chiedendo l’annullamento in autotutela, ma senza affidarsi solo a quello. Il giudice del lavoro di norma sospenderà l’efficacia della cartella in attesa dell’esito fiscale, oppure annullerà direttamente la cartella riservando all’INPS di riprendere eventualmente con un nuovo atto dopo la definizione del caso fiscale.
D: Ho dimenticato di inviare il Modello 5 alla Cassa Forense due anni fa. Finora non ho ricevuto nulla; cosa rischio e come posso rimediare?
R: L’omessa comunicazione reddituale è una violazione che comporta una sanzione amministrativa (in passato era € 100 per ogni mese di ritardo, ora la disciplina è cambiata). Inoltre la Cassa, non avendo i suoi dati reddituali, potrebbe presumere che Lei abbia percepito reddito e che debba versare i contributi su tale reddito. Poiché sono passati due anni, è probabile che presto la Cassa Le invii una lettera di contestazione dell’omesso invio (come previsto dal Regolamento, art.63). Le consigliamo di non attendere: può spontaneamente inviare ora il Mod.5 mancante (anche se in ritardo). In tal modo, sanerà la posizione dichiarativa. Le verrà comunque applicata una sanzione ridotta per il ritardo, ma notevolmente inferiore rispetto a quella prevista se la contestazione fosse già partita (di solito entro 12 mesi si applica la sanzione minima ridotta). Nel contempo, se dal Mod.5 risulta che erano dovuti contributi (perché aveva reddito), provveda subito a versare quanto dovuto, eventualmente chiedendo una rateazione alla Cassa. Questo è un caso di ravvedimento operoso in ambito previdenziale: evitare che l’ente La debba inseguire. Così facendo, eviterà ulteriori sanzioni e l’iscrizione a ruolo. Se invece non fa nulla, la Cassa potrebbe emettere un accertamento d’ufficio basandosi sui Suoi redditi comunicati dal fisco (che potrebbero includere anche voci che forse non richiederebbero contributi), con sanzione piena (anche il doppio del contributo). Meglio dunque prevenire ora.
D: Ho ricevuto una cartella da Agenzia delle Entrate-Riscossione per “Contributi Cassa Forense anni 2015-2016” per circa €8.000. Non ricordavo questo debito. Cosa devo fare?
R: Prima di tutto, verifichi la data di notifica della cartella e i termini: ha 40 giorni da quella data per presentare opposizione in Tribunale (sezione lavoro). Se i 40 giorni non sono trascorsi, Le suggeriamo di presentare ricorso per evitare la definitività. Nel ricorso potrà far valere diversi aspetti:
- Prescrizione: contributi 2015-2016 in Cassa Forense: per il 2015 il termine sarebbe 5 anni (essendo credito maturato prima della riforma 2012? Attenzione, la riforma è 2012 ma si applica ai crediti non prescritti a quella data, quindi contributi 2015 cadono sotto termine decennale). Se Lei nel 2016 ha inviato il Mod.5 e la Cassa non ha agito fino al 2023 (mettiamo che la cartella sia arrivata ora), potrebbe teoricamente invocare la prescrizione quinquennale per il 2015-16, ma la L.247/2012 rende più probabile che si applichi il termine di 10 anni. Occorrerà vedere quando è stato spedito il ruolo. Se ad esempio il ruolo è stato reso esecutivo nel 2022, i contributi non sono prescritti. Se invece il ruolo è del 2023 e Lei non aveva solleciti prima, valuterà se fare comunque l’eccezione prescrizionale per tentare.
- Mancata previa contestazione: se nella cartella vede addebitata una “sanzione per omessa comunicazione”, e Lei non ha mai ricevuto la raccomandata di avviso violazione, potrà eccepire il difetto di preventiva contestazione, chiedendo l’annullamento di quella sanzione.
- Verifica importi: controlli se per gli anni 2015-16 Lei aveva versato magari i contributi minimi. Se sì, l’importo richiesto dovrebbe essere solo la differenza. Se sembra che chiedano più del dovuto, prepari le ricevute di quanto versato e lo faccia presente (l’errore di calcolo è motivo di riduzione della pretesa).
- Notifica tardiva: se la cartella Le è stata notificata a distanza di molti anni (oltre 5) dalla data in cui avrebbe dovuto versare, valuti anche questo profilo da contestare come decadenza.
Nel frattempo, potrebbe contattare la Cassa Forense per chiedere un estratto conto dettagliato: a volte emergono spiegazioni (es: non ha presentato Mod.5, la Cassa ha appreso redditi dal fisco e generato il debito). In base a ciò, deciderà se trovare un accordo (pagamento rateale) oppure proseguire in causa.
D: Non riesco a pagare una cifra così alta in un’unica soluzione. Posso rateizzare i contributi richiesti?
R: Sì. Ci sono due livelli di rateazione:
- In fase amministrativa, con la Cassa/ADER: per importi iscritti a ruolo, può presentare domanda di dilazione all’Agenzia Entrate-Riscossione. Debiti fino a €120.000 possono essere rateizzati in 72 rate mensili automaticamente; debiti superiori richiedono documentare lo stato di difficoltà. Presenti la richiesta prima che inizino azioni esecutive pesanti (fermo amministrativo, ipoteca). Pagando la prima rata, si sospendono le procedure esecutive. Tenga però conto che la rateazione con ADER non sospende il procedimento giudiziale: se ha fatto ricorso, conviene informare il giudice che ha chiesto la rateazione (e viceversa informare ADER del ricorso). In alcuni casi, l’ente può decidere di ritirare la cartella se il debitore propone un piano di rientro diretto.
- In fase giudiziale/transattiva: se è in causa, può sempre trovare un accordo transattivo con la controparte (la Cassa) – spesso il Consiglio di Amministrazione può approvare una conciliazione con rateizzazione e magari lieve riduzione delle sanzioni. Questa però è una strada negoziale, non obbligatoria per l’ente.
D: Ho pagato in ritardo dei contributi ENPAP (versati con 6 mesi di ritardo). Mi è arrivata una sanzione di circa €150. Posso contestarla?
R: Pagare in ritardo i contributi comporta sempre una sanzione, di entità stabilita dal regolamento. €150 su un ritardo di 6 mesi sembra congruente con la sanzione ENPAP prevista (che, come detto, è 1/5 del contributo minimo se >90 giorni di ritardo). Può verificare se il regolamento prevede una causa di esonero (es: eventi straordinari, calamità, ecc.) che giustifichi l’annullamento della sanzione. In assenza di ciò, contestarla in giudizio sarebbe probabilmente infruttuoso, perché il ritardo c’è stato ed ENPAP ha applicato la norma. In generale, le sanzioni da ritardato versamento possono semmai essere ridotte dall’ente in via amministrativa con istanze di clemenza (ad esempio, spiegando che c’erano motivi di forza maggiore per il ritardo). Se le ragioni sono valide, il Consiglio di ENPAP potrebbe deliberare l’annullamento parziale. Ma legalmente, se il regolamento è chiaro, un ricorso formale avrebbe poche chance. Valuti i costi-benefici: per €150 forse non conviene avviare un giudizio. Diverso sarebbe se la sanzione fosse sproporzionata (es: pari al 100% del contributo per un ritardo di pochi mesi – cosa che non accade con le norme attuali).
D: Sono iscritto sia all’Albo Avvocati sia dipendente pubblico. Non ho prodotto redditi da avvocato, ma Cassa Forense mi chiede comunque i contributi minimi. Posso oppormi?
R: La L.247/2012 ha reso obbligatoria l’iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli avvocati iscritti all’albo, indipendentemente da reddito, con alcune eccezioni (es. se si è iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria per l’attività forense – ma nel suo caso, come dipendente pubblico, la previdenza è per il lavoro dipendente, non copre l’attività forense). Tuttavia, se non esercita affatto la professione forense (nessuna partita IVA, nessuna fattura emessa, nessun cliente) e l’iscrizione all’albo è solo formale, potrebbe valutare la possibilità di sospendersi o cancellarsi dall’albo per non dover versare. Purtroppo attualmente l’alternativa è: o si resta iscritti e si pagano i contributi minimi (anche a zero reddito, a meno di ottenere esoneri per reddito basso se previsti), oppure ci si sospende dall’albo. Alcuni avvocati hanno impugnato in passato la pretesa di contributi minimi in assenza di reddito, ma le norme sono state ritenute legittime in quanto facenti parte del regime obbligatorio di solidarietà. Se Lei è iscritto all’albo e contemporaneamente, poniamo, è iscritto a un’altra cassa professionale per diversa attività, c’è qualche caso di esonero parziale (ad es. commercialista-avvocato, una delle due casse può esonerare per evitare doppia contribuzione integrativa). Nel suo caso di dipendente pubblico, non c’è esonero totale: dovrà pagare il contributo minimo soggettivo (salvo deliberazioni temporanee: ad es. per gli anni 2018-2022 Cassa Forense ha abolito il contributo integrativo minimo, quindi chi non fatturava nulla pagava solo il soggettivo minimo e non l’integrativo minimo). In sintesi: a meno che dimostri che la Cassa Le ha chiesto contributi in eccesso rispetto alle regole (cosa che può verificare leggendo le delibere Cassa per i dipendenti senza reddito, se esistono), l’opposizione difficilmente Le darà ragione. Valuti se mantenere l’iscrizione all’albo conviene, oppure se far domanda di esonero (ad esempio alcuni enti prevedono esonero temporaneo per periodi all’estero o per chi è in aspettativa).
D: Il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) mi è stato negato per un debito di €200 verso l’ENPAP. Possono farlo?
R: Sì, la normativa sulla regolarità contributiva prevede che l’ente non possa attestare la regolarità se c’è anche un piccolo debito pendente. ENPAP specifica che non rilascia il certificato se il debito supera €150. Nel suo caso, €200 > €150, quindi scatta l’irregolarità. Purtroppo questo significa che finché non salda quel debito, non otterrà il DURC e ciò può precluderle accesso a incarichi, appalti o bonus pubblici. Le conviene sanare subito il dovuto (magari verificando che la cifra sia corretta e non prescritta, ma se vuole il DURC rapidamente, paghi e poi eventualmente chieda rimborso se scoprisse che non era dovuta). Ricordi che la soglia di tolleranza è minima (€150), quindi in futuro controlli periodicamente la sua posizione ENPAP per evitare anche residui. Essere “in regola” contributivamente è essenziale per usufruire di diverse agevolazioni (ad esempio, Cassa Forense spesso richiede regolarità contributiva per partecipare ai bandi assistenziali, e comunque per ottenere prestazioni come pensione o indennità).
D: Ho vinto in Cassazione contro l’Agenzia delle Entrate: avevano sbagliato, il reddito non era imponibile. Ora come recupero i contributi che intanto avevo pagato alla Cassa su quel reddito?
R: Se Lei, nel timore di sanzioni, aveva già versato i contributi su un reddito poi risultato non dovuto fiscalmente, ha diritto a chiederne il rimborso o lo storno. In genere, deve presentare istanza di rimborso alla Cassa allegando la sentenza che attesta che quel reddito (es. plusvalenza, indennità, etc.) non era reddito professionale imponibile. La Cassa Forense ha una procedura per rimborsi di contributi non dovuti (ad esempio, contributi versati in eccesso). Potrebbero anche offrirle di compensare quel credito con futuri contributi. L’importante è che ci sia un atto ufficiale (sentenza passata in giudicato) che certifichi l’inesistenza dell’obbligo sul reddito in questione. Attenzione: se il reddito è stato escluso per motivi extrafiscali (es. condono tombale), la Cassa potrebbe opporre che ciò non equivale a dichiarare il reddito inesistente. Ma se, come dice, c’era un errore e lei ha vinto sul merito, allora la base contributiva cade. Quindi faccia subito domanda di rimborso, perché anche i rimborsi hanno un termine (spesso 10 anni). Nel caso in cui l’ente faccia resistenza, l’ultima ratio è fare causa di ripetizione, ma generalmente se il diritto è chiaro la Cassa rimborsa spontaneamente.
D: In sede di accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate mi propone di aumentare il reddito di €10.000. Se firmo l’adesione, poi posso evitare le sanzioni contributive su quell’importo?
R: Firmando l’adesione, lei riconosce €10.000 di reddito in più. La Cassa/INPS la richiederà i contributi dovuti su quei €10.000 (ad es. 14% se avvocato, 10% se psicologo). Non ci sono sanzioni “penali” in senso stretto, ma dovrà pagare: (a) i contributi in sé; (b) gli interessi da quando erano dovuti (di solito dal 2019 se reddito 2018, etc.); (c) una sanzione civile. Tuttavia, poiché l’accertamento fiscale è stato concluso con adesione (quindi bonariamente), anche l’ente spesso è meno severo: come detto, Cassa Forense applica sanzione ridotta (30%) se l’iscritto aderisce all’accertamento contributivo. Bisogna vedere se considerano l’adesione fiscale come adesione implicita anche per loro. Non c’è automatismo, ma può senz’altro argomentare, se arriverà l’atto, che lei non ha contestato e quindi chiedere la sanzione minima. Per maggiore prudenza, potrebbe informare la Cassa della conclusione dell’adesione e chiedere se intendono formalizzarle un atto di accertamento contributivo concordato. Alcune casse invitano l’iscritto stesso a denunciare i maggiori redditi emersi (sarebbe corretto farlo: dopo l’adesione, dovrebbe presentare un Mod.5 integrativo con +€10.000). Facendo ciò spontaneamente, la sanzione per tardivo versamento potrebbe essere ulteriormente attenuata (in alcuni casi, se uno denuncia spontaneamente prima di essere scoperto, la sanzione è molto ridotta).
D: Le pronunce delle Commissioni Tributarie o della Cassazione in materia di contributi previdenziali professionali dove si trovano?
R: Le sentenze di Cassazione si possono reperire sul sito ufficiale (database italgiure) o su portali giuridici. Nella sezione Fonti in calce a questa guida troverà i riferimenti di alcune sentenze chiave citate:
- Cass. 18730/2013 (su controlli incrociati fisco-Cassa Forense, prescrizione e omessa dichiarazione)
- Cass. 9310/2022 (su obbligo di preventiva contestazione delle sanzioni CF)
- Cass. 14690/2021 (prescrizione quinquennale non “allungabile” per cartella non opposta)
- Cass. SS.UU. 23397/2016 (stesso tema, massimata)
- Cass. 8379/2014 (coordinamento accertamento fiscale e contributi, mai smentita)
- Cass. 21541/2019 e altre (definizione agevolata e contributi).
Inoltre abbiamo citato decisioni di merito come Tribunale Tivoli 563/2021. Tutti questi riferimenti sono elencati con link nella sezione Fonti qui sotto.
Conclusione
Dal punto di vista del debitore professionista, difendersi da un accertamento su contributi ENPAP o Cassa Forense richiede una conoscenza interdisciplinare: nozioni di diritto tributario, di legislazione previdenziale privata, e padronanza delle procedure processuali davanti a giudici diversi. Come abbiamo visto, esistono però solide linee difensive – la prescrizione su tutte – e garanzie procedurali che tutelano il contribuente da pretese tardive o ingiuste. È fondamentale agire tempestivamente (rispettando i termini di ricorso) e utilizzare tutti gli strumenti deflattivi o transattivi offerti dalla legge per ridurre l’esborso (adesioni, definizioni, rottamazioni, rateazioni).
Dal punto di vista preventivo, il miglior consiglio è: mantenere una corretta dichiarazione dei redditi alla propria Cassa (compilare ogni anno il Modello reddituale, anche se con zero reddito) e versare almeno i minimi obbligatori. In caso di difficoltà economiche, molte casse prevedono aiuti o possibilità di rinvio/riduzione dei contributi minimi (ad esempio, Cassa Forense durante il COVID ha sospeso temporaneamente l’obbligo dei minimi integrativi). Ignorare l’obbligo contributivo porta solo ad accumulare sanzioni e interessi. Meglio concordare piani di rientro sostenibili.
Speriamo che questa guida – con le sue oltre 10.000 parole di approfondimento – abbia fornito un quadro chiaro e aggiornato (luglio 2025) della materia, aiutando professionisti e consulenti legali a orientarsi “come difendersi” efficacemente in caso di accertamenti fiscali e previdenziali relativi ai contributi di Cassa Forense ed ENPAP.
Fonti (normative e giurisprudenziali)
- Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. n.18730/2013: conferma che la Cassa Forense può richiedere in ogni momento all’Agenzia Entrate i dati reddituali degli iscritti e usare tali dati per emissione di cartelle; art.19 L.576/1980 prevede prescrizione decennale decorrente dall’invio della dichiarazione (se omessa, il termine non decorre).
- Legge 20 settembre 1980, n.576: istitutiva Cassa Forense. Art.17 obbligo comunicazione redditi, art.19 disciplina prescrizione (comma 2: 10 anni da trasmissione dichiarazione).
- Legge 8 agosto 1995, n.335: (Riforma Dini) art.3 co.9 lettera b) fissa prescrizione generale contributi previdenziali in 5 anni (estesa a 10 in caso di denuncia del lavoratore entro 5 anni).
- Cass., SS.UU., sent. n.25790/2009: distinzione tra prescrizione decennale ex art.2953 c.c. per titoli giudiziari e prescrizione quinquennale per pretese contributive da provvedimenti amministrativi definitivi (art.2953 c.c. non applicabile analogicamente).
- Cass., SS.UU., sent. n.23397/2016: risolve contrasto, stabilendo che cartelle non opposte non producono effetto di giudicato, niente conversione decennale ex art.2953 c.c.; conferma prescrizione resta quinquennale (salvo diversi termini di legge).
- Cass. civ. Sez. Lav. sent. n.14690/2021 (ord. 26/05/2021): ribadisce che mancata impugnazione di cartella o avviso di addebito non converte prescrizione breve in decennale; art.2953 c.c. inapplicabile perché atti amministrativi non equiparabili a sentenza.
- Cass. civ. Sez. Lav. sent. n.8379/2014: interpretando art.24 co.3 D.Lgs.46/99, chiarisce che il divieto di riscossione in pendenza di giudizio si applica anche se accertamento fatto da Agenzia Entrate; INPS (o cassa) non può notificare avviso di addebito finché la questione fiscale è sub iudice.
- Cass. civ. Sez. VI Lav. ord. n.1799/2016: solleva questione a SS.UU. (poi decisa da 23397/16) sul conflitto giurisprudenziale circa art.2953 c.c. per cartelle definitive.
- Cass. civ. Sez. Unite sent. n.6729/2013: (citata da Mefop) ha chiarito che l’art.66 L.247/2012 non ha natura interpretativa retroattiva; si applica da entrata in vigore in avanti.
- Legge 31 dicembre 2012, n.247 (Nuova disciplina ordinamento forense): art.66 comma 1 esclude applicazione L.335/95 alla Cassa Forense, quindi prescrizione torna decennale per CF.
- Tribunale di Tivoli – sent. n.563/2021: in opposizione a decreto ingiuntivo ENPAP, conferma obbligo iscrizione psicologi autonomi anche se dipendenti; onere prova in opposizione DI; accoglie eccezione di prescrizione quinquennale parziale (solo una raccomandata interruppe) e ridetermina importo.
- Cass. civ. Sez. Lav. sent. n.9310/2022: sancisce necessità di preventiva contestazione all’iscritto per sanzioni Cassa Forense ex L.689/81; cartella priva di tale previo avviso è invalida.
- D.Lgs. 46/1999: art.24 co.3 vieta iscrizione a ruolo dei contributi se l’accertamento fiscale è impugnato salvo provvedimento esecutivo del giudice; art.24 co.5 fissa termini ricorso 40 giorni al giudice lavoro contro cartella contributi.
- D.Lgs. 509/1994 & D.Lgs.103/1996: decreti di privatizzazione casse professionali (Cassa Forense rientra nel 509/94, ENPAP nel 103/96). Prevedono autonomia regolamentare degli enti in materia contributiva nel rispetto dei principi generali (es: prescrizione, sanzioni).
- Legge 689/1981: artt.13-14 obbligo contestazione immediata o successiva di violazioni amministrative e termine per emanare ordinanza-ingiunzione; applicabile per sanzioni contributive Cassa Forense secondo Cass.2022.
- Art.2 comma 1-bis D.L. 463/1983 (conv. L.638/1983): punisce omesso versamento di ritenute previdenziali > €10.000 annui; soglia modif. da L. 311/2004; reato a dolo generico, esclusa punibilità se pagamento entro 3 mesi da contestazione.
- Cass. pen. Sez. III sent. n.4200/2025 (ud.18.11.2024): ribadisce che crisi di impresa non esime da reato di omesso versamento contributi dipendenti (a conferma orientamento).
- Cassa Forense – Regolamento Unico Previdenza 2021: art.63 disciplina inadempimento obblighi dichiarativi e avviso all’interessato. Regolamento sanzioni 2019: adesione accertamento contributivo riduce sanzione al 30%.
- ENPAP – Regolamento Previdenza: prevede prescrizione contributi 5 anni; disciplina sanzioni per ritardo >90gg = 1/5 contributo minimo.
- Legge 197/2022 (Bilancio 2023): ha introdotto compensazione crediti gratuito patrocinio con debiti contributivi (scadenza 30/4/2023); ha riaperto definizione agevolata liti e rottamazione-quater ruoli (includendo contributi).
- Tribunale Roma sent.6088/2013 e Corte Appello Roma sent.5927/2017 (citate in Cass.26531/2020) – caso Cassa Forense vs Equitalia su “non riscosso per riscosso” e discarichi ruoli: questione contabile non direttamente di difesa del contribuente ma rilevante per crediti ante 2000 condonati ex L.228/2012.
Accertamento fiscale su contributi ENPAP o Cassa Forense? Fatti Difendere da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento fiscale o un avviso di irregolarità sui contributi previdenziali dichiarati in dichiarazione dei redditi?
L’Agenzia delle Entrate contesta la deducibilità dei contributi versati a ENPAP, Cassa Forense, Inarcassa o altra cassa professionale?
Molti professionisti ricevono accertamenti in cui viene contestato l’uso improprio delle deduzioni previdenziali, o addirittura il mancato versamento dei contributi dichiarati. Ma con una difesa mirata puoi evitare il recupero delle imposte e delle sanzioni.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Verifica i contributi dichiarati, le ricevute di pagamento e i dati trasmessi dalla Cassa
- 📌 Accerta eventuali errori nei quadri dichiarativi o incongruenze nei modelli Redditi
- ✍️ Redige memorie difensive o istanze di correzione/autotutela all’Agenzia delle Entrate
- ⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio e in eventuale contenzioso tributario
- 🔁 Ti assiste nella corretta deduzione dei contributi nelle prossime dichiarazioni fiscali
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in contenzioso fiscale per liberi professionisti
- ✔️ Specializzato in dichiarazioni, deduzioni e accertamenti su contributi previdenziali
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Un accertamento su contributi ENPAP, Cassa Forense o altra Cassa può essere contestato se ci sono errori nei dati fiscali o nella trasmissione.
Con il supporto legale giusto puoi difenderti, evitare sanzioni ingiuste e proteggere la tua posizione previdenziale e fiscale.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa professionale comincia da qui.