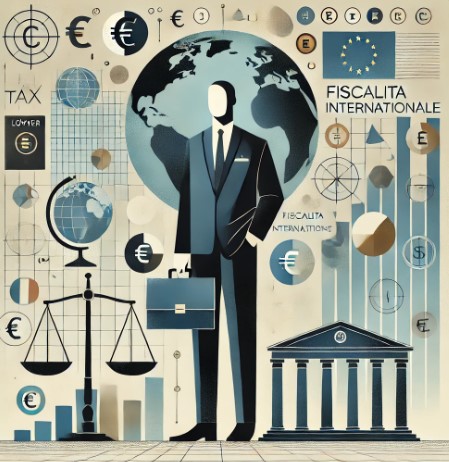Se hai beni, redditi o società all’estero – o risiedi fuori dall’Italia ma mantieni legami fiscali con il nostro Paese – potresti aver bisogno di un avvocato esperto in fiscalità internazionale. Questa figura, spesso definita anche fiscalista estero, è fondamentale per aiutarti a gestire correttamente gli obblighi tributari transnazionali, evitare la doppia imposizione e difenderti in caso di accertamenti fiscali legati all’estero.
Cosa fa un avvocato esperto in fiscalità internazionale?
– Ti assiste nella dichiarazione di investimenti esteri, immobili, conti correnti e partecipazioni (quadro RW)
– Ti aiuta a regolarizzare capitali detenuti all’estero con il ravvedimento operoso
– Verifica se sei realmente fiscalmente residente in Italia, oppure se puoi dimostrare una residenza estera effettiva
– Ti consiglia su come trasferire la residenza fiscale in modo corretto, evitando contestazioni di esterovestizione
– Ti tutela in caso di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate su redditi o patrimoni esteri
– Ti assiste nella difesa contro le lettere di compliance per mancata compilazione del quadro RW o per anomalie da CRS
– Ti guida nella pianificazione fiscale per operazioni transfrontaliere, trust, fondazioni o holding estere
Quando è utile affidarsi a un fiscalista esperto in estero?
– Se possiedi immobili o conti correnti fuori dall’Italia
– Se hai partecipazioni in società estere
– Se hai trasferito la residenza in un altro Paese ma continui ad avere interessi economici in Italia
– Se hai ricevuto una comunicazione o un accertamento su capitali esteri, dividendi, plusvalenze
– Se operi con trading, criptovalute, piattaforme online o investimenti esteri
– Se sei erede di un patrimonio con beni situati all’estero
Cosa può fare concretamente per te l’avvocato esperto in fiscalità internazionale?
– Analizza la tua posizione fiscale e individua eventuali rischi di accertamento
– Redige istanze, memorie difensive, ricorsi contro contestazioni su redditi e patrimoni esteri
– Predispone strategie di protezione patrimoniale nel rispetto delle normative internazionali
– Ti assiste nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, anche in fase di adesione o accertamento con contraddittorio
– Ti guida nella corretta compilazione della dichiarazione dei redditi con attività estere
– Ti supporta in caso di contestazioni per esterovestizione societaria o residenza fiscale fittizia
Perché scegliere un avvocato e non solo un commercialista?
Perché l’avvocato esperto in fiscalità internazionale non si limita alla parte contabile o dichiarativa:
– Ti difende in giudizio davanti alle Commissioni tributarie
– Può impugnare avvisi di accertamento, sanzioni e atti impositivi
– Ha competenza giuridica e processuale, fondamentale in ambito contenzioso
– È in grado di valutare rischi penali nei casi più gravi (es. autoriciclaggio, omessa dichiarazione RW)
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fiscalità internazionale, quadro RW e accertamenti esteri ti spiega cosa fa un fiscalista estero, quando serve e come può aiutarti a evitare sanzioni e contenziosi fiscali internazionali.
Hai conti, beni o redditi all’estero? Sei oggetto di una verifica dell’Agenzia delle Entrate? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione fiscale e ti diremo come agire per tutelarti al meglio.
Introduzione
Nell’era della globalizzazione economica, la fiscalità internazionale è divenuta un ambito cruciale sia per i privati che per le imprese. Spostarsi all’estero, investire oltre confine o operare tramite società multinazionali comporta l’applicazione di normative tributarie complesse, spesso concorrenti tra diversi Paesi. Un avvocato esperto in fiscalità internazionale – detto anche fiscalista estero – è il professionista che assiste contribuenti (persone fisiche e società) a navigare questa complessa rete di leggi fiscali, assicurando il rispetto delle norme e ottimizzando il carico fiscale nel rispetto della legge.
La fiscalità internazionale si occupa principalmente di evitare la doppia imposizione dei redditi (ossia che gli stessi redditi vengano tassati due volte, in Stati diversi) e, specularmente, di prevenire fenomeni di evasione o elusione sfruttando disallineamenti tra sistemi tributari nazionali. In base al principio del worldwide income, un soggetto fiscalmente residente in Italia è tassato su tutti i redditi ovunque prodotti, mentre un non residente è tassato in Italia solo sui redditi di fonte italiana. Ciò può portare allo scenario in cui uno stesso reddito venga attratto a tassazione in due Stati differenti (Stato della residenza e Stato della fonte). Per evitare questa “duplice tassazione” esistono strumenti normativi come il credito d’imposta per imposte estere (art. 165 TUIR), che consente al residente in Italia di scomputare dall’imposta italiana quanto già pagato all’estero. Inoltre, l’Italia ha stipulato numerose Convenzioni contro le doppie imposizioni che ripartiscono la potestà impositiva tra gli Stati contraenti, prevenendo conflitti fiscali. Questi accordi prevedono in alcuni casi una tassazione concorrente in entrambi gli Stati, in altri l’esclusiva tassazione in uno solo Stato. È importante notare che, per esplicita previsione normativa, se una disposizione interna italiana risulta più favorevole al contribuente rispetto a quella convenzionale, prevale la norma più favorevole (principio di prevalenza della fonte più vantaggiosa, art.169 TUIR).
In questo contesto, l’avvocato specializzato in fiscalità internazionale svolge un ruolo fondamentale: assistere dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta) chiunque abbia interessi fiscali oltre confine, sia per pianificare correttamente le proprie attività sia per difendersi da eventuali contestazioni del Fisco. Questa guida approfondisce cosa fa in concreto un esperto in fiscalità internazionale, analizzando la normativa italiana aggiornata a luglio 2025 (comprese le più recenti riforme e sentenze), con un taglio avanzato ma dal linguaggio chiaro. Troverete tabelle riepilogative, esempi pratici, domande e risposte, il tutto con riferimenti a fonti ufficiali e giurisprudenza recente. L’obiettivo è offrire una panoramica completa, utile ad avvocati, privati cittadini e imprenditori che necessitano di orientamento in materia tributaria internazionale.
Cos’è la Fiscalità Internazionale?
La fiscalità internazionale è quella branca del diritto tributario che si occupa delle questioni fiscali con elementi di internazionalità, ovvero di situazioni in cui due o più sistemi fiscali nazionali interagiscono sullo stesso presupposto impositivo. Tipicamente, ciò avviene quando un soggetto risiede in uno Stato ma produce redditi in un altro Stato, oppure detiene beni e investimenti oltre confine, o ancora quando opera tramite società estere. In tali casi occorre stabilire quali Stati abbiano il potere di tassare e in che misura.
I principi cardine della fiscalità internazionale sono essenzialmente due:
- Principio di residenza (worldwide taxation): il Paese di residenza fiscale di un soggetto tassa tutti i redditi ovunque prodotti dal soggetto medesimo. In Italia, l’art. 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) sancisce che i soggetti residenti sono tassati su tutti i redditi posseduti, indipendentemente da dove questi sono stati prodotti.
- Principio della fonte (territorialità): ciascuno Stato può tassare i redditi generati nel proprio territorio da parte di soggetti non residenti. Sempre l’art. 3 TUIR stabilisce infatti che i non residenti sono tassati in Italia solo sui redditi prodotti nel territorio italiano (ad esempio un cittadino straniero che abbia un immobile locato in Italia pagherà le imposte in Italia su quel reddito).
Questa “doppia prospettiva” può generare doppia imposizione internazionale, ossia la medesima base imponibile tassata due volte, una nel Paese di residenza e una nel Paese della fonte. Per ovviare a ciò intervengono le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (in inglese Double Taxation Agreements, DTA) stipulate tra Stati: l’Italia ne ha concluse molte, che disciplinano quale Stato tassa quali categorie di reddito, evitando sovrapposizioni. In assenza di convenzione, il TUIR prevede comunque il meccanismo unilaterale del credito per imposte estere: se un residente italiano paga un’imposta su un reddito all’estero, può detrarla dall’imposta dovuta in Italia su quello stesso reddito (entro certi limiti proporzionali).
Un altro aspetto della fiscalità internazionale è il monitoraggio fiscale dei capitali all’estero: gli Stati (Italia inclusa) vogliono evitare che i propri residenti nascondano redditi o ricchezze in Paesi esteri a bassa fiscalità. Per questo esistono obblighi dichiarativi specifici (ad esempio il quadro RW in Italia per dichiarare investimenti esteri) e strumenti di cooperazione internazionale tra Amministrazioni finanziarie (scambio di informazioni automatico su conti finanziari, accordi come il FACTA con gli USA, direttive UE DAC). Di questo tratteremo diffusamente più avanti.
In sintesi, la fiscalità internazionale è un ambito dinamico e complesso, che richiede un costante aggiornamento: basti pensare alle recenti iniziative come la Global Minimum Tax del 15% per le multinazionali (recepita dall’UE nel 2022 e dall’Italia nel 2023), oppure alle continue pronunce giurisprudenziali su casi di esterovestizione (fittizio trasferimento della residenza fiscale all’estero) e di abuso delle convenzioni internazionali.
Il Ruolo dell’Avvocato Fiscalista Internazionale
Cosa fa in concreto un avvocato esperto in fiscalità internazionale? Le sue competenze spaziano su più fronti, combinando conoscenze di diritto tributario nazionale, norme convenzionali e diritto internazionale pubblico, con nozioni di diritto penale-tributario e procedura tributaria. Di seguito le principali aree di attività di un fiscalista internazionale:
- Consulenza e pianificazione fiscale internazionale: analisi preventiva delle attività cross-border del cliente per ottimizzare il carico fiscale nel rispetto della legge (tax planning lecito, distinto dall’evasione). L’avvocato suggerisce le soluzioni più efficienti, ad esempio scegliendo la forma societaria o la giurisdizione più adatta per un investimento estero, tenendo conto delle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili e delle normative anti-elusive. Per i privati, offre consulenza sul trasferimento della residenza fiscale (ad esempio per pensionati o imprenditori che si spostano all’estero) e sull’accesso a eventuali regimi agevolati (come il regime speciale per “impatriati” che trasferiscono la residenza in Italia, o la flat tax per nuovi residenti facoltosi, di cui diremo oltre).
- Gestione della compliance internazionale: assistenza nel rispettare tutti gli obblighi dichiarativi e comunicativi previsti in Italia per chi ha attività estere. Ciò include la compilazione del quadro RW (monitoraggio di investimenti finanziari e patrimoniali esteri), il calcolo e versamento di IVIE e IVAFE (imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie estere), nonché l’eventuale richiesta di rimborsi o crediti d’imposta per imposte pagate all’estero. Un esperto fiscalista tiene aggiornato il cliente sulle scadenze e sulle novità normative (es. nuovi accordi sullo scambio informazioni, liste di Paesi “non cooperativi”, etc.). In caso di redditi esteri, valuta l’applicazione delle convenzioni per evitare doppia imposizione e prepara eventuali istanze di interpello internazionale all’Agenzia delle Entrate per quesiti interpretativi complessi.
- Contenzioso tributario internazionale e difesa del contribuente: se il Fisco italiano avvia un accertamento in materia internazionale (ad esempio contestando una esterovestizione di residenza, l’esistenza di una stabile organizzazione occulta in Italia, o prezzi di trasferimento non congrui tra consociate estere e italiane), l’avvocato tributarista interviene per difendere il contribuente. Ciò avviene sia nella fase amministrativa (redazione di memorie, adesione, accertamento con adesione) sia dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie). Un bravo fiscalista internazionale conosce la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, e sa impostare la strategia difensiva appropriata. Ad esempio, in caso di contestazione di residenza estera fittizia, saprà che l’onere della prova dell’esterovestizione grava in primis sull’Amministrazione finanziaria, come affermato da varie sentenze (Cass. 5003/2024), e utilizzerà documentazione e testimonianze per dimostrare la reale residenza estera del cliente quando possibile.
- Assistenza nel penale tributario internazionale: se dalle violazioni fiscali emergono ipotesi di reato tributario, l’avvocato (spesso in coordinamento con un penalista) tutela il contribuente nelle indagini e nel processo penale. I casi tipici includono l’omessa dichiarazione di redditi esteri (art.5 D.Lgs. 74/2000) quando l’imposta evasa supera soglie di punibilità, la dichiarazione infedele (art.4) per avere occultato attivi esteri, o la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11) qualora il contribuente abbia occultato o trasferito beni allo scopo di non pagare imposte o sanzioni. Un esempio recente di rilevanza è la pronuncia della Cassazione n.20649/2025, che ha escluso il reato di sottrazione fraudolenta in un caso di trasferimento di capitali all’estero volto a evitare il pagamento di sanzioni amministrative del quadro RW, in assenza però di una contestazione di reale imposta evasa sui redditi esteri. Questa e altre sentenze (che approfondiremo) evidenziano come sia fondamentale, per la difesa, conoscere i confini tra illecito amministrativo e penale in ambito internazionale.
- Supporto in operazioni societarie straordinarie e transfrontaliere: un fiscalista internazionale affianca le imprese nelle fusioni, acquisizioni o riorganizzazioni che coinvolgono società estere. Fornisce pareri sulla struttura ottimale (ad esempio creazione di sub-holding in Paesi a fiscalità privilegiata rispettando le norme CFC, o scelta di finanziare una consociata estera con capitale vs debito per sfruttare deduzioni su interessi in limiti consentiti), cura la due diligence fiscale internazionale e predispone accordi preventivi (ruling) con l’Agenzia delle Entrate quando necessari per dare certezza al trattamento fiscale di operazioni complesse. Ad esempio, può negoziare accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (Advance Pricing Agreements, APA) per conto di un gruppo multinazionale, in modo da evitare future contestazioni su come vengono valorizzati i beni e servizi scambiati intra-gruppo.
- Interlocuzione con professionisti esteri e autorità straniere: spesso l’avvocato fiscalista internazionale opera in network con studi legali e fiscali stranieri, per garantire al cliente un’analisi coordinata sulle normative di più Stati. Partecipa inoltre a procedure amichevoli tra Stati, come la Mutual Agreement Procedure (MAP) prevista dai trattati o dalla Convenzione arbitrale UE, qualora il contribuente subisca una doppia imposizione non risolta dalle vie ordinarie. Il fiscalista internazionale rappresenta il cliente anche in caso di verifiche condotte congiuntamente da autorità estere (ad es. audit fiscali simultanei Italia-estero) e conosce le procedure di scambio di informazioni attivabili su richiesta dell’Amministrazione (art.26 Modello OCSE e Direttive UE in materia).
In sintesi, il taglio professionale di un avvocato esperto in fiscalità internazionale è a 360 gradi: dalla consulenza preventiva per evitare problemi, fino alla difesa contenziosa e penale quando necessario, passando per il costante aggiornamento normativo. Nel prossimo capitolo entreremo nel vivo delle principali tematiche affrontate da questo professionista, dal concetto di residenza fiscale ai meccanismi di imposizione delle imprese multinazionali, dalle norme anti-elusive alle sanzioni penali tributarie internazionali.
Principali Tematiche della Fiscalità Internazionale
In questa sezione esamineremo gli argomenti chiave che un fiscalista internazionale deve dominare. Si tratta di concetti e normative di livello avanzato, il cui approfondimento è essenziale per fornire consulenza qualificata. Per ciascun tema verranno illustrati i punti principali, con riferimento alla normativa italiana vigente (incluse le novità normative 2024-2025) e alla giurisprudenza più recente.
Residenza Fiscale delle Persone Fisiche
Quando un individuo è considerato “fiscalmente residente” in Italia? La risposta è data dall’art. 2 del TUIR, che fissa tre criteri alternativi (anche uno solo soddisfatto è sufficiente) per essere considerati residenti ai fini delle imposte sui redditi in un dato periodo d’imposta:
- Iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni l’anno).
- Domicilio in Italia ai sensi del codice civile (art. 43 c.c.), inteso come sede principale degli affari e interessi, non necessariamente coincidente con la residenza anagrafica.
- Residenza (abituale dimora) in Italia, ossia la dimora abituale intesa come presenza fisica, anch’essa per più di 183 giorni l’anno.
Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) che si trasferiscono in Paesi a fiscalità privilegiata, la legge prevede una presunzione relativa di residenza in Italia, salvo prova contraria: significa che l’Italia li considera comunque residenti fiscali italiani (tassati sul worldwide income) a meno che dimostrino di essersi effettivamente stabiliti all’estero (questa presunzione è contenuta nell’art. 2, co. 2-bis TUIR). Di conseguenza, chi intende trasferirsi fuori dall’Italia deve non solo iscriversi all’AIRE, ma anche trasferire effettivamente il centro dei propri interessi fuori dall’Italia, per evitare future contestazioni di residenza fittizia.
Effetti della residenza fiscale: Se una persona è fiscalmente residente in Italia, sarà soggetta a tassazione in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti (principio worldwide). I non residenti, invece, pagano imposte in Italia solo sui redditi di fonte italiana (principio di territorialità). Pertanto, la determinazione corretta della residenza è cruciale: ad esempio, un cittadino italiano che vive e lavora stabilmente nel Regno Unito potrebbe evitare la tassazione in Italia sui redditi esteri solo se riesce a dimostrare la perdita della residenza fiscale italiana e l’acquisto di quella britannica secondo i criteri sopra detti e la Convenzione Italia–UK.
Doppia residenza e conflitti: Può accadere che due Stati considerino la stessa persona come residente (ad esempio, Italia e Francia se il soggetto ha legami forti con entrambi). In tali casi intervengono le tie-break rules previste nelle convenzioni: criteri come l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale e infine la cittadinanza, vengono applicati in sequenza per attribuire la residenza fiscale ad uno solo dei due Stati. In mancanza di accordo, le autorità possono risolvere il caso attraverso una procedura amichevole (MAP). Anche il place of effective management può essere rilevante per i soggetti diversi dalle persone fisiche (si veda oltre, in tema di società).
Residenza e regime di tassazione per i residenti esteri: Una persona fisica non residente, come detto, paga le imposte in Italia solo sui redditi prodotti nel territorio italiano. L’art. 23 TUIR elenca i criteri per definire se un reddito è “prodotto in Italia” (ad esempio: i redditi fondiari lo sono se i beni immobili sono in Italia; i redditi di lavoro se l’attività è svolta in Italia; i dividendi se la società che li distribuisce è italiana, ecc.). Il calcolo dell’imposta per i non residenti avviene allo stesso modo dei residenti (aliquote IRPEF progressive, ecc.), con la particolarità che i non residenti non beneficiano di alcune detrazioni e deduzioni previste per i residenti, tranne poche eccezioni (alcune spese deducibili molto specifiche e le detrazioni per lavoro dipendente). Questo implica che un non residente, a parità di reddito imponibile, potrebbe pagare in Italia un’imposta maggiore di un residente, non potendo ad esempio detrarre carichi di famiglia o interessi passivi su mutuo (salvo sia residente in UE/SEE e ricorrano certe condizioni di equiparazione).
Esempio pratico: Mario, cittadino italiano, si trasferisce fiscalmente in Portogallo aderendo a un regime locale per pensionati esteri, e si iscrive all’AIRE. Se Mario soddisfa i requisiti di residenza in Portogallo (passa lì più di 183 giorni l’anno, affitta casa stabile, ecc.) e non mantiene in Italia né abitazione né famiglia, l’Italia lo considererà non residente. Di conseguenza, la sua pensione italiana potrà – in base alla convenzione Italia-Portogallo – essere tassata solo in Portogallo e in Italia non dovrà nulla (o potrebbe subire in Italia una ritenuta a titolo d’imposta ridotta, secondo il trattato). Viceversa, se Mario omette l’iscrizione all’AIRE e di fatto trascorre buona parte dell’anno ancora in Italia, l’Agenzia delle Entrate potrà considerarlo residente italiano e chiedere le imposte italiane sui suoi redditi ovunque prodotti, disconoscendo il trasferimento all’estero come esterovestizione della residenza.
Residenza Fiscale delle Società ed Esterovestizione
Strettamente collegata al tema precedente è la residenza fiscale delle società e degli enti. In Italia la disciplina è contenuta nell’art. 73 del TUIR, che recentemente è stato modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (attuativo della legge delega di riforma fiscale 2023). Secondo le nuove regole (in vigore dal 1° gennaio 2024), sono considerate fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno in Italia la sede legale oppure la sede di direzione effettiva oppure la sede della gestione ordinaria in via principale.
- Sede legale: il luogo indicato nell’atto costitutivo/statuto dell’ente (criterio formale, rimasto invariato).
- Sede di direzione effettiva: il luogo in cui vengono assunte in modo continuativo e coordinato le decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso. In pratica, dove si riuniscono gli organi direttivi apicali e da cui proviene l’impulso gestionale.
- Gestione ordinaria in via principale: il luogo in cui, sempre in modo continuativo e coordinato, si svolgono gli atti di gestione corrente dell’ente (una nozione nuova introdotta dal 2024, parallela alla direzione effettiva).
Rispetto al passato, la novità è l’eliminazione del vecchio criterio dell’oggetto principale (che causava incertezze interpretative) e la sua sostituzione con quello della “gestione ordinaria”. Resta ferma la regola che basta uno solo di questi criteri (alternatività) per qualificare la residenza in Italia di una società, e che il criterio deve sussistere per più di metà anno.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, ha chiarito che sostanzialmente, al di là del linguaggio nuovo, permane la continuità con la normativa previgente: la sede legale in Italia da sola continua a essere sufficiente a rendere residente la società, mentre la “sede dell’amministrazione” è ora articolata nei due criteri di sede di direzione effettiva e gestione ordinaria, più precisi. In pratica, l’intento è allinearsi alle prassi internazionali e al concetto di place of effective management. L’Agenzia riconosce però che ciò non esclude possibili casi di doppia residenza societaria (ad esempio, un Paese estero potrebbe considerare la stessa società residente da loro in base ad altri criteri), ma in tali situazioni opereranno le clausole risolutive dei trattati contro le doppie imposizioni, che generalmente assegnano la residenza allo Stato in cui si trova il place of effective management (sede di direzione effettiva).
Una problematica centrale legata alla residenza delle società è la esterovestizione: si ha esterovestizione quando una società formalmente costituita all’estero viene di fatto gestita dall’Italia, al solo scopo di ottenere una tassazione più favorevole, risultando quindi fittiziamente localizzata fuori dai confini. In tali casi, l’Amministrazione finanziaria italiana tende a riqualificare la società come residente in Italia, con tutte le conseguenze del caso (tassazione in Italia dei redditi mondiali della società, applicazione delle sanzioni per dichiarazioni omesse/infedeli se non ha dichiarato nulla in Italia, ecc.).
La legge italiana da tempo contrasta l’esterovestizione con alcune presunzioni legali relative inserite nell’art. 73 TUIR. Ad esempio, salvo prova contraria, sono considerate residenti in Italia anche le società ed enti esteri che:
- sono controllati da soggetti residenti in Italia (anche indirettamente) oppure sono amministrati da un consiglio di amministrazione con maggioranza di consiglieri residenti in Italia, e al contempo hanno talune caratteristiche (detengono partecipazioni di controllo di società residenti, oppure hanno asset prevalentemente investiti in immobili tramite fondi, etc.).
Queste presunzioni (art. 73, commi 5-bis e 5-ter TUIR) significano che, ad esempio, una holding costituita in Lussemburgo ma controllata al 100% da una famiglia italiana e gestita di fatto dai membri della famiglia, viene presunta residente in Italia, a meno che provi concretamente di avere una reale direzione all’estero indipendente dai residenti italiani. La prova contraria può consistere, tra l’altro, nel dimostrare che le decisioni strategiche vengono prese all’estero da amministratori non italiani e che la società ha una struttura operativa reale fuori Italia (uffici, dipendenti, attività economica effettiva nel Paese di insediamento).
Giurisprudenza recente in tema di esterovestizione: La Corte di Cassazione ha più volte affrontato casi di esterovestizione societaria, offrendo importanti chiarimenti. Una sentenza di particolare rilievo è la n. 17289/2024 (Sez. Tributaria), la quale ha ribadito che la “sede di direzione effettiva” di una società va individuata nel luogo in cui sono assunte le decisioni amministrative e strategiche, non va confusa col luogo dove si trovano gli asset o gli immobili sociali. In quel caso, una società lussemburghese proprietaria di immobili in Italia era stata considerata residente in Italia dalla Commissione Tributaria, solo perché i beni sociali (immobili) erano qui ubicati e generavano reddito in Italia. La Cassazione ha censurato questo approccio: per individuare la sede effettiva bisogna guardare dove si svolge l’attività degli organi decisionali apicali, dove si tengono le assemblee, dove risiedono gli amministratori, dove si adottano le politiche finanziarie, ecc., e non semplicemente dove sono collocati fisicamente gli immobili o da dove proviene il fatturato. Dunque, se la gestione (decisioni su affitti, politiche di investimento, ecc.) avveniva in Lussemburgo, la società non poteva dirsi esterovestita solo perché i suoi beni erano in Italia.
Un altro aspetto sottolineato dalla giurisprudenza è la distinzione tra esterovestizione in ambito UE e extra-UE. Per le società situate in Paesi UE occorre considerare la libertà di stabilimento garantita dai Trattati europei: una contestazione di residenza fittizia verso una società in uno Stato membro non può basarsi unicamente sul vantaggio fiscale, ma deve dimostrare che l’insediamento all’estero è meramente artificioso e privo di sostanza economica reale. In altre parole, nell’UE la linea di confine con l’abuso del diritto (oggi codificato nell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente) è sottile: la Cassazione (sent. n.1883/2023) ha affermato che la contestazione dev’essere “strutturata diversamente” se la società è in UE, dovendo tener conto che limitare la libertà di stabilimento è lecito solo per prevenire abusi reali. Fuori dall’UE, invece, l’amministrazione ha mano più libera nel presumere l’abuso se vede schemi puramente elusivi.
Conseguenze dell’esterovestizione: se una società estera viene considerata residente in Italia, l’Agenzia delle Entrate richiederà le imposte sui redditi ovunque prodotti dalla società, tipicamente recuperando a tassazione gli utili non dichiarati in Italia. Potranno essere contestate le violazioni di omessa dichiarazione dei redditi (con sanzioni amministrative dal 120% al 240% dell’imposta evasa, oltre interessi) e, se i numeri lo giustificano, potranno scattare denunce penali per omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs.74/2000) a carico degli amministratori di fatto. Nel caso di specie della sentenza 17289/2024, la Cassazione ha proprio evidenziato come la rettifica della residenza in Italia “dispiega i suoi effetti anche ai fini dell’imposizione indiretta” come l’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari – segnalando che l’esterovestizione non riguarda solo le imposte sui redditi ma anche eventuali atti societari che, se la società è estera, erano stati tassati in modo diverso.
In pratica, un avvocato fiscalista dovrà assistere il cliente nel fornire la prova contraria all’esterovestizione (esibendo documenti che mostrino la reale attività all’estero, verbali, contratti stipulati all’estero, etc.), oppure – se la posizione del contribuente è indifendibile – nel regolarizzare la situazione (valutando adesione, ravvedimento operoso se possibile, o transazioni in sede contenziosa) limitando sanzioni e conseguenze penali.
Doppia Imposizione e Convenzioni Internazionali
Come accennato, uno dei pilastri della fiscalità internazionale è la lotta alla doppia imposizione giuridica. Ciò avviene principalmente tramite le Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) bilaterali che l’Italia ha stipulato con numerosi Paesi (oltre 100 convenzioni in vigore). Tali accordi si ispirano in gran parte al Modello OCSE di convenzione fiscale e prevedono norme uniformi su definizioni (residenza, stabile organizzazione, ecc.) e ripartizione della potestà impositiva sui vari tipi di reddito (redditi immobiliari, d’impresa, di lavoro, pensioni, interessi, dividendi, royalties, plusvalenze, ecc.).
In base alle convenzioni, alcuni redditi sono tassabili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario (criterio di tassazione esclusiva), altri sono tassabili in entrambi gli Stati ma con limiti (criterio di tassazione concorrente) e con l’obbligo per lo Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione, in genere tramite credito d’imposta. Ad esempio, un dividendo pagato da una società francese a un residente italiano può essere tassato in Francia (imposta alla fonte, con aliquota limitata dal trattato, ad es. 15%) e poi tassato in Italia come reddito di capitale del residente, ma l’Italia dovrà dare credito per l’imposta francese pagata, evitando il doppio carico.
La normativa interna italiana prevede anch’essa strumenti unilaterali di relief: l’art. 165 TUIR sul foreign tax credit, già citato, consente il credito per imposte estere pagate su redditi esteri poi tassati in Italia. Il credito spetta fino a concorrenza dell’imposta italiana proporzionalmente riferibile a quel reddito estero. Se l’imposta estera superasse quella italiana, l’eccedenza di norma non è rimborsabile (alcune convenzioni però prevedono meccanismi di esenzione per evitare la doppia tassazione su certi redditi: ad esempio, la convenzione Italia-Svizzera prevede l’esenzione in Italia per alcuni redditi prodotti in Svizzera da residenti italiani, come gli stipendi pubblici svizzeri).
Un elemento importante: il trattato può derogare alla legge interna, ma vige un principio nel nostro ordinamento (art. 169 TUIR) per cui se la legge interna è più favorevole del trattato, si può applicare la legge interna. Ad esempio, se una norma interna esenta un certo reddito estero e il trattato invece darebbe solo un credito d’imposta, il contribuente può scegliere l’esenzione interna (più favorevole). Questo principio tutela il contribuente assicurando che il trattato sia un “ombrello di protezione” minimo e non peggiori mai la sua posizione.
Clausole anti-abuso nei trattati: Va segnalato che, negli ultimi anni, molte convenzioni includono disposizioni per prevenire utilizzi impropri (treaty shopping). Dopo il progetto BEPS dell’OCSE, è stata introdotta nelle CDI una clausola generale detta Principal Purpose Test (PPT): se uno dei principali scopi di un’operazione o struttura è ottenere un beneficio di convenzione, tale beneficio può essere negato. Inoltre l’Italia ha sottoscritto il Multilateral Instrument (MLI) OCSE che modifica in blocco molte convenzioni con clausole anti-abuso e procedure di risoluzione dispute più efficaci.
Procedure amichevoli (MAP) e arbitrati: Qualora un contribuente subisca un’imposizione non conforme alla convenzione (ad esempio doppia tassazione non risolta), può attivare la Mutual Agreement Procedure prevista nei trattati: l’autorità competente italiana (Dipartimento Finanze – ufficio per le convenzioni internazionali) si consulterà con l’autorità dell’altro Stato per eliminare la doppia imposizione, trovando un accordo (che spesso comporta che uno dei due Stati rinunci parzialmente alla sua pretesa). Dal 2019 è in vigore anche la Direttiva UE 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle dispute fiscali in ambito UE, che prevede un arbitrato vincolante se le autorità non trovano accordo entro 2 anni: questo strumento potenzia la tutela dei contribuenti, costringendo gli Stati membri a evitare doppie imposizioni protratte nel tempo.
Per un avvocato fiscalista internazionale, conoscere approfonditamente le convenzioni applicabili e le procedure di MAP/arbitrato è essenziale: ad esempio, nel caso di un imprenditore italiano tassato su un reddito estero sia in Italia che nel Paese fonte (nonostante la convenzione), l’avvocato potrà presentare istanza di MAP all’autorità italiana entro i termini (di solito 3 anni dal primo avviso di imposizione) e seguire l’iter negoziale sino alla soluzione (che potrà comportare, ad esempio, uno sgravio parziale in Italia con restituzione delle imposte eccedenti).
Stabile Organizzazione delle Imprese Estere
Il concetto di stabile organizzazione (SO) è fondamentale nella tassazione delle imprese internazionali. Riguarda in particolare le imprese non residenti che operano in Italia: se la loro attività nel territorio configura una “stabile organizzazione”, allora l’Italia ha il diritto di tassarne i redditi prodotti qui, attribuendo a tale SO un utile come se fosse una filiale autonoma. In assenza di SO, invece, l’impresa estera generalmente non è tassabile in Italia tranne che per ritenute su certi redditi specifici (es. royalties, interessi, ecc.).
La definizione legislativa italiana di stabile organizzazione si trova nell’art. 162 TUIR (introdotto dal 2018, prima ci si basava solo sulle convenzioni e il modello OCSE). L’art. 162 TUIR recepisce in gran parte la definizione internazionale: “una sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”. Sono espressamente esempi di stabile organizzazione: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, una miniera o cava, ecc.. Nel 2018 è stata aggiunta la lettera f-bis) che considera SO anche “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non evidenziare una presenza fisica”. Questa innovazione mira a colpire le attività digitali di imprese estere (ad esempio colossi del web) che operano stabilmente sul mercato italiano generando valore, pur senza strutture fisiche: se c’è una presenza economica rilevante (per numero di utenti, volume d’affari, ecc.), si può configurare una SO “virtuale” in Italia ai fini fiscali.
Sono invece escluse dalla nozione di SO le strutture ausiliarie o preparatorie, come depositi di merce, esposizioni, consegne, acquisti di beni, raccolta informazioni, e altre attività di supporto che non costituiscono il core business. Questa lista di attività esenti riflette l’art. 5(4) del Modello OCSE e serve a chiarire che, ad esempio, un semplice magazzino di stoccaggio di proprietà di un’azienda estera in Italia non è di per sé una stabile organizzazione tassabile, se usato solo per consegne.
Oltre alla stabile organizzazione “materiale” (sede fissa), esiste la stabile organizzazione personale: quando una persona (fisica o giuridica) agente in Italia conclude abitualmente contratti in nome dell’impresa estera o svolge comunque un ruolo essenziale nella conclusione di contratti, l’impresa estera può considerarsi avente una SO tramite quell’agente, anche senza una sede fissa. Questo è previsto sia dalle convenzioni (art. 5 del Modello OCSE) sia recepito nell’art. 162 TUIR. Fa eccezione l’agente indipendente: se l’agente italiano è veramente indipendente e lavora per molti clienti, la sua attività non configura una SO dell’impresa estera.
Perché è importante la stabile organizzazione? Perché se la si configura, l’impresa estera deve dichiarare in Italia i redditi attribuibili a quella SO e pagarci le imposte italiane (IRES al 24% sugli utili netti e, se applicabile, IRAP). Di contro, i redditi della SO non saranno tassati anche nello Stato estero della casa madre (grazie all’esenzione o al credito d’imposta previsto dai trattati). In pratica la SO viene trattata come se fosse un’entità separata: deve tenere una contabilità separata, viene tassata sugli utili, e se trasferisce utili alla casa madre estera, quei utili non subiscono ritenuta (non essendo dividendi formalmente, ma mero trasferimento interno).
Rischio di stabile organizzazione occulta: Molte controversie sorgono quando il Fisco italiano sostiene che un’impresa estera operava da anni con una SO di fatto non dichiarata (ad esempio tramite un agente locale che in realtà è dipendente mascherato, o tramite una filiale non dichiarata). In tali casi l’Agenzia recupera le imposte su tutti i redditi che attribuisce alla SO non dichiarata, spesso con sanzioni per omessa dichiarazione. Un avvocato fiscalista assiste l’azienda in due modi: preventivamente, evitando di incorrere in SO indesiderate (strutturando bene i contratti degli agenti, limitando la presenza fisica in Italia, ecc.), e a posteriori, difendendo il contribuente se la SO viene contestata, eventualmente dimostrando che l’attività in Italia era preparatoria o che l’agente era indipendente.
Novità recente – Investment Management Exemption: Per rendere l’Italia più attrattiva come piazza finanziaria, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’esenzione mirata riguardo alle stabili organizzazioni. È stato stabilito che non costituisce stabile organizzazione in Italia il fatto che un soggetto indipendente (un gestore) svolga attività di gestione di investimenti per conto di un fondo/veicolo d’investimento estero. In altre parole, se un fondo estero affida la gestione a un asset manager italiano, tale asset manager non “attraversa” la soglia della SO per il fondo, a condizione che rispetti certe condizioni (indipendenza, svolgimento di attività analoghe per altri, remunerazione a mercato, ecc.). Questo regime – detto Investment Management Exemption – allinea l’Italia a Londra e altre piazze finanziarie, per evitare che i fondi esteri evitino di usare gestori italiani per timore di creare involontariamente una base imponibile in Italia.
In conclusione, la stabile organizzazione è un concetto tecnico ma cruciale: l’avvocato fiscalista deve saper individuare se un cliente estero stia rischiando di avere una SO in Italia (o viceversa, se un’azienda italiana rischia una SO all’estero) e porre in essere misure contrattuali e operative per mitigare il rischio fiscale. Ad esempio, potrebbe consigliare a una società straniera di aprire direttamente una sede secondaria dichiarata in Italia (ottenendo una partita IVA italiana, dichiarando redditi, ecc.) per regolarizzare la propria posizione ed evitare contestazioni peggiori in futuro.
Transfer Pricing e Prezzi di Trasferimento
Le operazioni infragruppo internazionali – cioè quelle tra società appartenenti al medesimo gruppo multinazionale ma residenti in Stati diversi – devono essere effettuate a valori di mercato (arm’s length principle). Il transfer pricing riguarda proprio la determinazione dei prezzi di trasferimento di beni, servizi e finanziamenti all’interno di un gruppo societario, in modo da evitare che attraverso prezzi “di comodo” si spostino utili imponibili da un paese all’altro (di solito verso paesi a tassazione inferiore).
In Italia, il principio di libera concorrenza nei prezzi di trasferimento è sancito dall’art. 110, comma 7 del TUIR: se i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti controllate, controllanti o consociate risultano inferiori o superiori a quelli che sarebbero stati praticati tra indipendenti a normali condizioni di mercato, l’Amministrazione finanziaria può rettificare i redditi imponibili della società italiana, riportandoli al valore di mercato. In pratica, se una società italiana vende beni a una consociata estera a un prezzo troppo basso (rispetto al fair value), il Fisco può aumentare il suo imponibile come se avesse incassato il prezzo pieno; viceversa, se acquista a prezzo troppo alto da una collegata estera, può ridurre la deduzione di costi al prezzo normale.
I metodi per determinare il prezzo di libera concorrenza sono quelli indicati dalle Linee Guida OCSE (metodo del confronto di prezzo, del prezzo di rivendita, del costo maggiorato, ecc., e metodi profit-based). Un avvocato fiscalista deve collaborare spesso con i dottori commercialisti esperti in transfer pricing per predisporre la documentazione idonea a giustificare i criteri di prezzo seguiti. L’Italia infatti prevede che, qualora il contribuente predisponga la documentazione transfer pricing (Masterfile e Documentazione Nazionale, secondo standard definiti da Provvedimenti dell’Agenzia Entrate) e lo comunichi in dichiarazione dei redditi, in caso di successiva rettifica TP non si applicano le sanzioni amministrative (resta dovuta l’imposta eventualmente accertata). Si tratta di un regime di penalty protection molto importante: incentiva le imprese multinazionali a dotarsi di apposita documentazione di transfer pricing, da esibire in caso di verifica, per evitare multe.
Dal punto di vista pratico, il fiscalista internazionale assiste l’azienda nella redazione o revisione dei contratti infragruppo (licenze di marchi, finanziamenti intercompany, contratti di servizio, accordi di ripartizione costi, ecc.), verificando che le condizioni economiche siano arm’s length. Ad esempio, se una controllata italiana paga royalties a una capogruppo estera per l’uso di un marchio, il fiscalista valuterà se la royalty (in percentuale sulle vendite) è allineata ai tassi di mercato per licenze simili; in caso contrario, l’Italia potrebbe contestare parte di quelle royalties come indebita erosione della base imponibile.
Profili internazionali recenti: L’Italia ha recepito l’Action 13 BEPS dell’OCSE: le multinazionali di grandi dimensioni sono soggette a Country-by-Country Reporting (comunicazione annuale all’Agenzia Entrate dei principali dati economici e fiscali per ogni paese in cui operano, poi scambiati tra autorità). Inoltre, con la Direttiva DAC6 (2018/822/UE), certi meccanismi transfrontalieri potenzialmente elusivi, anche riguardanti transfer pricing, devono essere comunicati alle autorità (mandatory disclosure) – obbligo in capo agli intermediari o ai contribuenti. Un avvocato fiscalista deve essere consapevole di questi obblighi per evitare omissioni (DAC6 prevede sanzioni per mancata segnalazione di schemi elusivi transfrontalieri).
Risoluzione preventiva delle dispute TP: Un altro campo di azione è la negoziazione degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (APA – Advance Pricing Agreements) con l’Amministrazione finanziaria. L’azienda può chiedere di concordare in anticipo con il Fisco il metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento per certe operazioni, ottenendo così certezza per il futuro (tipicamente per 3-5 anni). L’APA può essere unilaterale (solo con l’Italia) o bilaterale/plurilaterale (coinvolge anche le amministrazioni degli altri Paesi interessati, tramite MAP parallela). Un fiscalista internazionale spesso istruisce e conduce queste procedure, predisponendo position paper, analisi economiche e partecipando a meeting con l’Ufficio Accordi Preventivi dell’Agenzia Entrate. Ciò rientra nella strategia di tax risk management che i grandi gruppi adottano per evitare contenziosi costosi.
Esempio pratico: Un gruppo italiano ha consociate produttive in Est Europa che vendono semilavorati alla società madre italiana. L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare che i prezzi di cessione sono troppo bassi (lasciando troppi utili tassati a bassa aliquota nell’Est Europa anziché in Italia). Per evitare ciò, il gruppo può stipulare un APA con l’Agenzia concordando un margine minimo sulle vendite per le consociate estere (così che la quota di utili in Italia sia adeguata). L’avvocato fiscalista predisporrà l’accordo e garantirà che, se rispettato, l’Agenzia non effettuerà rettifiche.
Norme Antielusive Internazionali: CFC, Dividendi Esteri, Abuso del Diritto
I sistemi tributari nazionali, oltre a tassare e regolare, prevedono norme antielusive specifiche per situazioni internazionali, al fine di contrastare lo spostamento artificioso di imponibile verso Paesi a fiscalità privilegiata. Di seguito alcune delle principali norme italiane in materia:
- Controlled Foreign Companies (CFC): La normativa CFC (art. 167 TUIR) mira a impedire che si costituiscano società controllate in paradisi fiscali per accumularvi utili tassati quasi zero, lasciandoli fuori dalla portata del Fisco italiano. In base alla regola CFC, se una società italiana controlla (anche indirettamente) una società estera localizzata in un Paese a bassa tassazione, gli utili di quest’ultima vengono imputati per trasparenza alla società (o persona) italiana controllante, come se fossero percepiti direttamente da quest’ultima. Cioè, l’Italia tassa immediatamente l’utile del veicolo estero, indipendentemente dalla distribuzione di dividendi. La legge di riforma fiscale 2023 ha modificato i criteri CFC in ottica BEPS: oggi si considera bassa tassazione un livello di tassazione effettiva inferiore al 15% (in precedenza era la metà dell’aliquota italiana, quindi 12.5%, ora allineato alla global minimum tax). Inoltre, oltre al tax rate basso, è richiesto che oltre un terzo dei proventi della società estera siano “passive income” (redditi di natura principalmente finanziaria o da intermediazione, non derivanti da attività industriali o commerciali effettive). Solo se entrambe le condizioni sussistono, la società estera è qualificata come CFC e i suoi redditi tassati in Italia in capo al controllante. La norma prevede esimenti: il contribuente può evitare l’applicazione CFC se prova che la società estera svolge un’effettiva attività economica nel mercato locale (c.d. safe harbour di sostanza) o, in certi casi, se dimostra che dai suoi investimenti non consegue l’effetto di localizzare reddito artificiosamente (prova di esclusione). La riforma 2023 ha anche introdotto la possibilità, in alternativa al test del tax rate, di optare per una tassazione semplificata al 15% sull’utile della controllata estera (per 3 anni), una sorta di switch-over option per dare certezza al gruppo ed evitare calcoli complessi. Esempio: Alfa S.p.A. (Italia) possiede Beta Ltd, società alle Cayman (zero tasse) che detiene investimenti finanziari. Beta Ltd ha solo interessi attivi (passive income). Questa è una tipica CFC: tassazione effettiva 0% (<15%) e redditi passivi al 100% (>1/3). Gli utili di Beta verranno imputati ad Alfa e tassati in Italia al 24% IRES come fossero redditi propri di Alfa. Se Alfa non dichiarasse questi utili, subirebbe accertamento in Italia con sanzioni e interessi; inoltre potrebbe configurarsi reato di omessa dichiarazione se l’imposta evasa supera 50.000 €.
- Dividendi e plusvalenze da paradisi fiscali: La normativa italiana prevede normalmente che i dividendi provenienti dall’estero siano imponibili al 95% (se ricevuti da società) o al 100% con credito d’imposta se da partecipazioni qualificate (per persone fisiche in regime IRPEF), oppure soggetti a imposta sostitutiva 26% se da partecipazioni non qualificate. Tuttavia, se i dividendi provengono da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list), la legge richiede la piena tassazione al 100% salvo prova che da quegli utili la controllata estera ha svolto attività commerciale effettiva (similmente al test CFC). Norme analoghe valgono per le plusvalenze sulla cessione di partecipazioni in società paradisiache. In sintesi, un fiscalista deve valutare se una giurisdizione estera sia considerata privilegiata (lista aggiornata dal DM 4.5.1999 e successive modifiche) e avvisare il cliente che eventuali utili da lì potrebbero non godere dell’esenzione parziale normalmente applicata.
- Interessi e royalties: Pagamenti di interessi, canoni, compensi verso soggetti esteri collegati possono essere scrutinati non solo ai fini transfer pricing ma anche sotto norme antiabuso. Ad esempio, l’Italia ha una regola di thin capitalization implicita nella limitazione alla deducibilità degli interessi passivi (30% EBITDA) e, per interessi verso società consociate estere, bisogna assicurarsi che rispettino il benefit test (in presenza di direttive UE madre-figlia e interessi-canoni, se applicabili, bisogna dimostrare che non vi sia costruzione abusiva per fruire di esenzione di ritenute).
- Abuso del diritto ed elusione fiscale internazionale: Dal 2015 l’Italia ha una clausola generale antiabuso (art. 10-bis L. 212/2000) secondo cui sono disconosciute le operazioni prive di sostanza economica effettuate al solo scopo di ottenere vantaggi fiscali indebiti. Questa norma si applica anche in ambito internazionale: ad esempio, se una società italiana trasferisce formalmente la sede in un paese UE ma senza reale trasferimento di attività (esterovestizione), l’operazione può essere ignorata dal Fisco italiano per tassare comunque in Italia i redditi (ciò spesso avviene appunto in contestazioni di residenza). L’abuso del diritto comporta solo conseguenze amministrative (tasse, interessi, sanzioni) ma non costituisce reato di per sé. È importante però distinguere: un’operazione internazionale abusiva (ad esempio routing di pagamenti verso un paradiso tramite una società interposta) se accompagnata da atti falsi o omissioni dichiarative, può comunque integrare reati tributari (es. dichiarazione infedele).
- Normativa ATAD: L’Italia ha recepito le direttive UE anti-elusione (ATAD I e II). Oltre alle CFC già viste, abbiamo norme come la limitatore sugli interessi passivi, la Exit Tax (tassazione sulle plusvalenze latenti quando un’impresa trasferisce la residenza all’estero o sposta asset all’estero; il D.Lgs. 142/2018 ha aggiornato le regole di exit tax con possibilità di pagamento dilazionato se si trasferisce in UE), e le norme sulle mismatch ibridi (disallineamenti da strumenti o entità ibride, per evitare deduzioni doppie o deduzione senza inclusione). Tali norme sono tecniche, ma un avvocato fiscalista deve saperle applicare ad es. se un cliente ha strutture con strumenti finanziari ibridi tra Italia ed estero.
Caso pratico su abuso/elusione: Un imprenditore italiano decide di vendere la sua azienda, e prima della vendita sposta la sede della società in un paese con esenzione sulle plusvalenze (ad es. Emirati Arabi) per non pagare tasse sulla plusvalenza dalla cessione. Se la mossa avviene senza sostanza (nessuna reale presenza negli Emirati), l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare l’abuso del diritto, tassando in Italia la plusvalenza come se la società non fosse mai uscita dal territorio (oltre a contestare l’eventuale esterovestizione). L’avvocato in questo caso dovrà valutare il rischio e magari sconsigliare un’operazione così scoperta, suggerendo alternative lecite (ad es. l’uso di regimi di partecipation exemption italiani, se applicabili, che permettono l’esenzione del 95% della plusvalenza in Italia stessa senza bisogno di spostare la società).
Monitoraggio Fiscale di Attività Estere (Quadro RW, IVIE, IVAFE)
L’ordinamento tributario italiano impone alle persone fisiche residenti (nonché ad alcune entità come società semplici ed equiparate) di dichiarare annualmente il possesso di investimenti e attività finanziarie estere attraverso il cosiddetto Quadro RW della dichiarazione dei redditi. Si tratta di uno strumento di monitoraggio fiscale istituito dal D.L. 167/1990, volto a contrastare l’illecito trasferimento o detenzione all’estero di capitali non dichiarati.
Cosa va indicato nel Quadro RW: conti correnti e depositi esteri, partecipazioni in società estere, immobili situati all’estero, investimenti finanziari di ogni genere detenuti all’estero (azioni, obbligazioni, fondi, polizze, metalli preziosi in custodia fuori Italia, criptovalute su exchange esteri, ecc.). Sono esonerati solo i casi espressamente previsti (ad esempio, singoli conti con giacenza media sotto 5.000 € solo per il monitoraggio, ma attenzione che IVAFE si applica comunque se si supera 5.000 € al 31/12).
IVIE e IVAFE: Oltre al monitoraggio, il Quadro RW serve anche al calcolo di due imposte patrimoniali introdotte dal 2012: l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero, aliquota 0,76% sul valore dell’immobile estero, simile all’IMU) e l’IVAFE (Imposta sul valore delle Attività Finanziarie Estere, aliquota 0,2% annuo sul valore di conti, depositi e attività finanziarie estere, simile all’imposta di bollo titoli italiana). Queste imposte sono dovute dai residenti che detengono tali attività estere, salvo casi di esenzione o credito (es. per immobili UE si può scomputare un’imposta patrimoniale pagata all’estero).
Sanzioni per omessa dichiarazione RW: La mancata compilazione del quadro RW è soggetta a pesanti sanzioni amministrative: dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato, elevato al 6%–30% se l’attività è in un Paese black-list (paradiso fiscale). Si noti che queste sanzioni sono patrimoniali, calcolate sul valore dell’attività non monitorata, e sono dovute a prescindere dalle imposte sui redditi eventualmente evase. Infatti, il monitoraggio ha scopo dichiarativo, non genera di per sé imposta sui redditi. Ciò significa che un contribuente potrebbe essere perfettamente in regola con il pagamento delle tasse sui redditi esteri (es. ha pagato le imposte su interessi attivi esteri) ma, se non li ha indicati in RW, è comunque passibile di multa.
Un recente principio affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 20649/2025) evidenzia proprio la natura distinta tra sanzione RW e imposte sui redditi: la Cassazione ha stabilito che trasferire beni per sottrarsi al pagamento delle sanzioni da quadro RW non integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 D.Lgs.74/2000, se non c’è una contestuale evasione d’imposta sui redditi esteri. La ragione è che la sanzione RW è riferita al patrimonio e non presuppone un debito d’imposta, quindi evitare di pagarla non equivale a sottrarsi al pagamento di un’imposta dovuta. In altri termini, la sanzione RW è una punizione amministrativa per omessa dichiarazione, ma non è indice automatico di evasione fiscale. La Cassazione ha sottolineato che affinché scatti il penale, dev’esserci una effettiva imposta evasa sui redditi prodotti da quel patrimonio estero (ad esempio redditi di interessi non dichiarati).
Presunzione di evasione per attività estere non dichiarate: Attenzione, però: la normativa italiana prevede una presunzione (D.L. 167/90, art. 12) secondo cui gli investimenti esteri non dichiarati si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria. In passato questa presunzione era limitata ai Paesi black-list, ora è tendenzialmente generale (con alcune differenze se paradisi fiscali). Ciò consente al Fisco, se scopre capitali non monitorati, di presumere un’evasione su un reddito correlato a quei capitali. Ad esempio, se Tizio ha 1 milione su un conto svizzero non dichiarato, l’Agenzia potrebbe presumere che derivi da redditi non tassati in Italia e accertargli un reddito evaso (talora con metodologie induttive). Tuttavia, in sede penale la Cassazione ha chiarito che questa presunzione normativa, da sola, non basta: serve che sia stata quantificata e contestata un’imposta evasa in concreto perché si configuri reato. Quindi, se il Fisco non accerta alcun reddito evaso (ma commina solo la sanzione patrimoniale RW), non vi è base per il penale. Questo è un punto di tutela importante per i contribuenti, confermato dalla giurisprudenza recente.
Voluntary disclosure: Negli anni 2015 e 2017 l’Italia ha varato programmi di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali esteri: i contribuenti che spontaneamente denunciavano gli asset non dichiarati pagavano le imposte evase con sanzioni ridotte ed evitavano le conseguenze penali. Oggi tali programmi non sono attivi, ma chi ha ancora attività estere irregolari può valutare il ravvedimento operoso: pagando spontaneamente imposte e sanzioni ridotte prima di eventuali verifiche, si evitano guai peggiori (anche se per grandi patrimoni emersi l’esposizione penale resta un rischio da gestire, poiché il ravvedimento totale esclude il reato di omessa dichiarazione solo se avviene prima che il contribuente abbia formale conoscenza di accessi o indagini – art. 13 D.Lgs. 74/2000).
In sintesi, il fiscalista internazionale assiste il cliente con attività estere nel:
- Corretta compilazione del Quadro RW ogni anno, evitando omissioni.
- Calcolo di IVIE/IVAFE e verifica di eventuali crediti d’imposta (es. se sull’immobile estero si paga già una patrimoniale locale, si detrae).
- Strategie di regolarizzazione in caso di patrimoni non dichiarati (valutando rischi e benefici del ravvedimento).
- Difesa in caso di accertamento: spesso l’Agenzia ricostruisce il valore di conti esteri e applica sanzioni, il fiscalista può negoziare riduzioni in adesione o far annullare atti se vizi procedurali (ad esempio nullità se le informazioni bancarie estere sono state ottenute illegalmente).
- Consulenza proattiva: es. se un cliente vuole trasferire legalmente somme all’estero, l’avvocato suggerirà di seguire canali tracciati e dichiarare tutto, magari valutando il regime fiscale del Paese estero per eventuali dichiarazioni anche lì.
Un aspetto ulteriore è la cooperazione internazionale: oggi l’Italia riceve dai paesi esteri (circa 100 giurisdizioni) segnalazioni automatiche dei conti finanziari detenuti da residenti italiani all’estero (Common Reporting Standard – CRS) e scambia informazioni su vari redditi (interessi, salari, pensioni, immobili) in ambito UE. Dunque, è sempre più difficile nascondere attività estere. Anche per questo la figura del fiscalista è fondamentale per aiutare i contribuenti a mettersi in regola prima che tali dati arrivino al Fisco italiano e generino accertamenti.
Aspetti Penali-Tributari Internazionali
Quando le violazioni fiscali assumono una certa gravità, scatta in Italia la sfera penale-tributaria disciplinata dal D.Lgs. 74/2000. Vediamo quali reati possono emergere in contesti di fiscalità internazionale e con quali soglie:
- Omessa Dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): Si verifica quando un soggetto obbligato non presenta la dichiarazione annuale (dei redditi o IVA) entro i termini, con l’intento di evadere le imposte. In ambito internazionale, ciò può avvenire ad esempio se un cittadino si considera (a torto) residente all’estero e quindi non presenta la dichiarazione in Italia, pur avendone l’obbligo. Il reato scatta solo se l’imposta evasa supera 50.000 € per ciascuna imposta. È punito con la reclusione da 2 a 5 anni (pene inasprite dalla riforma 2019). Un caso tipico: Tizio si trasferisce fiscalmente a Dubai ma in realtà vive ancora gran parte dell’anno in Italia (quindi per il Fisco è residente). Se non presenta la dichiarazione dei redditi in Italia e l’imposta evasa (su redditi esteri non dichiarati, ecc.) eccede la soglia, commette omessa dichiarazione. Analogo per società esterovestite: gli amministratori di fatto possono rispondere di omessa dichiarazione se la società fittiziamente estera non ha presentato dichiarazioni in Italia.
- Dichiarazione Infedele (art. 4): È la presentazione di una dichiarazione indicante elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi, con superamento di specifiche soglie: imposta evasa > 100.000 € e ammontare degli elementi sottratti > 10% del totale o comunque > 2 milioni. In ottica internazionale, questo reato si configura se il contribuente dichiara qualcosa ma omette redditi esteri o detrae indebitamente crediti d’imposta esteri non spettanti, restando tuttavia entro certi limiti per evitare l’omessa. Ad esempio, Caio dichiara redditi italiani ma “dimentica” di dichiarare interessi da un conto estero cospicuo: se l’imposta evasa su quegli interessi supera 100k, sarà infedele. La pena è la reclusione, recentemente aumentata fino a 4 anni (prima era max 3 anni). Anche indicare costi fittizi legati a operazioni estere (come fatture false da fornitori esteri inesistenti) configurerebbe questo reato se non si rientra nella frode documentale più grave.
- Dichiarazione Fraudolenta (artt. 2 e 3): Sono forme aggravate di frode fiscale. L’art. 2 punisce l’uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti, senza soglie di imposta evasa (pena 4 a 8 anni dopo riforma 2019). L’art. 3 punisce altri artifici fraudolenti (es. contabilità doppi, operazioni simulate) con soglie di € 100k imposta e 2 milioni elementi attivi sottratti. In ambito internazionale, pensiamo a schemi di frode carosello con società estere (soprattutto in ambito IVA intracomunitaria) o creazione di documenti falsi esteri per dedurre costi: ricadono in queste fattispecie più gravi. Ad esempio, un imprenditore italiano potrebbe creare società fittizie in paradisi fiscali che emettono fatture false di consulenza per abbattere il reddito in Italia: ciò è dichiarazione fraudolenta (art.2).
- Emissione di fatture false (art. 8): rilevante se c’è un “fornitore” estero fittizio: emettere (anche dall’estero) fatture false poi usate in Italia è reato (anche dall’estero? Sì, se l’autore è preso in Italia, art. 9 c.p. prevede giurisdizione se danno allo Stato italiano).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11): punisce chi aliena o simula vendite di beni per evitare il pagamento di imposte o di sanzioni già irrogate. Soglia: occorre un debito tributario (anche solo sanzione) già accertato e superiore a circa € 50.000. Tipico caso internazionale: contribuente trasferisce capitali all’estero o li intesta a terzi quando ha cartelle esattoriali o accertamenti, per non farseli pignorare. La Cassazione di recente ha escluso che il semplice spostare soldi per non pagare la sanzione RW integri il reato, se non c’è un’imposta evasa correlata. Ma se c’è un’imposta evasa (es. da redditi esteri) e poi sposti beni, allora sì. Pena: reclusione fino a 6 anni.
- Altri reati: Ricordiamo Omesso versamento di IVA o ritenute (art.10-bis e ter) – anche qui ci può essere profilo internazionale, ad es. un datore di lavoro estero che non versa ritenute per dipendenti in distacco in Italia, ma casi particolari. L’autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.) è un reato extratributario ma connesso: se uno sposta all’estero capitali frutto di reati tributari (es. utili in nero) e li reimpiega per “ripulirli”, risponde anche di autoriciclaggio oltre che del reato fiscale.
Cooperazione internazionale in ambito penale tributario: I reati fiscali rientrano nella cooperazione giudiziaria UE (Eurojust, Ordine Europeo di Indagine) e convenzioni di estradizione. Se un contribuente commette reati fiscali rilevanti e si rifugia all’estero, può essere estradato (per l’UE vale il Mandato d’Arresto Europeo, applicabile anche a frodi fiscali gravi, specialmente se IVA in danno del bilancio UE). Inoltre, l’Italia scambia informazioni anche per prove penali: per esempio, conti esteri possono essere oggetto di sequestro preventivo con rogatorie o ordini di sequestro europei se collegati a reati fiscali.
Diritto di difesa e penal-tributario internazionale: Un avvocato fiscalista in procedimenti penali tributari spesso affianca il difensore penale di fiducia, fornendo l’expertise tecnica per contestare la sussistenza dell’evasione. Ad esempio, in un processo per omessa dichiarazione legato a residenza estera, il fiscalista può portare elementi a dimostrazione che la residenza estera era effettiva (smontando l’accusa che il soggetto fosse residente in Italia). Oppure nel caso di contestazione art.11 per soldi trasferiti all’estero, può evidenziare – come nel caso di Cass. 20649/2025 – che quelle somme erano legate solo a sanzioni e non a imposte, quindi mancando un debito d’imposta, viene meno l’elemento oggettivo del reato.
Strumenti di Risoluzione delle Controversie Fiscali Internazionali
Oltre al contenzioso interno e ai MAP già citati, esistono altri strumenti utili in ambito internazionale per prevenire o risolvere incertezza:
- Interpello Internazionale sui Nuovi Investimenti: Introdotto dal 2015 (art. 2 DL 147/2015), consente agli investitori esteri o italiani che fanno un investimento rilevante in Italia (oltre 30 milioni €) di ottenere dall’Agenzia delle Entrate una risposta sui trattamenti fiscali applicabili al piano di investimento. È una forma di ruling che copre vari aspetti (transfer pricing, dividenti, interessi, regime CFC, stabile organizzazione). L’avvocato fiscalista predispone istanze dettagliate, anche qui per dare certezza ex ante ai grandi investimenti cross-border.
- Cooperative Compliance: L’Italia ha avviato un regime di adempimento collaborativo (D.Lgs.128/2015) per grandi contribuenti (fatturato >1 mld, ora soglia abbassata a 100 mln per chi aderisce post-pilot). In tale regime l’azienda collabora attivamente e comunica al Fisco le operazioni fiscali a rischio, ottenendo un canale di dialogo continuo ed evitando sanzioni in caso di accordo preventivo sulle soluzioni. Questo è particolarmente utile per gruppi multinazionali con operazioni complesse; l’avvocato tributarista può assistere l’azienda nella predisposizione del tax control framework richiesto e nella gestione del dialogo.
- Arbitrato Internazionale: Oltre a quello previsto dalla direttiva UE (già discusso), esiste la Convenzione Arbitrale Europea del 1990 sul transfer pricing tra Stati UE (che però è stata in parte sostituita dalla nuova direttiva 2017/1852). L’avvocato conosce questi meccanismi e li suggerisce se un cliente è colpito da doppia imposizione persistente.
In generale, l’obiettivo è evitare il doppio pagamento di tasse o situazioni di conflitto tra Stati: rivolgersi a questi strumenti può far risparmiare molto al contribuente, ma serve competenza specifica e capacità di interagire con autorità anche straniere in inglese o francese.
Incentivi Fiscali per l’Attrazione di Capitali e Persone (Regimi Speciali)
L’Italia, oltre a tassare, cerca anche di attrarre investimenti e talenti tramite regimi fiscali agevolati, in concorrenza con altri Paesi. Un fiscalista internazionale deve conoscere questi regimi per poter consigliare al meglio chi intenda trasferirsi in Italia o rimpatriare capitali:
- Regime “Neo Residenti” (Flat Tax 100.000 €): Introdotto nel 2017 (art. 24-bis TUIR), consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, dopo aver risieduto fuori almeno 9 anni negli ultimi 10, di optare per una tassa forfettaria fissa di €100.000 annui sui redditi prodotti all’estero (qualunque ammontare essi siano). In pratica, il nuovo residente paga 100k € all’anno e l’Italia non tassa i suoi redditi esteri (salvo alcune esclusioni come le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate nei primi 5 anni). È un regime pensato per individui ad altissimo reddito (HNWI, sportivi, ecc.) per attrarli a stabilirsi in Italia. Si può estendere ai familiari con €25k aggiuntivi caduno. Un avvocato assiste nella richiesta di interpello probatorio (facoltativo) e nell’opzione in dichiarazione. Questo regime non copre però i redditi prodotti in Italia, che restano tassati ordinariamente.
- Regime Impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015): Dedicato a lavoratori (dipendenti o autonomi) e manager altamente qualificati che si trasferiscono in Italia per lavorare almeno 2 anni, non residenti nei 2 anni precedenti. Prevede una detassazione del 70% del reddito di lavoro prodotto in Italia per 5 anni (si tassa solo il 30%). L’agevolazione sale al 90% per chi si trasferisce in regioni del Sud (tassa solo 10% del reddito). È prorogabile per altri 5 anni (al 50% o 90% detassato) se il soggetto acquista casa in Italia o ha figli. Questo regime è molto usato da italiani che rientrano dall’estero (es. ricercatori, manager) e da stranieri qualificati che vengono a lavorare qui. L’avvocato aiuta a verificare i requisiti (titolo di studio, ruolo manageriale ecc. non sono più richiesti dal 2019, è molto più accessibile ora) e a compilare correttamente le autocertificazioni al datore di lavoro o in dichiarazione.
- Regime Ricercatori e Docenti (art. 44 DL 78/2010): Previsto per professori e ricercatori italiani o stranieri che rientrano in Italia per svolgere ricerca. Esenta dal 90% del reddito da lavoro scientifico per 6 anni (proroghe possibili fino a 13 anni se hanno figli o acquistano casa). Simile all’impatriati ma specifico per accademici.
- Pensionati Esteri (art. 24-ter TUIR): Introdotto nel 2019, consente ai pensionati residenti all’estero che si trasferiscono in piccoli comuni del Sud Italia di pagare una tassa del 7% forfettaria sui redditi esteri (pensione e altri redditi esteri) per 10 anni. Requisiti: provenire da paesi con accordo di cooperazione fiscale, non essere stati residenti nei 5 anni precedenti, trasferirsi in comuni con meno di 20k abitanti in regioni del Mezzogiorno o del centro (zone terremotate incluse). È un regime volto a attrarre pensionati stranieri (sulla scia del Portogallo o Spagna).
- Incentivi per “reshoring” di attività economiche: Novità del 2023 (D.Lgs. 150/2023, in attuazione delega art. 4) è un incentivo fiscale per chi riporta in Italia attività d’impresa svolte prima fuori UE. Consiste in un’esenzione del 50% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’attività rimpatriata, per l’anno del trasferimento e i 5 anni successivi. Occorre mantenere separata contabilità e l’attività doveva provenire da un Paese extra-UE/SEE. Ci sono cause di decadenza (ad esempio, se l’attività cessa prima dei 5 anni, si recupera l’imposta risparmiata). Questo favorisce il rientro di produzioni delocalizzate.
- Branch exemption: Introdotta nel 2016, permette alle società residenti di optare per l’esenzione degli utili (e perdite) attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all’estero (anziché tassazione con credito). È utile in specifici casi per semplificare la tassazione e evitare dual filing.
Tutti questi regimi richiedono un’attenta pianificazione e verifica dei requisiti. Un fiscalista internazionale aggiorna i clienti su queste opportunità. Ad esempio, se un imprenditore straniero volesse trasferirsi in Italia, l’avvocato valuterebbe se conviene il regime neo residenti (flat 100k) o se rientra come impatriato (se verrà assunto come dirigente qui). Analogamente, per un cliente italiano emigrato che sta pensando di tornare, si analizzerà la possibilità di impatriati o ricercatori.
Nota bene: Questi regimi non sono automatici; spesso vanno esercitate opzioni in sede di prima dichiarazione o comunicate ai datori. Il fiscalista cura queste formalità e, nel caso ad esempio della flat tax 100k, può predisporre l’interpello all’Agenzia per avere conferma che il contribuente abbia i requisiti (percentuale di successo di tali interpelli è stata alta finora).
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande e risposte comuni che aiutano a chiarire ulteriormente i concetti trattati, adottando il punto di vista pratico del contribuente (debitore d’imposta) che si confronta con la fiscalità internazionale:
- D: Cosa si intende esattamente per “fiscalità internazionale”?
R: Si intende l’insieme di norme tributarie e principi che disciplinano la tassazione di redditi, patrimoni e operazioni economiche quando vi è un elemento di internazionalità, cioè un collegamento con più ordinamenti nazionali. Ad esempio, riguarda la tassazione di un reddito estero di un residente, l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, il monitoraggio di conti all’estero, la determinazione dei prezzi tra società di diversi Paesi (transfer pricing), ecc. In sostanza è il campo in cui il diritto tributario italiano interagisce con i sistemi fiscali esteri e con il diritto internazionale (trattati, direttive UE). - D: Quando una persona fisica è considerata residente fiscale in Italia?
R: Come spiegato, una persona è residente fiscale italiana se per più di 183 giorni all’anno ha in Italia domicilio, residenza (abituale dimora) o iscrizione anagrafica. Basta uno di questi requisiti. Ciò significa che gli italiani che si trasferiscono all’estero devono togliersi dall’anagrafe italiana (iscriversi all’AIRE) e stabilire altrove il centro dei propri interessi, altrimenti rischiano di restare considerati residenti italiani. La verifica pratica si basa su elementi di fatto: dove la persona abita la maggior parte del tempo, dove lavora, dove risiede la famiglia, ecc. Le convenzioni internazionali aiutano a risolvere i casi dubbi assegnando la residenza all’uno o all’altro Stato tramite criteri di prevalenza. - D: Come si determina la residenza fiscale di una società o di un’impresa?
R: Per le società, la residenza fiscale in Italia sussiste se la società ha in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione principale per la maggior parte dell’anno. In pratica, oltre all’eventuale sede legale, conta dove vengono prese le decisioni aziendali e dove si svolge la gestione quotidiana. Inoltre, esistono presunzioni anti-abuso che considerano residenti in Italia società formalmente estere ma controllate o amministrate da soggetti italiani (salvo prova contraria). Se una società è residente, viene tassata in Italia sugli utili ovunque prodotti; se non lo è, viene tassata solo sulle attività svolte in Italia (tramite stabile organizzazione o ritenute alla fonte su certi redditi). Infine, se due Stati rivendicano entrambi la residenza della società, si applicano eventuali criteri del trattato (spesso il place of effective management). Un’attenzione particolare va alle esterovestizioni: lo spostamento all’estero solo cartolare della sede può essere ignorato dal Fisco se l’azienda resta di fatto gestita dall’Italia. - D: Cos’è una stabile organizzazione e quali conseguenze comporta?
R: La stabile organizzazione è un’entità, fisica o anche personale, attraverso cui una società estera esercita attività sul territorio di un altro Stato. Può essere una sede d’affari (ufficio, filiale, stabilimento) o un agente che conclude contratti per la società estera. Se c’è una stabile organizzazione in Italia di una società estera, quest’ultima deve dichiarare in Italia i redditi attribuibili alla SO e pagarvi le imposte come fosse un’impresa locale. Di contro, i pagamenti dalla SO alla casa madre (come trasferimento di utili) non subiscono ritenute, essendo flussi interni. Avere una SO non è una scelta del contribuente ma un fatto che deriva dalla presenza economica: se una società estera opera in Italia in modo stabile, deve comportarsi come SO. Le conseguenze sono importanti: mancata dichiarazione di una SO equivale a evasione fiscale con rischi sanzionatori e penali. Le aziende cercano spesso di evitare di configurare SO (se non vogliono aprire posizione fiscale in Italia) mantenendo l’attività sul territorio nei limiti di attività preparatorie o tramite agenti indipendenti. Il fiscalista internazionale viene consultato proprio per capire se certi progetti di presenza in Italia faranno scattare o meno una stabile organizzazione. - D: Che differenza c’è tra elusione fiscale e evasione fiscale in ambito internazionale?
R: L’evasione fiscale è la violazione della legge tributaria, ad esempio non dichiarare un reddito estero, presentare una dichiarazione falsa, usare fatture fittizie, insomma comportamenti illegali. L’elusione fiscale invece consiste nello sfruttare le pieghe (lecite) delle norme per ottenere vantaggi fiscali indebitamente, senza violare in apparenza la lettera della legge ma aggirandone lo spirito. In ambito internazionale l’elusione tipica può essere il treaty shopping (usare un’entità in un terzo paese solo per sfruttare un trattato fiscale), la localizzazione di utili in filiali in paradisi fiscali tramite prezzi di trasferimento artificiosi, o il trasferimento di residenza fittizio (esterovestizione) senza sostanza. Oggi l’ordinamento prevede la clausola antiabuso (art. 10-bis L.212/2000) che consente al Fisco di disconoscere i benefici ottenuti da operazioni prive di sostanza economica rivolte solo al risparmio d’imposta. La differenza pratica: l’elusione comporta recupero di imposte e sanzioni amministrative, ma non è reato; l’evasione (dichiarazione infedele, omessa, frode) invece integra reati oltre alle sanzioni tributarie. Un avvocato esperto aiuta a pianificare in modo lecito (tax planning) evitando di cadere nell’abuso, e in caso di contestazione difende sostenendo che l’operazione aveva valide ragioni economiche oltre al risparmio d’imposta (cosa che, se provata, può far decadere l’accusa di abuso). - D: Cosa succede se non dichiaro in Italia i redditi o i patrimoni detenuti all’estero?
R: Sul piano amministrativo, se sei residente fiscale italiano devi dichiarare sia i redditi esteri (inclusi conti che producono interessi, affitti di immobili esteri, ecc.) sia gli asset detenuti (nel quadro RW). Se ometti di dichiarare i redditi esteri, l’Agenzia delle Entrate può accertare l’imposta evasa, con sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta (per dichiarazione infedele). Inoltre, se l’imposta evasa supera le soglie penali (es >100k € per infedele, >50k per omessa), rischi un procedimento penale. Se ometti di dichiarare i patrimoni esteri in RW, l’Agenzia può irrogare le sanzioni patrimoniali (3-15% del valore, raddoppiate se paradiso fiscale) anche se magari quei beni non generano reddito. In più, c’è la presunzione che quei asset derivino da redditi non tassati, dunque potresti subire un accertamento induttivo su redditi presunti. Sul piano penale, come visto, tenere soldi all’estero di per sé non è reato, ma se ometti del tutto la dichiarazione dei redditi (comprensiva di quelli esteri) oltre soglia diventa reato di omessa dichiarazione; se dichiari ma nascondi una parte significativa, può essere dichiarazione infedele. E se trasferisci fondi segretamente all’estero per non pagar tasse, questo può costituire il reato di sottrazione fraudolenta (art.11), salvo riguardi solo sanzioni amministrative come chiarito da Cassazione. In sintesi: non dichiarare attività estere espone a rischi molto alti, specie oggi con lo scambio di informazioni che rende probabile l’individuazione dei capitali offshore. Meglio avvalersi di strumenti di regolarizzazione prima di essere scoperti. - D: Un conto corrente estero non dichiarato può portare al sequestro o a condanne penali?
R: Il solo fatto di avere un conto estero non dichiarato comporta sanzioni amministrative (3-15% del saldo, appunto). Per il penale, serve un passo ulteriore: che da quel conto si evincano redditi non dichiarati di importo rilevante (interessi, capital gains, ecc.), tali da configurare evasione oltre soglia. Oppure che il trasferimento di denaro su quel conto sia considerato atto per sottrarsi a pagamenti di imposte già dovute. Una recente sentenza (Cass. 20649/2025) ha annullato un sequestro su un conto estero relativo a sanzioni RW, proprio perché non c’era un’evasione IRPEF contestata sui redditi sottostanti. Quindi un conto estero non dichiarato può essere congelato/sequestrato dall’autorità giudiziaria solo se collegato a un reato tributario (dichiarazione omessa/infedele o sottrazione fraudolenta) già ipotizzato. Se emergono redditi evasi, sì, si può arrivare anche a condanne penali per i reati visti sopra. - D: Quali sono i reati tributari “internazionali” più comuni e le loro pene?
R: I reati tributari non fanno distinzione tra condotte interne o estere, ma nella pratica quelli che si manifestano spesso in contesti internazionali sono:- Omessa dichiarazione: se non presenti la dichiarazione pur essendo residente e hai evaso oltre 50k € di imposte. Pena 2–5 anni reclusione.
- Dichiarazione infedele: dichiari il falso (ad esempio ometti redditi esteri), con imposta evasa >100k €. Pena fino a 4 anni circa (dipende dall’entità, la cornice è 1½–4 anni dopo riforma).
- Dichiarazione fraudolenta: casi più gravi con artifici, ad es. schermi esteri, false fatture estere. Pena elevata, fino a 6–8 anni nei casi più seri.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento: se sposti/occulti patrimoni per non saldare debiti tributari. Tipicamente contestato se vendi beni a familiari o bonifichi milioni su un trust offshore dopo un avviso di accertamento. Pena massima 6 anni.
- D: Cosa può fare un avvocato fiscalista in caso di accertamento fiscale internazionale?
R: Tantissimo. In primo luogo, analizza l’atto di accertamento per verificare eventuali vizi formali o sostanziali (ad esempio, in ambito internazionale, controlla se le informazioni provenienti dall’estero sono state acquisite tramite procedure legittime di scambio informazioni; se l’accertamento è stato notificato regolarmente anche se il contribuente è all’estero; se sono state applicate sanzioni nel rispetto dei limiti). Poi prepara una strategia difensiva. Spesso conviene tentare un accertamento con adesione (una sorta di “mediazione” con l’Ufficio) per trovare un accordo ed evitare il lungo contenzioso: qui l’avvocato negozia riduzioni di imponibile o sanzioni. Se l’adesione non riesce, predispone il ricorso alla Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), sollevando tutte le eccezioni di diritto (es. violazione di convenzione internazionale, errori di calcolo del credito estero, mancato riconoscimento di esimenti CFC, ecc.) e producendo prove a favore (documenti esteri, perizie sui prezzi di trasferimento di mercato, certificazioni di residenza estera, etc.). Rappresenta poi il cliente in ogni grado fino in Cassazione se serve. In parallelo, se c’è un profilo penale, l’avvocato tributarista collabora con il legale penalista per allineare la difesa: ad esempio, se il tema è la residenza, le stesse prove saranno usate sia nel giudizio tributario sia per convincere il PM a chiedere l’archiviazione in penale. - D: Come si possono evitare le doppie imposizioni sui redditi esteri?
R: Il primo strumento sono le convenzioni contro le doppie imposizioni: prima di pagare tasse sia all’estero che in Italia, bisogna vedere cosa prevede il trattato tra i due Paesi. Spesso riserva la tassazione di un certo reddito a uno solo dei due Stati, oppure limita la tassazione alla fonte (ad es. una ritenuta massima del 10% sul dividendo estero) e poi l’Italia dà un credito d’imposta pari a quanto pagato all’estero. Quindi applicando correttamente il trattato, di norma il doppio prelievo integrale non avviene: o c’è esenzione o c’è credito. Se non esiste convenzione con quel Paese, l’Italia comunque riconosce il credito per imposte estere pagate a titolo definitivo all’estero (art.165 TUIR), entro il limite dell’imposta italiana proporzionale a quel reddito. Ciò garantisce almeno di non pagare più tasse di quelle italiane sullo stesso reddito. In casi particolari in cui, nonostante tutto, c’è doppia imposizione (ad es. due Stati litigano su chi ha la residenza del contribuente e tassano entrambi sul worldwide), ci si può attivare con la procedura amichevole (MAP) prevista dal trattato o dalla direttiva UE 2017/1852, per far dialogare le due Amministrazioni e trovare una soluzione (spesso con arbitrato finale). In sintesi: studiare le convenzioni, utilizzare i crediti d’imposta unilaterali e, se serve, attivare gli strumenti di cooperazione sono i modi per evitare la doppia tassazione economica. - D: L’Italia offre regimi fiscali agevolati per attirare stranieri o far rientrare gli italiani dall’estero?
R: Sì, e molto competitivi. Abbiamo il regime “residente non dom” con flat tax 100.000 € per ricchi stranieri (o italiani da lungo all’estero) che si trasferiscono qui. C’è il regime Impatriati che tassa solo il 30% del reddito di lavoro per chi viene a lavorare in Italia (persino 10% al Sud) per 5 anni (estendibili). C’è il regime Ricercatori che esenta il 90% per docenti e ricercatori. Per i pensionati esteri che scelgono il Sud, c’è la flat tax 7%. Inoltre, per le imprese, come visto, è stato introdotto uno sgravio del 50% degli utili per 5 anni per chi reloca attività produttive dall’estero in Italia (reshoring). Tutti questi incentivi mirano a rendere l’Italia fiscalmente attraente in settori specifici: persone facoltose, professionisti qualificati, pensionati con buona pensione, imprese che possono riportare occupazione. Un avvocato fiscalista presenta al cliente questi vantaggi e lo aiuta a ottenere l’agevolazione, curando l’iter (domanda di interpello, rispetto requisiti temporali, etc.). Ad esempio, se un manager italiano oggi a Londra vuole tornare, con regime impatriati pagherà tasse solo sul 30% dello stipendio: l’avvocato lo assiste nel capire se ne ha diritto (non residente negli ultimi 2 anni, contratto di lavoro di almeno 2 anni in Italia, etc.), nella comunicazione al datore di lavoro e nella predisposizione delle dichiarazioni con l’agevolazione. - D: Cos’è l’esterovestizione e come viene provata dal Fisco?
R: L’esterovestizione è la finta localizzazione all’estero di un soggetto che in realtà mantiene la residenza fiscale in Italia. Può riguardare persone (fingere di vivere a Montecarlo ma in realtà stare in Italia) o società (costituire una LTD in UK ma gestirla interamente dall’Italia). Il Fisco per provarla raccoglie indizi e prove fattuali: per le persone, controlla dove abitano effettivamente (utenze, celle telefoniche, utilizzo carte di credito, presenza social), se sono iscritte AIRE o no, dove hanno il medico, la famiglia, ecc. Per le società, verifica dove si tengono i consigli di amministrazione, dove operano gli amministratori, dove è l’ufficio che dirige l’impresa, se l’azienda estera ha mezzi e dipendenti propri o è solo un indirizzo. Ci sono anche presunzioni legali (per società controllate da italiani in paradisi fiscali). Dalla parte del contribuente, la difesa consiste nel fornire prova contraria: contratti di affitto all’estero, biglietti aerei, attestati di lavoro, verbali esteri, ecc., che dimostrino una vita reale all’estero o un’attività vera della società fuori Italia. La giurisprudenza, come detto, ha chiarito che non basta avere beni in Italia per dire che la società è qui: conta dove si prendono le decisioni. Ma se il contribuente non ha nulla di concreto a supportare la sua tesi, l’Amministrazione avrà gioco facile a dimostrare la natura fittizia del trasferimento. In caso di contenzioso, saranno decisivi i documenti e le testimonianze. L’esterovestizione, quando accertata, porta a far pagare tutte le imposte come se la persona/azienda fosse sempre stata italiana, con sanzioni e possibili reati (omessa dichiarazione in primis). Meglio quindi evitare operazioni di esterovestizione: se ci sono ragioni genuine per andare all’estero, bene; se l’unico scopo è il taglio delle tasse e si mantiene tutto invariato tranne la carta intestata, è un rischio altissimo. - D: Come funziona la cooperazione internazionale tra autorità fiscali?
R: Esistono diversi livelli. A livello europeo, c’è uno scambio automatico di informazioni su: redditi da lavoro, pensioni, compensi, proprietà immobiliari (Direttiva DAC1); conti bancari e investimenti finanziari (DAC2, che recepisce il CRS OCSE); ruling fiscali preventivi (DAC3); informazioni country-by-country per multinazionali (DAC4); beneficiari effettivi delle società (DAC5); schemi elusivi (DAC6); piattaforme digitali (DAC7) e in arrivo cripto-attività (DAC8). Ciò significa che ogni anno, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate italiana riceve dall’estero i dati dei conti detenuti da italiani in Svizzera, San Marino, UE, etc., con saldo, interessi, dividendi, ecc. e può quindi controllare se li hai dichiarati. Sul fronte extra-UE, l’OCSE gestisce il Common Reporting Standard (CRS) a cui aderiscono oltre 100 Paesi con analoga comunicazione di conti (USA esclusi che hanno FATCA bilaterale con vari paesi incluso Italia). Inoltre ci sono scambi su richiesta: l’Italia può chiedere a un Paese estero specifici dati bancari o fiscali di un contribuente (art. 26 modello OCSE), e di solito ottiene risposta (il segreto bancario classico non esiste quasi più). E poi indagini congiunte: talvolta Agenzia Entrate e GdF collaborano con omologhi esteri in verifiche simultanee su multinazionali. A livello penale, invece, l’autorità giudiziaria può usare rogatorie o l’Ordine di indagine europeo per ottenere documenti o congelare beni. Tutta questa cooperazione fa sì che il mondo fiscale non abbia quasi più frontiere: per questo i paradisi fiscali non cooperativi sono rimasti pochissimi (es. alcuni Emirati, Panama fino a poco fa, ecc.) e comunque chi vi nasconde soldi rischia di incappare in strumenti come il whistleblowing (dipendenti di banche che passano liste, ecc.). Il fiscalista internazionale deve essere aggiornato su quali paesi scambiano cosa e da quando, per poter avvisare il cliente (“guarda che quel conto a Singapore dal 2018 è segnalato al Fisco”). - D: Cos’è un interpello internazionale o un accordo preventivo con il fisco?
R: L’interpello è la possibilità di chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere vincolante sulla corretta interpretazione di una norma rispetto a un caso concreto che ti riguarda. Ci sono interpelli speciali per materia internazionale: ad esempio, l’interpello sui nuovi investimenti (per progetti sopra €30M) per avere certezza complessiva sul trattamento fiscale; l’interpello per disapplicare la normativa CFC (se ritieni che la tua controllata estera non sia un mero schermo, puoi chiederlo preventivamente); l’interpello per evitare la qualifica di residenza in Italia per società estere in presenza di certe condizioni; l’interpello per regimi agevolati (flat tax neo residenti, impatriati in alcuni casi se dubbio su requisiti). Presentare interpello significa descrivere compiutamente la situazione e attendere risposta entro 60-120 giorni. Se l’Agenzia dice OK alla tesi del contribuente, lui è protetto: non potranno fargli accertamenti contrari dopo. Se dice no, almeno si sa come la pensa e ci si regola (o non si fa l’operazione, o si fa assumendosi il rischio di contenzioso). L’accordo preventivo invece è una sorta di contrattazione su temi come transfer pricing, valori di ingresso/uscita in caso di trasferimenti di residenza (ruling di branch stepping-up), regimi di patent box (ora trasformati in super-deduzione), ecc. È meno formale dell’interpello, ma il risultato è un accordo scritto col Fisco che vale per alcuni anni. Un classico è l’APA sui prezzi di trasferimento: azienda e Agenzia concordano il margine di utile su certe transazioni infragruppo future. Altro esempio: un’azienda che trasferisce la sede in Italia può chiedere un accordo sul valore normale delle sue attività per evitare discussioni future (step-up dell’avviamento tassato forfettariamente). In generale, interpelli e accordi servono ad evitare liti future ottenendo chiarezza prima. Un fiscalista competente li utilizza strategicamente quando c’è molta incertezza o in gioco importi grandi.
Tabelle Riepilogative
Di seguito, alcune tabelle riepilogative per ricapitolare in modo schematico i punti salienti della guida:
Residenza Fiscale: Criteri per Persone Fisiche e Società
| Soggetto | Criteri di Residenza in Italia | Riferimenti |
|---|---|---|
| Persona Fisica | – Iscrizione nelle anagrafi comunali per >183 giorni/anno.– Domicilio in Italia (sede principale interessi) per >183 gg.– Residenza (dimora abituale) in Italia >183 gg.(Alternative: basta uno dei tre) | Art. 2 TUIR; art. 4, co. 1, DL 167/90 (AIRE) |
| Società/Ente | – Sede legale in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta o– Sede di direzione effettiva in Italia (decisioni strategiche) >183 gg o– Sede di gestione ordinaria in Italia (attività correnti) >183 gg.(Alternative, almeno uno presente) | Art. 73 TUIR (come modif. da D.Lgs. 209/2023) |
| Presunzioni Esterovestizione | – Società estera controllata da soggetti italiani e/o con amministratori in maggioranza residenti in Italia → presunta residente salvo prova contraria.– Società estera con attivi principalmente in fondi immobiliari italiani e controllata da italiani → presunta residente salvo prova contraria. | Art. 73, co.5-bis e 5-ter TUIR |
Note: Per le persone fisiche, l’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente a perdere la residenza italiana se rimangono in Italia domicilio o interessi. Per le società, la nuova definizione in vigore dal 2024 allinea i criteri italiani alle prassi internazionali (place of effective management). Le presunzioni anti-esterovestizione colpiscono in particolare società in paradisi fiscali controllate da italiani.
Principali Reati Tributari con Profilo Internazionale
| Reato (D.Lgs. 74/2000) | Fatto Tipico | Soglia di punibilità | Pena prevista |
|---|---|---|---|
| Omessa Dichiarazione (art. 5) | Non presentare la dichiarazione annuale (redditi o IVA) al fine di evadere. Es: residente italiano che non dichiara redditi esteri. | Imposta evasa > €50.000 (per imposta). | Reclusione 2 – 5 anni (pena aumentata nel 2019). |
| Dichiarazione Infedele (art. 4) | Dichiarare elementi attivi inferiori o passivi fittizi. Es: dichiarare meno redditi esteri di quelli reali, o gonfiare costi esteri. | Imposta evasa > €100.000 e elementi sottratti > 10% del reddito dichiarato o > €2 mln. | Reclusione fino a 4 anni circa (1–3 anni era ante 2019; ora da 2 a 4 anni). |
| Dichiarazione Fraudolenta (art. 2 o 3) | Dichiarare il falso con mezzi fraudolenti. Art.2: utilizzo di fatture/documenti per operazioni inesistenti (anche da società estere fittizie); Art.3: altre frodi (contabilità falsa, artifici). | Art.2: nessuna soglia minima (reato di pericolo).Art.3: imposta evasa > €100.000 e elementi sottratti > 5% dei ricavi o > €1,5 mln. | Art.2: Reclusione 4 – 8 anni (da 1½ a 6 anni ante 2019).Art.3: Reclusione 3 – 8 anni (da 1½ a 6 anni ante 2019). |
| Sottrazione Fraudolenta (art. 11) | Compiere atti simulati o fraudolenti sui propri beni per evitare il pagamento di imposte o relativi interessi/sanzioni. Es: trasferire fondi su conti offshore dopo un avviso di accertamento per renderli non aggredibili da Equitalia.* | Esistenza di un debito tributario (anche solo sanzioni) già accertato > €50.000.(N.B.: senza debito d’imposta non c’è reato, vedi Cass. 20649/2025). | Reclusione fino a 4 – 6 anni (1½ – 6 anni ante 2015, aumentata a max 6). |
| Omesso Versamento (art. 10-bis/ter) | Omesso versamento di IVA o ritenute dovute. Profilo internaz.: es. datore estero con dipendenti in Italia che non versa ritenute. | > €250.000 IVA non versata; > €150.000 ritenute non versate. | Reclusione 6 mesi – 2 anni. (Estinzione se paghi tutto entro termini). |
Tabella 2: Principali reati tributari. (Le pene indicate tengono conto delle modifiche introdotte dal DL 124/2019 conv. L.157/2019. Le soglie sono quelle attuali. I reati indicati sono quelli più frequentemente connessi a condotte internazionali. Non sono inclusi reati come emissione di fatture false, associazione per delinquere finalizzata all’evasione, etc., meno pertinenti al focus.)
Adempimenti Fiscali Internazionali e Sanzioni
| Obbligo | Descrizione | Sanzioni per omissione/violazione |
|---|---|---|
| Dichiarazione redditi esteri | Dichiarare in Italia i redditi prodotti all’estero dai residenti (con possibilità di credito d’imposta per le tasse estere pagate). | Omessa dichiarazione: sanzione 120% – 240% imposta evasa; possibile reato se > €50k imposto evaso.Infedele: sanzione 90% – 180% imposta; reato se > €100k. |
| Quadro RW (monitoraggio) | Dichiarare attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (conti, investimenti, immobili, crypto, ecc.). Serve anche al calcolo IVIE/IVAFE. | Sanzione amministrativa 3% – 15% valore non dichiarato (per anno); 6% – 30% se attività in paesi non cooperativi. Nessun reato solo per RW, ma possibili reati se correlate evasioni su redditi. |
| IVIE – IVAFE | Pagamento imposta 0,76% su immobili esteri (IVIE) e 0,2% su attività finanziarie estere (IVAFE) da parte di residenti. | Omesso versamento IVIE/IVAFE: sanzione 30% dell’imposta non versata + interessi. (Se importi rilevanti, può configurare sottrazione fraudolenta se si occultano beni per non pagare). |
| Transfer pricing documentation | Preparare documentazione (“Masterfile” e “Documentazione Nazionale”) sui prezzi di trasferimento intra-gruppo e comunicarne il possesso in dichiarazione. | Nessuna sanzione per mancata predisposizione in sé, ma se non si possiede documentazione adeguata in caso di verifica e l’Agenzia rettifica i prezzi, si applica sanzione piena (90-180% imposta) senza esimenti. Se invece si ha la documentazione conforme, niente sanzioni (penalty protection). |
| Comunicazioni fiscali internazionali (es. Esterometro, DAC6) | Vari obblighi di comunicazione: Esterometro (dati fatture verso/da estero, ora confluito in Sistema Tessera/SdI); DAC6 segnalazione schemi elusivi transfrontalieri da parte intermediari. | Esterometro: sanzione fino a €2 per fattura omessa (max €400 per trimestre). DAC6: sanzioni da €2.000 a €21.000 per mancata/difettosa comunicazione (intermediario o contribuente). |
| Iscrizione AIRE per espatrio | Obbligo di iscriversi all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero entro 90 giorni dal trasferimento all’estero (per cittadini italiani). | Sanzione anagrafica amministrativa modesta (fino a €300). Ma rilevanza fiscale: se non iscritto, presunzione di residenza italiana e rischio di tasse su redditi esteri + sanzioni ben maggiori su omessa dichiarazione. |
(La tabella sopra riassume alcuni obblighi chiave. Non sono elencati tutti gli adempimenti possibili; ad esempio, il modello IV trimestrale per trasferimenti da/verso l’estero superiori a €5.000, abolito dal 2014, ecc.)
Regimi Fiscali Agevolati per Inbound (attrarre in Italia)
| Regime | Benefici Fiscali | Requisiti Principali | Durata |
|---|---|---|---|
| Flat Tax “Neo Residenti” (Art.24-bis TUIR) | Imposta sostitutiva €100.000 fissa annua su tutti i redditi esteri (a prescindere dall’ammontare). Esenzione dall’obbligo di monitoraggio RW e da IVIE/IVAFE sui beni esteri coperti dal regime. Dividendi esteri non soggetti a ulteriori imposte. | Non residente fiscale in Italia per almeno 9 anni negli ultimi 10. Opzione da esercitare alla prima dichiarazione da residente. Possibile estendere a familiari con €25.000 cadauno. Esclusi redditi esteri da paradisi che si vogliono escludere dall’opzione (si può escludere stati). | Max 15 anni (rinnovabile annualmente, revocabile). |
| Impatriati (Art.16 DL 147/2015) | Esenzione 70% (o 90% al Sud) del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia. Di fatto tassazione su solo 30% (o 10%) dello stipendio o compenso. | Non residente in Italia nei 2 anni precedenti; impegno a risiedere almeno 2 anni; attività lavorativa principalmente in Italia. Non serve più titolo di studio o ruolo direttivo (dal 2019). Valido anche per cittadini UE e extraUE. | 5 anni fiscali. Prorogabili +5 anni con esenzione al 50% (o 90% con 3 figli o acquisto casa) se requisiti (figli minorenni o acquisto immobile in Italia). |
| Ricercatori e Docenti (Art.44 DL 78/2010) | Esenzione 90% del reddito di lavoro da attività di ricerca/docenza in Italia (tassa solo 10%). | Non residente in Italia nei 2 anni prev.; svolgere attività di ricerca o insegnamento in Italia per almeno 2 anni presso università, centri ricerca, enti pubblici o privati. | 6 anni. Proroghe possibili: +4 anni (esenzione 90%) se hanno un figlio minorenne o diventano proprietari di casa in Italia; ulteriori +3 anni (tot 13) se ≥2 figli minorenni. |
| Pensionati Esteri (Sud Italia) (Art.24-ter TUIR) | Tassa 7% forfettaria su tutti i redditi prodotti all’estero (inclusa pensione estera) – in luogo di aliquote IRPEF ordinarie. Esenzione RW e IVIE/IVAFE simile al regime neo-residenti. | Non residente nei 5 anni precedenti; trasferimento residenza in Italia in un Comune con popolazione ≤20.000 in regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia (anche centri terremotati Centro Italia ammessi). Provenienza da paese con accordo di cooperazione fiscale con l’Italia. | 10 anni (opzione rinnovabile annualmente). |
| Reshoring – Attività Estere Trasferite in Italia (Art. 7 D.Lgs attuativo delega fiscale 2023) | Esenzione 50% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotto dalle attività che vengono trasferite in Italia da un paese extra-UE/SEE. In pratica, dimezza l’IRES e IRAP su quei redditi. | Trasferimento nel 2024 (periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore) di attività economica dal fuori UE in Italia. Mantenimento di separate evidenze contabili per tali redditi. Decadenza se attività viene dismessa prima di 5 anni. | Anno del trasferimento + 5 periodi d’imposta successivi (tot 6 anni). |
(Tabella regimi agevolativi inbound: per ciascun regime indicati i tratti salienti. Sono regimi opzionali, salvo impatriati/ricercatori che si applicano di default se si possiedono i requisiti e si esercita l’opzione in dichiarazione o al sostituto d’imposta.)
Conclusione
La fiscalità internazionale rappresenta dunque un terreno sfidante dove si intersecano legislazioni nazionali, accordi internazionali e principi sovranazionali. In questo contesto, il ruolo dell’avvocato esperto in fiscalità internazionale è di guida e tutela per il contribuente: guida nell’orientarsi tra obblighi e opportunità (assicurando il pieno adempimento delle norme ma anche sfruttando i benefici consentiti), tutela nel difendere i diritti del contribuente di fronte alle pretese talvolta aggressive delle Amministrazioni fiscali.
Abbiamo visto come un fiscalista internazionale debba avere conoscenze multidisciplinari: diritto tributario sostanziale italiano e comparato, diritto convenzionale (trattati), procedure di cooperazione e contenzioso internazionale, fino al penale tributario. Aggiornamento costante (le norme evolvono di continuo, come la riforma fiscale del 2023 e l’introduzione della global minimum tax dimostrano) e visione strategica globale sono qualità imprescindibili.
Dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta), affidarsi a un professionista qualificato in questo campo significa poter agire con sicurezza nel contesto internazionale: pianificare un espatrio o un investimento all’estero sapendo in anticipo il trattamento fiscale, evitare errori costosi (come sanzioni per omessa dichiarazione di capitali), e, nel malaugurato caso di una controversia, avere la miglior difesa possibile basata su normativa e giurisprudenza aggiornata.
In un mondo in cui i flussi economici non conoscono confini, la fiscalità internazionale è destinata a essere sempre più centrale. L’avvocato tributarista internazionale diventa quindi una figura chiave per privati e aziende che operano oltre frontiera, garantendo che la “longa manus” del Fisco – sia italiano che straniero – venga gestita in modo equilibrato, nel rispetto delle regole ma anche dei diritti dei contribuenti.
Fonti (normativa, prassi e giurisprudenza citata):
- Camera dei Deputati – Dossier tematico: La fiscalità internazionale, 28 maggio 2025 .
- TUIR (D.P.R. 917/1986), artt. 2, 3, 23 (residenza persone fisiche, worldwide taxation); art. 73 (residenza società, come modif. da D.Lgs. 209/2023); art. 162 (stabile organizzazione); art. 165 (credito imposte estere); art. 167 (CFC, come modif. 2023); art. 169 (prevalenza norme interne favorevoli su trattati); art. 24-bis e 24-ter (flat tax neo-residenti, pensionati esteri); art. 16 D.Lgs.147/2015 (impatriati).
- D.Lgs. 74/2000 (reati tributari): art. 4 (dich. infedele) e 5 (omessa dich.) – soglie €100k/50k e pene aggiornate; art. 11 (sottrazione fraudolenta) – Cass. Pen. su sanzioni RW non rilevanti penalmente.
- Cass. civ. Sez. Trib. n.17289/2024 – Esterovestizione: sede effettiva vs. luogo beni.
- Cass. civ. Sez. Trib. n.3386/2024 – Esterovestizione di società estera e effetti anche su imposte indirette.
- Cass. Pen. Sez. III n.20649/2025 – Quadro RW: trasferimento di beni all’estero per non pagare sanzioni amministrative non è reato ex art.11 senza evasione imposte sui redditi.
- Cass. civ. nn.5066/2023 e 5075/2023 – Esterovestizione in ambito UE: necessario vantaggio fiscale indebito, rilievo della libertà di stabilimento.
- Agenzia Entrate – Provvedimento 30/04/2024 – modalità opzione tassazione sostitutiva 15% CFC (post riforma); Circolare 20/E 2024 – criteri residenza società (sede effettiva/gestione).
- OCSE Model Tax Convention, art. 4 (tie-breaker residenza), art.5 (stabile org) – recepiti in art.162 TUIR.
- Normativa UE: Dir. 2011/16/UE (DAC1) e succ. mod. DAC2…DAC7 – scambio info; Dir. 2017/1852 (doppia imposizione dispute); Dir. 2018/822 (DAC6 obbligo disclosure schemi).
- Ministero Economia – elenco Convenzioni internazionali in vigore (agg. sul sito Finanze.gov).
Cerchi un avvocato esperto in fiscalità internazionale? Affidati allo Studio Monardo
Hai conti, immobili, società o redditi all’estero e temi conseguenze fiscali in Italia?
Hai ricevuto lettere di compliance, avvisi di accertamento o richieste di chiarimenti su attività fuori confine?
La fiscalità internazionale è un terreno delicato, dove errori, omissioni o ritardi possono costare caro. Solo un professionista con esperienza in imposte estere, residenza fiscale e monitoraggio internazionale può tutelarti davvero.
🛡️ Cosa fa l’Avvocato Giuseppe Monardo per te
- 📂 Analizza la tua posizione fiscale transfrontaliera: conti, immobili, investimenti, partecipazioni
- 📌 Verifica obblighi di dichiarazione nel quadro RW e di versamento di imposte come IVIE e IVAFE
- ✍️ Ti assiste nel ravvedimento operoso o nella regolarizzazione spontanea per attività estere
- ⚖️ Ti difende da accertamenti per residenza fittizia, esterovestizione o redditi esteri non dichiarati
- 🌍 Ti supporta nella pianificazione fiscale internazionale, anche in caso di espatrio o rientro in Italia
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario internazionale
- ✔️ Specializzato in contenzioso fiscale su beni e redditi esteri
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Se hai legami fiscali con l’estero, non rischiare sanzioni o accertamenti improvvisi.
Con il supporto giusto puoi dichiarare correttamente, difenderti da contestazioni e pianificare ogni passaggio nel rispetto della legge.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua tutela fiscale internazionale comincia da qui.