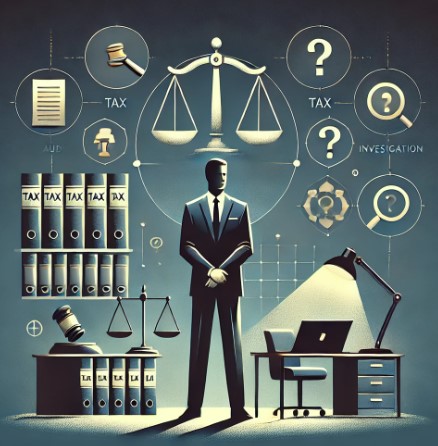Hai ricevuto un accertamento fiscale per indebita deduzione di costi? Ti contestano che alcune spese portate in deduzione non sono inerenti, non documentate o riferite a operazioni inesistenti? Ti stai chiedendo come difenderti e cosa puoi fare per evitare il recupero delle imposte e le sanzioni?
L’Agenzia delle Entrate può rettificare il reddito imponibile quando ritiene che determinati costi non siano deducibili secondo le regole fiscali. Tuttavia, non tutte le contestazioni sono fondate, e hai il diritto di dimostrare la legittimità delle tue deduzioni.
Quando può avvenire l’accertamento per indebita deduzione di costi?
– Quando i costi non sono inerenti all’attività d’impresa, professionale o di lavoro autonomo
– Quando le spese sono prive di idonea documentazione
– Quando i costi sono relativi a soggetti considerati “non operativi” o in black list
– Se le fatture risultano emesse da fornitori inesistenti o da soggetti coinvolti in frodi IVA
– Se mancano prove dell’effettiva esecuzione della prestazione o consegna del bene
Cosa può contestare il Fisco?
– Fatture per consulenze, servizi o forniture non dimostrate
– Costi per beni ad uso promiscuo (es. auto, telefoni, viaggi) non separati tra uso personale e professionale
– Spese per operazioni inesistenti o considerate soggettivamente false
– Deduzioni di costi pluriennali non ammortizzati correttamente
– Omissione di elementi essenziali nei documenti fiscali (data, oggetto, destinatario, prestazione)
Come difendersi da un accertamento per costi indeducibili?
– Dimostra l’inerenza del costo con l’attività svolta, anche con documentazione extracontabile
– Ricostruisci la tracciabilità dei pagamenti, l’avvenuta fornitura o esecuzione del servizio
– Presenta contratti, ordini, rapporti tecnici, mail, documenti di trasporto o collaudi
– Verifica che il costo sia correttamente registrato e attribuito all’esercizio di competenza
– Contesta eventuali presunzioni dell’Ufficio prive di riscontri oggettivi
– Se l’errore è formale ma il costo è reale, chiedi l’annullamento delle sanzioni per buona fede
– Valuta se presentare adesione, autotutela o ricorso tributario
Cosa puoi ottenere con una buona difesa?
– Annullamento totale o parziale dell’accertamento, se i costi sono legittimi
– Riconoscimento della deducibilità, anche con prove extrafattura
– Riduzione o annullamento delle sanzioni, se l’errore è scusabile
– Rateizzazione dell’imposta, in caso di accordo con l’Ufficio
– Sospensione della riscossione, se ricorri in giudizio
Un accertamento sui costi dedotti può compromettere la tua dichiarazione, la tua posizione fiscale e la tua liquidità aziendale. Ma non sempre la contestazione è corretta: puoi far valere le tue ragioni se hai agito con buona fede e hai documentazione a supporto.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa d’impresa ti spiega come reagire all’accertamento per indebita deduzione di costi, quali prove usare e quali risultati puoi ottenere.
Hai ricevuto una contestazione su costi dedotti? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo le tue spese, i documenti e la strategia migliore per difendere la tua azienda e annullare l’accertamento.
Introduzione
Un accertamento fiscale per indebita deduzione di costi si verifica quando l’Agenzia delle Entrate contesta a un contribuente (impresa, professionista o lavoratore autonomo) l’omessa indicazione o la deduzione di costi che ritiene non spettanti. Ciò può avvenire in presenza di fatture false o costituzioni artificiose dei costi (ad es. fatture emesse da “società cartiere” o prestanome) oppure quando spese personali o non inerenti all’attività vengono impropriamente portate in deduzione. In tali casi l’Amministrazione finanziaria ripristina il reddito imponibile maggiorandolo dei costi contestati e recupera le imposte evase, applicando sanzioni e interessi.
Di seguito si illustrano in dettaglio i profili essenziali dell’accertamento per indebita deduzione di costi: la normativa di riferimento, le tipologie di operazioni false (oggettive e soggettive), i requisiti per la deducibilità, la ripartizione dell’onere della prova, le modalità del contraddittorio e dell’accertamento, nonché le strategie difensive a disposizione del contribuente-debitore. Si riportano anche tabelle riassuntive, quesiti e risposte pratiche ed esempi concreti per chiarire le più comuni situazioni applicative. Il linguaggio è tecnico-giuridico ma divulgativo, mirato ad avvocati, imprenditori e contribuenti esperti. Le fonti normative e giurisprudenziali utilizzate sono elencate alla fine.
1. Normativa di riferimento
- Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) – D.P.R. 917/1986: stabilisce i criteri generali per la deducibilità dei costi di impresa e di lavoro autonomo (artt. 54-95 TUIR). In particolare:
- Art. 95 TUIR: costi per lavoro dipendente, indennità e compensi a terzi deducibili se inerenti.
- Art. 109 TUIR: costi generali sostenuti per l’attività di impresa (es. ufficio, utenze, ammortamenti) sono deducibili se inerenti.
- In generale, i costi sono deducibili se effettivamente sostenuti, certi e inerenti all’attività (principio di inerenza qualitativa).
- D.P.R. 600/1973 (Testo unico delle imposte sui redditi): disciplina gli accertamenti fiscali diretti (IVA, imposte dirette), tra cui l’art. 43 (raddoppio termini in caso di frode fiscale, quali false fatturazioni) e l’art. 32 (attuazione del contraddittorio preventivo).
- D.Lgs. 471/1997 (sanzioni amministrative): prevede le sanzioni per dichiarazioni fraudolente, costituite da violazioni di norme tributarie (art. 5 e 6), compresa la sanzione al 90% per indebita detrazione IVA.
- D.Lgs. 472/1997 (sanzioni amministrative): disciplina le sanzioni per le violazioni degli obblighi formali e sostanziali, nonché lo ravvedimento operoso (art. 13, che riduce le sanzioni se il contribuente corregge spontaneamente l’errore).
- D.Lgs. 74/2000 (penale tributario): prevede i reati fiscali. In particolare:
- Art. 2: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti falsi, sanziona il contribuente che nasconde redditi con falsi.
- Art. 8: emissione di fatture false, colpisce chi emette fatture per operazioni inesistenti.
- Art. 13: se il contribuente estingue il debito tributario (imposte, sanzioni e interessi) prima del giudizio penale, il reato non è punibile.
- L. 212/2000 (Statuto del Contribuente): all’art. 12 garantisce al contribuente il contraddittorio preventivo (sembra modificato dal 2025).
- L. 130/2022 (cd. riforma del processo tributario): ha introdotto l’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, ribadendo che l’amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate, ferma restando la regola generale dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova.
A livello europeo, le corti (Corte di Giustizia UE) hanno stabilito che la deducibilità dei costi legati a operazioni inesistenti richiede la prova della reale esecuzione delle prestazioni.
2. Tipologie di “operazioni inesistenti”
Nel diritto tributario italiano si distinguono due principali categorie di operazioni inesistenti:
- Operazioni oggettivamente inesistenti: l’operazione economica (cessione di beni o prestazione di servizi) non è mai avvenuta. La fattura è totalmente falsa perché né i beni né i servizi sono stati effettivamente forniti. Ad esempio, una fattura per la vendita di merce mai prodotta o consegnata. I costi derivanti da tali fatture sono sempre indeducibili (sono “fittizi” tout court) e l’IVA non è detraibile.
- Operazioni soggettivamente inesistenti: l’operazione economica è avvenuta realmente tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura. Tipicamente un’impresa effettua una prestazione o cede beni, ma la fattura viene emessa da un’altra persona o società (di solito un’interposizione fittizia come una “società cartiera” o prestanome). In sostanza, la fattura è soggettivamente falsa: il cedente/prestatore indicato in fattura non è colui che ha eseguito la prestazione. Un classico esempio è il meccanismo della frode carosello: un soggetto A vende merce ad un intermediario fittizio B (la cartiera), che emette fattura a C, mentre in realtà la merce proviene direttamente da A a C. In questi casi l’operazione c’è stata realmente, ma non con il soggetto indicato.
Caratteristiche principali:
| Oggettivamente inesistente | Soggettivamente inesistente | |
|---|---|---|
| Esistenza reale | Nessuna operazione reale: il bene/servizio non è mai stato scambiato. | L’operazione economica è avvenuta realmente, ma con un soggetto diverso da quello in fattura. |
| Falsità della fattura | Totale: il documento è interamente fittizio. | Parziale: falso l’emittente (il cedente/prestatore indicato non è quello che ha operato). |
| Scopo fiscale | Creare costi e crediti IVA dal nulla (per evadere le imposte). | Ottenere detrazioni/deduzioni fiscali per operazioni reali nascondendo il vero fornitore (spesso un evasore IVA). |
| Deducibilità dei costi | NO: i costi fittizi sono del tutto indeducibili. | SI, in linea di principio, a condizione che il costo sia effettivamente sostenuto, inerente e certo. |
La Cassazione ha chiarito che i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, ma solo se il contribuente dimostra in modo effettivo, inerente e certo l’avvenuta prestazione. Viceversa, i costi di operazioni oggettivamente inesistenti (cioè senza alcuna reale esecuzione) restano sempre indeducibili, anche se formalmente documentati.
Tabella riepilogativa (estrapolata dalla giurisprudenza):
“Sono deducibili i costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti a condizione che il contribuente dimostri l’effettività, l’inerenza e la certezza delle prestazioni; viceversa, è esclusa in via assoluta la deduzione dei costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, anche in presenza di documentazione formalmente regolare”.
Si tenga presente che esistono anche casi misti o parziali (ad es. fatture sovrafatturate, prestazioni non corrispondenti) che si valutano fatto per fatto, assimilando la porzione fittizia a una operazione inesistente.
3. Requisiti di deducibilità e onere della prova
3.1 Requisiti generali di deducibilità
Per poter dedurre un costo dal reddito d’impresa/lavoro autonomo ai sensi del TUIR, è necessario che il costo sia effettivamente sostenuto, certo e inerente all’attività (D.P.R. 917/1986, artt. 54, 95, 109). Inerenza significa che il costo deve avere una correlazione logica con l’attività produttiva di reddito. La Cassazione ha sottolineato che l’inerenza è un giudizio qualitativo: è sufficiente che il costo sia correlato in generale all’attività, non necessariamente a uno specifico ricavo. Tuttavia, parametri quantitativi (ad esempio spese totalmente sproporzionate rispetto alle entrate o ai consueti indicatori settoriali) possono costituire indizi di difetto di inerenza.
In ogni caso, l’effettività della prestazione è imprescindibile: il costo dedotto deve corrispondere a un reale esborso o servizio fruito dal contribuente. La mancanza di prova dell’effettiva esecuzione della prestazione rende il costo indeducibile e l’IVA indetraibile.
3.2 Onere della prova in sede di contenzioso
In caso di controversia tributaria, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’onere della prova gravante inizialmente sul contribuente rimane inalterato anche dopo la riforma del 2022. In altre parole, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza del costo e la sussistenza dei presupposti di deducibilità (effettività, inerenza, correlazione economica).
Ciononostante, l’Agenzia delle Entrate deve anch’essa dare prova adeguata delle contestazioni mosse: quando emette l’avviso di accertamento l’ufficio contesta l’indeducibilità di un costo, ma è tenuto a fornire elementi di prova (anche indiziari, purché gravi, precisi e concordanti) a sostegno di tale contestazione. In particolare, nel caso di fatture sospette, la prassi è che l’Amministrazione raccolga presunzioni di inesistenza (ad es. accertamenti sulla struttura dei fornitori, irregolarità contributive, incongruenze nelle movimentazioni) per sostenere che l’operazione è fittizia.
Principio consolidato: se l’Amministrazione dimostra l’oggettiva inesistenza delle operazioni (anche tramite indizi affidabili), incombe al contribuente provare concretamente l’avvenuta prestazione. La Corte di Cassazione ha infatti spiegato che una semplice produzione di fatture regolari, scritture contabili o di pagamenti non è di per sé sufficiente ad affrontare la presunzione di inesistenza, poiché tali elementi formali potrebbero essere stati usati proprio per far apparire “reali” operazioni fittizie.
Novità del 2022 (L.130/2022): l’introduzione dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 ha ribadito che “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate” e che il giudice annulla l’atto impositivo se tale prova manca o è contraddittoria. La Cassazione con l’ordinanza n. 31878/2022 ha chiarito che questa norma non invertirà automaticamente l’onere generale: rimane confermata la regola dell’art. 2697 c.c. (la prova delle proprie affermazioni è in capo a chi le allega) salvo casi in cui intervengano presunzioni legali di frode. In pratica, se l’Amministrazione fiscale dispone di presunzioni di frode (come nel caso di operazioni inesistenti), esse operano come presunzioni legali che spostano temporaneamente l’onere sul contribuente; altrimenti resta principio che sia l’ufficio a provare la validità della pretesa.
3.3 Giurisprudenza chiave
- Cass. 13.06.2024, n. 16493: ha ribadito che, in tema di IVA, «una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri […] l’oggettiva inesistenza delle operazioni (anche mediante semplici presunzioni), spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate». In tale sentenza l’Agenzia, in appello, sosteneva che il contribuente doveva provare le forniture; la Cassazione ha invece confermato che questa prova grava sul contribuente solo dopo che l’ufficio abbia posto elementi gravi di falsità (inversione virtuosa dell’onere probatorio).
- Cass. 02.04.2025, n. 8716: ha confermato che i costi da operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, purché dimostrati effettivi, inerenti e certi; al contrario, i costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti sono sempre indeducibili anche se formalmente documentati. La Corte ha precisato che la mera produzione di fatture regolari non esime il contribuente dal dimostrare la realtà economica delle prestazioni, quando l’Amministrazione ha provato la fittizietà del fornitore (ad esempio società cartiere).
- Cass. 16.06.2020, n. 11624: ha riaffermato il corretto riparto dell’onere della prova nelle fatture inesistenti, sancendo che il contribuente deve dimostrare l’effettività delle operazioni (ne ha dato rilievo questa pronuncia nei commenti).
- Cass. 33568/2022 (ord. 15.11.2022): attraverso l’ordinanza n. 33568/2022, ha ribadito che l’onere della prova della regolarità dei costi rimane originariamente in capo al contribuente, anche dopo la riforma del 2022. I giudici hanno chiarito che la legge non ha modificato il riparto di base: il contribuente deve comunque provare l’esistenza e l’inerenza dei costi, fermo restando che l’Ufficio, nella contestazione, dovrà anch’esso fornire adeguata prova (presuntiva) delle proprie allegazioni.
- Corte di Giustizia UE, sentenze Kemwater (C-281/20, 11.11.2021) e PPUH (C‑277/14, 22.10.2015): hanno stabilito in sintonia con la Cassazione che il diritto alla detrazione IVA è subordinato alla prova della reale esecuzione delle operazioni, poiché fatture e documenti formali non bastano ad annullare la presunzione di frode.
In sintesi, la giurisprudenza prevalente evidenzia che il contribuente deve dotarsi di prova concreta ed economica delle operazioni contestate. In caso di operazioni oggettivamente inesistenti non c’è difesa; in caso di operazioni soggettivamente inesistenti il contribuente può far valere la deducibilità solo dimostrando l’effettivo compimento della prestazione. Se il contribuente era in buona fede e diligente, la Corte di legittimità tende a tutelarlo: ad esempio, ha osservato che «se uno acquista merce reale da un soggetto e ignora che questi è solo un prestanome, non può automaticamente subire le conseguenze del comportamento fraudolento altrui, purché abbia tenuto un comportamento diligente». Tuttavia, la prova della “buona fede” (diligenza) spetta sempre al contribuente.
4. Procedura dell’accertamento
4.1 Attività ispettive e notifiche
L’accertamento inizia con controlli dell’Agenzia o della Guardia di Finanza, spesso accompagnati da un processo verbale di constatazione (PVC) che rileva irregolarità contabili o fiscali. Se si ritiene che vi sia indebita deduzione di costi, l’Agenzia emette un avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. 600/1973 (per imposte dirette e IVA) o del D.Lgs. 446/1997 (per l’IRAP), notificandolo al contribuente.
- Termini di decadenza: in via generale l’Agenzia ha 4 anni (dichiarati) o 5 anni (omessa dichiarazione) dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per accertare le imposte. Tuttavia, in presenza di violazioni gravi (tra cui la falsità delle fatture) i termini si raddoppiano (8 anni). È quanto prevede l’art. 43 del D.P.R. 600/73 per i casi di frode fiscale (false fatture, evasione contributiva, ecc.). Ad esempio, un accertamento su fatture inesistenti potrà essere notificato fino a 8 anni dopo l’anno d’imposta.
- Contraddittorio preventivo: ai sensi dell’art. 12 della L. 212/2000, prima di notificare l’avviso deve essere esperito il contraddittorio (sessione orale in cui il contribuente può produrre memorie e documenti). Il contribuente dispone di un termine di 60 giorni per inviare osservazioni scritte (contraddittorio a documenti). Novità 2025: il decreto correttivo Irpef-Ires del 14 luglio 2025 ha chiarito che i 60 giorni concessi sono “termine unico” comprensivo anche del tempo necessario per richiedere gli atti, eliminando la possibilità di una sospensione per accesso. In pratica, ora il contribuente ha 60 giorni in tutto per preparare le proprie difese e ottenere gli atti istruttori.
- Accertamento con adesione e conciliazione: il contribuente può anche valutare le opzioni di definizione agevolata (entro i termini), come l’Accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997) o la conciliazione giudiziale, per ridurre oneri e sanzioni. Tuttavia queste ipotesi sono possibili solo prima dell’instaurazione del contenzioso o nelle condizioni che regolano il contenzioso stesso.
4.2 Contenuto dell’avviso di accertamento
L’avviso deve riportare:
- Le imposte accertate (IRPEF/IRES/IRAP, IVA, etc.) con la relativa maggiorazione, interessi e sanzioni.
- Le motivazioni: in caso di indebita deduzione di costi la motivazione consisterà nel descrivere le operazioni ritenute inesistenti o non inerenti, e gli elementi raccolti (ad es. accertamenti GdF) che portano a questa conclusione.
- L’indicazione della possibilità di proporre ricorso in Commissione Tributaria.
4.3 Effetti dell’accertamento
A seguito dell’avviso di accertamento indebita deduzione di costi, il contribuente:
- Vede rettificato in aumento il reddito d’impresa/lavoro autonomo: i costi contestati vengono aggiunti al reddito imponibile (IRES/IRPEF) e al valore della produzione netta (IRAP).
- Per l’IVA: se derivavano crediti IVA non spettanti, viene richiesto il recupero di tali crediti con sanzioni (minimo 90% dell’importo detratto) e interessi.
- Subisce sanzioni amministrative: di regola la violazione è classificata come “dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi” e viene applicata la sanzione dal 100% al 200% delle imposte evase (art. 5-6 D.Lgs. 472/1997). Inoltre, ai sensi dell’art. 6 co.6 D.Lgs. 471/1997 la semplice detrazione IVA indebita è sanzionata al 90% dell’imposta indebitamente detratta. (Ad es., detratto indebitamente 10.000€ di IVA, si pagheranno 10.000€ + interessi + 9.000€ di sanzione).
- Sì espone risvolti penali: l’utilizzo di fatture inesistenti configura reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) per l’emittente del documento e di falso (art. 8 D.Lgs. 74/2000) per il fornitore fittizio. Ciò può tradursi in indagini o procedimenti penali a carico degli amministratori coinvolti. Tuttavia, se il contribuente paga integralmente imposte e sanzioni entro il dibattimento, il reato si estingue (art. 13 D.Lgs. 74/2000) grazie alla causa di non punibilità.
Pratica riassuntiva: l’avviso specifica i costi disconosciuti, l’imposta aggiuntiva con gli interessi, la sanzione applicata e ricorda le difese possibili. In sostanza, l’accertamento «recupera» ciò che il contribuente ha dedotto o detratto indebitamente, applicando quasi il doppio a causa di sanzioni e interessi (p.es. se una deduzione indebita ha inciso per €X sulla base imponibile, l’azienda pagherà circa €X di imposte dovute + €X di imposte + sanzioni 90% + interessi).
5. Come difendersi (strategia del contribuente)
Dal punto di vista del debitore (contribuente), la difesa contro un accertamento per indebita deduzione di costi si sviluppa su più fronti:
- Contraddittorio preventivo: rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni e produrre memorie e documenti difensivi. La legge (ancora codificata nell’art. 12 L. 212/2000) garantiva il contraddittorio orale; tuttavia la prassi spesso si è limitata alla presentazione di scritti entro 60 giorni. Con le modifiche del 2025, questi 60 giorni ora includono anche l’accesso agli atti, per cui è essenziale avvalersi subito del diritto di accesso per ottenere prove e documenti interni dell’Ufficio. Nel contraddittorio si dovranno fornire tutte le prove disponibili dell’effettivo svolgimento delle operazioni (ad es. contratti, report di lavoro, fotografie, testimonianze dei dipendenti, coordinate bancarie, ecc.) per confutare l’accusa di inesistenza.
- Onere della prova e documentazione: come detto, la difesa non può limitarsi a esibire fatture, estratti conti o scritture regolari; è necessario allegare elementi “sostanziali”. Ad esempio, se si contesta l’inesistenza di un servizio erogato da un fornitore “cartiera”, il contribuente dovrebbe provare di fatto che il servizio è stato reso (via documentazione tecnica, report, corrispondenza e-mail, scritture di consegna, appalti supervisionati, testimonianze, pagamenti diretti a terzi che hanno effettuato il lavoro, ecc.). In sostanza, la strategia è dimostrare la realtà economica dell’operazione. La Cassazione invita infatti a “predisporre una documentazione completa e sostanziale dell’effettiva esecuzione delle prestazioni” e “adottare tutte le cautele possibili nella selezione dei fornitori”.
- Ricorso tributario: se l’avviso viene notificato nonostante il contraddittorio, il contribuente può impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni, facendo valere le motivazioni di fatto e di diritto. In appello e poi in Cassazione, dovrà insistere sulla mancanza di prova dell’Amministrazione e sulla propria dimostrazione concreta. Va sottolineato che proclamare genericamente la propria innocenza non basta: «il punto di vista del debitore deve essere pragmatico: proclamare la propria innocenza non basta, occorre dimostrarla con fatti (documenti, …)». Le giurisprudenze di merito (Commissioni Tributarie) sono allineate a quella di legittimità: il contribuente deve fornire elementi concreti, mentre l’ufficio deve fornire prove oggettive della frode.
- Eventuali eccezioni procedurali: in alcuni casi è possibile contestare vizi formali dell’accertamento (notifica errata, calcolo ministero errato delle imposte, eccessiva anzianità del PVC, mancato contraddittorio orale, etc.). Tali eccezioni non inficiano però l’analisi di merito, se non si verifica un difetto assoluto (ad es. atto notificato oltre i termini). Ad esempio, si può contestare il raddoppio dei termini se non ricorrono i presupposti (art. 43 DPR 600/73), o lamentare la violazione del contraddittorio se non era dovuto nel caso specifico.
- Collaborazione e ravvedimento: se il contribuente intuisce di avere ricevuto fatture potenzialmente inesistenti (o se è troppo tardi per raccogliere prove concrete), può optare per una strategia di “danni minimi”. Ciò significa collaborare con l’Agenzia: pagare le imposte dovute su quei costi sospetti, chiedendo magari una definizione agevolata. Ad esempio, attraverso il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13) si possono pagare volontariamente imposte e sanzioni con sconto delle sanzioni (fino a 1/8 dell’ordinaria se prima del controllo, o 1/10 dopo) ed evitare l’avviso accertativo. Sul versante penale, pagare subito tutto (imposte, interessi, sanzioni) in sede di giudizio permette di usufruire dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000: il reato si estingue e si evita la pena detentiva. Esempio (semplificato): la società Zeta S.p.A. si accorge di aver dedotto nel 2023 un costo di 100.000€ derivante da fatture false. Decide di procedere con autotassazione (ravvedimento). Consegna al fisco una dichiarazione integrativa: corregge i redditi imponibili (+100.000€) e paga le maggiori imposte (ad es. IRES 24% di 100.000 = 24.000€), l’IVA 22% di 100.000 = 22.000€ (da restituire), più interessi e una sanzione ridotta (90%*6,25% ≈ 5,6% per ravvedimento oltre un anno). In totale versa circa 50.000€ di imposte aggiuntive e pochi migliaia di sanzione. L’Agenzia prende atto del ravvedimento e non emette accertamento. In ambito penale, l’amministratore dimostra di aver estinto il debito prima del giudizio e chiede applicazione art. 13 D.Lgs. 74/2000: il reato penale si estingue. Risultato: Zeta ha evitato sanzioni maggiori (90%) e rischi di carcere, pur pagando tasse e qualche penalità ridotta.
- Tutela in caso di buona fede: se il contribuente agisce in buona fede e ha tenuto una condotta diligente nell’ambito commerciale, ciò può attenuare la sua posizione soprattutto sul piano penale. In sede tributaria però l’operazione non viene sanata dalla semplice buona fede; resta cruciale fornire prove documentali della prestazione. La Cassazione ha comunque riconosciuto che un imprenditore mediamente esperto deve essere avvisato da alcuni “indizi idonei” sulla possibile fittizietà dell’operazione: se tali indizi esistono (ad es. fornitore mai incontrato, pagamenti in nero, anomalie contabili) e il contribuente li ha ignorati, si presume la sua consapevolezza.
6. Domande frequenti
D. Che differenza c’è tra “soggettivamente inesistente” e “oggettivamente inesistente” per un costo?
R. Un’operazione è oggettivamente inesistente quando il bene o servizio non è mai stato fornito in concreto. In tal caso il costo è fittizio e in nessun caso deducibile. Un’operazione è soggettivamente inesistente quando il servizio è stato eseguito, ma la fattura è stata emessa da un altro soggetto (di solito un intermediario fittizio). In questo caso il costo è deducibile se provato reale e inerente.
D. Chi deve provare che l’operazione c’è stata?
R. In linea di principio, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni fatturate, poiché lui è l’unico a poter fornire elementi sostanziali. Tuttavia l’Amministrazione deve allegare almeno indizi gravi di fittizietà (per esempio verifiche sulla struttura dei fornitori). Se l’ufficio dimostra (anche per presunzioni) che l’operazione è fittizia, il contribuente deve rovesciare tale presunzione provando fatti concreti.
D. Una semplice fattura regolare è sufficiente per provare un costo?
R. No. Come ha più volte ricordato la Cassazione, “la mera produzione di fatture regolari, scritture contabili e mezzi di pagamento non è idonea a superare la presunzione di inesistenza oggettiva”. Ciò vale soprattutto se l’amministrazione ha dimostrato che il fornitore è una “società cartiera” o comunque fittizia. In sostanza serve documentazione aggiuntiva: ad esempio prove dell’avvenuta lavorazione, del possesso dei beni, delle registrazioni operative interne, ecc.
D. Quali sanzioni rischio se uso fatture false?
R. Sul piano fiscale, in caso di operazioni inesistenti l’Agenzia recupera l’imposta evasa con interessi e applica sanzioni amministrative elevate. Per l’IVA indebitamente detratta la sanzione minima è il 90% dell’importo (art. 6 c.6 D.Lgs. 471/97). Per le imposte sui redditi, la violazione rientra nelle “dichiarazioni fraudolente” (art. 2 c.2 D.Lgs. 472/1997), con sanzione dal 100% al 200% dell’imposta. Si ricordino anche gli interessi di mora. Sul piano penale, chi emette o utilizza fatture false può essere perseguito per reati tributari (art. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000). Se il reato viene accertato, l’amministratore rischia fino a 6 anni di carcere (a fronte di pene aumentate dal 2019). Tuttavia, pagando integralmente prima del dibattimento le imposte dovute e relative sanzioni, il reato non è punibile (art. 13 D.Lgs. 74/2000).
D. In cosa consiste il contraddittorio?
R. Il contraddittorio è un incontro (o scambio di documenti) con l’ufficio prima della notifica dell’avviso. Serve a fornire chiarimenti e prove documentali. Dall’estate 2025, i 60 giorni concessi al contribuente sono “termine unico”: si dispone anche del tempo per l’accesso agli atti. È quindi fondamentale richiedere subito copia dei documenti (P.V.C., documenti esibiti dall’ufficio, segnalazioni interne) e presentare una memoria difensiva completa. Ignorare il contraddittorio o non parteciparvi limita le difese possibili in contenzioso.
D. Il contribuente può autodenunciarsi?
R. Sì. Se scopre fatture false nella propria contabilità, può regolarizzare la posizione: si parla di autodenuncia fiscale o ravvedimento operoso. Ciò comporta presentare dichiarazioni integrative e versare spontaneamente le imposte, l’IVA, gli interessi e (in misura ridotta) le sanzioni dovute. Come visto nell’esempio di Zeta S.p.A., l’autodenuncia consente di evitare l’accertamento ufficiale e di ridurre drasticamente le penalità (ad esempio, la sanzione ordinaria del 90% può essere ridotta a circa l’11% pagando entro un anno). Inoltre, sul fronte penale, l’azzeramento del debito prima del processo fa scattare l’art. 13 D.Lgs. 74/2000: il reato tributario si estingue. Questa strategia è consigliata soprattutto quando emerge prima del controllo di avere importi irregolari: può salvaguardare dalla galera, anche se comporta un oneroso esborso fiscale.
D. Cosa cambia con la riforma 2022 (L.130/2022)?
R. In realtà poco è cambiato sul piano delle situazioni concrete di frode. L’unica vera novità è l’esplicito richiamo in legedel contrassegnata da prassi (art. 7, co. 5‑bis D.Lgs. 546/92) che l’onere di provare le violazioni è dell’Amministrazione. Tuttavia, come accennato, la Cassazione ha chiarito che ciò ribadisce quanto già previsto dall’art. 2697 c.c. e non sposta l’onere di base, se non nei casi di presunzioni legali. In pratica, nel processo tributario l’amministrazione deve sempre produrre la propria prova in giudizio e il giudice annullerà l’avviso se non ci sono motivi circostanziati e coerenti che lo giustifichino. Resta fermo che, per il contribuente sotto accertamento, il dovere di dimostrare concretamente le operazioni contestate non è venuto meno.
7. Conclusioni
L’accertamento fiscale per indebita deduzione di costi è una delle contestazioni più complesse e rischiose per un contribuente. Le norme fiscali e la giurisprudenza richiedono la massima cautela nella tenuta della contabilità e nella selezione dei fornitori. Difendersi efficacemente significa predisporre una prova solida delle operazioni reali – oltre ai documenti formali – e saper utilizzare i rimedi previsti (contraddittorio, ricorso, ravvedimento). Quando un accertamento viene notificato, il contribuente deve agire rapidamente: raccogliere elementi, valutare soluzioni bonarie o giurisdizionali, e preparare una difesa che ponga l’accento sulla propria buona fede e diligenza. In ogni caso, la strategia deve essere concreta: la Cassazione stessa avverte che “proclamare la propria innocenza non basta, occorre dimostrarla con fatti”. Conoscere le ultime pronunce giurisprudenziali e le modalità procedurali (ad es. limiti del contraddittorio) è fondamentale per massimizzare le possibilità di successo.
Fonti e riferimenti normativi
- Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 16493 del 13 giugno 2024 (onere della prova, fatture inesistenti).
- Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 8716 del 2 aprile 2025 (operazioni soggettivamente vs oggettivamente inesistenti).
- Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022 (riforma onere della prova).
- Cassazione, ord. n. 33568/2022 (riparto onere della prova e inerenza dei costi).
- Cass. 16 giugno 2020, n. 11624 (fatture inesistenti e onere probatorio).
- Cass. sent. n. 28628/2021, n. 9851/2018, n. 5339/2020, n. 15369/2020, n. 25891/2023 e altre menzionate in nota.
- Cass. 14 dicembre 2023, n. 35091 (partecipazione contribuente al reato, fatture false).
- Corte di Giustizia UE, causa C-277/14 (PPUH, 22 ott. 2015) e C-281/20 (Kemwater, 11 nov. 2021): deducibilità IVA e operazioni inesistenti.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 54, 95, 109 (deducibilità dei costi d’impresa).
- D.P.R. 600/1973, artt. 43 (raddoppio termini di accertamento per frodi fiscali) e 55 (accertamento analitico).
- D.Lgs. 471/1997, art. 6, comma 6 (sanzione 90% per indebita detrazione IVA).
- D.Lgs. 472/1997, artt. 5-6 (sanzioni per omessa/infedele dichiarazione; ravvedimento art. 13).
- D.Lgs. 74/2000, artt. 2 e 8 (reati tributari: dichiarazione fraudolenta e emissione fatture false); art. 13 (estinzione reato per integrale pagamento).
- L. 212/2000, art. 12 (contraddittorio preventivo).
- L. 130/2022, art. 6 (introduzione comma 5-bis all’art. 7 D.Lgs. 546/1992).
- Cassazione tributaria e Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (CTP e CTR) – giurisprudenza di merito citata nei commenti.
- Circolari e risoluzioni Agenzia Entrate (es. Ris. 3/8/2021 n. 51, conferma sanz. 90% per detrazioni indebite, vedi).
Accertamento fiscale per indebita deduzione di costi? Fatti Difendere da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento in cui l’Agenzia delle Entrate contesta la deducibilità di alcuni costi aziendali o professionali?
Ti accusano di aver portato in deduzione spese non inerenti, fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti?
Molte aziende, liberi professionisti e partite IVA vengono colpiti da accertamenti basati su presunzioni o rilievi formali. Se l’Agenzia ritiene che un costo non sia legittimamente deducibile, può rettificare il reddito imponibile e applicare pesanti sanzioni. Ma puoi difenderti.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’accertamento e i costi contestati, distinguendo tra spese legittime e presunte
- 📌 Verifica la corretta applicazione dei principi di inerenza, competenza e tracciabilità
- ✍️ Redige memorie difensive e ricorso contro l’accertamento, con prova dell’effettività del costo
- ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Commissione Tributaria e durante il contraddittorio con l’Agenzia
- 🔁 Ti assiste in caso di definizione agevolata, ravvedimento operoso o autotutela
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e fiscalità d’impresa
- ✔️ Specializzato nella difesa da accertamenti su costi non deducibili e operazioni inesistenti
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Un accertamento per indebita deduzione di costi può essere contestato punto per punto, anche con prova documentale, testimoniale o ricostruzioni tecniche.
Con una difesa mirata puoi difendere la tua posizione fiscale e ridurre sanzioni e imposte richieste.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa fiscale comincia da qui.