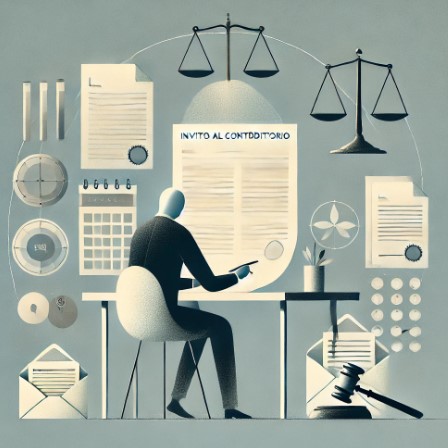Hai ricevuto un invito al contraddittorio dall’Agenzia delle Entrate e ti chiedono di presentare le tue memorie difensive? Ti stai chiedendo come si scrivono, quali documenti allegare e quanto possono incidere sull’esito dell’accertamento?
L’invito al contraddittorio è un passaggio fondamentale del procedimento fiscale. È il momento in cui puoi difenderti prima che venga emesso l’avviso di accertamento. Presentare memorie ben scritte, documentate e tecnicamente fondate può evitare l’accertamento o ridurre fortemente le somme richieste.
Cos’è l’invito al contraddittorio?
– È un atto formale con cui l’Agenzia ti comunica le ipotesi di accertamento
– Ti offre la possibilità di presentare osservazioni, documenti, giustificazioni e memorie
– Ha lo scopo di garantire il principio del contraddittorio preventivo, oggi obbligatorio per legge
– Deve essere inviato almeno 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento
Cosa sono le memorie difensive?
– Sono un documento scritto, da presentare in risposta all’invito
– Servono a contestare punto per punto le ricostruzioni del Fisco
– Possono essere accompagnate da documentazione giustificativa (contratti, estratti conti, fatture, ecc.)
– Possono contenere richieste di chiarimenti, accesso agli atti, o richieste di archiviazione
Come si scrivono correttamente le memorie difensive?
– Analizza attentamente i rilievi contenuti nell’invito al contraddittorio
– Raccogli tutti i documenti utili a giustificare le tue operazioni
– Contesta in modo tecnico le presunzioni o le ricostruzioni errate
– Usa un linguaggio chiaro, preciso, giuridicamente fondato
– Sottolinea l’assenza di dolo, l’esistenza di errori formali, o circostanze attenuanti
– Richiedi, se opportuno, un incontro personale con l’Ufficio per chiarimenti
– Fai redigere o revisionare le memorie da un avvocato tributarista esperto
Quali sono gli errori da evitare?
– Risposte generiche o senza documenti allegati
– Confondere le memorie con un ricorso (che va fatto solo dopo l’avviso)
– Non rispettare il termine di 60 giorni
– Ignorare l’invito, lasciando il campo libero all’Agenzia di emettere l’accertamento senza replica
– Affidarsi al “fai da te” se i rilievi sono complessi o rilevanti
Cosa puoi ottenere con memorie ben fatte?
– Archiviazione dell’intero procedimento, se le tue spiegazioni sono convincenti
– Riduzione significativa delle contestazioni
– Accesso a un eventuale accertamento con adesione in condizioni più favorevoli
– Dimostrare buona fede e collaborazione, utile anche per eventuali fasi successive (ricorso o mediazione)
Le memorie difensive sono uno strumento potente, se redatte correttamente. È il momento per prendere in mano la tua posizione fiscale, mostrare che sei preparato e che le contestazioni sono infondate, sproporzionate o da ridimensionare.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa da accertamenti fiscali ti spiega come redigere memorie difensive efficaci in risposta a un invito al contraddittorio e come usarle per evitare l’accertamento.
Hai ricevuto un invito e non sai come rispondere? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso e ti aiuteremo a scrivere memorie difensive tecniche, documentate e mirate a tutelare i tuoi diritti.
Introduzione
Le memorie difensive nell’ambito dell’invito al contraddittorio sono uno strumento fondamentale con cui il contribuente (debitore d’imposta) può far valere le proprie ragioni prima che l’Ufficio emetta un avviso di accertamento. In pratica, quando l’Agenzia delle Entrate intende emettere un atto impositivo, deve (salvo eccezioni di legge) invitare il contribuente a un confronto – scritto e/o orale – durante il quale quest’ultimo può presentare osservazioni, documenti e argomentazioni difensive. Tale fase, detta contraddittorio endoprocedimentale o preventivo, serve a garantire il diritto di difesa e la partecipazione del contribuente, correggendo eventuali errori o fraintendimenti prima che l’atto diventi definitivo.
Dal punto di vista del contribuente, redigere efficacemente una memoria difensiva significa “farsi sentire” dall’Amministrazione finanziaria: esporre chiaramente i fatti, le norme e le prove a proprio favore, con un linguaggio giuridico appropriato ma comprensibile. Una memoria ben fatta può portare l’ufficio a rinunciare all’accertamento o a ridurre la pretesa fiscale, evitando un contenzioso lungo e costoso. Anche se non sempre l’Ufficio accoglierà le difese, il contribuente avrà comunque posto le basi della propria linea difensiva, costringendo l’Amministrazione a tenerne conto (l’avviso finale dovrà motivare il perché di un eventuale mancato accoglimento delle osservazioni).
In questa guida – aggiornata a luglio 2025 – vedremo come si redigono le memorie difensive in risposta a un invito al contraddittorio, con riferimento alla normativa italiana vigente e alle prassi operative più attuali. Il taglio è avanzato: forniremo i riferimenti normativi (anche recentissimi), le pronunce giurisprudenziali più rilevanti e suggerimenti pratici utili a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) ma anche a privati cittadini e imprenditori che vogliano capire meglio come tutelarsi in sede pre-contenziosa.
Quadro normativo: evoluzione del contraddittorio negli accertamenti tributari
Per contestualizzare il tema delle memorie difensive, occorre comprendere come si è evoluto in Italia il principio del contraddittorio nel procedimento di accertamento tributario. Di seguito ripercorriamo sinteticamente le tappe principali, fino alle novità del 2024–2025 che hanno introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio prima dell’emissione degli atti fiscali.
- Procedimento amministrativo e (esclusione) tributario: In via generale, la legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) prevede il diritto dei destinatari di atti amministrativi a partecipare al procedimento presentando memorie e documenti (artt. 7 e 10 L.241/1990). Tuttavia, storicamente i procedimenti di accertamento tributario erano esclusi dall’applicazione della L.241/1990, essendo regolati da leggi speciali. Questo ha fatto sì che, fino ai primi anni 2000, non esistesse una norma generale sul contraddittorio “preventivo” in materia fiscale.
- Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000): Un primo spiraglio si è avuto con lo Statuto del Contribuente, in particolare con l’art. 12, comma 7 della L.212/2000. Tale disposizione – tuttora in vigore – stabilisce che dopo una verifica fiscale svolta presso i locali del contribuente (es. accesso della Guardia di Finanza in azienda) il contribuente ha diritto a 60 giorni per presentare osservazioni e richieste, e l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine (salvo casi di particolare e motivata urgenza). In altre parole, nelle verifiche “in loco” l’ufficio deve redigere un Processo Verbale di Constatazione (PVC) finale, consegnarlo al contribuente e attendere le sue eventuali memorie difensive su quanto constatato. Questo articolo 12, c.7 ha rappresentato a lungo l’unica previsione generale di contraddittorio endoprocedimentale in ambito tributario. Va sottolineato che la norma impone anche all’ufficio, qualora emetta poi l’avviso, di valutare le osservazioni del contribuente e fornire risposta motivata alle stesse nell’atto (cd. “motivazione rafforzata” a tutela del diritto di difesa).
- Limiti dello Statuto e giurisprudenza fino al 2015: Al di fuori delle verifiche con PVC, non vi era un obbligo esplicito di contraddittorio prima dell’accertamento. Nei controlli cosiddetti “a tavolino” (effettuati dall’ufficio su banche dati, documenti inviati dal contribuente o incrocio di informazioni, senza accessi fisici), l’Agenzia spesso procedeva direttamente all’emissione dell’atto impositivo senza un preavviso o invito formale, salvo alcune ipotesi specifiche (come negli accertamenti basati sugli studi di settore, dove era prevista la convocazione del contribuente). Alcune pronunce di merito e di Cassazione avevano provato a estendere in via interpretativa un principio generale di contraddittorio, fondandolo su principi costituzionali (art. 24 Cost. – diritto di difesa; art. 97 Cost. – buon andamento della PA) e sui principi di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente (art. 10, c.1 L.212/2000). Tuttavia, questo orientamento non ha prevalso. Con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24823 del 9 dicembre 2015 si è stabilito in modo definitivo che, in assenza di una specifica previsione di legge, non si poteva annullare un avviso di accertamento per mancato contraddittorio, salvo il caso dei tributi armonizzati UE (es. IVA) per i quali invece trovano applicazione i principi comunitari. In sostanza, fino al 2019 circa lo scenario era: obbligo di contraddittorio solo dove la legge lo dice (PVC ex art.12, c.7 Statuto, o altri casi mirati), nessun obbligo generalizzato per gli altri tributi interni (IRPEF, IRES, ecc.), fatta salva l’IVA per la quale la giurisprudenza comunitaria e nazionale riconosceva il diritto di essere sentiti come principio fondamentale.
- Principio UE e “prova di resistenza”: Per i tributi armonizzati (IVA, dazi), la Corte di Giustizia UE aveva affermato il diritto al contraddittorio quale principio fondamentale (sentenza “Sopropé” C-349/07 del 2008, seguita da altre). La Cassazione italiana, recependo tali indicazioni, aveva stabilito che l’assenza di contraddittorio pre-accertamento in materia IVA rende nullo l’atto, ma solo se il contribuente dimostra in giudizio che la sua partecipazione avrebbe potuto influire sull’esito dell’atto – il che introduce la cosiddetta “prova di resistenza”. Questo concetto, formulato per l’IVA già nel 2013 (Cass. 28432/2013), implica che la nullità non è automatica: il contribuente deve indicare concretamente quali argomenti difensivi avrebbe sollevato e come questi avrebbero potuto cambiare (anche solo in parte) la decisione dell’Ufficio. Ad esempio, se l’atto contesta ricavi non dichiarati ma il contribuente in giudizio non sa indicare alcuna giustificazione plausibile (perché magari quei ricavi non dichiarati esistono davvero senza spiegazioni), allora l’omesso contraddittorio viene considerato un vizio “non influente” e l’atto rimane valido. Questa esigenza di prova di resistenza è stata poi applicata dalla Cassazione anche ai tributi non armonizzati in alcune decisioni, sebbene in modo non uniforme.
- Introduzione dell’obbligo “mirato” nel 2019–2020 (art. 5-ter D.Lgs. 218/1997): Di fronte all’assenza di un obbligo generalizzato e alle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il legislatore è intervenuto una prima volta con il Decreto Legge 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”, convertito con L.58/2019). In sede di conversione è stato inserito l’art. 4-octies, che ha introdotto nel D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (quello che disciplina l’accertamento con adesione) un nuovo articolo 5-ter, in vigore dal 1° luglio 2020. Questo art. 5-ter prevedeva, in sintesi, che prima di emettere un avviso di accertamento (per i tributi maggiori, imposte dirette e IVA), in assenza di un PVC l’ufficio deve notificare un invito a comparire al contribuente, avviando un contraddittorio. Erano escluse solo alcune ipotesi, ad esempio gli accertamenti parziali e i controlli formali/automatizzati. Importante: l’art.5-ter conteneva una specifica sanzione di invalidità: l’omessa attivazione del contraddittorio comportava la nullità dell’atto, ma limitata ai casi in cui il contribuente, impugnando l’avviso, avesse indicato le ragioni difensive che avrebbe prospettato se fosse stato convocato. Di fatto veniva tipizzata per legge la prova di resistenza: l’atto era annullabile solo se l’assenza di contraddittorio aveva potenzialmente pregiudicato il diritto di difesa del contribuente (onere di dimostrarlo a carico di quest’ultimo). Questa normativa ha segnato un passo avanti, ma rimaneva parziale: applicabile solo ad alcuni accertamenti (quelli “a tavolino” senza PVC) e con la condizione sopra descritta.
- Intervento della Corte Costituzionale (2023): La disparità di trattamento tra accertamenti con PVC (dove c’era contraddittorio ex Statuto) e accertamenti a tavolino senza PVC (dove l’obbligo c’era solo dal 2020 in poi e comunque non per tutti i casi) ha dato luogo anche a questioni di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47 del 21 marzo 2023, ha affrontato proprio il tema dell’assenza di un contraddittorio generalizzato. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione (ritenendo necessario un intervento legislativo sistematico anziché una pronuncia additiva), ma ha contestualmente lanciato un “monito” al legislatore: ha sottolineato che la mancata previsione di un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato era divenuta un’anomalia e che occorreva porvi rimedio. In pratica, la Consulta ha invitato il Parlamento a introdurre una disciplina organica che garantisse il diritto al contraddittorio in ogni accertamento, superando le differenze tra tributi e situazioni.
- La riforma fiscale 2023–2025: contraddittorio generalizzato (art. 6-bis Statuto): Accogliendo tale monito, la legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111) ha incluso espressamente il principio di generalizzazione del contraddittorio. In attuazione della delega, è stato emanato il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024, che modifica lo Statuto del contribuente introducendo il nuovo articolo 6-bis. Si tratta di una norma di portata generale, che sancisce quanto segue:
- Obbligo generalizzato: “Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giustizia tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”. In altre parole, prima di notificare qualunque atto fiscale che il contribuente potrebbe impugnare in Commissione tributaria (ora “Corte di giustizia tributaria”), l’ente impositore deve attivare un contraddittorio vero e proprio con il contribuente, altrimenti l’atto è illegittimo. Questa regola vale per tutti i tributi, sia erariali che locali, e colma finalmente la lacuna esistente.
- Eccezioni tassative: Sono esclusi da tale obbligo solo gli atti di natura totalmente automatizzata o di mera liquidazione/controllo formale, individuati da un apposito decreto ministeriale, nonché i casi di fondato pericolo per la riscossione (urgenza) da motivare adeguatamente. Il decreto attuativo previsto (D.M. 24/04/2024) è stato emanato e ha elencato in dettaglio gli atti esclusi (li vedremo a breve in una tabella dedicata). Al di fuori di queste eccezioni, il contraddittorio è sempre dovuto.
- Schema di atto e termine di 60 giorni: Per dare sostanza al contraddittorio, l’art. 6-bis impone all’Amministrazione finanziaria di comunicare al contribuente uno schema di atto (in pratica una bozza o una comunicazione delle contestazioni con tutti gli elementi essenziali dell’accertamento che si intende emettere), assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per presentare eventuali controdeduzioni (osservazioni, memorie) e/o per accedere al fascicolo e ottenerne copia. Durante questo periodo dilatorio, l’Ufficio non può emettere l’atto definitivo. Il contraddittorio così instaurato deve essere “informato ed effettivo”, cioè il contribuente dev’essere messo concretamente in grado di conoscere gli elementi raccolti a suo carico e di interloquire in modo utile.
- Proroga dei termini di decadenza: Un problema pratico poteva essere quello dei termini di decadenza (il limite entro cui l’ufficio deve emettere l’accertamento, ad es. 31 dicembre del quinto anno successivo per i redditi). L’art. 6-bis risolve prevedendo che, se i 60 giorni di contraddittorio cadono a ridosso della scadenza di decadenza, tale termine è automaticamente prorogato di 120 giorni dalla scadenza del contraddittorio. In questo modo l’ufficio ha il tempo di concludere il procedimento senza dover rinunciare al confronto col contribuente.
- Obbligo di motivazione sull’esito del contraddittorio: L’eventuale avviso di accertamento emesso all’esito del contraddittorio deve “tener conto delle osservazioni del contribuente ed essere motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere”. Ciò formalizza un obbligo di motivazione rafforzata: se il contribuente ha sollevato specifiche difese nelle memorie, l’ufficio deve rispondere puntualmente nell’atto finale (accogliendole o confutandole). La mancata considerazione delle deduzioni del contribuente può rendere l’atto viziato sotto il profilo della motivazione.
- Coordinamento con l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): La riforma 2023-2024 ha anche modificato la procedura di accertamento con adesione, integrandola con il nuovo contraddittorio generalizzato. Il D.Lgs. 12/2024 (in vigore per gli atti dal 30 aprile 2024) ha previsto che lo schema di atto inviato al contribuente per il contraddittorio contenga anche l’invito a presentare, in alternativa, un’istanza di accertamento con adesione. In pratica, quando riceve la comunicazione con le contestazioni (invito al contraddittorio ex art.6-bis), il contribuente ha due opzioni:
- Presentare memorie difensive/osservazioni entro 60 giorni (senza attivare subito la procedura di adesione); oppure
- Presentare un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione.
- Atti esclusi dal contraddittorio (DM 24/04/2024): Come anticipato, la legge ha demandato a un decreto MEF l’individuazione degli atti “di routine” per cui non serve il contraddittorio preventivo. Il DM 24 aprile 2024 (G.U. n.100 del 30/04/2024) ha elencato tali fattispecie, che in sintesi comprendono:
- Controlli automatizzati e formali su dichiarazioni: ad es. liquidazioni automatiche dei tributi (ex art. 36-bis DPR 600/1973 per imposte dirette, e corrispondenti per IVA), controlli formali ex art. 36-ter DPR 600/1973, riscossione automatica di crediti tributari.
- Avvisi “parzialmente automatizzati” basati su incrocio di dati: ad es. accertamenti parziali ex art. 41-bis DPR 600/1973 (redditometro, ecc.) o ex art. 54, c.5 DPR 633/1972 (IVA) fondati esclusivamente su banche dati, recuperi di crediti d’imposta non spettanti individuati automaticamente.
- Atti dell’Agenzia Entrate-Riscossione per ruoli: ruoli, cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, provvedimenti di decadenza da rateazione, che già di per sé non prevedono margini di discrezionalità impositiva.
- Avvisi di liquidazione per tributi “minori”: ad esempio tasse automobilistiche (bollo auto), canone RAI, imposta di registro su atti tipizzati, ecc., dove l’ufficio si limita ad applicare dati dichiarati o tariffari.
- Atti catastali meramente recuperatori (iscrizione di rendite presunte, ecc.).
- Casi di urgenza per rischio per la riscossione: situazione in cui l’ufficio può saltare il contraddittorio se esiste e motiva un fondato pericolo che il contribuente possa sottrarsi alla riscossione (es. dispersione di beni, fuga). Questa ipotesi, già prevista dalla norma primaria, è residuale e va motivata specificamente nell’atto; un uso improprio può essere censurato dal giudice.
- Situazione attuale (2025): Con l’entrata in vigore dell’art. 6-bis Statuto e dei decreti attuativi, la regola generale è l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per quasi tutti gli accertamenti tributari. L’art. 5-ter D.Lgs.218/97, che dal 2020 aveva introdotto l’invito obbligatorio in alcuni casi, è stato abrogato (di fatto superato dalla nuova disciplina). Resta in vigore l’art. 12, c.7 Statuto per i PVC in sede di verifica: in tali casi il contraddittorio si svolge sulla base del PVC e la prassi odierna è considerare quello come contraddittorio sufficiente (dopo il PVC l’ufficio attende 60 giorni e può eventualmente integrare il verbale con esito del contraddittorio) senza dover inviare un ulteriore schema di atto. In altre parole, se c’è stato un PVC e il contribuente ha avuto la chance di presentare memorie ex art.12, c.7, normalmente non si invia un nuovo invito ex art.6-bis prima dell’accertamento (evitando duplicazioni). Se invece il contribuente non ha presentato alcuna osservazione al PVC, alcune Direzioni inviano comunque un invito a comparire per discutere prima di emettere l’avviso, altre emettono direttamente l’atto trascorsi i 60 giorni (è una prassi non uniforme, ma l’obbligo formale di un secondo contraddittorio in tal caso non sussiste, essendoci già stata una fase di contraddittorio garantita dallo Statuto). Sul fronte giurisprudenziale, l’evoluzione normativa sta portando a un riallineamento delle posizioni: le pronunce più recenti della Cassazione tendono a riconoscere la centralità del nuovo art.6-bis e a ritenere annullabile l’atto emesso senza contraddittorio quando dovuto, senza gravare il contribuente di oneri probatori troppo stringenti. Ad esempio, Cass. 19/06/2024 n.16873 ha affermato l’obbligo di contraddittorio anche per gli accertamenti “a tavolino” relativi a imposte non armonizzate, pur riferendosi a fatti anteriori, in linea con il nuovo quadro normativo. Permangono tuttavia questioni aperte, prima fra tutte quella della prova di resistenza: alcune decisioni del 2024-2025 per i tributi armonizzati continuano a richiederla (v. Cass. ord. 5/02/2025 n.2795, che richiama Cass. 33818/2024), mentre altri segnali indicano che, alla luce dell’art.6-bis, tale approccio potrebbe essere superato. La Cassazione ha investito le Sezioni Unite della questione, affinché chiariscano “contenuti e limiti della prova di resistenza” nel nuovo contesto normativo. Dunque è lecito attendersi, a breve, un assestamento definitivo: probabilmente le SS.UU. stabiliranno se la violazione del contraddittorio ex lege comporti nullità ipso facto (tesi garantista) oppure se, nonostante la legge, il contribuente debba comunque allegare il pregiudizio sofferto (tesi sostanzialista).
In conclusione, oggi (luglio 2025) chi riceve un invito al contraddittorio da parte del Fisco si trova in una posizione di maggior tutela rispetto al passato: la legge gli riconosce espressamente il diritto di essere ascoltato, e la violazione di tale diritto costituisce motivo di annullamento dell’atto. Al contempo, però, sono state introdotte responsabilità e oneri per il contribuente diligente: ad esempio, se non presenta in sede pre-contenziosa documenti di cui disponeva e li tira fuori solo in giudizio, rischia la compensazione delle spese legali anche in caso di vittoria (come vedremo, per effetto del nuovo art.15 D.Lgs.546/1992 modificato). È quindi nell’interesse del contribuente sfruttare appieno la fase di contraddittorio e preparare con cura le proprie memorie difensive.
Quando e perché presentare una memoria difensiva
Vediamo ora in quali situazioni pratiche il contribuente è chiamato a predisporre memorie difensive e perché farlo è importante per la tutela dei suoi diritti.
Invito al contraddittorio: cos’è e come avviene
L’invito al contraddittorio è l’atto con cui l’Ufficio fiscale (in primis l’Agenzia delle Entrate, ma concetti simili valgono per altri enti impositori) comunica formalmente al contribuente l’avvio del procedimento accertativo nei suoi confronti, illustrando le contestazioni emerse e invitandolo a esporre le proprie difese prima di emettere l’eventuale avviso di accertamento. Può assumere la forma di:
- Processo Verbale di Constatazione (PVC) seguito da invito a presentare osservazioni ex art.12, c.7 Statuto: tipico nei casi di verifica in azienda da parte della Guardia di Finanza o dell’Agenzia. In realtà qui l’“invito” è implicito nella norma: ricevuto il PVC, il contribuente ha 60 giorni per inviare una memoria difensiva (osservazioni e richieste) prima che l’ufficio emetta l’atto. Spesso l’ufficio, oltre ad attendere i 60 giorni, invia anche una lettera di convocazione per un incontro di contraddittorio orale, specialmente se il contribuente presenta memorie articolate.
- Invito a comparire ex art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 (previgente): per gli accertamenti relativi ad anni fino al 2022-2023 (atti emessi entro aprile 2024), l’ufficio notificava questo invito nelle ipotesi obbligatorie previste dalla legge (assenza di PVC, accertamenti analitico-induttivi, ecc.). L’invito indicava le questioni contestate e concedeva in genere 15 giorni per comparire a discutere, oppure 60 giorni per presentare memorie scritte (secondo prassi consolidata). Se il contribuente rispondeva per iscritto, l’ufficio poteva decidere se convocare comunque un incontro. Con la riforma, questa tipologia di invito è confluita nel nuovo schema di atto art.6-bis.
- Comunicazione dello “schema di atto” ex art. 6-bis L.212/2000 (vigente): per gli accertamenti attuali, l’invito al contraddittorio si sostanzia in una comunicazione che anticipa il contenuto dell’accertamento. Essa solitamente contiene: l’intestazione e riferimento normativo (art.6-bis Statuto), una descrizione dei rilievi (ad es. maggior imponibile accertato, imposte e sanzioni calcolate, motivazioni delle rettifiche), l’invito a presentare osservazioni entro 60 giorni, l’avvertimento che l’atto non sarà emesso prima di tale termine e che, in alternativa, si può chiedere l’adesione entro 30 giorni. Talora viene indicato anche un contatto (telefono/email) per eventuali chiarimenti o per concordare un incontro. Questa comunicazione non è ancora un avviso di accertamento: non comporta l’obbligo di pagare nulla, ma è un passaggio cruciale per far valere le proprie difese.
- Altre comunicazioni simili: Ci sono casi in cui, pur non essendovi un obbligo di legge, l’Amministrazione invia comunque al contribuente una comunicazione di compliance o una richiesta di chiarimenti prima di un accertamento. Ad esempio, l’Agenzia può inviare lettere al contribuente segnalando anomalie (da studi di settore, da liquidazioni, ecc.) invitandolo a fornire spiegazioni. Rispondere a queste comunicazioni informali può evitare che si arrivi proprio all’emissione formale di un invito ex art.6-bis o di un accertamento. Anche in tali casi, redigere una “memoria” o risposta scritta chiara e documentata è fortemente consigliato, sebbene qui siamo al di fuori del contraddittorio procedimentale in senso stretto.
In generale, se riceviamo una qualsiasi comunicazione dall’Erario che anticipa contestazioni o richiede giustificazioni, non ignoriamola: è sempre un’opportunità per chiarire la nostra posizione ed eventualmente evitare sanzioni o aggravamenti.
Perché è fondamentale presentare memorie difensive
I vantaggi di partecipare attivamente al contraddittorio con una memoria difensiva (anziché restare silenti) sono molteplici:
- Evitare o ridurre l’accertamento: Se il contribuente fornisce spiegazioni convincenti e prove solide, l’Ufficio potrebbe archiviare il caso senza emettere l’accertamento. Ciò accade raramente per un’accoglienza totale delle ragioni del contribuente, ma non sono infrequenti gli accoglimenti parziali: ad esempio, su vari rilievi contestati, alcuni possono decadere grazie alle osservazioni del contribuente, con conseguente riduzione dell’imponibile accertato. Eliminare anche solo in parte la pretesa fiscale prima che diventi un atto definitivo significa risparmiare imposte, sanzioni e interessi, oltre che evitare un successivo contenzioso su quei punti.
- Porre le basi della difesa in giudizio: Se il contraddittorio non porta all’archiviazione e l’avviso viene emanato, il contribuente avrà comunque gettato le fondamenta del futuro ricorso. Infatti, tutto ciò che è stato dedotto in sede precontenziosa potrà essere ripreso e sviluppato davanti al giudice tributario. Non solo: l’Ufficio dovrà aver replicato in motivazione a tali argomentazioni. In sede di giudizio, poter dimostrare che l’Amministrazione è stata messa a conoscenza di certi fatti sin dall’inizio e magari non li ha adeguatamente confutati può costituire un punto a favore del contribuente. Al contrario, un contribuente che non ha detto nulla nel contraddittorio e tira fuori le sue ragioni solo in tribunale potrebbe essere visto con maggior scetticismo (perché non l’ha fatto prima?) e, come accennato, rischia la compensazione delle spese legali se ha “tenuto nel cassetto” documenti decisivi.
- Ottenere più tempo (in modo utile): La partecipazione al contraddittorio non sospende formalmente alcun termine processuale (poiché l’atto non è stato ancora emesso), ma in pratica differisce l’eventuale emissione dell’accertamento di almeno 60 giorni. Questo tempo può essere impiegato dal contribuente per organizzare le proprie difese, raccogliere documenti, farsi assistere da un professionista, e magari anche cercare soluzioni alternative (ad esempio prepararsi economicamente nel caso di una probabile adesione o definizione agevolata). Inoltre, se si instaura un dialogo costruttivo con l’Ufficio, spesso i funzionari concedono anche proroghe del termine per le memorie, specie in casi complessi (ad esempio, se occorre recuperare molta documentazione, l’Ufficio può accordare 30 giorni in più). In ogni caso, partecipare al contraddittorio evita che l’accertamento arrivi “a sorpresa”: se ne conoscerà già in anticipo il contenuto e si potrà reagire con meno stress.
- Mantenere aperta la porta dell’adesione: Presentare memorie difensive non preclude affatto la possibilità di definire l’accertamento per via concordata. Come visto, oggi c’è un coordinamento preciso: dopo aver inviato le memorie (entro 60 gg), il contribuente può aspettare l’eventuale avviso e poi, entro 15 giorni, presentare istanza di adesione. Anche nel regime previgente, nulla vietava di presentare osservazioni all’invito e, se l’atto usciva comunque, chiedere l’adesione entro i 60 giorni classici; anzi, era (ed è) una strategia spesso adottata. L’adesione comporta benefici sulle sanzioni ridotte a 1/3 e la possibilità di ottenere uno sconto concordato su imposte e interessi, quindi è un’opzione da non escludere. Ma attenzione: con la riforma, se non si sono presentate certe prove o argomenti nel contraddittorio, l’Ufficio in sede di adesione post-avviso potrà rifiutarsi di prenderli in considerazione. Dunque il contraddittorio diventa anche l’occasione per “mettere sul tavolo” tutti gli elementi utili che poi, eventualmente, potranno agevolare una trattativa.
- Evitare la nullità per mancato contraddittorio: Questo punto riguarda l’operato dell’Ufficio, ma indirettamente coinvolge il contribuente. Oggi se l’Ufficio omette di invitare al contraddittorio quando dovrebbe, l’atto è annullabile in giudizio. Tuttavia, è onere del contribuente eccepirlo tempestivamente (nel ricorso introduttivo) e, soprattutto prima della riforma, era suo onere provare la rilevanza delle difese non svolte. Se invece l’Ufficio vi invita regolarmente e siete voi a non partecipare, non avrete poi questo “asso nella manica”: l’inerzia del contribuente infatti non vizia l’atto, l’obbligo dell’amministrazione si considera assolto con il semplice invito. Insomma, una volta ricevuto l’invito, sta a voi cogliere l’opportunità. Se la ignorate, non potrete poi lamentare di non essere stati ascoltati.
In sintesi, presentare la memoria difensiva conviene: è uno strumento gratuito, che vi dà l’opportunità di ridurre o eliminare la pretesa fiscale prima che diventi definitiva, e che comunque rafforza la vostra posizione difensiva in seguito. L’unica situazione in cui si potrebbe valutare di non rispondere è quando si intenda percorrere immediatamente la strada dell’adesione (nel nuovo regime, presentando istanza entro 30 giorni): in tal caso, si sceglie di negoziare direttamente con l’ufficio invece di fornire deduzioni formali. Ma anche in quel caso spesso è utile preparare una memoria illustrativa da usare durante l’incontro di adesione, perché aiuta a chiarire i punti di trattativa (la differenza è che quella resterà interna alla negoziazione, non protocollata come difesa formale).
Nei paragrafi seguenti ci concentreremo su come predisporre concretamente una memoria difensiva efficace in risposta a un invito al contraddittorio, passo per passo, e forniremo anche un fac-simile di memoria. Successivamente esamineremo le alternative (memoria vs adesione) e risponderemo a varie domande frequenti dal punto di vista pratico del contribuente.
Come redigere una memoria difensiva efficace
La redazione della memoria difensiva richiede attenzione sia agli aspetti formali sia ai contenuti sostanziali. L’obiettivo è presentare all’Ufficio un documento chiaro, completo e persuasivo, che illustri la vostra versione dei fatti e le ragioni giuridiche per cui l’accertamento prospettato è (in tutto o in parte) infondato o illegittimo. Qui di seguito analizziamo la struttura, i contenuti da includere, gli aspetti pratici di invio e alcuni errori da evitare.
Struttura e contenuto della memoria
Una buona memoria difensiva dovrebbe essere strutturata in modo logico e facile da seguire per chi la legge (il funzionario dell’Ufficio). Ecco uno schema consigliato:
- Intestazione iniziale: in alto a destra indicate i riferimenti del documento (
DestinatarioeMittente):- Destinatario: l’Ufficio che ha emesso l’invito. Ad esempio: “Direzione Provinciale di [Nome Provincia] – Agenzia delle Entrate – Ufficio Accertamento”, con l’indirizzo se disponibile. Questi dati sono solitamente presenti sull’intestazione dell’invito ricevuto.
- Mittente: i vostri dati (nome e cognome, o ragione sociale se società, codice fiscale/partita IVA, domicilio fiscale, eventuale PEC). Se vi fate rappresentare da un professionista, qui potete indicare il nome dello studio e del difensore con delega, ma non è obbligatorio nominare formalmente un difensore in questa fase; potete presentare la memoria anche personalmente.
- Potete inserire anche un vostro riferimento (es. “Rif: risposta a invito n…”) e oggetto del documento.
- Oggetto della memoria: scrivete un breve oggetto che identifichi chiaramente di cosa si tratta. Ad esempio: “Memoria difensiva – Invito al contraddittorio prot. n. ___ del //2025 – [vostro codice fiscale]”. Oppure, se è post-PVC: “Osservazioni ex art.12 c.7 L.212/2000 al PVC della Guardia di Finanza del //2025”. Indicare il riferimento normativo (art.6-bis L.212/2000 o art.12 c.7, a seconda dei casi) aiuta a contestualizzare la vostra memoria nell’ambito giusto.
- Formula di apertura: rivolgetevi all’Ufficio in modo formale ma rispettoso. Esempio: “Ill.mo Ufficio,” oppure “Spett.le Direzione,”. In alternativa va bene anche “Alla c.a. del Responsabile del Procedimento [se noto]”. Dopodiché, nella prima frase, richiamate l’atto ricevuto: “In riferimento all’Invito a comparire prot. n. ___ notificato in data ____, con la presente il sottoscritto intende formulare le proprie osservazioni difensive ai sensi dell’art. 6-bis L.212/2000.” Se invece scrivete dopo un PVC: “…formulare le osservazioni e richieste previste dall’art.12, comma 7, L.212/2000, nell’ambito del contraddittorio antecedente l’emissione dell’avviso di accertamento.”.
- Sintesi delle contestazioni dell’Ufficio: prima di esporre le vostre ragioni, è utile dimostrare di aver compreso cosa vi viene contestato. Potete inserire un paragrafo di “Premessa” o “Sintesi dei rilievi”, in cui riassumete brevemente i punti sollevati dall’ufficio. Ad esempio: “Nell’invito in oggetto si contesta che il contribuente avrebbe omesso di dichiarare ricavi per € 50.000 nell’anno d’imposta 2021, e si prospetta il recupero di IVA e imposte dirette su tale importo, con relative sanzioni. Inoltre, si contesta l’indebita deduzione di costi per € 10.000 afferenti fatture ritenute inesistenti.”. Questa sezione deve essere imparziale e fattuale: limitatevi a descrivere cosa l’ufficio sostiene, senza ancora confutarlo. Ciò serve sia a chiarire il contesto, sia a creare un sommario che agevola il lettore.
- Argomentazioni difensive divise per punti: Questo è il cuore della memoria. Conviene affrontare un rilievo alla volta, numerandoli per chiarezza (ad es. 1. Rilievo “Ricavi non dichiarati € 50.000”, 2. Rilievo “Costi non deducibili € 10.000”, ecc.). Per ciascun punto:
- Esponete la vostra versione dei fatti: spiegate perché quella contestazione è sbagliata o esagerata. Seguite un approccio razionale: prima i fatti, poi il diritto. Ad esempio, per un ricavo non dichiarato, potreste scrivere: “Si osserva che l’importo di €50.000 contestato non costituisce in realtà un ricavo commerciale, bensì un finanziamento soci, come da contratto del //2021 allegato. Tale somma, quindi, non andava dichiarata come ricavo e non configura materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi né IVA.”. Fornite dettagli concreti (date, importi, controparti) e smentite puntualmente gli elementi addotti dall’ufficio (ad esempio, se l’Agenzia ha dedotto quei €50.000 da un movimento bancario, spiegate la natura effettiva di quel movimento).
- Supporto documentale: ogni fatto affermato dovrebbe, ove possibile, essere provato da un documento. Annunciate nella memoria i documenti che allegate: “come risulta dal contratto di finanziamento allegato sub 1”, oppure “si allega estratto conto dal quale si evince la restituzione del prestito, doc. 2”. Numerate gli allegati e, in calce alla memoria, fate un elenco degli stessi (vedi punto 8). Non sommergete l’ufficio di carte inutili: includete solo ciò che è rilevante e spiegato nel testo.
- Argomentazione giuridica: dopo aver chiarito i fatti, argomentate perché, alla luce della normativa, la pretesa dell’Ufficio non regge. Ad esempio: “Ai fini fiscali, un finanziamento soci non costituisce ricavo tassabile (art. 44 TUIR: non è un reddito di capitale né ricavo d’impresa). L’operazione è regolarmente registrata a bilancio e non configura un’operazione imponibile IVA (mancando il presupposto oggettivo della cessione di beni o prestazione di servizi). Pertanto, il rilievo in questione risulta basato su un’errata qualificazione giuridica dei fatti.” Se ci sono circolari, risoluzioni o sentenze a vostro favore, citatele (con estremi e magari allegandole se facilmente ottenibili). Ad esempio: “Si richiama la circ. AE n.__/____, par. __, che conferma la non imponibilità di apporti finanziari dei soci.” Per le sanzioni, potete argomentare eventuali cause di non punibilità o attenuanti (es. errore scusabile, obiettiva incertezza normativa).
- Tono e stile: mantenete un tono professionale e concentrato sui fatti e sul diritto. Evitate attacchi personali al funzionario o all’ufficio, e non usate toni sarcastici o polemici: potrebbero irrigidire l’atteggiamento di chi legge. Frasi come “appare evidente l’abnormità della pretesa” o “il Funzionario ha mal compreso i documenti” è meglio sostituirle con “si ritiene che la pretesa debba essere rivista alla luce di…”. Dimostrate rispetto e collaborazione, pur affermando con fermezza le vostre ragioni.
- Chiusura del punto: dopo aver esposto tutto per quel rilievo, concludete esplicitamente cosa chiedete sull’accertamento. Ad esempio: “Alla luce di quanto esposto, si chiede l’integrale archiviazione del rilievo n.1, non ravvisandosi materia imponibile né violazioni fiscali.” Questo aiuta l’ufficio a capire cosa vi attendete (es.: che quel punto sia eliminato). Se su un rilievo riconoscete invece una parziale fondatezza, potete chiedere una rettifica (es.: “…si chiede quantomeno la rideterminazione del maggior imponibile nella misura di €…, tenuto conto dei costi correlati documentati in allegato.”). Mostrare onestà intellettuale laddove magari l’ufficio ha colto un errore minore ma reale, ammettendolo, può giovare alla vostra credibilità sulle altre contestazioni.
- Conclusioni finali: Dopo aver trattato tutti i punti contestati, è buona norma inserire un paragrafo conclusivo riepilogativo. Qui potete:
- Ribadire sinteticamente l’esito che vi attendete: “In conclusione, si confida che l’Ill.mo Ufficio, alla luce delle evidenze fornite, voglia procedere all’archiviazione del procedimento accertativo, in quanto i rilievi sollevati risultano infondati.” Oppure, se alcuni rilievi li avete contestati e altri no: “…voglia rideterminare la pretesa eliminando i rilievi nn.1 e 3 e riquantificando il rilievo n.2 come sopra argomentato.”.
- Manifestare apertura al dialogo: “Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per un eventuale incontro volto a definire in via collaborativa la presente vicenda.”. Questo segnale di collaborazione può invogliare l’ufficio a fissare un colloquio (se già non previsto) o comunque a considerare la buona fede del contribuente.
- Ringraziare cortesemente per l’attenzione: “Si ringrazia per l’attenzione dedicata alla presente memoria.” (non è servile, è educato).
- Salutare formalmente: “Distinti saluti,”.
- Data e firma: In calce a destra mettete la data e la firma del contribuente (o del difensore che la presenta). Se la inviate in formato cartaceo, la firma autografa è necessaria; se inviate via PEC un PDF, la firma autografa scansionata è normalmente accettata (o potete apporre firma digitale se lo preferite). È utile aggiungere anche il nome in stampatello sotto la firma, specie se la grafia non è chiara.
- Elenco allegati: Subito sotto (o anche a margine sinistro finale) elencate i documenti allegati, numerandoli come li avete richiamati nel testo. Ad esempio:
- “Allegati:
1. Contratto di finanziamento soci del 01/07/2021 (n. __ pagine);
2. Estratto conto bancario c/c n…. evidenziante accredito e restituzione €50.000;
3. Copia Bilancio 2021 di [Società];
4. Documentazione fatture fornitori per €10.000 (rilievo n.2) – nn.___.”*
Indicate sempre l’oggetto e se possibile una descrizione sintetica. Questo elenco aiuta l’ufficio a controllare di aver ricevuto tutto e di capire a cosa serve ogni documento.
- “Allegati:
Fac-simile – Estratto di una memoria difensiva (esempio semplificato)
Destinatario: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino – Ufficio Accertamento
Mittente: Mario Rossi, C.F. RSSMRA80A01H501X, residente in Torino, Via XYZ n.1 – PEC: mariorossi@pec.it
Oggetto: Osservazioni e deduzioni difensive in risposta all’Invito al contraddittorio prot. n. 12345/2025 notificato il 01/07/2025 – art. 6-bis L.212/2000.Ill.mo Ufficio,
in riferimento all’Invito a comparire indicato in oggetto, con la presente il sottoscritto Mario Rossi intende fornire le proprie osservazioni difensive nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale precedente l’emissione dell’avviso di accertamento.
Sintesi dei rilievi contestati: Nell’invito in oggetto l’Ufficio contesta quanto segue: (a) il mancato assoggettamento ad IVA di alcune operazioni attive nell’anno 2022 per un imponibile di €20.000 (fatture emesse a maggio 2022 ritenute dall’Ufficio non imponibili art. 7-ter DPR 633/72 ma in realtà giudicate imponibili); (b) la deduzione di costi per sponsorizzazioni, pari a €5.000, ritenuta indebita per mancanza del requisito di inerenza.
Dopo attenta analisi, il sottoscritto ritiene tali contestazioni infondate per le ragioni di seguito esposte.
1. Rilievo IVA operazioni attive (€20.000 imponibile non dichiarato) – Fatti: le operazioni fatturate a maggio 2022 alla Alpha Srl (cfr. fatture nn.10 e 11/2022) sono state correttamente trattate come non imponibili IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972, in quanto si tratta di servizi resi a soggetto passivo estero (Alpha Srl è identificata ai fini IVA in Francia, come risulta dalla VIES – v. doc.1 allegato). L’ufficio sembra ritenere, invece, che tali servizi fossero imponibili in Italia. Giustificazioni: Come documentato, i servizi (consulenza ingegneristica) sono stati svolti in parte in Italia e in parte all’estero, ma il committente ai fini IVA è estero e vi è stata emissione di fattura senza IVA ex art. 7-ter. La normativa IVA prevede che per i servizi B2B la territorialità è fissata nel paese del committente (in questo caso la Francia); pertanto l’IVA non era dovuta in Italia. L’interpretazione dell’Ufficio parrebbe erronea: forse si è ritenuto applicabile un criterio diverso (es. art. 7-quinquies per servizi in materia immobiliare, ma non è questo il caso). Si allega estratto VIES (doc.1) attestante la posizione IVA estera del cliente. Si allega inoltre copia del contratto di consulenza (doc.2) dal quale emerge che il progetto riguardava un impianto situato in Francia. Conclusione: alla luce di quanto sopra, si chiede l’integrale stralcio del rilievo IVA in questione, poiché l’operato del contribuente risulta conforme alla disciplina IVA vigente (art. 7-ter) e nessuna imposta era dovuta in Italia su tali operazioni.
2. Rilievo costi di sponsorizzazione (€5.000) – L’ufficio contesta la deduzione di costi per sponsorizzazione sportiva ritenendo che l’evento sponsorizzato (torneo locale di calcio) non abbia attinenza con l’attività dell’impresa. Osservazioni: Il costo in oggetto (documentato dalla fattura XYZ Srl n.77 del 20/09/2022, doc.3 allegato) è invece pienamente inerente all’attività aziendale di Mario Rossi (commercio articoli sportivi). La sponsorizzazione di un torneo di calcio locale rientra nelle comuni strategie di marketing per dare visibilità al marchio in un contesto sportivo attinente al proprio settore commerciale. Si evidenzia come la giurisprudenza tributaria abbia riconosciuto l’inerenza di spese di sponsorizzazione sportiva per imprese operanti nel settore sportivo o affini (cfr. CTR Lombardia, sent. n. 100/2019, doc.4). Inoltre, trattandosi di sponsorizzazione a favore di associazione sportiva dilettantistica, il costo è peraltro qualificabile come spesa di pubblicità deducibile al 100% (ai sensi dell’art. 108 comma 2 TUIR, come da prassi AE circolare 34/E/2009). Conclusione: si chiede pertanto il riconoscimento dell’integrale deducibilità di tali costi di sponsorizzazione, con conseguente eliminazione del rilievo in questione.
Conclusioni: Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto confida che l’Ill.mo Ufficio voglia riesaminare con esito favorevole la presente vicenda, annullando o significativamente riducendo i rilievi contenuti nello schema di accertamento. In particolare, si ritiene che non sussistano i presupposti per il recupero a tassazione né dell’IVA né dei costi oggetto di contestazione. Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e, auspicando un approccio collaborativo, manifesto sin d’ora la disponibilità a un incontro di contraddittorio orale ove si rendesse necessario.
Data: 20/08/2025
Firma: Mario Rossi
Allegati: 1. Visura VIES cliente Alpha Srl (stampa del 15/07/2025); 2. Contratto di consulenza in lingua inglese con traduzione (15 pagine); 3. Fattura n.77/2022 di XYZ Srl (€5.000) e ricevuta bonifico pagamento; 4. Copia sentenza CTR Lombardia 100/2019.
(Fac-simile a scopo illustrativo: ogni memoria va adattata ai dati reali del caso concreto.)
Aspetti pratici di invio e presentazione
Una volta redatta la memoria difensiva, occorre trasmetterla correttamente all’Ufficio entro i termini. Ecco alcuni consigli pratici:
- Modalità di invio: La via oggi più comoda e consigliata è tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). La PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata A/R e consente di avere una ricevuta di consegna con data e ora. Assicuratevi di inviare da una vostra PEC personale (o del difensore) all’indirizzo PEC ufficiale dell’ufficio destinatario. Gli indirizzi PEC dell’Agenzia Entrate sono spesso indicati sull’invito stesso; in caso contrario, sono reperibili sul sito dell’Agenzia o sull’IndicePA. Nell’oggetto della PEC mettete un riferimento chiaro (tipo: “Osservazioni difensive – Invito a comparire prot… – CF XYZ”). Allegate il PDF della memoria (meglio se firmato digitalmente o scansionato con firma autografa) e i PDF degli allegati documentali. Se i file sono pesanti, potreste doverli comprimere o inviare in più PEC.
In alternativa, è possibile consegnare la memoria a mano presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia: portate due copie (una per loro e una per voi) e fatevi apporre il timbro di protocollo sulla vostra copia per ricevuta. Oppure potete inviare tutto tramite raccomandata A/R tradizionale; in tal caso fa fede la data di arrivo all’ufficio (non quella di spedizione), quindi spedite con ampio anticipo.
Sia PEC che raccomandata vanno benissimo; la PEC è preferibile per tempestività e sicurezza. - Rispetto dei termini: Come già evidenziato, generalmente il termine concesso è di 60 giorni dal ricevimento dell’invito (o dal PVC). Annotatevi la scadenza esatta. Ad esempio, se l’invito è stato notificato il 1º luglio, i 60 giorni decorrono dal 2 luglio e scadono il 30 agosto (salvo diverse indicazioni). Se il 60° giorno cade di sabato o festivo, è prudente inviare entro il giorno precedente (trattandosi di termine amministrativo, non è chiaro se valga la proroga al primo giorno lavorativo successivo, quindi meglio non rischiare).
Invii tardivi: se inviate le memorie oltre il termine, l’Ufficio potrebbe legittimamente ignorarle (l’accertamento potrebbe essere già stato emesso). Tuttavia, se siete leggermente in ritardo e l’atto non è ancora uscito, vale comunque la pena inviarle, sperando che vengano considerate.
Richiedere una proroga: in casi eccezionali, potete chiedere all’ufficio una proroga del termine (meglio prima della scadenza), motivandola. Ad esempio: “Considerata la mole di documentazione da analizzare, si chiede una proroga di 30 giorni del termine per le controdeduzioni.” L’ufficio non è obbligato a concederla, ma a volte lo fa, comunicandovi per iscritto il nuovo termine. Questa richiesta va rivolta al responsabile del procedimento indicato nell’invito (anche via PEC va bene). Se per caso l’ufficio concede solo verbalmente più tempo (es. al telefono), cercate di farvelo confermare via mail o PEC per sicurezza, oppure inviate voi una PEC di riepilogo: “Facendo seguito a contatti intercorsi, prendo atto che l’Ufficio ha acconsentito a ricevere le memorie entro il …”. In mancanza, tenetevi comunque prudentemente entro i 60 giorni originari. - Accesso agli atti del fascicolo: L’art.6-bis vi dà diritto, su richiesta, di accedere agli atti raccolti dall’ufficio. Ciò è molto utile: potreste scoprire documenti o informazioni in possesso del fisco che non conoscevate (es. comunicazioni di altri enti, segnalazioni, perizie). Quindi, subito dopo aver ricevuto l’invito, valutate di inviare una richiesta di accesso agli atti (ai sensi dell’art.6-bis, comma 3 e della L.241/1990). Indirizzatela all’ufficio, specificando di voler visionare ed estrarre copia di tutti gli atti dell’istruttoria relativa al vostro accertamento (indicate il riferimento dell’invito). L’Ufficio deve rispondere tempestivamente, compatibilmente con i 60 giorni. Spesso concedono l’accesso in sede (vi fissano un appuntamento per visionare il fascicolo) oppure vi inviano i documenti via PEC. Solo dopo aver visto gli atti completi conviene finalizzare la memoria, così da poter contestare elementi specifici emersi dal fascicolo. Se l’ufficio non risponde all’istanza di accesso in tempi rapidi, inviate comunque la memoria nei termini, e nel frattempo segnalate nella memoria stessa di aver richiesto l’accesso senza esito (ciò documenta una possibile “non effettività” del contraddittorio, utile in ottica difensiva futura).
- Stile di redazione: Scrivete in modo chiaro e conciso. Paragrafi brevi (come raccomandato, 3-5 frasi), frasi non interminabili, uso di elenchi puntati/numerati per ordinare i punti (ad es. come abbiamo fatto col rilievo 1 e 2 nell’esempio). Evitate latineggiare inutilmente (meglio “inoltre” che “ultraque”), ma mantenete un registro formale (dare del “voi” o “Lei” all’ufficio non è necessario; va bene la terza persona: “l’Ufficio” fa questo, “il contribuente” fa quello). Occhio alla ortografia e grammatica: un documento con errori marchiani rischia di non essere preso sul serio. Se non vi sentite sicuri, fate rileggere a qualcuno, oppure focalizzatevi su semplicità e correttezza.
Inoltre, numerate le pagine del documento, specialmente se sono molte, e mettete eventualmente una intestazione con nome/contribuente e protocollo (in caso si separino le pagine, l’ufficio capirà a cosa si riferiscono). - Conservazione delle prove di invio: Conservate con cura la ricevuta PEC di consegna (stampatela o salvatela in PDF) oppure la ricevuta della raccomandata, o la copia protocollata. Questo potrà servire più avanti se dovrete dimostrare in giudizio di aver presentato le osservazioni entro i termini (ad esempio, per contestare una motivazione carente dell’ufficio, o per evitare che vi si imputi inerzia). Se usate PEC, la ricevuta completa include anche il file consegnato, mantenetela integra.
- Seguito dell’invio: Una volta inviata la memoria, generalmente l’ufficio non risponde con una comunicazione formale. Potrebbe però:
- Contattarvi telefonicamente o via email (se avete lasciato recapiti) per chiarimenti, documenti aggiuntivi o per fissare un incontro. È buona pratica presentarsi all’eventuale incontro con copia della memoria inviata e magari con ulteriori copie di documenti se richiesti. Dell’incontro l’Ufficio dovrebbe redigere un sintetico verbale sottoscritto da voi e dal funzionario, in cui si dà atto di ciò che si è discusso e delle conclusioni (es. se l’ufficio ha accettato qualcosa, deve metterlo a verbale).
- Ignorare la memoria (o meglio, valutarla internamente senza darvene riscontro immediato) e, trascorso il periodo, emettere l’avviso di accertamento. In tal caso nell’avviso troverete, in motivazione, un paragrafo dedicato alle vostre osservazioni: ad esempio “Il contribuente ha presentato memoria difensiva in data …: al riguardo si osserva quanto segue …”, e qui l’ufficio replicherà punto per punto. Se malauguratamente l’atto fosse emesso prima dei 60 giorni senza urgenza, sarebbe nullo per violazione di legge (ma è difficile che accada deliberatamente, stante l’attenzione posta dalla circolare AE 17/2020 e dalle nuove norme).
- Accogliere (totalmente o parzialmente) le vostre ragioni senza dover emettere l’avviso. In questo caso potreste ricevere una lettera informale dall’ufficio che comunica l’archiviazione, ma spesso semplicemente non arriverà alcun accertamento. Potete comunque chiedere all’ufficio un feedback trascorsi i 60 giorni: a volte vi diranno “abbiamo chiuso, tutto a posto”, altre volte “stiamo rivedendo il caso” o “l’atto è in emissione”. Non c’è un obbligo per loro di comunicarvi esiti intermedi, ma nulla vieta di chiamare per avere aggiornamenti.
- Assistenza di un professionista: Pur non essendo obbligatorio in questa fase, farsi assistere da un dottore commercialista o avvocato tributarista può fare la differenza, specialmente se il caso è complesso o di importo rilevante. Un professionista esperto saprà come impostare al meglio la memoria, quali documenti evidenziare, quali norme e sentenze citare. Inoltre, potrebbe conoscere i funzionari dell’ufficio e gestire con loro in maniera efficace il contraddittorio. Se decidete di affidarvi a un difensore:
- Potete firmare voi la memoria e farvi solo aiutare “dietro le quinte”, oppure potete far firmare direttamente al professionista. In questo secondo caso, è opportuno allegare una procura/delega sottoscritta da voi in cui lo autorizzate a rappresentarvi nel procedimento di adesione/contraddittorio (non strettamente richiesto per legge in sede amministrativa, ma consigliabile).
- Comunicate all’ufficio che avete incaricato Tizio come vostro difensore di fiducia, chiedendo che ogni convocazione o comunicazione venga inviata anche a lui (fornendo i suoi recapiti).
- Valutate i costi: molti professionisti offrono un’assistenza calibrata (ad esempio, solo la redazione memoria, oppure memoria + eventuale adesione, ecc.). Dato che la materia è ostica e un errore può costare caro, investire qualcosa in consulenza può essere molto conveniente.
Errori da evitare
Nel preparare la vostra memoria difensiva, fate attenzione ai seguenti errori comuni, che possono ridurre l’efficacia delle vostre difese:
- Non rispettare il termine: inviare la memoria in ritardo (o peggio ancora dopo che l’avviso è stato emesso) è quasi inutile. Pianificatevi per tempo. Se vi accorgete tardi dell’invito (es. perché siete stati in ferie), cercate almeno di fare una memoria sintetica toccando i punti fondamentali ed inviatela subito, piuttosto che niente.
- Ignorare parte delle contestazioni: La memoria dovrebbe rispondere a tutti i rilievi sollevati dall’ufficio, anche quelli che ritenete minori. Tralasciarne qualcuno potrebbe essere interpretato come un’implicita ammissione. Se proprio su un punto non avete contro-argomentazioni (es. sapete di aver commesso un errore), potete riconoscerlo esplicitamente ma provare a ridurne l’impatto (chiedendo magari la non applicazione di sanzioni per buona fede, o evidenziando circostanze attenuanti). L’importante è non lasciare rilievi “scoperti”.
- Inviare documenti senza spiegazione: Evitate di allegare pile di documenti confidando che “loro capiranno”. Spetta a voi spiegare il significato probatorio di ogni documento. Contestualizzate ogni allegato nel testo della memoria. Un faldone di fatture buttate lì senza un filo conduttore rischia di essere ignorato o di irritare il lettore. Meglio pochi documenti chiave, ben commentati, che tantissimi elementi confusi.
- Tono aggressivo o polemico: Anche se siete convinti che l’accertamento sia ingiusto, mantenete un atteggiamento professionale. Evitate frasi come “il suo operato è chiaramente persecutorio” o “l’Agenzia dovrebbe vergognarsi per questo errore”. Queste uscite non fanno che irrigidire la controparte. Piuttosto, smontate la loro tesi con dati e norme, e lasciate che l’assurdità (se c’è) emerga da sé. Allo stesso modo, non fate appelli emotivi (“se mi imponete queste tasse andrò fallito”): concentratavi su elementi verificabili, non sulla compassione.
- Menzionare precedenti accordi o negoziazioni: Se in passato avevate avuto colloqui informali o vi era stata fatta una proposta di adesione, ecc., non inseriteli nella memoria scritta ufficiale, a meno che non siano formalizzati. Ad esempio, se un funzionario vi ha detto a voce “paghi il 50% e chiudiamo”, non riferitelo nella memoria – è riservato e potrebbe metterlo in imbarazzo ufficialmente. La memoria deve riferirsi agli atti e alle posizioni ufficiali, non a conversazioni ufficiose.
- Dare informazioni non richieste che possono aprire altri fronti: Attenetevi ai rilievi contestati. Non è il caso di menzionare aspetti che l’ufficio non ha sollevato. Ad esempio, se state difendendo un ricavo non dichiarato come finanziamento soci, non dilungatevi su altre movimentazioni che potrebbero insospettire l’ufficio su nuovi rilievi. Restate focalizzati su ciò che è contestato. Allo stesso modo, non fornite documenti non pertinenti: ogni cosa che consegnate può teoricamente essere usata dall’ufficio per nuovi spunti (anche se in teoria dovrebbero limitarsi all’oggetto dell’invito, è meglio non metterli su nuove piste).
- Trascurare la forma: Una memoria piena di refusi, poco organizzata, senza un indice dei documenti, fa una cattiva impressione. Come detto, curate l’aspetto: uniformità di carattere, titoletti in grassetto per i vari punti, numerazione, etc. Questo non è estetismo fine a se stesso, è comunicazione efficace. Volete che chi legge colga subito i vostri argomenti di peso, non che si perda cercando un numero di fattura tra le pagine.
- Non conservare copia di ciò che inviate: Può sembrare banale, ma assicuratevi di archiviare il PDF o la copia cartacea esatta di quello che avete mandato, con tutti gli allegati. Potrebbe passare del tempo prima di un eventuale processo, e dovrete ricordare e avere sottomano cosa avevate scritto e prodotto all’ufficio. Nel ricorso, infatti, è buona norma allegare la memoria difensiva presentata in sede amministrativa e la ricevuta di invio, per dare al giudice un quadro completo del pregresso.
Riassumendo, professionalità, completezza e tempestività sono le parole d’ordine. Una memoria difensiva ben fatta non garantisce al 100% che l’ufficio vi darà ragione (ci sono casi in cui, per politica interna o indirizzi nazionali, l’Agenzia tira dritto comunque), ma sicuramente migliora le vostre chance di ottenere un esito favorevole o quantomeno di prepararvi un terreno solido per la fase successiva.
Esiti del contraddittorio e prossime fasi
Dopo aver presentato le memorie difensive e concluso il contraddittorio, il procedimento può evolvere in diversi modi. Dal punto di vista del contribuente, è importante capire cosa aspettarsi e come comportarsi nelle fasi successive:
- Accoglimento totale: Caso ideale ma poco frequente. L’ufficio, riconoscendo pienamente fondate le vostre ragioni, archivia il procedimento. In pratica non vi notificherà alcun avviso di accertamento. Potreste ricevere, se siete fortunati, una lettera di “avvenuto riesame con esito favorevole” oppure, più semplicemente, non succederà nulla (silenzio-assenso). Per vostra tranquillità, se a distanza di molti mesi non arriva nulla, potete chiedere conferma all’ufficio. Una volta decorso il termine di decadenza dell’accertamento, sarete certi che il caso è chiuso.
- Accoglimento parziale / rideterminazione: Più spesso avviene che alcune osservazioni vengano accolte e altre no. L’avviso di accertamento verrà comunque emesso, ma con rilievi ridotti o modificati. Ad esempio, se inizialmente contestavano 100 e grazie alle vostre difese 40 sono stati tolti, l’atto sarà emesso per i restanti 60. In tal caso, leggete attentamente la motivazione dell’avviso: troverete indicato quali parti delle vostre deduzioni sono state accettate (es. “In esito al contraddittorio l’Ufficio riconosce la correttezza di …, pertanto elimina il rilievo relativo a …”) e quali invece sono state respinte (con relative contro-deduzioni dell’Agenzia). A questo punto, dovrete valutare se impugnare l’avviso per la parte rimasta in contestazione. La buona notizia è che avrete già pronte molte argomentazioni (quelle che avevate presentato) e potrete aggiungerne di nuove se necessario. La “cattiva” è che, comunque, un contenzioso c’è, anche se più piccolo. In sede di ricorso, ricordate di evidenziare che alcune vostre ragioni sono già state riconosciute fondate dall’Ufficio stesso (ciò accredita la vostra posizione complessiva).
- Nessun accordo – atto invariato: Può succedere che il contraddittorio non sposti nulla: l’ufficio rimane della propria idea su tutti i punti, e dopo 60 giorni emette l’accertamento integralmente confermando i rilievi iniziali. Dal vostro punto di vista, aver partecipato non è stato inutile: intanto avete soddisfatto un passaggio obbligato (evitando eccezioni procedurali a voi sfavorevoli) e avete già pronte le difese. Inoltre, l’atto dovrà confutare in motivazione le vostre tesi, e potreste trovare in quelle risposte qualche elemento su cui fare leva in giudizio (ad es. un errore di valutazione dell’Ufficio, o una contraddizione). Ad ogni modo, dovrete decidere se:
- Proporre ricorso: Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine standard) o entro il termine prorogato se fate adesione post-atto (vedi oltre). Nel ricorso, potete riproporre tutte le questioni già sollevate nel contraddittorio, e aggiungerne altre eventualmente (ad es. vizi formali dell’avviso, questioni di legittimità, ecc.). Il giudice valuterà ex novo la vicenda, senza vincoli rispetto a quanto fatto dall’ufficio, ma certamente tener traccia del contraddittorio (allegando la memoria presentata e il verbale se c’è stato) aiuta a mostrare la vostra correttezza e collaborazione.
- Chiedere accertamento con adesione dopo l’avviso: Se non l’avevate fatto prima, potete presentare istanza di adesione entro 15 giorni dall’avviso (essendo stato preceduto da contraddittorio). Questo sospende i termini per ricorrere di 30 giorni. Durante la nuova fase di adesione l’ufficio, per legge, non è tenuto a riconsiderare elementi di fatto nuovi rispetto a quelli discussi in precedenza, ma nulla vieta che possa comunque emergere una soluzione di compromesso, magari attenuando le pretese per chiudere la lite. Tenete presente però che se in questa sede tirate fuori un documento nuovo “decisivo” che avevate taciuto prima, anche definendo l’atto rischiate la compensazione spese se qualcuno poi impugnasse (teoricamente la definizione chiude lì la questione, ma è una norma dissuasiva).
- Optare per il pagamento/acquiescenza: Se ritenete che il gioco non valga la candela (magari l’importo residuo è modesto e non conviene litigare), potete decidere di pagare. Pagare entro 60 giorni comporta la riduzione delle sanzioni ad 1/3 (acquiescenza) e chiude la partita senza contenzioso. Attenzione: se avevate avuto ragione su parte dei rilievi, l’ufficio dovrebbe ricalcolare sanzioni e interessi solo su ciò che è rimasto. Verificate che l’atto tenga conto dei vostri argomenti accolti. In caso di dubbi, potete chiedere all’ufficio la quantificazione esatta per l’acquiescenza.
- Mancata risposta del contribuente: Per completezza, notiamo cosa accade se il contribuente non presenta alcuna memoria né chiede incontri. In tal caso, semplicemente decorso il termine l’Ufficio emetterà l’avviso definitivo. Il contribuente potrà ancora fare tutto (ricorso, adesione post atto, ecc.), ma avrà perso un’occasione. Inoltre, in giudizio la sua scelta di non partecipare potrebbe essere valutata negativamente (il giudice potrebbe pensare che il contribuente non avesse nulla da obiettare, o che stia tentando tattiche dilatorie). Come già detto, l’importante è che l’Ufficio abbia inviato regolarmente l’invito: dopodiché, la palla era nel campo del contribuente e se questi l’ha lasciata cadere, l’atto rimane valido.
È interessante notare che, con la riforma, è stato inserito anche un “disincentivo processuale” verso chi non collabora: l’art. 15, c.2-quater D.Lgs. 546/1992 (introdotto dal D.Lgs. 156/2015 e ora modificato dal D.Lgs. 130/2022) prevede la compensazione delle spese se il contribuente vince in giudizio sulla base di documenti che non aveva esibito in fase amministrativa senza giustificato motivo. Quindi ignorare il contraddittorio e serbare le carte per il tribunale è una strategia perdente. - Violazione dell’obbligo di contraddittorio (omissione totale o parziale): Dal lato opposto, se l’Ufficio omette di attivare il contraddittorio dove doveva, o lo fa in modo solo formale (ad es. concedendo un termine irragionevolmente breve, o non comunicando affatto gli elementi essenziali poi posti a fondamento dell’atto), il contribuente potrà far valere questo vizio in sede di ricorso. Come visto, l’art.6-bis qualifica l’atto come annullabile. Ciò significa che dovrete eccepirlo nel ricorso introduttivo; non è un vizio rilevabile d’ufficio oltre certe fasi. Una volta eccepito, però, se il giudice verifica che effettivamente l’atto rientrava tra quelli con obbligo di contraddittorio e l’ufficio non lo ha rispettato, annullerà l’atto. Ad oggi, data la chiarezza della norma, pare che non si debba più dimostrare la famosa “prova di resistenza” (il pregiudizio concreto) – basterebbe la violazione in sé. Tuttavia, come detto, rimaniamo in attesa di conferme dalle Sezioni Unite su questo punto, soprattutto in relazione ai principi comunitari.
In caso di urgenza invocata dall’ufficio per saltare il contraddittorio, il contribuente potrà contestare l’assenza dei presupposti di urgenza: se dimostra che non c’era alcun pericolo concreto per la riscossione, l’avviso può essere annullato per difetto di motivazione su tale punto. Ad esempio, se l’ufficio ha invocato il “fondato pericolo” solo perché vicino alla decadenza, ciò non è legittimo di per sé (la norma dell’art.6-bis non considera la semplice imminenza della decadenza come urgenza, visto che prevede la proroga di 120 giorni). Diversamente, se emergono atti di alienazione di beni durante il contraddittorio, l’urgenza sarebbe motivata. Queste situazioni si discuterebbero poi in giudizio.
Riassumendo: partecipare attivamente al contraddittorio, con memorie ben congegnate, mette il contribuente nella migliore condizione sia per evitare l’accertamento sia, se ciò non riesce, per affrontare l’eventuale fase contenziosa su un terreno favorevole. Nel contenzioso, l’esito non è mai scontato, ma di certo il giudice guarderà con occhio più benevolo un contribuente che abbia mostrato collaborazione e abbia evidenziato presto le proprie ragioni, rispetto a chi “spunta fuori” solo in aula. E non dimentichiamo che esiste sempre, fino all’ultimo, la possibilità di un accordo transattivo col Fisco: l’atteggiamento costruttivo nel contraddittorio può predisporre meglio anche l’ufficio ad eventuali soluzioni conciliative (come la conciliazione giudiziale) se si arriva in giudizio.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande comuni che i contribuenti si pongono riguardo alle memorie difensive e all’invito al contraddittorio, con risposte concise basate sulla normativa e sulla prassi attuale.
- D1: Cos’è esattamente l’“invito al contraddittorio”?
R: È la comunicazione con cui l’Ufficio fiscale vi informa delle contestazioni emerse a vostro carico prima di emettere un accertamento definitivo, offrendovi la possibilità di interloquire. Può assumere nomi diversi (invito a comparire, avviso di avvio del procedimento, schema di atto), ma la sostanza è che vi viene data conoscenza delle contestazioni tributarie e vi è assegnato un termine (di norma 60 giorni) per presentare osservazioni o chiedere un incontro. Dal 2024 è obbligatorio per quasi tutti gli atti impugnabili (a pena di nullità dell’accertamento), salvo atti di natura automatica o casi di urgenza. In passato era previsto solo in certi casi specifici (ad es. senza PVC) e la nullità dell’atto per omessa attivazione era condizionata alla prova di un concreto pregiudizio. - D2: Quando è obbligatorio il contraddittorio preventivo?
R: Oggi, sempre, per qualsiasi avviso di accertamento o atto fiscale impugnabile, tranne nelle ipotesi di esclusione previste dal D.M. 24/4/2024 (controlli automatizzati/formali, atti catastali, ecc.) e nei casi di particolare urgenza debitamente motivata. Dunque, per accertamenti di redditi, IVA, registro, IMU, ecc., l’ente impositore deve instaurare il contraddittorio. Se non lo fa, l’atto è annullabile dal giudice su eccezione del contribuente. In passato (periodo 2015-2023) l’obbligo c’era: (a) dopo i PVC di verifica (60 giorni ex art.12 Statuto); (b) dal 2020, prima degli accertamenti “a tavolino” senza PVC (ex art.5-ter) – con eccezioni come accertamenti parziali; (c) per IVA e dazi, già in forza di principi UE. Ora tutto questo è ricondotto ad un principio unico (art.6-bis) che copre ogni tributo. - D3: Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non mi invita al contraddittorio e mi manda direttamente l’accertamento?
R: Se l’accertamento rientra tra quelli per cui il contraddittorio è obbligatorio (la maggior parte, come visto), la mancata attivazione del contraddittorio è un vizio dell’atto. In base all’art.6-bis, l’atto è annullabile dal giudice. Dovrete però impugnarlo voi davanti alla Commissione/Corte tributaria e sollevare espressamente questo motivo. In giudizio, attualmente l’orientamento è che basti dimostrare che l’Ufficio doveva invitarvi e non l’ha fatto, per ottenere l’annullamento, senza ulteriori oneri (specie dopo l’introduzione della norma che lo prevede “a pena di nullità”). Tuttavia, per prudenza, molti difensori allegano comunque una sorta di “prova di resistenza” nel ricorso, spiegando quali argomenti non hanno potuto far valere per il mancato contraddittorio – questo per convincere maggiormente il giudice. Se invece l’atto non era soggetto all’obbligo (es. cartella da controllo automatizzato), allora la mancata attivazione del contraddittorio non costituisce vizio (perché la legge lo esclude espressamente). Attenzione: prima del 2024, per i tributi non armonizzati, la giurisprudenza non riconosceva l’annullabilità dell’atto per omesso contraddittorio in assenza di specifica norma (Cass. SU 24823/2015). Dal 2020 al 2023 vi era l’art.5-ter che prevedeva nullità con prova di resistenza, quindi per atti di quegli anni occorre valutare caso per caso secondo la normativa vigente allora (ad es., un accertamento IRPEF 2019 emesso senza invito non era annullabile perché la norma è entrata in vigore dopo; uno del 2021 emesso senza invito se doveva averlo può essere annullato se provate il pregiudizio). In definitiva, per gli atti dal 2024 in avanti la tutela è più forte: il contraddittorio omesso comporta nullità annullabile senza eccezioni generali. - D4: Quanto tempo ho per presentare la memoria difensiva?
R: Almeno 60 giorni. Questo è il termine minimo fissato dalla legge per consentirvi di predisporre le vostre deduzioni. L’invito o schema di atto che ricevete indicherà una data precisa di scadenza (es. “entro 60 giorni dal ricevimento”). In certi casi specifici (es. adesione a PVC ante 2016) erano 30 giorni, ma attualmente 60 è lo standard, sia per art.12 Statuto che per art.6-bis. L’ufficio non può emettere l’avviso prima che siano decorsi i 60 giorni (salvo che dichiari l’urgenza, vedi dopo). Se avete bisogno di più tempo e avete motivi validi, potete provare a chiedere una proroga come spiegato prima – è a discrezione dell’Ufficio concederla. Ricordate che entro 30 giorni dovete decidere se eventualmente presentare istanza di adesione al posto delle memorie, perché quella scadenza è più breve (nel caso scegliate l’adesione immediata, non farete la memoria per ora, ma esporrete le vostre ragioni in sede di incontro di adesione). Se invece presentate le memorie, non dovete fare altro entro i 60 giorni; poi, dopo l’eventuale atto, avrete 15 giorni per chiedere adesione post-avviso se vorrete. - D5: Devo partecipare per forza al contraddittorio? Posso anche non rispondere all’invito?
R: Non c’è un obbligo legale per il contribuente di partecipare (il contraddittorio è un diritto, non un dovere coattivo). Nessuna sanzione diretta è prevista se non rispondete. Tuttavia, come ampiamente spiegato, ignorarlo è fortemente sconsigliato. Non rispondere significa perdere la chance di evitare l’atto o ridurlo, e in più in giudizio potreste subire la compensazione delle spese se vincerete solo grazie a documenti presentati tardivamente. L’assenza di risposta non vi preclude di fare ricorso dopo, ma certamente indebolisce “moralmente” la vostra posizione (il giudice potrebbe chiedersi perché non avete detto nulla quando potevate). Quindi, potete legalmente tacere, ma praticamente è un autogol. L’unico caso in cui è comprensibile non inviare memorie è se si intende aderire immediatamente: in tal caso presentate l’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni e la vicenda proseguirà su quel binario (incontro di adesione). Ma anche in questo caso, nulla vieta di presentare comunque una breve memoria, o quantomeno di portare documenti all’incontro di adesione. In sintesi: rispondere è sempre meglio. L’impegno richiesto è modesto rispetto ai potenziali benefici. - D6: L’invito al contraddittorio interrompe o sospende qualche termine (tipo la decadenza dell’accertamento)?
R: L’invito in sé non interrompe né sospende formalmente termini di legge a favore dell’Erario, però la normativa prevede un meccanismo di proroga del termine di decadenza dell’accertamento se necessario. Mi spiego: supponiamo che l’ufficio vi invii l’invito a fine novembre e l’anno accertabile decada il 31/12; i 60 giorni andrebbero oltre il 31/12. Ebbene, la legge consente all’ufficio di emettere l’atto fino a 120 giorni dopo la scadenza dei 60 giorni, quindi di fatto sposta in avanti la decadenza. Questo per garantire che abbiate comunque tutti i vostri 60 giorni di tempo. Per voi contribuenti, quindi, l’invito non “blocca” nulla perché tanto siete in attesa dell’atto; per l’ufficio, evita di dover fare corse o di saltare il contraddittorio per non decadere. Quanto ai termini di impugnazione: quelli decorreranno solo dalla notifica dell’eventuale avviso finale. Se poi fate istanza di adesione post-avviso, lì scatta la sospensione di 90 giorni (o 30 giorni se l’accertamento era preceduto da contraddittorio, come da ultime modifiche). Ma l’invito in sé non dà luogo ad alcuna sospensione del diritto di ricorrere perché, ovviamente, non c’è ancora un atto impugnabile. È giusto una fase preliminare. - D7: Se accetto le contestazioni (per esempio, mi rendo conto di aver sbagliato) cosa mi conviene fare in fase di contraddittorio?
R: Se dai rilievi emerge chiaramente un errore da parte vostra e volete regolarizzare spontaneamente, potete valutare due strade:- Adesione immediata: presentate istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni e cercate di chiudere con l’ufficio un accordo sulle somme dovute. Otterrete le sanzioni ridotte a 1/3 e rateazione se serve.
- Acquiescenza agevolata: attendete l’avviso e pagate entro 60 giorni con sanzioni a 1/3 (o valutate se c’è una definizione agevolata in corso, tipo condono, ecc.).
In sede di contraddittorio scritto, comunque, non è obbligatorio contestare per forza. Se riconoscete la fondatezza, potete anche non inviare memorie o inviare una lettera in cui dite di essere d’accordo. Però, attenzione: ammettere formalmente un rilievo nell’ambito del procedimento potrebbe chiudere spazi di manovra; meglio eventualmente usare l’adesione per patteggiare sanzioni e importi. Un caso tipico: rilevano un reddito non dichiarato, siete d’accordo sull’importo; allora magari non fate lunghe memorie (non avrebbe senso negare l’evidenza), ma piuttosto chiedete all’ufficio un incontro e puntate a una definizione via adesione con sanzioni ridotte. Ricordatevi sempre che se l’ufficio sbaglia la qualificazione giuridica o il calcolo delle sanzioni, anche se ammettete il fatto potete difendervi sull’inquadramento (es.: “sì, ho omesso €10.000, ma non è reddito evaso, è un errore formale, sanzione minore”, ecc.). Il contraddittorio serve anche a ridimensionare le pretese. Quindi, anche in caso di errore vostro, partecipate magari per spiegare circostanze attenuanti (buona fede, errore scusabile, ecc.). Potreste ottenere dall’ufficio la non applicazione di sanzioni amministrative in autotutela se dimostrate che c’era una palese incertezza normativa (capita raramente, ma tentare non nuoce).
- D8: Posso portare nuovi documenti in giudizio se non li ho presentati nelle memorie?
R: Sì, nel processo tributario vige un principio di libera prova fino al primo grado: potete produrre documenti nuovi anche dopo, insieme al ricorso o fino alla prima udienza (oltre, solo se sono prove tardive ammisse dal giudice). Non c’è preclusione come in altri processi. Tuttavia, come più volte detto, la nuova normativa prevede che se vincete la causa solo grazie a documenti che non avevate presentato prima senza motivo, il giudice deve compensare le spese di lite. Cioè, vi negherà il rimborso delle spese legali sostenute. Ciò per punire la mancata collaborazione preventiva. Inoltre, l’ufficio in giudizio sicuramente enfatizzerà il fatto che “il contribuente aveva taciuto questo documento in fase precontenziosa, segno che… (lo aveva nascosto, poco trasparente, ecc.)”. Dunque, vi conviene giocare subito le vostre carte migliori nelle memorie difensive, così da massimizzare le chance di convincere l’ufficio e non avere penalizzazioni sulle spese in caso di contenzioso. - D9: Cosa comporta scegliere la strada della memorie difensive rispetto alla richiesta di adesione subito?
R: Vediamolo in uno schema comparativo: Tabella 2 – Memoria difensiva VS Istanza di accertamento con adesione (fase pre-atto) Aspetto Memoria difensiva (Osservazioni) Istanza di accertamento con adesione Termine per presentarla 60 giorni dal ricevimento dell’invito/schema di atto. 30 giorni dal ricevimento dell’invito/schema di atto. Effetto immediato L’ufficio esamina le memorie; può invitare a un incontro di discussione. Non c’è sospensione formale dei termini, ma l’atto non esce prima di 60 gg. L’ufficio invierà un invito a comparire ex art.5 D.Lgs.218/97 e fisserà un incontro di adesione (entro 15-20 gg di solito). Da quel momento, trattativa su importi e sanzioni; l’atto finale potrebbe essere l’atto di adesione firmato dalle parti (se accordo) o, in mancanza di accordo, l’accertamento definitivo. Coinvolgimento del contribuente Prevalentemente scritto: il contribuente espone le sue ragioni per iscritto; può chiedere incontro orale (non obbligatorio). Prevalentemente orale: si instaura un dialogo faccia a faccia (o telematico) con l’ufficio; è una negoziazione. Anche qui si possono presentare memorie illustrative, ma il fine è raggiungere un accordo economico. Vantaggi – Permette di far valere integralmente le ragioni di illegittimità dell’atto (non solo di ridurne l’entità). – Non “brucia” la possibilità di adesione dopo: se l’atto esce, si può ancora chiederla (entro 15 gg, sospensione 30 gg). – Mantiene pieni diritti di difesa in giudizio, avendo già introdotto le proprie argomentazioni. – Consente di ottenere subito una riduzione delle sanzioni a 1/3 (se si trova l’accordo). – Evita il contenzioso trovando un compromesso: spesso l’ufficio è disposto a rivedere al ribasso imponibili e sanzioni pur di chiudere. – Sospende i termini di decadenza dell’ufficio durante la trattativa (3 mesi) e, una volta perfezionata l’adesione, la materia è definita (niente ricorso, niente altre sanzioni). Svantaggi – L’ufficio potrebbe, dopo aver letto le memorie, emettere l’atto senza modifica: avrete “perso tempo” (relativamente, perché potrete comunque impugnare). – Non c’è garanzia di chiusura rapida: se l’ufficio non è convinto, si andrà comunque in contenzioso. – Se poi aderite post-avviso, la sospensione termini ricorso è minore (30 gg) e l’ufficio non è tenuto a considerare elementi nuovi oltre a quelli già dedotti. – Se non si raggiunge accordo, l’accertamento esce comunque (magari a distanza di mesi) e avrete già consumato la possibilità di adesione (non potete richiederla di nuovo dopo l’avviso). – Nell’adesione, per chiudere, spesso dovete rinunciare a qualche difesa (è un compromesso): ad es., accettare un’imposta parziale anche se ritenete di aver ragione, pur di evitare rischi. – Se emergono questioni di solo diritto che non volete accettare, l’adesione non aiuta (il funzionario non può cancellare la norma, il giudice sì eventualmente). Quando sceglierla? – Quando siete convinti di avere solide ragioni nel merito o in diritto per far annullare/ridurre l’accertamento. – Quando volete mantenere aperta ogni strada (difesa integrale o adesione successiva). – Importo molto elevato in cui anche un accordo con sanzioni ridotte sarebbe troppo oneroso e preferite tentare l’annullamento totale. – Quando riconoscete almeno in parte la fondatezza delle pretese e puntate a ottenere uno sconto su imposte e sanzioni. – Quando privilegiate la certezza e rapidità: preferite pagare qualcosa ma chiudere la vicenda, anziché avventuravi nel contenzioso. – Quando l’accertamento riguarda materie quantificabili su cui si può transigere (es. ricavi non dichiarati dove si può “venirsi incontro” su una cifra intermedia). In molti casi, una strategia è: presentare le memorie difensive e contestualmente (entro 30 gg) presentare istanza di adesione. È controverso se si possano fare entrambe le cose insieme: la prassi fino al 2023 lo permetteva (le circolari AE suggerivano che se arrivava istanza adesione, l’invito 5-ter si considerava assolto e si procedeva su adesione). Col nuovo art.6-bis pare disegnato come alternative esclusive. Quindi ufficialmente dovreste scegliere. Nulla vieta però di allegare alle memorie una frase tipo: “Qualora l’Ufficio ritenesse di non poter accogliere integralmente le presenti osservazioni, il contribuente sin d’ora manifesta l’intenzione di addivenire ad una definizione concordata, riservandosi di attivare il procedimento di adesione nei termini di legge.”. Così li mettete in guardia che se non cedono, siete disposti a trattare. Formalmente poi potrete fare istanza di adesione post-avviso. In pratica, usate la memoria per “tirare la corda” a vostro favore; se poi capite che rischiate, c’è sempre l’opzione accordo prima o dopo. - D10: E se durante il contraddittorio vengo convocato per un incontro, che devo fare?
R: Presentatevi, assolutamente (a meno che abbiate già deciso di non collaborare affatto). L’incontro è spesso un’opportunità d’oro per chiarire a voce malintesi, far vedere fisicamente documenti, e anche per “umanizzare” la vostra posizione (mostrandovi cooperativi e disponibili). Preparatevi bene: portate copia delle memorie (se già inviate) e degli allegati, evidenziate i passaggi chiave che volete sottoporre. Potete farvi accompagnare da un consulente anche se non è formalmente delegato (basta la vostra presenza per legittimarlo a parlare, previo vostro consenso). All’incontro, siate pragmatici: ascoltate cosa vi dice l’ufficio, cercate di capire se c’è apertura su alcuni punti. Se percepite che su qualcosa proprio non mollano ma su altro sì, potete anche rimodulare le vostre richieste (es.: “sui ricavi non dichiarati capisco che insistete, ma almeno riconoscetemi questo costo in più…”). L’incontro può preludere a un’adesione: a volte il funzionario vi dirà “se vuole possiamo fare un’adesione su tot”. Valutate sul momento, non siete obbligati a decidere subito; potete dire che preferite pensarci ma intanto avete voluto far presente le vostre ragioni. Alla fine del colloquio si redigerà un verbale: leggetelo prima di firmare e assicuratevi che riporti fedelmente i punti discussi e le eventuali concessioni dell’ufficio. Se l’ufficio si impegna a togliere un rilievo, fatelo mettere nero su bianco. - D11: Se l’ufficio accoglie le mie memorie e archivia l’accertamento, sono al sicuro per sempre su quella questione?
R: Sì e no. Se l’ufficio decide di non emettere l’atto, il procedimento si chiude. Occorre però distinguere: se era un accertamento su imposte dirette/IVA, l’archiviazione significa che per quell’anno e per quelle materie non vi faranno ulteriori accertamenti (a meno di scoprire elementi nuovi eccezionali, ma è raro e comunque dovrebbero notificare un nuovo eventuale invito se fosse il caso). Diciamo che potete stare tranquillo. Se invece era, poniamo, una comunicazione bonaria o una contestazione minore archiviata, l’ufficio potrebbe teoricamente tornare sul tema con un’altra base giuridica, ma nel contraddittorio parliamo di accertamenti veri e propri. In generale, se avete una comunicazione scritta di archiviazione, conservatela a prova. Se non l’avete ma sono decorsi i termini di decadenza, il silenzio vale quanto un’archiviazione. In casi dubbi (es. archiviazione parziale), potete chiedere all’ufficio un provvedimento di autotutela che formalizzi la cessazione della materia del contendere, ma spesso non lo emettono se non c’è atto da annullare. Ad ogni modo, una volta superato l’anno in cui potevano farvi l’accertamento, direi che potete considerarvi al sicuro. Attenzione però: se l’ufficio archivia perché, ad esempio, avete dimostrato che un reddito appartiene a un altro soggetto, potrebbe girare la segnalazione ad altro ufficio o all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ma ciò esula dalla vostra posizione (è un rischio per l’altro soggetto semmai). In sintesi: sì, se archiviano, quel capitolo per voi è chiuso. - D12: Che differenza c’è tra memorie difensive e istanza di autotutela?
R: Le memorie difensive si presentano prima che l’atto sia emesso, nell’ambito del contraddittorio obbligatorio. L’istanza di autotutela, invece, è una richiesta che si fa dopo che l’atto è stato emesso (e notificato), chiedendo all’ente di riesaminarlo e annullarlo/ridurlo se riconosce degli errori. Quindi sono due cose diverse come tempi e scopo. In contraddittorio argomentate per prevenire l’atto; con l’autotutela, cercate di far correggere un atto già emanato, magari in pendenza di ricorso. Formalmente, poi, le memorie sono un diritto del contribuente insito nel procedimento, l’autotutela è una facoltà discrezionale della PA (l’ufficio può anche non rispondere). Vi dirò: se avete svolto bene il contraddittorio e l’atto esce ugualmente, riproporre un’istanza di autotutela con gli stessi motivi è di solito inutile (l’ufficio ha già deciso). L’autotutela post-accertamento ha senso se emergono elementi nuovi dopo l’atto o se notate errori clamorosi che magari il funzionario preferisce correggere da sé senza andare in giudizio. Ma ricordate che l’istanza di autotutela non sospende i termini di ricorso: non aspettate l’esito dell’autotutela per decidere se ricorrere, altrimenti rischiate di far passare i 60 giorni e perdere il diritto al ricorso. - D13: In sede di contraddittorio posso transigere solo alcune annualità o solo alcuni rilievi?
R: Sì, informalmente. Il contraddittorio endoprocedimentale non è vincolato dalle regole processuali di domanda: potete discutere con l’ufficio come meglio credete. Ad esempio, se avete accertamenti su più anni notificati insieme, nulla vieta che nelle memorie diciate: “Relativamente all’anno 2020 si propone il pagamento integrale delle imposte dovute, chiedendo l’abbandono delle sanzioni per obiettiva incertezza, mentre per l’anno 2021 si confida nell’archiviazione totale stante la fondatezza delle osservazioni presentate.” Certo, questa è quasi una proposta di accordo, non proprio una memoria tecnica, ma potete farla. Così come potete “sacrificare” un rilievo minore per farvi togliere quello grosso. Formalmente poi, se l’ufficio accetta, la via è l’adesione: per esempio, definirete un’adesione sull’anno 2020 e l’atto 2021 verrà archiviato. Oppure emetteranno l’avviso 2020 concordato e nulla per 2021. In sostanza, il contraddittorio consente flessibilità. Se avete più annualità oggetto di indagine, potete trattarle anche in un unico incontro/memoria se l’ufficio è d’accordo, o separatamente. L’importante è che ogni annualità abbia poi la sua definizione formale corretta (atto o non atto). L’ufficio ovviamente sarà ben lieto se voi siete disposti a pagare una parte: potrà formalizzare quell’accordo con adesione parziale. Durante il contraddittorio, però, non firmate nulla che suoni come rinuncia alle difese su altri rilievi, a meno che non rientri in un chiaro contesto di adesione. - D14: Cosa significa contraddittorio “informato ed effettivo”?
R: Sono aggettivi usati nella norma (art.6-bis) per qualificare la qualità del contraddittorio. “Informato” vuol dire che il contribuente dev’essere messo a conoscenza di tutti gli elementi su cui si baserà l’accertamento: non possono convocarvi senza dirvi chiaramente cosa vi contestano. Ad esempio, se hanno ricevuto una segnalazione o documenti, dovrebbero metterveli a disposizione (da qui il diritto di accesso agli atti). “Effettivo” significa che deve essere una opportunità reale di difesa, non solo fittizia. Dunque, l’ufficio deve concedere un tempo congruo (i 60 gg di legge) e poi prendere in esame seriamente le vostre deduzioni, motivando l’eventuale rigetto. Un contraddittorio condotto pro forma, ad esempio spedendo l’invito senza allegare la documentazione utile, o dando 5 giorni per rispondere, o ignorando completamente le memorie ricevute, potrebbe essere considerato non effettivo. In giudizio si potrebbe far valere che, pur avendo l’ufficio avviato un contraddittorio, questo è stato meramente apparente (violazione del principio di buona fede e collaborazione ex art.10 Statuto). Sono casi limite, ma la giurisprudenza li contempla – ad esempio se viene leso il diritto di accesso agli atti o il termine è stato drasticamente ridotto senza ragione, il giudice potrebbe sanzionare la violazione. In generale, comunque, con “informato ed effettivo” il legislatore ha voluto ribadire che non basta all’ufficio fare un atto simbolico: deve dare davvero modo al contribuente di esprimersi consapevolmente e deve ascoltarlo con mente aperta. - D15: Quali sono le sentenze più importanti in materia di contraddittorio recente?
R: Sul piano generale, citiamo alcune pronunce chiave:- Cass. SS.UU. 9/12/2015 n.24823: ha negato l’esistenza di un obbligo generale di contraddittorio per i tributi non armonizzati, se non previsto da legge. Ha retto fino alle riforme attuali (superata dai fatti).
- Cass. 27/11/2013 n.28432: sezione semplice che per prima introdusse la “prova di resistenza” per la nullità degli atti IVA senza contraddittorio.
- Cass. 18/09/2014 n.19667: (e altre coeve) ha esteso il concetto anche agli altri tributi, prima delle SU 2015, richiedendo comunque il pregiudizio concreto.
- Cass. 11/05/2018 n.11560: ha stabilito che la violazione dell’art.12 c.7 Statuto (PVC) comporta nullità dell’atto senza prova di resistenza (orientamento favorevole al contribuente, sul presupposto che la legge già lo prevedeva a pena di nullità).
- Corte Cost. 21/03/2023 n.47: monito al legislatore per introdurre obbligo generalizzato.
- Cass. 05/02/2025 n.2795 (ordinanza): ha ribadito per l’IVA la necessità della prova di resistenza, richiamando un orientamento del 2024 (Cass. 33818/2024) e rimarcando l’attesa di un intervento delle Sezioni Unite in merito.
- Cass. 19/06/2024 n.16873: ha riconosciuto che, alla luce del nuovo art.6-bis, l’obbligo di contraddittorio è destinato a valere in generale (caso relativo ad imposte dirette, con rinvio alla normativa sopravvenuta).
- Cass. ord. Sez. V, 14/04/2024 (ord. n. …): ha rimesso alle Sezioni Unite la questione del se serva ancora la prova di resistenza nel nuovo contesto, dato il contrasto tra principio unionale e norma interna, come si evince da quanto scritto nel Quadro normativo.
- C.Giust. UE, cause “Sopropé” (2008), “Kamino” e “Dock Terminal” (2014), “Ispas” (2017): a livello europeo, hanno affermato da un lato il diritto al contraddittorio quale principio fondamentale (anche in assenza di norme nazionali), ma dall’altro hanno ammesso che la violazione può non comportare annullamento se il contribuente non dimostra che, se sentito, avrebbe potuto difendersi meglio. Questa visione utilitaristica del contraddittorio è quella recepita nella nostra giurisprudenza come prova di resistenza.
- C.TP/C.TR di vari locali: ci sono anche sentenze di merito interessanti, ad esempio CTP Reggio Emilia 2021 che annulla un atto perché l’ufficio aveva inviato l’invito ma non aveva poi considerato né menzionato le memorie del contribuente, ravvisando motivazione carente (confermata in CTR). Questo a riprova che ormai non basta invitare, bisogna anche rispondere alle difese.
Conclusione
Redigere memorie difensive efficaci nell’ambito di un invito al contraddittorio è una competenza cruciale per avvocati e consulenti tributari, ma è anche un diritto/dovere che ogni contribuente informato può esercitare. Abbiamo visto come preparare e inviare tali memorie, e come queste si inseriscano in un procedimento che, da eccezione, è divenuto la regola generale dell’accertamento tributario.
Dal punto di vista del debitore fiscale, il contraddittorio preventivo è passato dall’essere una gentile concessione dell’ufficio a un vero e proprio baluardo di tutela previsto dalla legge: sfruttiamolo al meglio. Presentare le nostre ragioni con calma e precisione, prima che l’atto sia emesso, può fare la differenza tra un accertamento annullato o ridotto e uno confermato integralmente. In ogni caso, pone le fondamenta per una difesa consapevole e forte in eventuale sede contenziosa.
Ricordiamo sempre che il fine ultimo del contraddittorio non è fare “melina” o prendere tempo, bensì cercare di risolvere la controversia senza litigare. In un sistema tributario ideale, contribuente e Amministrazione dovrebbero cooperare per accertare il giusto: il contraddittorio è il momento in cui questa cooperazione può davvero avvenire. Sta a noi, con una memoria ben fatta e un atteggiamento collaborativo, dimostrare che spesso il dialogo è meglio dello scontro. E se proprio scontro deve essere, arrivare preparati è metà della vittoria.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, Circolare 22 giugno 2020 n. 17/E – Chiarimenti sull’invito obbligatorio al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs. 218/1997.
- Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 219, art. 6-bis Statuto del Contribuente – Introduzione dell’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2024 – Atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio ai sensi dell’art.6-bis L.212/2000.
Memorie difensive per invito al contraddittorio? Fatti Assistere da Studio Monardo
Hai ricevuto un invito al contraddittorio da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Vuoi evitare un accertamento fiscale definitivo e far valere le tue ragioni in modo efficace?
L’invito al contraddittorio è una fase fondamentale che ti consente di difenderti prima che venga emesso l’avviso di accertamento. Presentare memorie difensive ben strutturate può fare la differenza tra una chiusura favorevole e una contestazione fiscale pesante.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza in dettaglio l’invito ricevuto e i rilievi formulati dall’Agenzia
- 📌 Ricostruisce la tua posizione fiscale con documenti, giustificativi e prove a tuo favore
- ✍️ Redige memorie difensive efficaci, puntuali e basate su norme e prassi aggiornate
- ⚖️ Ti assiste nel confronto con l’ufficio durante il contraddittorio preventivo
- 🔁 Se necessario, prepara la strategia per eventuale ricorso in caso di accertamento
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e procedure di accertamento
- ✔️ Specializzato nella redazione di memorie difensive e difesa precontenziosa
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Un invito al contraddittorio è un’opportunità per bloccare o alleggerire un accertamento fiscale.
Con memorie difensive ben fondate puoi tutelare la tua posizione e ridurre sensibilmente gli importi richiesti.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa comincia da qui.