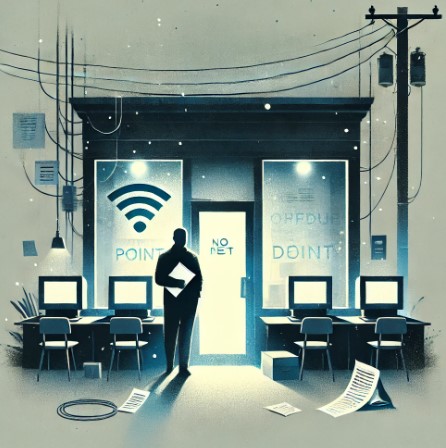Hai gestito un Internet Point e oggi ti trovi con debiti fiscali, bancari o contributivi che non riesci più a sostenere? Hai ricevuto cartelle esattoriali, pignoramenti o avvisi di accertamento dopo la chiusura dell’attività? Ti stai chiedendo come difenderti, cosa rischi personalmente e se esistono soluzioni legali per uscire dalla crisi?
Molti ex titolari di Internet Point si trovano in difficoltà a causa di ricavi discontinui, spese fisse elevate e debiti accumulati nel tempo. Ma anche se l’attività è cessata, la legge ti offre strumenti concreti per difenderti e ripartire, senza subire passivamente le azioni dei creditori.
Quali sono i problemi più frequenti per un ex titolare di Internet Point con debiti?
– Cartelle dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per IVA, IRPEF, INPS, TARI non pagati
– Pignoramento del conto corrente o dello stipendio se hai trovato un nuovo lavoro
– Richieste di pagamento da parte di ex fornitori o banche per finanziamenti non estinti
– Segnalazione nelle banche dati (CRIF, Centrale Rischi) che blocca ogni accesso al credito
– Difficoltà a ricominciare o a intestarsi beni per timore di nuove azioni esecutive
Cosa rischi se non fai nulla?
– Azioni legali per il recupero del credito
– Aggressione del tuo patrimonio personale, anche se hai cessato l’attività
– Impossibilità di lavorare in tranquillità o costruire una nuova attività regolare
– Accumulo di interessi e sanzioni, che aggravano ulteriormente il debito
Come puoi difenderti legalmente?
– Verificando se i debiti sono effettivamente dovuti, contestando cartelle o accertamenti viziati
– Valutando l’accesso alla procedura di sovraindebitamento per ex imprenditori individuali
– Presentando un piano del consumatore se oggi percepisci un reddito fisso o una pensione
– Richiedendo la liquidazione controllata del patrimonio se non puoi offrire un piano sostenibile
– Ottenendo la cancellazione dei debiti residui con l’esdebitazione finale, anche se non puoi pagarli tutti
Cosa puoi ottenere con la giusta difesa?
– Stop immediato a pignoramenti e riscossione coattiva
– Azzeramento di interessi e sanzioni
– Rateizzazione legale del debito in base alle tue reali possibilità
– Cancellazione totale dei debiti non pagabili, se sei meritevole
– Ritorno alla vita economica attiva, senza più vivere sotto minaccia
Non esiste una crisi senza soluzione. Anche se sei un ex titolare, la legge oggi ti riconosce la possibilità di ripartire, proteggere il tuo presente e difenderti legalmente.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi da debito e difesa degli ex imprenditori ti spiega come affrontare la tua situazione se hai chiuso un Internet Point e sei rimasto con debiti.
Hai ricevuto atti di riscossione o vivi una situazione di blocco? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione debitoria e ti diremo qual è la soluzione migliore per difenderti e ricominciare.
Introduzione
La chiusura di un’attività commerciale, come un Internet Point, non mette automaticamente fine ai debiti contratti durante la sua gestione. Un ex titolare di Internet Point con debiti si trova spesso a dover affrontare le pretese dei creditori anche dopo aver cessato l’attività. In Italia la responsabilità patrimoniale è illimitata per le obbligazioni: significa che il debitore risponde dei debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Pertanto, la cessazione della partita IVA o la cancellazione dal Registro Imprese non cancella i debiti pregressi. L’obiettivo di questa guida è spiegare, con un taglio giuridico ma accessibile, come difendersi dai debiti dopo la chiusura di un Internet Point, illustrando i diversi tipi di debito, le forme giuridiche d’impresa e relative responsabilità, nonché gli strumenti di tutela e le soluzioni legali (incluse le procedure concorsuali e di sovraindebitamento di recente introduzione).
Tipologie di debiti di un ex imprenditore e relative criticità
Un ex titolare di Internet Point può trovarsi a fronteggiare molteplici tipologie di debiti, derivanti tanto dall’attività aziendale quanto dalla sfera personale. È importante distinguere tra le diverse categorie di debito, poiché ognuna è regolata da normative specifiche e può presentare strumenti di difesa differenti. Ecco le principali tipologie di debiti che possono gravare su un ex imprenditore, con un focus sulle problematiche connesse e sulle possibili strategie difensive:
- Debiti fiscali ed erariali: comprendono imposte statali (es. IVA, IRPEF), tasse locali (TARI, COSAP ecc.) e contributi previdenziali (INPS) o assicurativi (INAIL). Questi debiti sono generalmente affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) per il recupero coattivo, tramite la notifica di cartelle esattoriali. I debiti tributari non si estinguono con la chiusura dell’attività: restano a carico personale dell’ex titolare, dato che la ditta individuale non ha personalità giuridica distinta. Ciò vale anche per contributi previdenziali non versati o premi assicurativi non pagati: la cessazione dell’attività non blocca i diritti di riscossione degli enti previdenziali né eventuali azioni giudiziarie dei dipendenti per stipendi o TFR non corrisposti. I debiti fiscali hanno spesso natura privilegiata e seguono regole speciali di prescrizione (di norma 10 anni, salvo interruzioni). Inoltre, l’Agenzia Riscossione può attivare procedure rapide come il fermo amministrativo sui veicoli, l’ipoteca sugli immobili e il pignoramento presso terzi senza necessità di un decreto ingiuntivo, in base alla procedura delineata dal DPR 602/1973. Un elemento critico è che, sebbene alcune sanzioni penali possano configurarsi per l’omesso versamento di talune imposte (ad es. IVA oltre soglie di punibilità), nella maggior parte dei casi il problema è civilistico: affrontare cartelle esattoriali e azioni di recupero forzato. Come difendersi? L’ex imprenditore dovrà valutare la correttezza degli importi (eventualmente impugnando nei termini gli atti impositivi o di riscossione), sfruttare strumenti come la rateizzazione del debito con l’AER (piani fino a 72 o 120 rate a seconda dell’importo), oppure aderire a eventuali definizioni agevolate (es. rottamazione delle cartelle), che consentono di pagare il debito fiscale senza sanzioni né interessi di mora. Va ricordato che nel 2023-2025 il legislatore ha introdotto la rottamazione quater (Legge n.197/2022) e ulteriori proroghe: fino al 30 aprile 2025 è possibile chiedere la riammissione ai benefici della rottamazione se si erano persi termini precedenti. Tali misure permettono di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 versando solo il capitale e le spese, con abbuono di interessi e sanzioni. Per le cartelle di piccolo importo, la Legge di Bilancio 2023 ha persino previsto l’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 € affidati tra il 2000 e il 2015. Dunque, una prima forma di difesa è cogliere queste opportunità normative. In caso di impossibilità di pagamento, l’ex titolare potrà valutare l’accesso alle procedure da sovraindebitamento (si veda oltre) per stralciare o dilazionare il debito fiscale in sede giudiziale. È importante sottolineare che la prescrizione dei debiti tributari (di regola decennale) può essere interrotta da ogni atto notificato (cartella, sollecito, intimazione) facendo ripartire il termine da capo. Dunque, l’assenza di solleciti per qualche anno non significa che il debito sia scomparso: se un atto interruttivo è stato notificato tempestivamente, il credito rimane valido per molti anni (potenzialmente decenni). Il debitore può eccepire la prescrizione solo se è in grado di dimostrare documentalmente che il termine è decorso senza atti interruttivi.
- Debiti verso banche e finanziarie: includono mutui, finanziamenti, affidamenti di conto, leasing e scoperti di conto contratti per l’attività (o personalmente). Dopo la chiusura dell’Internet Point, eventuali esposizioni bancarie rimaste insolute divengono debiti personali dell’ex titolare (anche qui, per la ditta individuale non c’è distinzione tra patrimonio aziendale e personale). La banca o la finanziaria potrà agire giudizialmente (ad esempio richiedendo un decreto ingiuntivo e attivando pignoramenti) oppure cedere il credito a società di recupero. Come difendersi? Innanzitutto verificando la regolarità del rapporto di credito: ad esempio, se vi sono interessi usurari o anatocismo, il debitore può contestare gli estratti conto e far ricalcolare il dovuto. In caso di contenzioso, sarà essenziale proporre opposizione al decreto ingiuntivo nei termini (40 giorni) se vi sono eccezioni da sollevare. Spesso, tuttavia, l’ex imprenditore insolvente non contesta l’esistenza del debito, ma la propria incapacità di pagare integralmente. In tali casi, una strada percorribile è tentare una trattativa stragiudiziale con la banca per un saldo e stralcio, ovvero il pagamento di una percentuale a stralcio del dovuto in cambio dell’esdebitazione. Le banche, specie se il debitore non ha garanzie aggredibili facilmente, possono accettare importi ridotti pur di chiudere la posizione (ad es., offrire 30% del debito in un’unica soluzione). Se il credito è stato ceduto a una società di recupero (che magari l’ha acquistato per pochi centesimi sull’euro), sarà talvolta possibile ottenere sconti significativi. È importante affrontare queste negoziazioni con il supporto di un legale o di un consulente del debito per non ammettere passività inesistenti e per formalizzare correttamente l’accordo transattivo. Anche per i debiti bancari esistono termini di prescrizione (ordinariamente 10 anni per le somme da contratto di mutuo o finanziamento). Tuttavia, come detto, qualsiasi atto con cui la banca richiede il pagamento (diffide, decreti ingiuntivi, atti di precetto) interrompe la prescrizione, rendendo di fatto difficile che un debito bancario cada in prescrizione senza reazioni del creditore. Un’altra difesa per il debitore è valutare la possibilità di accesso alle già menzionate procedure di sovraindebitamento: il piano del consumatore (oggi ristrutturazione dei debiti del consumatore) è pensato proprio per rinegoziare debiti come quelli bancari, obbligando i creditori dissenzienti ad accettare quanto il debitore può effettivamente pagare. Va aggiunto che, per i debiti bancari garantiti da ipoteca (es. mutuo su immobile), la banca mantiene il diritto di escutere il bene dato in garanzia. Se l’ex imprenditore non paga le rate del mutuo, la banca può avviare l’espropriazione dell’immobile ipotecato (anche se è la prima casa, non essendo questa una procedura esattoriale ma privata). Si potrà semmai tentare di conservare l’immobile ricorrendo al piano del consumatore: la legge consente, infatti, se il debitore è in regola con le rate o viene rimesso in regola, di preservare il contratto di mutuo ipotecario sulla prima casa continuando a pagare regolarmente le rate future. Diversamente, in mancanza di soluzioni, l’immobile verrà venduto all’asta giudiziaria e la banca sarà soddisfatta col ricavato (eventuale debito residuo potrà essere oggetto di esdebitazione).
- Debiti commerciali verso fornitori e locatori: riguardano fatture non pagate a fornitori di beni e servizi, canoni di affitto del locale commerciale rimasti insoluti, bollette utenze non saldate, indennità di fine contratto ecc. Questi debiti, di natura contrattuale, seguono le regole ordinarie del codice civile. Molti di essi hanno prescrizione breve (5 anni per le forniture periodiche, le utenze domestiche, i canoni di locazione, ex art. 2948 c.c.). Ad esempio, le bollette telefoniche o internet si prescrivono in 5 anni. Per gli affitti, pure il termine è quinquennale una volta scaduto il contratto. Se il debito rientra in queste categorie, il decorso del tempo può essere una difesa: verificare se il creditore ha lasciato decorrere più di cinque anni senza atti interruttivi (raccomandate, ingiunzioni) potrebbe significare poter eccepire la prescrizione e rendere il credito inesigibile. In caso contrario, il fornitore o locatore insoddisfatto può agire giudizialmente per ottenere un titolo (spesso tramite decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo se corredato da fattura o contratto registrato) e procedere a pignoramenti. L’ex titolare dovrà dunque stare attento a eventuali notifiche di atti giudiziari: se riceve un decreto ingiuntivo, ha 40 giorni per presentare opposizione motivata, altrimenti diviene definitivo. Come difendersi su questo fronte? Oltre alla già citata prescrizione, occorre valutare se vi siano contestazioni nel merito: ad esempio, merce non consegnata, viziata, o disdetta del contratto di affitto per tempo. In sede di opposizione, tali eccezioni vanno sollevate per ridurre o annullare il debito. In mancanza di contestazioni sostanziali, anche qui la trattativa può essere utile: molti fornitori preferiscono incassare almeno una parte subito piuttosto che inseguire a lungo un ex imprenditore che potrebbe risultare nulla tenente. Una scrittura di saldo e stralcio con il fornitore, magari mediata da un organismo di composizione della crisi, può prevenire azioni esecutive. Qualora il debitore non abbia risorse per offrire neppure un saldo parziale, rientra anche per questi debiti la possibilità di includerli in un concordato minore o nella liquidazione controllata, ripartendo proporzionalmente quel poco che c’è tra tutti i creditori chirografari (vedi oltre sezione procedure concorsuali). Si tenga presente, infine, che anche dopo la chiusura dell’attività i beni personali del debitore sono aggredibili per questi debiti commerciali: conti correnti, stipendio di eventuale nuovo lavoro, beni mobili e immobili dell’ex titolare restano esposti alle azioni esecutive dei creditori fornitori o locatori. Non esistono protezioni automatiche solo perché l’attività è cessata: anche un piccolo credito può condurre a un pignoramento se non ci si attiva.
- Debiti verso dipendenti e collaboratori: se l’Internet Point aveva personale dipendente o collaboratori, la chiusura dell’attività potrebbe aver lasciato insoluti stipendi, ferie non godute, TFR, o compensi a collaboratori occasionali. Questi debiti retributivi godono di tutela privilegiata: il lavoratore può ottenere un decreto ingiuntivo rapidamente e ha un credito privilegiato (sia nel fallimento, sia nel pignoramento individuale su eventuali beni mobili o immobili del datore). La legge prevede strumenti di garanzia per i lavoratori: in caso di insolvenza del datore di lavoro, il dipendente può accedere al Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime mensilità, ma ciò richiede di norma che il datore sia stato assoggettato a procedura concorsuale (fallimento o liquidazione concorsuale) oppure, per i non fallibili, che vi sia un accertamento giudiziale dell’insolvenza. In altre parole, se l’ex titolare è un soggetto non fallibile, il lavoratore potrebbe dover citare in tribunale l’ex datore per ottenere una dichiarazione di insolvenza (ai sensi dell’art. 14-quinquies L.3/2012 ora trasfuso nel Codice della Crisi) al fine di attivare il Fondo di Garanzia. In ogni caso, l’ex titolare resta personalmente obbligato: la chiusura della ditta non fa venir meno l’obbligo di saldare le spettanze dei dipendenti. Il lavoratore potrebbe procedere con pignoramento dei beni del datore (salvo riuscire a soddisfarsi tramite il Fondo INPS). Come difendersi in questo scenario? Se possibile, è sempre meglio cercare un accordo transattivo con gli ex dipendenti, magari dilazionando il pagamento (un pagamento parziale immediato e il resto a rate) in cambio di una quietanza a saldo. Questo può evitare cause di lavoro e ulteriori costi. Se il debito verso lavoratori è ingente e il datore non è fallibile, potrebbe valutare di avviare egli stesso una procedura di sovraindebitamento: in un concordato minore o in un piano del consumatore si possono anche soddisfare parzialmente i dipendenti, chiaramente tenendo conto che i crediti per retribuzioni hanno privilegio di legge. In sede di liquidazione controllata, i lavoratori verranno comunque soddisfatti con precedenza sugli eventuali beni liquidati, in quanto privilegiati sul patrimonio mobiliare e immobiliare (ex artt. 2751-bis c.c. e ss.). Un cenno va fatto anche alle conseguenze penali: l’omesso versamento di ritenute previdenziali (contributi INPS trattenuti al dipendente) oltre una soglia (oggi circa €10.000 annui) costituisce reato, così come il mancato versamento delle ritenute fiscali (IRPEF) sopra soglie di punibilità. L’ex titolare dovrà quindi anche considerare di regolarizzare, se possibile, queste posizioni per evitare denunce penali. Spesso, il pagamento (anche tardivo) delle ritenute può estinguere il reato prima della sentenza, quindi vale la pena trovare risorse almeno per queste componenti. In sintesi, i debiti verso il personale vanno posti al vertice delle priorità, sia per motivi etici sia giuridici: hanno tutele robuste e margini di falcidia meno ampi.
- Debiti personali estranei all’attività: infine, l’ex imprenditore potrebbe avere debiti non direttamente legati all’impresa, come ad esempio fideiussioni prestate, debiti familiari, multe o sanzioni amministrative. Un caso tipico: il titolare ha garantito personalmente (con fideiussione) un prestito bancario concesso alla società (es. S.r.l.) o alla ditta. In tal caso, se il debitore principale (es. la società) non paga, la banca può escutere immediatamente il fideiussore sugli stessi presupposti del debito principale. Il come difendersi qui rientra nelle strategie già viste per debiti bancari (contestazione di eventuali nullità delle fideiussioni omnibus se redatte su schema ABI – tematica su cui la Cassazione ha spesso dichiarato nulle certe clausole, ad es. intese anticoncorrenziali ex art. 2 L. 287/90 – oppure trattativa per stralcio). Per le sanzioni amministrative (multe stradali, sanzioni per violazioni di norme sul commercio, ecc.), la competenza alla riscossione spesso è sempre di Agenzia Entrate-Riscossione, con cartelle esattoriali. Queste sanzioni hanno termini di prescrizione propri (ad esempio le multe stradali si prescrivono in 5 anni dall’ultima notifica utile). La difesa in questo campo consiste nel verificare vizi di notifica o prescrizioni maturate e proporre eventualmente ricorso al Giudice di Pace o al tribunale competente, oppure utilizzare gli strumenti deflativi se disponibili (talora, in alcune definizioni agevolate, anche le sanzioni amministrative sono incluse). Va ricordato che le obbligazioni alimentari (assegni di mantenimento a coniuge o figli) non sono falcidiabili né in procedure concorsuali né estinguibili per prescrizione breve (sono soggette a 5 anni rate non pagate, ma il diritto al mantenimento in sé perdura). In sede di pignoramento dello stipendio, i crediti alimentari hanno una tutela speciale potendo coesistere con altri pignoramenti fino al limite della metà dello stipendio (ne parleremo più avanti). Dunque, se l’ex titolare ha anche obblighi di mantenimento, quei pagamenti vanno considerati “prioritari” e non sono derogabili legalmente.
Come si nota, tutti i tipi di debito possono concorrere a creare una situazione di sovraindebitamento per un ex imprenditore. L’ordinamento prevede oggi (dopo la riforma attuata con il D.lgs. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022) strumenti specifici per affrontare il sovraindebitamento in modo unitario e offrire al debitore onesto una via d’uscita dai debiti insostenibili. Prima di approfondirli, è cruciale capire come la forma giuridica sotto cui operava l’Internet Point incide sulla responsabilità per i debiti.
Forme giuridiche dell’attività e responsabilità del debitore
La responsabilità per i debiti dell’ex titolare varia sensibilmente a seconda della forma giuridica con cui l’attività veniva svolta: ditta individuale, società di persone (S.n.c. o S.a.s.) oppure società di capitali (S.r.l. o S.p.A.). Analizziamo separatamente queste situazioni, poiché dal tipo di impresa dipende quali beni dei soci o titolari sono aggredibili dai creditori e quali procedure concorsuali possono aprirsi.
- Ditta individuale: L’Internet Point gestito come impresa individuale non ha soggettività giuridica distinta dalla persona fisica del titolare. Ciò implica che il titolare risponde illimitatamente con tutto il proprio patrimonio personale per i debiti d’impresa, anche dopo la cessazione dell’attività. In pratica, i beni personali (conti, immobili, stipendio futuro, ecc.) rimangono aggredibili dai creditori della ditta anche dopo la chiusura della partita IVA. La chiusura della ditta ≠ cancellazione dei debiti: i debiti restano a carico dell’ex titolare, e i creditori possono agire nei suoi confronti in qualsiasi momento entro i termini di prescrizione. Questo concetto è fondamentale e spesso mal compreso: molti piccoli imprenditori sperano che, chiudendo l’attività, i debiti “spariscano” o che i creditori rinuncino. In realtà, salvo accordi transattivi o procedure di esdebitazione, il debitore continuerà ad essere obbligato sino a pagamento o prescrizione. Neppure l’inerzia temporanea dei creditori è rassicurante, dato che – come visto – possono interrompere la prescrizione e tenere il credito in vita per anni. In caso di morte dell’ex titolare, i debiti si trasferiscono agli eredi (che possono però tutelarsi rinunciando all’eredità o accettandola con beneficio d’inventario). Per quanto riguarda le procedure concorsuali, l’imprenditore individuale può essere assoggettato a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) solo se superava i limiti di legge per la fallibilità. La normativa esclude infatti dagli imprenditori commerciali soggetti a fallimento quelli considerati piccoli (non fallibili). I parametri attuali prevedono che non sia soggetto a fallimento l’imprenditore che nei tre esercizi antecedenti ha avuto un attivo patrimoniale non superiore a €300.000, ricavi lordi non superiori a €200.000 e un debito totale non oltre €500.000. Molte ditte individuali rientrano in questi limiti e quindi, se insolventi, non possono essere dichiarate fallite su istanza dei creditori. Questo non significa che i creditori rimangano senza tutela: potranno agire esecutivamente sul patrimonio personale del debitore (pignoramenti ecc.), oppure il debitore stesso potrà ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata – vedi oltre). Se invece l’impresa individuale superava i limiti di fallibilità, il rischio è la dichiarazione di liquidazione giudiziale (ex fallimento) entro un anno dalla cessazione: l’art. 10 L.F. (ora trasfuso nel Cod. Crisi) prevedeva che entro un anno dalla cancellazione dell’impresa individuale i creditori potessero chiederne il fallimento, provando l’insolvenza preesistente. Il Codice della Crisi conferma sostanzialmente questo principio: l’imprenditore che ha chiuso da meno di un anno può ancora essere sottoposto a liquidazione giudiziale su iniziativa dei creditori, se sussistono i presupposti di insolvenza. Ciò serve ad evitare facili elusioni (ad es., chiudere la partita IVA allo scoperto per sfuggire al fallimento). In sintesi: per la ditta individuale, il panorama vede una responsabilità illimitata su tutti i beni, nessuna limitazione automatica post-chiusura, e la necessità di utilizzare strumenti ad hoc (transazioni o procedure concorsuali minori) per risolvere la crisi debitoria.
- Società in nome collettivo (S.n.c.) e società in accomandita semplice (S.a.s.): Queste società di persone hanno una propria soggettività giuridica, ma i soci assumono per legge una responsabilità illimitata (in S.n.c. tutti i soci; in S.a.s. solo gli accomandatari, mentre gli accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita purché non ingeriscano nella gestione). In una S.n.c., dunque, i creditori sociali possono rivalersi sia sul patrimonio sociale sia, in caso di incapienza di questo, sul patrimonio personale di ciascun socio. Vige il beneficio di escussione: i creditori devono prima tentare di soddisfarsi sul fondo comune della società, e solo se questo risulta insufficiente possono aggredire i beni personali dei soci. Ciò non toglie che la responsabilità ultima dei soci sia solidale e senza limiti: ogni socio può essere chiamato a pagare l’intero debito sociale rimasto insoluto. La chiusura di una società di persone (tramite liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese) non libera i soci dai debiti sociali insoddisfatti. Anzi, l’art. 2312 c.c. stabilisce che, estinta la società, i soci rispondono personalmente dei debiti residui. Dunque, un ex socio di S.n.c. potrà essere citato dai creditori anche dopo la cancellazione della società. I debiti fiscali seguono la stessa logica: il Fisco può pretendere dai soci il pagamento dei tributi non pagati dalla società, ma deve dimostrare l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il suo credito. Secondo la Cassazione, in ambito di riscossione esattoriale il socio di S.n.c. non necessita di un avviso di accertamento separato: notificato l’atto alla società e risultando escussa negativamente la società, la cartella di pagamento può essere emessa direttamente a carico del socio (non è cioè indispensabile notificare al socio anche l’atto impositivo originario, purché sia stato notificato alla società). Questo non esonera l’agente della riscossione dall’onere di provare che il patrimonio sociale era incapiente rispetto al credito fiscale. In pratica, per il socio di S.n.c. (o accomandatario di S.a.s.) il rischio debiti è molto simile a quello del titolare individuale, con la differenza che i soci sono più d’uno e che il creditore deve agire prima sulla società. Ma se la società non paga, i soci rispondono con tutto il loro patrimonio, anche per debiti tributari (la Cassazione ha chiarito che i soci illimitatamente responsabili rispondono con il loro patrimonio personale anche di imposte non pagate dalla società, una volta escusso il patrimonio sociale). Un’ulteriore particolarità è che il socio che ha pagato un debito sociale ha diritto di regresso verso gli altri soci per la loro parte. Tuttavia, se gli altri soci sono insolventi, il socio che ha pagato sopporta di fatto l’intero esborso. Cosa accade se un socio esce dalla società prima della chiusura? Il socio che recede o cede la propria quota non è immediatamente liberato dai debiti sociali pregressi: l’art. 2290 c.c. prevede che è responsabile per le obbligazioni sociali sorte anteriormente al suo recesso per un periodo di 5 anni dalla pubblicazione dell’uscita. Ciò significa che un ex socio di S.n.c. potrebbe vedersi richiedere pagamenti di debiti contratti dalla società quando egli era ancora partecipe, entro i 5 anni successivi alla sua uscita, se la società (o i soci rimasti) non li adempiono. Anche per la società di persone, la morte del socio comporta il subentro degli eredi nelle responsabilità illimitate, salvo rinuncia all’eredità. Procedure concorsuali: una società di persone insolvente è soggetta a liquidazione giudiziale (fallimento) se supera i limiti di fallibilità (che si valutano in riferimento alla società stessa). Se la società viene dichiarata fallita, automaticamente vengono dichiarati falliti anche i soci illimitatamente responsabili (estensione del fallimento ai sensi dell’art. 147 L.F.). Questo è un aspetto delicato: ad esempio, se una S.n.c. chiude con grossi debiti e un creditore ne chiede il fallimento entro 1 anno dalla cancellazione, il tribunale potrà dichiarare la liquidazione giudiziale sia della società estinta che dei soci in proprio. I soci falliti subiscono tutti gli effetti del fallimento personale (come l’inabilitazione ad esercitare attività commerciale per un certo periodo, limitazioni patrimoniali, ecc.) e potranno ottenere l’esdebitazione personale solo a fine procedura alle condizioni di legge. Se la società di persone è sotto le soglie di fallibilità, non potrà essere dichiarata fallita; i creditori dovranno perseguire direttamente i soci con azioni esecutive individuali, oppure i soci potranno attivare le procedure di sovraindebitamento per risolvere la crisi. Un cenno sulla S.a.s.: il socio accomandante, se rimane tale (cioè non immischiato nella gestione e non presente nel nome sociale), non risponde oltre il conferimento. Ma se viola il divieto di ingerenza (art. 2320 c.c.) o fa comparire il proprio nome nella ragione sociale (art. 2314 c.c.), perde il beneficio della responsabilità limitata e diventa illimitatamente responsabile verso i terzi. Inoltre, va ricordato che l’accomandante risponde comunque illimitatamente se riconosce un debito sociale oltre i limiti della quota: ad esempio, una recente giurisprudenza ha ritenuto che l’accomandante che firmi atti di riconoscimento del debito sociale verso terzi possa incorrere in responsabilità illimitata. In sostanza, l’unico socio non a rischio illimitato in una S.a.s. è quello accomandante che si attiene rigorosamente al suo ruolo di investitore silente. Tutti gli altri (socio accomandatario e soci di S.n.c.) rischiano il patrimonio personale.
- Società di capitali (S.r.l., S.p.A.): Le società di capitali, a differenza delle precedenti, godono del principio della autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che dei debiti sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, mentre i soci (o l’azionista) non sono, di regola, personalmente responsabili oltre il capitale sottoscritto. Per esempio, in una S.r.l., se l’Internet Point era gestito tramite una società a responsabilità limitata, i debiti verso fornitori, banche, Fisco, ecc. gravano sulla S.r.l. come persona giuridica distinta. Se la società non paga e non ha beni, i creditori non possono automaticamente aggredire i beni personali dei soci. Ci sono però diverse eccezioni e precisazioni importanti: (a) Se un socio ha prestato garanzie personali (fideiussioni) per obbligazioni sociali, ne risponde come garante (es: tipico è il caso del socio amministratore che firma fideiussione alla banca per il fido concesso alla S.r.l.; la banca escute il fideiussore se la S.r.l. non paga). (b) In sede di chiusura della società, l’art. 2495 c.c. stabilisce che, una volta cancellata la società dal registro, per eventuali debiti insoddisfatti i creditori possono far valere le loro pretese nei confronti dei soci fino a concorrenza di ciò che questi hanno riscosso in sede di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. In pratica, la legge non abbandona del tutto i creditori di una società di capitali estinta: se i soci si sono ripartiti attivi nella liquidazione e alcuni debiti sono rimasti non pagati, il creditore può chiedere ai soci la restituzione (pro-quota) di quanto ricevuto, per soddisfare il suo credito fino a concorrenza di quell’importo. Non è invece consentito chiedere al socio più di quanto ottenuto dalla liquidazione, altrimenti si snaturerebbe il beneficio della responsabilità limitata. La Corte di Cassazione, con un’ordinanza recente, ha ribadito tale principio: “il socio di una società a responsabilità limitata estinta può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali solo entro le somme riscosse in sede di bilancio finale di liquidazione”. Nella ordinanza n. 32729/2023, la Cassazione ha chiarito che grava sul creditore insoddisfatto l’onere di provare che c’è stata distribuzione di attivo al socio, mentre spetta poi al socio provare di aver utilizzato quelle somme per pagare debiti sociali eventualmente noti. Nel caso affrontato, il socio unico di una S.r.l. cancellata non avendo ricevuto nulla dalla liquidazione è risultato non responsabile verso il creditore insoddisfatto. Questo orientamento tutela la separazione patrimoniale tipica delle società di capitali: il socio non diventa debitore personale dei creditori sociali oltre il limite del patrimonio sociale distribuito. (c) Un’altra eccezione riguarda possibili azioni di responsabilità contro amministratori o anche contro soci in casi di abuso della personalità giuridica. Ad esempio, se l’amministratore ha aggravato il dissesto violando i doveri, il curatore fallimentare (o i creditori, se non c’è fallimento) possono citarlo per responsabilità risarcitoria. Oppure, in casi estremi di utilizzo fraudolento della società come schermo, la giurisprudenza può ammettere forme di “piercing the corporate veil” (come l’estensione ai soci di obbligazioni tributarie in ipotesi di illeciti). Un caso noto in ambito fiscale: se una S.r.l. viene indebitamente svuotata dei beni sociali a beneficio dei soci lasciando impagate le imposte, l’Agenzia Entrate può notificare ai soci avvisi di accertamento per distribuzione occulta di utili o per configurare una responsabilità solidale in base a norme antiabuso (ad es. l’art. 37-bis DPR 600/73 per operazioni elusive, o l’art. 2495 c.c. come visto). Tuttavia, questi rimedi non sono automatici e richiedono procedimenti ad hoc. (d) Se la società di capitali è ancora in vita ma insolvente, i creditori possono chiederne la liquidazione giudiziale (fallimento) senza coinvolgere i soci. In caso di fallimento di S.r.l. o S.p.A., i soci non falliscono personalmente (a differenza delle società di persone). Subiranno però la perdita del capitale investito e, come detto, se avevano garanzie personali dovranno comunque pagarle. Inoltre, l’eventuale ripartizione dell’attivo ante fallimento potrebbe essere revocata (azione revocatoria fallimentare) se effettuata in pregiudizio dei creditori. Perciò, un socio che avesse ricevuto indietro finanziamenti o dividendi prima del fallimento potrebbe doverli restituire alla massa. Ma in linea generale, il socio di società di capitali insolvente che non ha commesso illeciti e non ha garantito personalmente i debiti vede il proprio rischio limitato al capitale conferito o distribuito. Questa è la ragione per cui molti imprenditori, specie in attività potenzialmente rischiose, scelgono la forma della S.r.l.: per proteggere il patrimonio personale. Nel nostro caso, se l’Internet Point era gestito tramite S.r.l., è possibile che la società sia stata messa in liquidazione e poi cancellata. I debiti rimasti pendenti formalmente non sono più esigibili verso la società (che non esiste più), ma come visto i creditori potrebbero entro i termini di legge agire contro i soci (per gli attivi percepiti) oppure chiedere al tribunale la riapertura della liquidazione entro 1 anno dalla cancellazione (ex art. 2495 c.c. e art. 121 CCII) qualora scoprissero attivi non considerati o irregolarità. Se la società non è stata liquidata regolarmente o vi sono profili di irregolarità (es. la società ha cessato attività di fatto ma non risulta cancellata, oppure ha dissipato attivo a favore di soci), allora i creditori hanno strumenti aggiuntivi: ad esempio l’azione revocatoria ordinaria per atti dispositivi compiuti a titolo gratuito o a titolo oneroso con pregiudizio (art. 2901 c.c.), che consente di far dichiarare inefficaci verso i creditori atti di distrazione di beni (come donazioni ai familiari, vendite sotto prezzo ai soci ecc.). Va menzionato che, in questi casi, se le distrazioni configurano reati (bancarotta fraudolenta), l’imprenditore può incorrere in responsabilità penale in caso di successivo fallimento. Ad esempio, svuotare intenzionalmente la S.r.l. dei beni per non pagare i creditori e poi chiuderla può essere perseguito se la società viene dichiarata fallita entro l’anno. Dunque, la forma a responsabilità limitata è un ottimo scudo in situazioni fisiologiche, ma non deve indurre a comportamenti dolosi: i soci e amministratori che abusano della personalità giuridica possono essere chiamati a rispondere in varie forme. Procedure concorsuali: le società di capitali sono sempre assoggettabili a fallimento (liquidazione giudiziale) in caso di insolvenza, a prescindere da dimensioni (il vecchio dubbio se le soglie di non fallibilità valessero anche per S.r.l. in realtà in giurisprudenza era risolto nel senso che valevano per qualunque piccolo imprenditore commerciale, società incluse; oggi il Codice della Crisi parla di “imprenditore minore” includendo anche società sotto soglia nei non assoggettabili a liquidazione giudiziale, quindi su questo c’è margine interpretativo, ma tendenzialmente una micro-S.r.l. potrebbe evitare la liquidazione giudiziale se sotto parametri). Se una S.r.l. viene dichiarata insolvente e supera i limiti dimensionali, il tribunale aprirà la procedura di liquidazione giudiziale. I soci non partecipano col proprio patrimonio (salvo il caso di socio unico che non abbia versato per intero il capitale sociale: in tal caso risponde verso la procedura per la parte non versata). Il fallimento della società non preclude che i soci persone fisiche possano a loro volta essere in sovraindebitamento per altre ragioni e valutare procedure ad hoc, ma generalmente i soci non falliscono. Discorso diverso per l’amministratore: questi potrebbe vedersi accusato di reati fallimentari se ha compiuto irregolarità (bancarotta fraudolenta, preferenziale, semplice a seconda dei casi). Dal punto di vista civilistico, però, soci e amministratori di società di capitali decadute restano tendenzialmente al riparo da azioni dirette dei creditori sociali, salvo i casi sopradescritti.
Riassumiamo dunque in tabella le differenze principali:
Come si evince, l’ex titolare di un Internet Point avrà probabilmente operato o come ditta individuale (la fattispecie più esposta) o in forma di piccola società (spesso S.n.c. fra familiari, o S.r.l. uninominale per limitare la responsabilità). Ciascuna situazione richiede un approccio leggermente diverso nella difesa dai creditori. In tutti i casi, tuttavia, se permangono debiti insostenibili occorrerà far ricorso a strumenti giuridici per risolvere o almeno contenere l’esposizione debitoria, come illustreremo nelle sezioni seguenti.
Strumenti di difesa del debitore: opposizioni, trattative e tutela del patrimonio
Affrontare i debiti post-chiusura implica da un lato reagire alle eventuali azioni dei creditori, dall’altro giocare d’anticipo organizzando le proprie risorse e utilizzando gli strumenti legali per proteggere i beni essenziali e pianificare una via d’uscita. Elenchiamo i principali strumenti di difesa a disposizione del debitore:
1. Verifica e contestazione del debito: la prima linea di difesa è sempre l’analisi critica di ogni pretesa. L’ex imprenditore dovrebbe esaminare dettagliatamente le richieste di pagamento ricevute (cartelle, solleciti, decreti ingiuntivi) per individuare possibili vizi formali o prescrizione. Ad esempio: una cartella esattoriale notificata oltre i termini di legge (spesso 5 anni dalla scadenza del tributo per molte imposte) può essere annullabile per tardività; un decreto ingiuntivo per fatture potrebbe contenere interessi non dovuti o calcoli erronei. Se emergono irregolarità, sarà fondamentale presentare opposizione nei modi e tempi previsti. Ci sono diversi tipi di opposizione: l’opposizione a decreto ingiuntivo (entro 40 giorni in tribunale ordinario) per contestare il credito prima che diventi definitivo; l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente (ad es., eccependo che il debito si è già estinto o non è più esigibile); l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se vi sono vizi formali nei singoli atti (ad es. un pignoramento notificato male). Queste opposizioni sospendono o rallentano le procedure, costringendo il creditore a dimostrare la validità della propria pretesa. Naturalmente, occorre avere motivi fondati: opporsi in modo pretestuoso può solo allungare i tempi e aumentare i costi (una soccombenza comporterà spese legali a carico del debitore). Conviene quindi che il legale valuti attentamente se vi sono eccezioni solide (prescrizione maturata, incompetenza del giudice, difetto di titolo esecutivo, pignoramento su bene impignorabile, ecc.). Alcuni esempi concreti: se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pignora un bene che la legge tutela (come la prima casa non ipotecata in determinate condizioni, vedi più avanti), il debitore può fare opposizione all’esecuzione per far dichiarare improcedibile quel pignoramento perché il bene è impignorabile per legge. Oppure, se un creditore notifica un atto di precetto (intimazione di pagamento) su un credito prescritto, l’opposizione potrà far valere la prescrizione come motivo per negare il diritto di procedere. Sintesi: la difesa attiva tramite contestazioni giudiziali è fondamentale quando c’è il fondato sospetto che il credito non sia dovuto (in tutto o in parte) o che il procedimento esecutivo presenti vizi.
2. Trattativa e soluzioni stragiudiziali: non sempre contestare è possibile; spesso il debito è certo e il problema è “solo” l’incapacità di pagarlo integralmente. In tali casi, negoziare direttamente col creditore può portare esiti benefici. Come anticipato per i debiti bancari o commerciali, proporre un saldo e stralcio – ovvero il pagamento immediato di una percentuale del dovuto, a fronte di rinuncia del creditore al resto – può essere una soluzione win-win: il debitore si libera del debito a costo ridotto, il creditore incassa subito evitando lungaggini dall’esito incerto. La riuscita di una trattativa dipende da vari fattori: l’entità del debito, la solvibilità apparente del debitore, la natura del creditore (una banca strutturata avrà procedure interne da seguire; un privato può essere più flessibile). Spesso il debitore sovraindebitato non ha somme immediate per offrire un saldo: in questi casi, a volte l’intervento di un familiare o terzo finanziatore può aiutare (es. un parente versa una tantum a chiudere un debito con la banca). In mancanza, si può tentare la via di un piano di rientro a rate, formalizzato per iscritto: il creditore accetta di dilazionare il pagamento (eventualmente congelando parte di interessi) e, se il debitore rispetta le rate, rinuncia ad azioni esecutive. È essenziale formalizzare bene tali accordi (meglio con l’assistenza di un legale) per evitare che, in caso di difficoltà, il creditore possa pretendere nuovamente l’intero importo. Gli accordi stragiudiziali possono anche essere plurilaterali: se il debitore ha più creditori, può convocarli (magari con l’aiuto di un organismo di composizione della crisi) per proporre un accordo globale di ristrutturazione. Questo però richiede il consenso di tutti (o quantomeno dei principali), e non sempre è fattibile. Attenzione: eventuali accordi vanno adempiuti puntualmente; un errore comune è “tirare a campare” promettendo pagamenti senza poi eseguirli, il che peggiora la credibilità del debitore e spinge il creditore ad agire giudizialmente. Se invece un accordo di riduzione e dilazione viene rispettato, il debitore evita pignoramenti e chiude la posizione. Anche con l’Agenzia Riscossione è possibile contrattare in parte: esistono procedure di rateazione standard (fino a 6 anni o, oltre certi importi, 10 anni con prova di difficoltà), e come visto procedure di definizione agevolata varate periodicamente dallo Stato. Queste ultime (rottamazioni) non sono negoziazioni individuali ma misure di legge aperte a tutti i contribuenti: il debitore aderisce e paga secondo le regole fissate (in genere niente sanzioni né interessi, pagamento rateale del capitale). Importante: durante il periodo di rateazione con AER, le procedure esecutive sono sospese a meno di decadenza dalla rateazione, quindi ottenere un piano di dilazione con il Fisco può congelare i pignoramenti in corso. Vi è poi lo strumento della “sospensione” della cartella: se il debitore ritiene che la cartella sia illegittima, può chiedere all’Agenzia Riscossione di sospendere le azioni esecutive presentando documentazione che provi l’errore (ad es., pagamento già avvenuto, sgravio ottenuto dall’ente creditore, prescrizione evidente, ecc.). L’agente della riscossione sospende 180 giorni in attesa di risposte dall’ente creditore. Questo non risolve il debito in sé, ma può guadagnare tempo in situazioni specifiche. In generale, la comunicazione con i creditori è importante: un debitore non può pagare tutti integralmente subito, ma mostrarsi collaborativo e trasparente sulle proprie difficoltà spesso evita il conflitto duro. Ad esempio, se l’ex titolare ha trovato un nuovo lavoro ma con reddito modesto, può far capire ai creditori che un pignoramento sullo stipendio frutterebbe loro 1/5 esiguo, mentre un accordo bonario potrebbe convenire a tutti. Documentare la propria situazione finanziaria (entrate/uscite, eventuali altri debiti, carichi familiari) può convincere i creditori della buona fede e della convenienza di una soluzione concordata.
3. Protezione del patrimonio personale: un ex imprenditore indebitato deve valutare anche azioni di salvaguardia dei pochi beni che gli restano, nei limiti della liceità. Ci sono strumenti come il fondo patrimoniale o il trust che teoricamente segregano beni rendendoli non aggredibili dai creditori estranei a certi scopi. Tuttavia, occorre usare estrema cautela: costituito dopo che i debiti sono sorti, un fondo patrimoniale o trust rischia di essere dichiarato inefficace verso i creditori mediante azione revocatoria (art. 2901 c.c., con termini di 5 anni per gli atti a titolo gratuito) oppure, per i debiti fiscali, può addirittura configurare tentativo di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (reato ex d.lgs. 74/2000 se supera certe soglie). Inoltre, il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) vincola beni immobili o mobili registrati per i bisogni della famiglia, rendendoli impignorabili ex art. 170 c.c. per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari. Molti imprenditori hanno in passato costituito un fondo patrimoniale includendovi la casa coniugale pensando di salvarla da Equitalia. Ma la Cassazione ha chiarito che il criterio non è la natura del debito (fiscale o commerciale) bensì la relazione tra il debito e i bisogni familiari: un debito tributario d’impresa può ritenersi contratto per i bisogni della famiglia se l’attività d’impresa serviva al mantenimento della famiglia stessa. Non basta che il debito derivi dall’attività lavorativa per considerarlo automaticamente estraneo ai bisogni familiari: occorre valutare in concreto se è stato contratto per esigenze voluttuarie o speculazione personale, oppure se, ad esempio, non pagando quelle imposte l’imprenditore finanziava indirettamente il tenore di vita familiare. In pratica, la tutela del fondo patrimoniale è piuttosto debole nei confronti del Fisco: spetta al debitore dimostrare che il debito ha finalità del tutto estranee alla famiglia (es. sanzione per un’operazione speculativa fallita) per opporre l’impignorabilità; se non lo prova, il bene in fondo è aggredibile. E anche qualora lo provi, se il creditore (AER) non era a conoscenza dell’estraneità ai bisogni familiari, può comunque procedere (la legge tutela il creditore che ignorava la destinazione familiare del bene). Quanto ai creditori privati, spesso il fondo li protegge solo per debiti manifestamente estranei alla famiglia. Concludendo: costituire un fondo patrimoniale dopo che i debiti esistono è generalmente inutile se non controproducente (può essere revocato e, se con intenti fraudolenti verso il Fisco su debiti ingenti, anche penalmente rilevante). Se invece un fondo esisteva da tempo (antecedente ai debiti) e i debiti erano estranei ai bisogni della famiglia, allora il debitore può difendersi facendo opposizione all’esecuzione su quei beni, richiamando l’art. 170 c.c. e giurisprudenza favorevole. In ogni caso, il principio generale è: non esiste una protezione totale e semplice dei propri beni contro i creditori; qualsiasi atto di disposizione volto a sottrarre beni ai creditori può essere annullato via revocatoria, se fatto in malafede. L’unica difesa veramente efficace per il patrimonio è agire per tempo (quando non si è in stato di insolvenza conclamata) e con strumenti leciti, ad esempio mantenendo una chiara distinzione tra finanze personali e aziendali, evitando di intestarsi beni se esposti a rischi (ma qui entriamo in piani leciti di pianificazione patrimoniale preventiva, che esulano dalla fase “ex post” che stiamo trattando). Pertanto, l’ex titolare indebitato dovrebbe più che altro concentrare gli sforzi su come pagare meno piuttosto che su come non pagare affatto proteggendo i beni. Un capitolo a parte potrebbe riguardare la legge “salva casa” (L. 3/2012, art. 12-ter, c. 3 quater introdotto nel 2015) che consentiva al debitore in piano del consumatore di chiedere la continuazione del mutuo sulla casa di abitazione per evitarne la vendita: principio poi ripreso nel Codice della Crisi. Ma parliamo di strumenti concorsuali, che ora approfondiamo.
Procedure concorsuali e di sovraindebitamento: soluzioni giudiziali
Quando i debiti sono troppi e le risorse insufficienti, le procedure concorsuali rappresentano la via legale per gestire la crisi. Dal punto di vista dell’ex titolare debitore, l’obiettivo di queste procedure è duplice: regolare la posizione con i creditori (anche riducendo l’ammontare dovuto) e, se possibile, ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui per poter ripartire pulito. Le procedure si distinguono a seconda che il debitore sia soggetto alle procedure ordinarie (liquidazione giudiziale/fallimento, concordato preventivo) oppure alle procedure di sovraindebitamento (dedicate a chi non è soggetto a fallimento). Dato che il nostro focus è su un ex titolare di Internet Point, presumibilmente un piccolo imprenditore, focalizzeremo sulle procedure da sovraindebitamento previste per debitori non fallibili. Tuttavia faremo un breve accenno anche a fallimento & co. per completezza di quadro.
Fallimento (Liquidazione Giudiziale) dell’ex imprenditore: se l’ex titolare (persona fisica) era soggetto fallibile e la sua impresa è collassata, un creditore o lui stesso potrebbe richiederne la liquidazione giudiziale. Gli effetti sono: nomina di un curatore, spossessamento del patrimonio (i beni del debitore vengono acquisiti alla massa fallimentare), sospensione delle azioni esecutive individuali (i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo). Il curatore liquiderà tutti i beni e distribuirà il ricavato secondo i privilegi. Il debitore fallito subisce anche delle incapacità personali temporanee (non può ricoprire cariche in società, perde il diritto di amministrare i propri beni, etc., fino alla chiusura). Difendersi dal fallimento può significare due cose: evitarlo (ad esempio trovando un accordo prima che i creditori lo istino) oppure, se inevitabile, gestirlo al meglio per poi uscirne con l’esdebitazione. Da notare che con la riforma, la procedura fallimentare è stata in parte umanizzata: la durata è limitata (di norma chiusura in pochi anni per insufficienza attivo o completata la liquidazione) e soprattutto è previsto il beneficio dell’esdebitazione di diritto decorsi 3 anni dalla chiusura del concorso. Se il debitore persona fisica non ha commesso irregolarità gravi, dopo la chiusura della liquidazione giudiziale può ottenere dal tribunale la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. Questo meccanismo, introdotto gradualmente a partire dal 2012 e ora consolidato, serve a dare fresh start al fallito onesto e sfortunato. Quindi, sebbene subire un fallimento sia estremamente spiacevole per un ex imprenditore (anche a livello di stigma sociale e limitazioni nell’immediato), a medio termine può condurre a una riabilitazione economica completa, grazie all’esdebitazione. Un difetto è che la liquidazione giudiziale riguarda solo i debiti anteriori alla dichiarazione di fallimento; se il debitore ne contrae di nuovi dopo, quelli restano a suo carico (ma almeno i vecchi verrebbero cancellati). Nel contesto del nostro debitore-tipo (internet point), il fallimento personale sarà raro perché di solito tale attività rientra nei parametri di non fallibilità. Se però l’impresa era formalmente una società di capitali poi fallita, l’ex titolare (socio) non fallisce personalmente. In sintesi, il fallimento è più uno strumento dei creditori per espropriare in massa i beni che una difesa del debitore; tuttavia il suo effetto positivo collaterale è l’esdebitazione finale del debitore persona fisica. Ovviamente, se si può raggiungere lo stesso risultato (pagare qualcosa ai creditori e cancellare il resto) con una procedura meno afflittiva, quella è preferibile: ed ecco l’ambito delle procedure di sovraindebitamento.
Procedure di sovraindebitamento (Codice della Crisi, artt. 65-83, 268-283): sono state pensate per debitori non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, start-up innovative, imprenditori agricoli, enti non profit, ecc.). Fino al 2022 erano regolate dalla L. 3/2012; oggi le troviamo nel Codice della Crisi con alcune novità terminologiche e sostanziali. Le procedure disponibili sono principalmente tre, più una speciale forma di esdebitazione:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”);
- Concordato minore (ex “accordo di composizione della crisi”);
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex “liquidazione del patrimonio”);
- Esdebitazione del debitore incapiente (o “esdebitazione senza utilità”).
Vediamole singolarmente dal punto di vista dell’ex titolare debitore, con i relativi requisiti e benefici:
– Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Piano del consumatore): è riservata alla persona fisica consumatore, cioè colui che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. La novità del Codice 2019 è una definizione di consumatore leggermente più ampia rispetto al passato, perché elimina la parola “esclusivamente” – prima era richiesto che tutti i debiti avessero origine estranea all’attività, ora si guarda ai debiti da ristrutturare nel piano, potendo includere anche debiti misti purché la parte imprenditoriale non sia preponderante nella composizione finale. In altre parole, oggi un ex imprenditore non fallibile che abbia perlopiù debiti personali e qualche debito residuo d’impresa (es. qualche cartella fiscale per IVA non pagata) può comunque accedere al piano del consumatore, mentre con la vecchia legge 3/2012 sarebbe stato escluso perché aveva anche debiti d’impresa. Cassazione già nel 2016 aveva inaugurato questo approccio più flessibile, ammettendo il piano per debiti misti se l’indebitamento complessivo era valutato nell’insieme, senza precluderlo per la sola presenza di alcune passività di origine imprenditoriale. Dunque, un ex titolare di Internet Point che, cessata l’attività, oggi fa un lavoro da dipendente e deve ancora pagare sia debiti personali (es. prestiti, carte di credito) sia qualche debito dell’ex attività (fornitori, Fisco), può qualificarsi come “consumatore” ai fini della procedura, in quanto agisce ora per scopi estranei ad attività imprenditoriali e i debiti oggetto del piano possono comprendere anche quelli originati dall’attività cessata. Requisiti ulteriori: non aver già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti (o, se ne ha avuta 2 in totale, niente terza volta); non aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, frode o malafede (la cosiddetta meritevolezza). Il concetto di “meritevolezza” implica che il giudice deve valutare il comportamento del debitore: ad esempio, un soggetto che ha continuato a indebitarsi sconsideratamente sapendo di non poter pagare potrebbe vedersi negare l’omologazione. Tuttavia, la giurisprudenza negli anni è stata piuttosto indulgente verso il debitore sovraindebitato salvo casi eclatanti di frode. Nel Codice attuale, la meritevolezza è sempre richiesta per accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Come funziona concretamente? Il debitore, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di un professionista gestore, predispone un piano di pagamento che tenga conto delle sue effettive possibilità economiche, indicando quali importi potrà pagare a ciascun creditore. Non serve l’accordo dei creditori: il piano del consumatore è l’unica procedura concorsuale unilaterale, che può essere omologata dal tribunale anche con il voto contrario dei creditori, purché il giudice la ritenga fattibile ed equa. Il giudice valuta la sostenibilità del piano e la meritevolezza del debitore; se soddisfatto, omologa il piano, rendendolo vincolante per tutti i creditori. Da quel momento i creditori devono accontentarsi di quanto previsto nel piano (es: il 20% a saldo dei loro crediti, pagato in 4 anni) e non possono agire esecutivamente, perché i debiti vengono ristrutturati ex lege. Il piano può prevedere anche classi di creditori, e può prevedere la falcidia (riduzione) di debiti che di regola sarebbero intoccabili: ad esempio, è espressamente consentito ridurre l’importo dovuto per prestiti su cessione del quinto dello stipendio, oppure mantenere in essere il mutuo ipotecario sulla prima casa (pagando le rate correnti regolarmente) così da non perdere l’immobile. I creditori privilegiati (come il Fisco per i tributi con privilegio, o la banca con ipoteca) possono essere pagati parzialmente solo fino a concorrenza del valore del bene su cui hanno privilegio (criterio del “best interest test”, per cui ricevono almeno quanto otterrebbero dalla vendita forzata di quel bene). Non c’è più invece la moratoria automatica di 1 anno per iniziare a pagarli, che era prevista in passato, anche se la Cassazione aveva già detto che tale moratoria poteva essere estesa col consenso del creditore. Vantaggi per l’ex imprenditore: il piano del consumatore permette di includere anche debiti erariali e contributivi (previo parere obbligatorio ma non vincolante dell’ente se si propone di pagarli meno del 100%). Inoltre, blocca le procedure esecutive in corso: già con la presentazione del ricorso, il giudice può sospendere le esecuzioni e le iscrizioni ipotecarie in atto (art. 70 CCII). Una volta omologato, i pignoramenti pendenti vengono dichiarati improcedibili. Al termine del piano, se il debitore ha eseguito tutto il fattibile, ottiene l’esdebitazione: è liberato dai debiti residui. Un esempio concreto: Tizio, ex titolare, ha €100.000 di debiti; con il piano offre ai creditori €30.000 da pagare in 5 anni (ottenuti dai suoi risparmi e da un piccolo stipendio), quindi circa il 30%. Il tribunale omologa. Tizio paga regolarmente i €30.000 secondo le scadenze. Al termine, i restanti €70.000 di debiti vengono cancellati. Tizio è libero dai creditori (salvo quelli eventualmente esclusi per legge, come alimenti, che in ogni caso andrebbero pagati integralmente). Limiti: se il debitore non rispetta il piano, si va incontro alla revoca dell’omologazione e alla ripresa delle azioni esecutive. Inoltre, non tutti possono accedere a questa procedura – solo i consumatori meritevoli come detto. Dunque, l’ex imprenditore che ancora ha partita IVA attiva per un’altra attività non può usare il piano (dovrebbe chiuderla e diventare a tutti gli effetti “consumatore”). In caso di omologazione con dolo o colpa del debitore (ad es. omissione di beni nell’inventario), può essere revocata d’ufficio.
– Concordato minore: è la procedura destinata agli imprenditori minori e in generale ai debitori diversi dal consumatore (piccoli imprenditori commerciali, professionisti, ditte individuali, società non fallibili, soci illimitatamente responsabili per debiti residuali, ecc.). Sostituisce il vecchio “accordo di composizione”. A differenza del piano del consumatore, qui i creditori votano: è più simile a un concordato preventivo in miniatura. Il debitore propone un piano di concordato che può prevedere sia la continuazione dell’attività (concordato in continuità) sia la liquidazione di beni (concordato liquidatorio minore). La proposta deve assicurare un soddisfacimento dei crediti in misura non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione controllata (principio di convenienza). Non c’è una percentuale minima di legge (nel concordato preventivo delle grandi imprese c’è il 20% minimo ai chirografari se liquidatorio; per il concordato minore questa soglia non è espressamente prevista, anche se la giurisprudenza potrebbe mutuare criteri analoghi di fattibilità). I requisiti di ammissibilità sono: trovarsi in stato di sovraindebitamento (cioè crisi o insolvenza conclamata) e non essere soggetto a liquidazione giudiziale. Quindi, per definizione, rivolto ai non fallibili, ossia coloro che mancano i requisiti dimensionali per il fallimento. Ad esempio, una S.n.c. sotto soglia, un imprenditore agricolo (che per legge non fallisce), un professionista con studio in crisi. Anche i soci illimitatamente responsabili falliti con la società, terminata quella procedura, potrebbero usare il concordato minore per sistemare eventuali altri debiti non toccati dalla precedente procedura (scenario raro ma teorico). Una peculiarità: il socio illimitatamente responsabile può accedere a un concordato minore anche per debiti che derivano da garanzie prestate (fideiussore non fallibile può usare questa procedura). Funzionamento: il debitore deposita la proposta con l’ausilio dell’OCC; il tribunale, verificati i documenti, nomina un gestore della crisi (analogo al commissario). Si fissano le classi di creditori e la percentuale offerta. I creditori votano la proposta: serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (50% +1), con adattamenti se c’è un unico creditore forte (in tal caso serve anche testa, non solo volume). Nel nuovo codice è stato abbassato il quorum (da 60% previsto dalla vecchia legge 3/2012 al 50% attuale), facilitando l’approvazione. Se i creditori approvano e il tribunale omologa, il concordato minore diventa vincolante per tutti, compresi i dissenzienti. Se i creditori non approvano, il giudice comunque può omologare ugualmente (cram-down) se ritiene la proposta vantaggiosa e i creditori dissenzienti verrebbero soddisfatti in misura non inferiore alla liquidazione alternativa (simile al meccanismo del concordato preventivo in continuità). Anche qui, come nel piano, i creditori privilegiati non possono essere pagati meno di quanto ricaverebbero liquidando le garanzie; i creditori con pegno/ipoteca, se non soddisfatti integralmente, devono esprimere consenso (a meno che non vi sia il cram-down giudiziale con perizia che attesta il ricavabile). Utilità per l’ex imprenditore: il concordato minore gli consente di risolvere in modo organizzato la crisi, magari mantenendo in vita la sua impresa o attività se vuole proseguire (è ammessa la continuità aziendale in concordato minore). Può includere una vasta gamma di debiti (anche qui, tributari, contributivi con eventuale necessità di transazione fiscale per le imposte da falcidiare). Può anche prevedere l’apporto di risorse di terzi. Ad esempio, l’ex titolare coinvolge un familiare che mette una somma per soddisfare parzialmente i creditori e salvare l’immobile di famiglia che era ipotecato: nel concordato minore ciò è fattibile, presentando un piano attestato da OCC che mostri come i creditori stiano meglio che a recuperare individualmente. Se il concordato ha esito positivo (ossia l’imprenditore esegue tutte le obbligazioni assunte nel piano), egli ottiene la esdebitazione per la parte residua dei debiti chirografari. In caso di inadempimento, c’è la risoluzione del concordato e possibili strascichi (i creditori riacquistano pieni diritti, ed eventualmente possono chiedere la conversione in liquidazione controllata). Da notare: durante il concordato minore, il debitore conserva l’amministrazione dei beni (salvo nomina di un ausiliario se necessario), sotto la supervisione del gestore nominato. È quindi meno invasivo di un fallimento. Questa procedura è assai vantaggiosa se il debitore ha molti creditori e intende offrire un pagamento parziale ma con l’accordo della maggioranza: evita singole trattative con ciascuno (basta convincerne >50%) e soprattutto congela le azioni esecutive appena ammesso il procedimento. Per contro, ha il difetto di richiedere il consenso dei creditori (almeno in parte): se vi sono creditori “ostili” che costituiscono più del 50% dei crediti, il concordato non passerà (salvo tentare il cram-down se i dissenzienti hanno trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione).
– Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’equivalente del fallimento per i non fallibili, o del vecchio istituto della liquidazione del patrimonio ex L.3/2012. Il debitore rinuncia alla ristrutturazione e mette a disposizione tutti i suoi beni (salvo quelli impignorabili) per soddisfare i creditori. Viene nominato un liquidatore dal tribunale, che avrà il compito di vendere i beni e distribuire il ricavato. Questa procedura può essere richiesta sia dal debitore stesso, sia – novità del Codice – da un creditore o su istanza del pubblico ministero, se il debitore è in stato di insolvenza (era previsto dall’art. 14-quinquies L.3/2012: i creditori possono provocarla, ma raramente accadeva). Perché un debitore dovrebbe attivarla volontariamente? Perché la liquidazione controllata ha un enorme vantaggio finale: consente comunque l’esdebitazione, anche se i creditori non hanno ricevuto nulla o pochissimo, purché il debitore sia meritevole e non abbia nascosto beni. In particolare, al termine della liquidazione, dopo che il liquidatore deposita il piano di riparto finale, il debitore persona fisica può chiedere al tribunale di essere liberato dai debiti residui (questo era l’art. 14-terdecies L.3/2012, ora art. 282 CCII). In passato la legge richiedeva che nella liquidazione del patrimonio i creditori chirografari avessero ottenuto almeno il 10% per concedere l’esdebitazione; tale limite è stato dichiarato incostituzionale nel 2020, consentendo di esdebitare anche chi non abbia pagato nulla per oggettiva incapienza. Dunque oggi la regola è: anche se il debitore non soddisfa affatto i creditori (zero riparto), può comunque essere esdebitato, a condizione che non abbia colpe gravi o frodi e abbia cooperato sinceramente. Questo è in linea con l’orientamento europeo di dare una seconda chance al debitore onesto ma sfortunato. La liquidazione controllata dura tipicamente 4 anni: infatti, la legge prevede che nella massa attiva confluiscano non solo i beni esistenti all’apertura, ma anche gli utili futuri del debitore per i 4 anni successivi (eccetto ciò che serve al mantenimento suo e della famiglia). Ciò significa che, ad esempio, se l’ex titolare trova un lavoro durante la liquidazione, una parte dello stipendio (quella pignorabile) fino a 4 anni andrà al liquidatore per i creditori. Dopo 4 anni, gli eventuali crediti sopravvenuti non possono più essere toccati (il nuovo Codice ha chiarito che 3 anni è il termine per incamerare utilità sopravvenute, con esdebitazione di diritto allo spirare di tale periodo; alcune pronunce come Corte Cost. n.6/2024 hanno confermato che tre anni dall’apertura rappresenta il limite massimo di soggezione del debitore, trascorso il quale i nuovi redditi non possono essere aggrediti in procedura). Di solito però si considera 4 anni come periodo standard (che era nella vecchia legge). In pratica, la liquidazione controllata è molto simile a un fallimento: il debitore perde l’amministrazione dei beni, subisce i pignoramenti secondo regole concorsuali, e attende la liberazione finale. È uno strumento difensivo estremo: si usa quando il debitore non ha alcuna risorsa per proporre un piano e magari nemmeno un reddito per pagare parzialmente, così che l’unica via sia dichiarare la resa, consegnare tutto il consegnabile e ottenere la cancellazione dei debiti. Il suo vantaggio rispetto al subire decine di esecuzioni individuali è evidente: è ordinata, relativamente rapida e definitiva. Dopo, i creditori non potranno più nulla. Durante, c’è il blocco delle azioni esecutive individuali. Quindi anche il debitore nullatenente può attivarla per mettere una fine all’incubo dei creditori che lo inseguono vita natural durante. In passato, qualcuno la evitava pensando “tanto non ho niente, i creditori non prendono nulla comunque”. Il problema è che, se non formalizzi nulla, i creditori possono restare a vita pronti a colpire se appare qualcosa (un’eredità, una vincita, un miglioramento reddituale). Con la liquidazione controllata seguita da esdebitazione, quei debiti vengono proprio spazzati via. Certo, il rovescio della medaglia è che per il periodo di durata il debitore vive con il minimo indispensabile perché tutto il superfluo va alla procedura. Anche qui, meritevolezza: se risultano atti in frode (es. ha nascosto soldi all’estero, o ha regalato la casa al fratello prima di avviare la procedura), il beneficio può essere negato o revocato.
– Esdebitazione del debitore incapiente (“senza utilità”): è una novità assoluta introdotta dal Codice della Crisi. Si rivolge a quei debitori persone fisiche che non hanno alcun patrimonio né capacità reddituale da offrire ai creditori – i cosiddetti nullatenenti assoluti – ma che allo stesso tempo sono meritevoli (cioè non hanno colpe nel loro dissesto). Prima, un tale debitore non aveva possibilità di esdebitarsi, perché anche la liquidazione del patrimonio richiede che un patrimonio (pur minimo) vi sia. Ora, invece, può chiedere direttamente al tribunale l’esdebitazione immediata senza pagare nulla, ovvero la cancellazione di tutti i suoi debiti pur in assenza di qualsiasi utilità per i creditori. È una misura potentissima, ma con dei paletti precisi: può essere concessa una sola volta nella vita; il debitore non deve aver dolo o colpa grave; e soprattutto deve davvero non possedere nulla di liquidabile. Se per caso emergesse che qualcosa poteva pagare, la procedura sarebbe rigettata o revocata. Inoltre, c’è una condizione postuma: nei 4 anni successivi, se il debitore incapiente esdebitato ottiene “utilità rilevanti” (un’eredità, una vincita, un aumento di reddito sostanzioso), ha l’obbligo di pagare i creditori fino almeno al 10% dei loro crediti. Deve quindi informare l’OCC annualmente sulla sua situazione economica per 4 anni. Se non lo fa e viene scoperto, l’esdebitazione può essere revocata. Questa norma vuole evitare che furbi senza patrimonio oggi lo diventino domani e beneficino indebitamente. In pratica, l’esdebitazione dell’incapiente è un atto di clemenza verso chi è schiacciato dai debiti senza via d’uscita: ad esempio, chi ha garantito un debito enorme di un’azienda fallita e si ritrova a vita con 0 reddito e 0 beni; oppure chi ha debiti dovuti a eventi sfortunati (salute, usura, ecc.) e nessuna capacità di produrre reddito sufficiente. La ratio è anche di politica sociale: liberare dal fardello dei debiti inesigibili quelle persone che altrimenti sarebbero tagliate fuori per sempre dall’economia legale (perché tanto tutto ciò che guadagnerebbero verrebbe aggredito dai creditori pregressi). Va evidenziato che l’esdebitazione senza utilità non cancella i debiti verso i coobbligati, fideiussori e obbligati in solido (restano responsabili gli eventuali altri condebitori) e non tocca i debiti alimentari, da risarcimento danni da fatto illecito e sanzioni penali/amministrative non pecuniarie (che per legge restano dovuti). Quindi ha comunque i suoi limiti. Ma è comunque uno strumento rivoluzionario nel panorama italiano: una sorta di “fresh start gratuito”. Il messaggio al debitore veramente incolpevole è: presentati al giudice, mostra che non hai nulla e che non hai fraudolentemente alienato nulla, e potrai ripartire da zero. Nel contesto dell’ex titolare di Internet Point, possiamo ipotizzare casi del genere se, ad esempio, la persona ha perso anche la casa (era magari in affitto), non ha auto, vive di sussidi o poco più, e i suoi debiti sono frutto del fallimento dell’attività. In tal caso potrebbe valutare l’esdebitazione incapiente. Al momento (luglio 2025) questa procedura è piuttosto nuova e si attendono statistiche su quante ne vengano accolte, ma rappresenta comunque una extrema ratio favorevole al debitore.
Riassumendo le caratteristiche salienti delle procedure concorsuali minori in una tabella comparativa:
È evidente che per il debitore queste procedure rappresentano spesso l’unica via di uscita definitiva. Infatti, come visto nelle sezioni precedenti, le azioni difensive individuali (opposizioni, trattative) possono tamponare singole situazioni, ma se il volume complessivo dei debiti supera di molto la capacità economica, prima o poi occorre un intervento “sistemico”. L’ex titolare di Internet Point con debiti ingenti farebbe bene a rivolgersi a un professionista o a un OCC per valutare la praticabilità di una di queste soluzioni concorsuali. Dal punto di vista del debitore, non c’è dubbio che ottenere l’esdebitazione – sia tramite concordato andato a buon fine, sia tramite liquidazione – è l’obiettivo finale: significa poter ricominciare senza l’ombra perenne dei vecchi crediti. Le statistiche pre-2022 indicavano che molte procedure di sovraindebitamento venivano omologate con successo, ma erano ancora usate in numero esiguo rispetto al potenziale bacino (c’era scarsa informazione e una certa ritrosia culturale). Con la riforma del 2022, ci si attende un aumento delle domande grazie anche a semplificazioni e all’istituto dell’esdebitazione incapiente.
Va chiarito che, accedere a una procedura di insolvenza, non è una scelta da prendere alla leggera: comporta costi (le spese dell’OCC, contributi unificati, eventuali acconti), obblighi stringenti di trasparenza, e comporta iscrizione in registri (il debitore in liquidazione controllata per esempio viene annotato nel Registro dei protesti e procedure concorsuali). Tuttavia, rispetto al rimanere per sempre esposto a decreti ingiuntivi e pignoramenti, spesso è il minore dei mali. Un avvocato specializzato saprà consigliare se i presupposti ci sono e quale procedura sia più adatta. Ad esempio: se il soggetto ha un lavoro e un reddito certo che consente di pagare magari il 20-30%, meglio tentare un piano del consumatore; se ha anche un piccolo immobile ipotecato che vuole preservare, forse un concordato minore in continuità; se non ha nulla, tanto vale l’esdebitazione incapiente.
Prima di passare alle domande frequenti, un ultimo aspetto: tempi e sviluppi futuri. Le procedure concorsuali minori non sono istantanee: un piano o concordato dura di solito diversi anni (dai 3 ai 5 anni, a seconda delle rateizzazioni previste). Una liquidazione controllata tipicamente dura almeno 3-4 anni (per il discorso degli utili futuri). Durante questi anni, il debitore vive con mezzi limitati, ma ha la prospettiva concreta di liberarsi dai debiti al termine. È un sacrificio temporalmente definito, preferibile a un’incertezza magari decennale di inseguimenti dei creditori. La legge cerca di contenere la durata nel principio di ragionevole durata (ad es. il concordato minore deve chiudersi entro 5-6 anni al massimo). Anche l’esdebitazione nel fallimento ora scatta dopo 3 anni dalla chiusura, il che segna un limite temporale alla “pena” del fallito. In prospettiva, l’ordinamento italiano si sta uniformando alla direttiva UE 2019/1023 che promuove la seconda opportunità: quindi è possibile che queste procedure diventino sempre più accessibili e snelle, per favorire la ripresa economica di chi è finito in difficoltà.
Domande frequenti (FAQ) – Difendersi dai debiti dopo la chiusura dell’attività
D: Ho chiuso il mio Internet Point pieno di debiti. La cessazione della partita IVA cancella i debiti?
R: No. La chiusura dell’attività non estingue automaticamente alcun debito. I debiti della ditta individuale rimangono a carico dell’ex titolare, che continua a risponderne con tutto il suo patrimonio. Anche la cancellazione di una società dal Registro Imprese non libera i soci dalle obbligazioni residue: i soci di società di persone restano responsabili illimitatamente, quelli di società di capitali possono essere chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in liquidazione. In sintesi, cessare l’attività è solo un atto amministrativo; i rapporti obbligatori con i creditori restano vigenti sino a pagamento, prescrizione o altra causa estintiva.
D: Non sto ricevendo solleciti da un po’ di tempo. Posso sperare che il mio debito sia andato in prescrizione?
R: Forse, ma bisogna essere molto cauti. La prescrizione decorre diversamente a seconda del tipo di debito (in generale 10 anni per debiti ordinari, 5 anni per molti crediti periodici). Tuttavia basta un atto qualsiasi del creditore (una raccomandata di messa in mora, una notifica di atto giudiziario, un sollecito di pagamento) ad interrompere la prescrizione, facendo ripartire il termine da zero. Ad esempio, i debiti fiscali si prescrivono in 10 anni, ma ogni cartella esattoriale o intimazione notificata interrompe il termine. Ciò significa che un credito può restare “vivo” per decenni se il creditore si attiva periodicamente. Quindi, il fatto di non essere stati contattati, poniamo, da 3-4 anni, non garantisce che il debito sia prescritto. Per averne certezza bisognerebbe conoscere l’ultimo atto interruttivo e calcolare se da allora è trascorso il periodo previsto senza altri atti. Inoltre, l’eventuale prescrizione va eccepita dal debitore: se non la sollevi in giudizio, il giudice non la applica d’ufficio (per i diritti disponibili). Dunque, attenzione: prima di “dormire tranquilli” occorre verificare con documenti la situazione. È consigliabile farsi assistere da un legale per controllare la cronologia delle notifiche. Se effettivamente il termine è passato, si potrà eccepire la prescrizione e ottenere l’annullamento del debito. Viceversa, se ci sono stati atti, la prescrizione è interrotta.
D: Possono pignorarmi la casa di abitazione per i miei debiti?
R: Dipende dal tipo di creditore e dalla situazione. Se il creditore è un privato (banca, fornitore) e hai un immobile di proprietà, purtroppo sì, può avviare il pignoramento immobiliare e metterlo all’asta, indipendentemente dal fatto che sia la tua prima casa. Non esiste nel codice civile una impignorabilità generale della prima casa verso i creditori privati. L’unica eccezione è che se l’immobile è in comunione dei beni col coniuge non debitore, alcune formalità sono più complesse, ma non impediscono l’azione. Quindi una banca con ipoteca sul tuo immobile di famiglia potrà certamente espropriarlo se non paghi il mutuo. Se il creditore è l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione), esiste una tutela per la prima casa introdotta dal 2013: l’AER non può espropriare l’immobile che è unico immobile di proprietà, adibito ad uso abitativo e residenza anagrafica del debitore, purché non di lusso. In pratica, Equitalia/AER non può pignorare la tua prima casa se possiedi solo quella e ci abiti (e non è accatastata A/8 o A/9). Può però iscrivere ipoteca su di essa (al raggiungimento di debiti oltre €20.000) e l’ipoteca resta un peso: se un domani vendi la casa, il debito andrà pagato in sede di vendita. Quindi, la casa rimane “bloccata”. Inoltre, l’esproprio esattoriale è vietato solo per l’unica casa: se possiedi due immobili, anche se uno è la tua abitazione, l’Agente potrà pignorarlo (di solito preferirà pignorare quello non abitato da te, ma non è escluso a priori). E attenzione: se la casa non rientra nei requisiti (es. seconda casa, oppure di lusso, oppure non è residenza), l’AER può procedere, previa iscrizione di ipoteca e dopo 30 giorni dalla notifica dell’intimazione, per debiti sopra €120.000. In sintesi: la legge protegge la prima casa solo contro il Fisco e con condizioni; contro creditori normali non c’è scudo legale. L’unica protezione è il fondo patrimoniale, ma come spiegato è molto aleatoria se il debito non è per scopi familiari. Dunque, se hai la casa come bene aggredibile, conviene trovare soluzioni (accordi o procedure) prima che si arrivi all’asta. Se è ipotecata e non riesci a pagare il mutuo, considera eventualmente di venderla tu stesso per saldare il debito, ottenendo magari un ricavato maggiore di un’asta (e risolvendo la posizione). Oppure valuta un piano del consumatore che mantenga il mutuo in essere ed eviti la decadenza.
D: Possono pignorare il mio stipendio o la mia pensione? Quanto mi possono togliere al massimo?
R: Sì, lo stipendio (così come altri redditi da lavoro) è pignorabile dai creditori, ma con dei limiti di legge. La regola generale, per creditori ordinari, è che al massimo il 20% (un quinto) dello stipendio netto mensile può essere pignorato. Quindi, se guadagni €1.500 al mese netti, al massimo €300 possono andare ai creditori ogni mese. Se hai più pignoramenti da creditori differenti, il codice prevede che possano coesistere pignoramenti di natura diversa fino al 50% dello stipendio totale. In particolare, le categorie sono: pignoramenti per crediti alimentari (assegno di mantenimento), per tributi, e per altri crediti. Possono esserci un pignoramento per ciascuna categoria in contemporanea, e il totale non può superare la metà dello stipendio. Ad esempio, potresti subire un quinto per un finanziamento non pagato e un quinto per degli alimenti arretrati, totalizzando 2/5 (40%) di trattenute. Un terzo pignoramento dovrebbe attendere (salvo sia anch’esso alimentare, ma due alimentari insieme di solito non capitano). Se il creditore è l’Agenzia Entrate Riscossione, i limiti sono un po’ diversi e variano in base all’importo dello stipendio: – 1/10 dello stipendio se la retribuzione netta ≤ €2.500; – 1/7 (circa 14%) se lo stipendio è tra €2.501 e €5.000; – 1/5 se oltre €5.000. Quindi il Fisco trattiene meno sui redditi più bassi (es: su €1.800, trattiene 180 € al mese). Per le pensioni, innanzitutto c’è un importo impignorabile pari a circa 1,5 volte l’assegno sociale (nel 2025, l’assegno sociale è attorno a €503, quindi 1,5x è ~€755): questa cifra deve rimanere libera. La parte eccedente è pignorabile con le stesse percentuali di cui sopra (1/5 per creditori ordinari, frazioni per AER a scaglioni). Esempio: pensione netta €1.000; minimo vitale €755 non toccabile; base pignorabile €245; un quinto di 245, cioè €49 mensili al max per cred. ordinari (per AER, se 1000 < 2500 → 1/10 di 245, circa €24). C’è poi una particolarità: stipendio sul conto corrente. Se il creditore pignora direttamente il conto corrente dove il datore ha già accreditato lo stipendio, la legge tutela l’ultimo accredito: all’atto del pignoramento, le somme già versate sul conto sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (€1.600). Ad esempio, se sul conto hai €2.000 comprensivi dello stipendio appena arrivato, il pignoramento può bloccare solo la parte oltre €1.600, cioè €400, lasciandoti i 1.600 (che coprono grosso modo tre mesi di minimo vitale). Gli accrediti successivi sul conto invece verranno bloccati nella misura del 20% ciascuno (per i creditori ordinari). Infatti, il meccanismo è: al momento della notifica alla banca, si guarda il saldo e si applica la regola del triplo minimo vitale; poi man mano che arrivano altri stipendi, questi affluiscono al conto ma la banca trattiene la quota pignorata e la gira all’ufficiale giudiziario. In pratica è come se diventasse un pignoramento presso terzi continuativo. Conclusione: stipendio e pensione sono aggredibili ma non integralmente. I limiti fissati servono a garantire un minimo per vivere al debitore (e famiglia). Va detto che questi limiti vanno rispettati cumulativamente: se per errore in busta paga trattengono più di un quinto, il pignoramento è nullo e il debitore deve segnalarlo subito al giudice. Nella prassi, di solito un quinto è la soglia massima salvo eccezioni dei concorsi di cause diverse. Attenzione che l’assegno di mantenimento non rientra in questi limiti: è considerato credito alimentare e può essere pignorato anche oltre il quinto, però come detto se concorre con altri pignoramenti il totale non supera metà stipendio.
D: Ho dei debiti fiscali con Agenzia Entrate Riscossione. Posso ottenere una dilazione o uno sconto?
R: Sì. La normativa permette di rateizzare le cartelle esattoriali abbastanza facilmente: per debiti fino a €120.000 puoi avere un piano fino a 72 rate (6 anni) con semplice domanda online, senza dover dare prova di difficoltà. Per importi superiori occorre documentare lo stato di difficoltà economica e si può arrivare fino a 120 rate (10 anni). Durante la rateazione, l’Agente della Riscossione sospende le azioni esecutive e non iscrive fermi o ipoteche nuove. Bisogna però pagare puntualmente le rate (se salti più di 5 rate, decadi). Oltre alle rateazioni ordinarie, negli ultimi anni lo Stato ha introdotto diverse definizioni agevolate (“rottamazioni”): l’ultima, detta rottamazione-quater, riguarda i carichi affidati dal 2000 al giugno 2022 e consente di pagarli senza sanzioni né interessi di mora, in un massimo di 18 rate in 5 anni. La scadenza per aderire era al 30 giugno 2023, ma se tu hai aderito e poi non sei riuscito a pagare qualche rata nel 2024, recentemente ti hanno dato la possibilità di fare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 pagando entro certe date. Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 ha disposto l’annullamento automatico dei debiti minori: le cartelle fino a €1.000 relative al periodo 2000-2015 sono state cancellate d’ufficio (salvo alcune eccezioni come debiti UE, sanzioni penali) – questo significa che potresti vederti stralciati completamente quei piccoli importi senza fare nulla, dovresti aver ricevuto comunicazione. Per il 2024-2025 si parla di una possibile rottamazione-quinquies per i nuovi carichi fino al 2023, ma al momento (luglio 2025) non c’è una norma definitiva: è in discussione. In sintesi: con il Fisco conviene sempre informarsi sulle agevolazioni vigenti. A volte, puoi chiudere pagando solo il capitale (ad esempio multe, iva, irpef) senza aggiungere il 45-50% di sanzioni/interessi. Se l’importo è grosso e non ce la fai neanche con la rottamazione, l’ultima ratio è includere il debito fiscale in una procedura concorsuale (piano, concordato minore). Lì potrai proporre di pagare anche solo una parte del tributo: servirà l’adesione dell’ente per la parte falcidiata (la cosiddetta “transazione fiscale”). Tipicamente, l’Agenzia delle Entrate aderisce se vede che la proposta è ragionevole (es. pagare il 30% subito è meglio di niente). L’Agente Riscossione invece conta come creditore chirografario per aggio e interessi, e come privilegiato per il capitale; anche lui può votare. C’è da dire che la normativa recente ha reso obbligatoria la proposta di trattamento dei crediti fiscali/previdenziali nei concordati minori: se non offri almeno quanto prendevano in liquidazione, la procedura non è ammissibile. Quindi va fatta una perizia sul valore dei beni. In ogni caso, le rateazioni e definizioni amministrative sono un primo scudo: se hai debiti con AER, presentare domanda di rateazione per tempo evita mosse aggressive immediate e ti permette di respirare.
D: Sono pieno di debiti e non possiedo nulla di valore. Vale la pena fare una procedura di sovraindebitamento o mi conviene lasciare che i creditori si arrangino?
R: Dipende dall’obiettivo. Se non possiedi davvero nulla né prevedi entrate, potresti essere tentato dal non fare nulla: in effetti, i creditori non possono prendere sangue dalle pietre, quindi oggi non ti ricavano niente. Tuttavia, le posizioni debitorie resterebbero aperte a tempo indeterminato: come detto, i creditori possono rinnovare gli atti e attendere tempi migliori. Se tra qualche anno migliori la tua condizione (trovi lavoro, erediti qualcosa), ti troverai di nuovo inseguito e pignorato, perché i debiti non risulteranno estinti. Inoltre vivere “invisibile” non è semplice: avresti difficoltà ad intestare beni, ad avere un conto corrente (ti potrebbero pignorare i saldi), ecc. Invece, sfruttando gli strumenti legali, puoi cristallizzare la situazione e risolverla definitivamente. Due strade possibili: la liquidazione controllata (ti dichiari insolvente e fai chiudere formalmente tutte le partite) oppure, se davvero sei nullatenente e meritevole, tentare la esdebitazione del debitore incapiente introdotta ora. Quest’ultima ti darebbe l’esdebitazione immediata senza pagare nulla, impegnandoti solo a segnalare eventuali miglioramenti reddituali futuri per 4 anni. È una opzione estremamente vantaggiosa se rientri nei requisiti (nessun bene, nessun reddito pignorabile, debiti insostenibili, buona fede comprovata). In mancanza dei requisiti per l’incapiente, la liquidazione controllata è comunque utile: durerà qualche anno durante i quali magari cederai il quinto di eventuali stipendi, ma poi uscirai pulito dai debiti con decreto di esdebitazione. Pensala così: senza procedura, sei tecnicamente libero oggi (perché non hai nulla da farti prendere), ma sei vincolato a restare nullatenente per paura dei creditori; con la procedura, sconti qualche anno di sacrificio controllato e poi sei libero di rifarti una vita anche economicamente, perché i vecchi debiti spariscono. Quindi, sì, vale la pena muoversi per una procedura concorsuale anche se non hai beni. Naturalmente, valuta con un professionista se le condizioni ci sono: ad esempio, per l’esdebitazione incapiente devi convincere il giudice di essere davvero incapiente e onesto (se hai dissipato volontariamente dei patrimoni, non te la darà). Se hai un’occupazione seppur minima, magari conviene proporre un piccolo piano del consumatore (pagando che so il 5-10%) per chiuderla in bellezza con i creditori, specie se sono pochi. Ogni caso fa storia a sé, ma l’importante è non rimanere in balìa della situazione per sempre. Inoltre tieni presente che attivare una procedura concorsuale sospende immediatamente le azioni esecutive in corso: se hai già pignoramenti allo stipendio o cause in atto, si fermano. Quindi c’è un beneficio immediato anche durante il procedimento.
D: Ho dei debiti bancari e altri debiti verso privati: posso includerli tutti in un’unica procedura di sovraindebitamento?
R: Sì. Le procedure di sovraindebitamento sono pensate proprio per gestire la pluralità di debiti. Nel piano del consumatore o concordato minore devi indicare tutti i creditori che hai, di qualsiasi natura (salvo alcuni per legge esclusi, es. debiti per mantenimento futuri). Non è possibile – né conveniente – escludere alcuni debiti dal perimetro. Dovrai quindi “mettere nel calderone” sia la banca, sia i fornitori, sia il Fisco, ecc. Ciascuno riceverà il trattamento previsto (in percentuale o con garanzie). Ad esempio, nel piano potresti proporre di pagare il 100% ai creditori privilegiati (es. la banca ipotecaria) e il 20% ai chirografari (fornitori, finanziarie senza garanzie) in 4 anni. Oppure, se fai liquidazione, tutti i creditori concorreranno sul ricavato dei tuoi beni. L’idea è di chiudere tutte le pendenze in un colpo solo. Fai attenzione però: non tutti i debiti sono cancellabili nemmeno con la procedura. I debiti per sanzioni penali, ad esempio, restano (ma quelli in genere sono multe o ammende pecuniarie, poco rilevanti di solito, e se sono cartelle sanzioni possono essere falcidiate nel concordato in quanto chirografarie). I debiti per assegni di mantenimento a coniuge/figli non possono essere ridotti né esdebitati – rientrano tra i crediti “estranei” che vanno pagati integralmente e, se non li paghi, restano dovuti anche dopo. Quindi se hai arretrati di mantenimento, la procedura non te li abbatte per legge. Dovrai prevederli per intero nel piano. Idem eventuali debiti da risarcimento per illecito causato da ubriachezza o colpa grave, per dire, che la legge esclude dall’esdebitazione (ipotesi rare). A parte queste eccezioni, tutto confluisce. Così, una volta terminato il piano o la liquidazione, ti trovi senza pendenze. Non sottovalutare poi il vantaggio psicologico: non riceverai più telefonate dai recupero crediti di qua e di là, perché la procedura pone un argine e canalizza tutte le pretese. Uno deve interfacciarsi col tribunale e l’OCC, non più col debitore direttamente.
D: Ho garantito con fideiussione un debito della mia ex società che ora non posso pagare. Ci sono difese particolari?
R: La fideiussione ti rende obbligato in solido col debitore principale verso il creditore: quindi, a meno che la fideiussione sia affetta da vizi formali o sostanziali, sarai costretto a pagare come se il debito fosse tuo. Tuttavia, esistono alcuni spiragli: negli anni scorsi la giurisprudenza (Banca d’Italia e Cassazione) ha ritenuto nulle per violazione antitrust certe clausole “standard” delle fideiussioni omnibus predisposte dall’ABI (clausole di reviviscenza, rinuncia eccezioni, ecc.). Se la tua fideiussione le conteneva, un giudice potrebbe dichiarare nulla l’intera fideiussione (o almeno quelle clausole) e liberarti. È materia tecnica: dovresti far esaminare il testo a un avvocato, invocando la nullità a monte per intesa restrittiva della concorrenza. Alcune corti hanno accolto queste eccezioni in favore dei fideiussori. Se però la fideiussione è valida, rimane quanto detto: puoi dilazionare, trattare o includere in una procedura. In un piano del consumatore, un fideiussore (se persona fisica non fallibile) può includere il debito derivante dalla garanzia. Anche la legge nuova specifica che i fideiussori di imprenditori/professionisti rientrano tra i soggetti che possono accedere al concordato minore. Quindi potresti presentare un concordato minore proponendo di pagare, ad esempio, una percentuale del debito garantito. Se il debitore principale (la società) è ancora attivo, di solito la banca escute prima la società; ma se quella è insolvente o fallita, viene direttamente da te. Dal punto di vista difensivo individuale, la fideiussione una volta escussa produce un decreto ingiuntivo nei tuoi confronti abbastanza rapido (la banca esibirà il contratto di fideiussione e l’insoluto). Potresti chiedere un “beneficio di escussione” se previsto (ma di solito nelle fideiussioni omnibus lo si è rinunciato, e comunque si applica raramente perché la banca può dimostrare di aver tentato invano sulla società). In definitiva, la difesa reale è negoziare un saldo e stralcio con la banca, oppure rifinanziare (magari un nuovo mutuo per consolidare se hai un immobile su cui accendere ipoteca, sebbene indebitarsi ancora non sia l’ideale) o ricorrere al sovraindebitamento. La nullità da antitrust è un colpo di fortuna se applicabile. Vale la pena farlo valutare.
D: Mi hanno pignorato il conto in banca: il giorno dell’accredito dello stipendio il conto è stato bloccato a zero. È lecito?
R: No, se effettivamente ti hanno azzerato l’intero stipendio appena accreditato, l’operazione non è conforme alla legge. Come detto, quando si pignora un conto su cui affluisce lo stipendio, la banca deve lasciare libero un importo pari al triplo dell’assegno sociale, e solo il resto può vincolarlo. E per gli accrediti futuri va applicato il quinto. Se davvero il conto era a zero e appena lo stipendio (supponiamo meno di €1.000) è arrivato è stato bloccato integralmente, l’Agente della Riscossione (se era lui) o il creditore hanno esagerato. Puoi fare istanza al giudice dell’esecuzione per svincolare la somma eccedente i limiti. Nel tuo caso, se avevi meno di ~€1.600 sul conto al momento del pignoramento, nulla doveva essere prelevato (perché tutto rientra nel triplo assegno sociale). È probabile che ci sia stato un errore procedurale o interpretativo. Consiglio: rivolgiti subito a un avvocato per fare un ricorso in sede di esecuzione, segnalando che il pignoramento eccede i limiti di impignorabilità (argomenta con art. 545 c.p.c. e normativa vigente). In genere, l’errore può essere sanato in corso di causa e la banca libererà i fondi dovuti. In futuro, potresti anche chiedere al datore di lavoro di accreditare lo stipendio su un altro conto (ad esempio intestato a un familiare) per evitare che venga agganciato, ma questa è una soluzione temporanea e talvolta sconsigliabile (ci sono stati casi in cui i giudici hanno considerato ciò come atto in frode se fatto dopo il pignoramento). Meglio risolvere la questione a monte tramite le procedure concorsuali di cui sopra, così sospendi i pignoramenti e risolvi alla radice.
D: Se attivo una procedura di sovraindebitamento, i miei fornitori/creditori verranno a saperlo? Ho paura per la reputazione.
R: In una procedura di composizione della crisi, i creditori devono essere notificati e coinvolti (soprattutto in concordato minore); quindi sì, i tuoi creditori ne verranno a conoscenza formalmente. Non solo: l’elenco dei procedimenti di sovraindebitamento è pubblico in quanto i decreti di apertura e omologazione vengono iscritti nel registro delle procedure concorsuali tenuto presso i tribunali, consultabile. Tuttavia, considera che probabilmente lo sanno già che sei in difficoltà, visto che non li stai pagando. Coinvolgerli in una soluzione regolamentata spesso migliora persino la reputazione: dimostri di voler affrontare il problema in modo serio e sotto controllo giudiziario, piuttosto che sparire. Certo, inizialmente potrebbero restare spiazzati nel ricevere la proposta dal tribunale, ma molte aziende creditrici (banche incluse) conoscono la legge sul sovraindebitamento e sanno che è uno strumento anche a loro tutela (meglio incassare qualcosa in concorso che nulla da un debitore che fa il fantasma). Dal 2022 è possibile anche presentare un “procedimento familiare”: se i membri di una stessa famiglia sono tutti indebitati insieme (es. marito e moglie coobbligati) si può fare un’unica procedura. Questo riduce costi e notifiche duplicate. Quindi non farti frenare troppo dall’aspetto reputazionale: i dati non vengono comunque pubblicati su giornali (a differenza dei fallimenti di società che finiscono nel Bollettino ufficiale), restano confinati negli ambienti di giustizia e ai creditori interessati. Una volta ottenuta l’esdebitazione, sarai cancellato da quei registri e potrai ricostruire anche la reputazione creditizia. Meglio un debitore che legalmente si è liberato dai debiti piuttosto che uno formalmente pieno di debiti insoluti.
D: Quanto mi costa fare un piano del consumatore o concordato minore?
R: Ci sono dei costi iniziali: innanzitutto va versato un compenso all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che ti assiste. Il compenso è regolato dal DM 202/2014 ed è proporzionale all’attivo/passivo, ma in procedure semplici può essere anche di poche migliaia di euro. Spesso gli OCC chiedono un acconto iniziale (es. 30%). Poi ci sono €98 di contributo unificato se persona fisica, e marche da bollo. E i costi del tuo avvocato, che variano a seconda della complessità (possono essere anche a forfait €2-3k, o percentuali). Alcuni OCC applicano agevolazioni se il caso è particolarmente grave e il cliente incapiente. Inoltre, nel caso dell’esdebitazione incapiente, la legge dice che è dovuto comunque un compenso minimo all’OCC (anche lì qualche centinaio di euro almeno), ma parliamo di cifre sostenibili. È importante discutere chiaramente di costi al primo incontro con l’OCC o col professionista: alcuni OCC pubblicano i tariffari. Esempio: se hai €100k di debiti e nessun attivo, l’OCC potrebbe chiederti un compenso di €1.500, pagabile anche a rate prima di depositare il piano. Alcuni avvocati dilazionano il loro onorario. Dato che sei in difficoltà economica, paradossalmente può essere oneroso anche pagare questi costi: magari li devi far anticipare da un familiare. Tieni presente però un fatto: quei costi sono un investimento per liberarti dai debiti ben più grossi. Quindi, se possibile, racimola le somme necessarie. Nella liquidazione controllata, le spese dell’OCC e del liquidatore sono pagate in prededuzione dalla procedura stessa (se ci sono attivi, altrimenti a carico dello Stato in parte). In un piano, di solito l’OCC vuole essere pagato dal debitore. Verifica se nella tua zona ci sono Organismi di composizione della crisi pubblici (presso le Camere di Commercio, ad esempio): spesso applicano tariffe più calmierate rispetto a quelli privati. Dal 2021 c’è un albo ministeriale degli OCC, quindi rivolgiti a uno accreditato. In conclusione, qualche migliaio di euro di costo totale va previsto; sembrano un controsenso se sei indebitato, ma forse puoi destinare una parte di quelle risorse che altrimenti avresti dato a un creditore, per pagarti la procedura e risolvere tutto. Inoltre, le definizioni agevolate di AER hanno un costo di per sé: se devi pagare, poniamo, €10k per rottamare le cartelle, potresti decidere di impiegare invece quei €10k per un piano del consumatore che comprenda anche altri debiti. È una valutazione strategica da fare con i consulenti.
D: Dopo l’esdebitazione (fallimentare o da sovraindebitamento), posso riavviare un’attività o ottenere credito?
R: Sì, la finalità dell’esdebitazione è proprio farti tornare “affidabile” giuridicamente. Una volta ottenuto il decreto di esdebitazione, i vecchi debiti sono inesigibili, e tu non sei più considerato un cattivo pagatore in eterno. Certo, i segnalazioni in Centrale Rischi o CRIF per i precedenti insoluti potrebbero restare per un certo numero di anni (di solito 36 mesi dalla regolarizzazione o dall’evento negativo). L’esdebitazione in sé non è una “regolarizzazione” dei pagamenti, è una cancellazione autoritativa, quindi bisognerà vedere come le banche lo interpretano. In genere, trascorso qualche tempo e se costruisci un nuovo storico positivo, potrai accedere di nuovo al credito. Dal punto di vista legale, non hai più preclusioni: ad esempio, il fallito non esdebitato non può intraprendere una nuova iniziativa commerciale senza informare i nuovi soci della sua condizione; l’esdebitato invece è libero da questo obbligo e può aprire una nuova impresa. Addirittura, la legge fallimentare prevedeva che l’esdebitato potesse ottenere la cancellazione del suo nominativo dal casellario dei falliti. Il Codice della crisi ha abolito il casellario dei falliti, ma rimangono i registri di procedure. Comunque, superato il periodo, nessuno ti potrà chiedere conto giuridicamente dei debiti antecedenti esdebitazione. In pratica, se vuoi chiedere un nuovo prestito, la banca guarderà ai tuoi redditi attuali e alle segnalazioni creditizie; se la procedura concorsuale risulta, potrebbe inizialmente essere cauta. Ma considera che l’esdebitazione non è ancora molto “famosa” nel settore creditizio: potrebbero confondere la tua procedura per un fallimento e basta. Sarà magari utile, se succede, spiegare che hai ottenuto la riabilitazione. Dal lato impresa, puoi aprire nuove partite IVA; se eri un imprenditore fallito, dopo la chiusura del fallimento e l’esdebitazione non hai più limitazioni come l’inabilitazione (che comunque dura solo finché dura la procedura). Quindi sì, l’intento è quello: dare una seconda possibilità. Ecco perché è importante puntare all’esdebitazione come obiettivo finale.
D: Cosa succede se muoio prima che i miei debiti siano risolti? I miei figli dovranno pagare?
R: I debiti (tranne quelli personali tipo multe penali) si trasmettono agli eredi. Però gli eredi hanno facoltà di scelta: possono rinunciare all’eredità, ed evitare così di ricevere sia beni che debiti del defunto; oppure possono accettare con beneficio d’inventario, che li limita al valore dei beni ereditati. Se nessuno accetta, l’eredità rimane giacente e poi devoluta allo Stato (che comunque paga i debiti entro il limite dell’attivo ereditario). Quindi i tuoi figli non saranno obbligati a pagare di tasca loro i tuoi debiti, purché facciano le mosse giuste in sede successoria. È importante che ne siano consapevoli: se accettano puramente e semplicemente l’eredità e poi scoprono che ci sono molti debiti, dovranno pagarli fino a copertura totale (anche oltre il valore dei beni ricevuti, perché con accettazione pura l’erede risponde illimitatamente). Ma per fortuna oggi è prassi, in presenza di situazioni dubbie, fare almeno il beneficio d’inventario. Nel caso di un imprenditore indebitato, spesso la soluzione migliore per i figli è rinunciare, specie se non c’è attivo. Attenzione: se uno spera di lasciare ai figli solo i beni e non i debiti, non funziona così a meno di predisporre strumenti come polizze vita (che non entrano nell’asse ereditario) o trust/fondi patrimoniali in largo anticipo. Inoltre, se il debitore in vita stava seguendo una procedura di liquidazione controllata, alla morte questa si converte in una liquidazione dell’eredità, proseguendo per conto degli eredi beneficiari d’inventario. Gli eredi dunque potrebbero lasciar proseguire la procedura concorsuale e poi ottenere l’esdebitazione del defunto – che non serve a lui, ma a liberare l’asse dai debiti. In conclusione: i figli non pagano automaticamente, ma devono agire correttamente. È consigliabile, se hai molti debiti e vedi la fine vicina, parlarne con un notaio o avvocato per istruire gli eredi sul da farsi (ad es. redigere testamento con raccomandazione di accettare con beneficio).
D: Avevo un socio in affari e avevamo debiti comuni. Se lui fallisce o fa sovraindebitamento, io resto obbligato?
R: Sì, la responsabilità nei confronti dei creditori in solido rimane sugli altri coobbligati. Se tu e il socio avevate firmato insieme un prestito, la banca potrà comunque chiedere a te l’intero importo anche se l’altro è in procedura concorsuale. Caso tipico: società di persone con due soci; uno fa liquidazione del sovraindebitato e ottiene esdebitazione personale, l’altro socio (coobbligato illimitato) non viene liberato da quell’esdebitazione (gli effetti liberatori sono personali). Quindi i creditori potrebbero concentrarsi su di lui. D’altra parte, se quell’altro socio ha pagato più di quanto dovuto per debiti comuni, ha diritto di regresso nei tuoi confronti. Ma se tu sei esdebitato, non potrà rivalersi. In pratica, il suo fallimento/sovraindebitamento non è contagioso in positivo su di te. Al contrario, il fallimento di una società di persone estende il fallimento ai soci illimitati. Ma se, ad esempio, uno fa il piano del consumatore individuale, quell’accordo non tocca i coobbligati: infatti la legge prevede espressamente che “l’esdebitazione non produce effetti nei confronti dei coobbligati e fideiussori”. Questo tutela il credito residuo del terzo creditore. Quindi preparati: se il tuo socio è insolvente, potresti dover portare tu l’intero peso. L’unico modo per equilibrare la cosa è che anche tu eventualmente attivi la tua procedura concorsuale. È possibile fare una procedura familiare congiunta se eravate, ad esempio, coniugi soci; se eravate solo soci non legati da vincoli familiari, dovete farne due separate (magari coordinate). Tieni presente che se il debito comune viene pagato anche solo parzialmente in una procedura del socio, ciò riduce il debito complessivo. Ad esempio: debito 100 in solido; il socio fa un concordato e ne paga 30; la banca poi verrà da te per il restante 70 (non per 100). Però se lui ottiene esdebitazione senza pagare nulla, la banca potrà ancora volere 100 da te. In conclusione, essere coobbligato significa dover valutare la propria strategia indipendentemente dagli altri: non pensare che il fallimento del socio ti “copra”, anzi, spesso ti espone di più.
D: Ho sentito parlare di saldo e stralcio “fai da te” comprando il mio debito a sconto da una società. È possibile?
R: Ci riferiamo al caso in cui il tuo debito viene ceduto a una società di recupero crediti, e magari un terzo legato a te cerca di acquistarlo per liberarti. In teoria, se un creditore cede il credito sul mercato e tu riesci a farlo comprare da qualcuno vicino a te a un prezzo ridotto, di fatto estingui il debito pagando meno. Questa pratica però è complessa e talora rischiosa: molte cessioni di crediti prevedono clausole che impediscono al debitore di riacquistare il proprio debito a sconto (perché sarebbe troppo facile liberarsi pagando meno bypassando la trattativa diretta). In particolare, per i crediti fiscali c’è il divieto di “accentrare” su entità collegate al debitore. Per i crediti bancari, se vengono messi in un portafoglio e venduti, potrebbe capitare che un tuo conoscente li compri (ad es. un investitore compra la posizione a un certo tot%). Ma poi legalmente quell’investitore è comunque tuo creditore e potrebbe esigere l’intero nominale. Se il pactum è che ti libererà con uno sconto, assicurati di metterlo per iscritto chiaro. Insomma, è un terreno scivoloso, e spesso non hai tu controllo su chi compra il tuo debito sul mercato secondario. Molto meglio negoziare direttamente un saldo e stralcio con chi di dovere. Ci sono società di “debt purchasing” serie che a volte propongono loro un saldo e stralcio al debitore una volta comprato il credito (l’hanno pagato magari 10%, se recuperano 30% ci guadagnano e a te conviene). L’importante è che qualsiasi accordo sia formalizzato con quietanza liberatoria e cessione eventuale del debito. Non affidarti a metodi poco chiari come “fondo salva debiti” et similia senza prima valutare con un legale: c’è il rischio di finire in truffe (ci sono stati casi di finte società che promettevano di acquistare i debiti e poi sparivano con l’“anticipo spese” del debitore). Il mondo del recupero è spietato, occhio alle scorciatoie troppo belle per essere vere.
Conclusioni
Difendersi efficacemente dai debiti, per un ex titolare di Internet Point o altro piccolo imprenditore, richiede un approccio lucido e informato. Abbiamo visto che la normativa italiana offre numerosi strumenti di tutela, sia reattivi (opposizioni e eccezioni per vizi, prescrizioni) che proattivi (piani di rientro, accordi transattivi, procedure concorsuali per sovraindebitamento). La chiave è non restare inerti. Ignorare i problemi porta a conseguenze peggiori: decreti ingiuntivi non opposti che diventano definitivi, pignoramenti che incidono su stipendio o beni, accumulo di interessi e sanzioni. Al contrario, agire per tempo – magari con l’aiuto di un avvocato o di un OCC – consente spesso di ridurre l’importo effettivamente da pagare e di attenuare gli effetti negativi sulla propria vita.
Il punto di vista del debitore ovviamente è focalizzato a salvare il salvabile: la casa, i risparmi minimi, la dignità personale e lavorativa. Le leggi attuali, frutto di una evoluzione recente, tengono in conto tutto ciò. Pensiamo all’impignorabilità parziale di stipendio e pensione, alle tutele sulla prima casa verso il fisco, alla possibilità di esdebitazione integrale. Un debitore onesto ma sfortunato oggi non è più condannato a una “pena perpetua” come avveniva decenni fa. C’è la possibilità concreta di ritornare solvibile e reinserito a pieno titolo nell’economia.
D’altro canto, anche dal punto di vista del creditore (sia esso banca, fisco o privato) gli strumenti concorsuali sono utili perché permettono di massimizzare il recupero in base alle reali capacità del debitore, evitando inutili accanimenti e procedure infruttuose. Si sta diffondendo una cultura di maggior equilibrio: la legge cerca di contemperare il diritto del creditore a essere soddisfatto col diritto del debitore a mantenere condizioni di vita dignitose. Ne sono prova i limiti di pignorabilità e la nozione stessa di “debiti per i bisogni familiari” discussa per il fondo patrimoniale.
In pratica, il debitore deve: 1) mappare tutti i suoi debiti; 2) controllare termini e vizi (prescrizioni, nullità eventuali); 3) dialogare se possibile coi creditori per soluzioni stragiudiziali; 4) se ciò non basta, valutare seriamente la procedura concorsuale adatta per chiudere la vicenda in modo definitivo. È essenziale tenere presente che ogni situazione ha le sue peculiarità: questa guida fornisce un panorama avanzato, ma il caso concreto va affidato a professionisti competenti.
In conclusione, un ex titolare di Internet Point indebitato può difendersi efficacemente combinando gli strumenti legali a disposizione. Non esistono bacchette magiche per far sparire i debiti dall’oggi al domani, ma con pazienza e le giuste mosse è possibile arrivare a una soluzione equa: pagare quanto si può (spesso una frazione del dovuto) e ottenere la liberazione dal resto. Il risultato finale – la ritrovata stabilità economica e la serenità di non avere più creditori alla porta – vale certamente l’impegno profuso nel percorso di difesa. Nessuna situazione debitoria, per quanto grave, deve essere considerata senza speranza: le vie giuridiche esistono, ed oggi più che mai sono orientate a dare una seconda chance al debitore meritevole.
Fonti e riferimenti normativi (Italia, aggiornate al 2025)
- Codice Civile: art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale illimitata del debitore); art. 2304 c.c. (beneficio d’escussione nelle società di persone); art. 2495 c.c. (effetti della cancellazione di società di capitali: responsabilità dei soci nei limiti dell’attivo ricevuto); art. 167-170 c.c. (fondo patrimoniale e impignorabilità per debiti estranei ai bisogni familiari); art. 2288-2290 c.c. (uscita del socio e responsabilità per debiti pregressi, per 5 anni dalla cessazione); art. 2313, 2314, 2320 c.c. (socio accomandante – perdita di limitazione se nome in ragione sociale o ingerenza); art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria 10 anni); art. 2948 c.c. (prescrizioni brevi 5 anni per prestazioni periodiche: affitti, stipendi, interessi, bollette ecc.); art. 2901 c.c. (azione revocatoria ordinaria, 5 anni); art. 2916 c.c. (impignorabilità beni fondo patrimoniale per debiti estranei a bisogni familiari).
- Codice Procedura Civile: art. 543 e segg. c.p.c. (pignoramento presso terzi, comprese retribuzioni); art. 545 c.p.c. (limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni – ultime modifiche introdotte da DL 83/2015 conv. L.132/2015, e aggiornamenti soglie da L. 197/2022); art. 615 c.p.c. (opposizione a esecuzione) e 617 c.p.c. (opposizione atti esecutivi).
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): art. 1 L.F. (imprese soggette a fallimento – soglie dimensionali); art. 10 L.F. (fallimento entro 1 anno da cessazione attività); art. 147 L.F. (fallimento esteso ai soci illimitatamente responsabili). [Nota: dal 15/07/2022 la legge fallimentare è stata sostituita dal D.lgs. 14/2019].
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, aggiornato D.lgs. 83/2022): art. 2 CCII (definizioni di crisi e insolvenza) e definizione di “consumatore” (art. 2, co.1 lett. e) – non più “esclusivamente” estraneo ad attività imprenditoriale; art. 65 CCII (ambito di applicazione procedure sovraindebitamento: debitori non soggetti a liquidazione giudiziale); art. 66 CCII (procedure familiari con unico progetto); artt. 67-73 CCII (Ristrutturazione dei debiti del consumatore – requisiti, presentazione, omologazione); artt. 74-83 CCII (Concordato minore – presupposti, maggioranze 50%, omologazione anche in mancanza di adesione se convenienza, ecc.); artt. 268-277 CCII (Liquidazione controllata del sovraindebitato – analoga al fallimento: nomina liquidatore, effetti, acquisizione utilità sopravvenute entro 3 anni); art. 282 CCII (Esdebitazione nella liquidazione controllata: concessa di diritto 3 anni dopo apertura se il debitore collabora – Corte Cost. n. 6/2024 ha confermato interpretazione temporale massima); art. 283 CCII (Esdebitazione del debitore incapiente**:** requisiti – persona meritevole, priva di attivo e di reddito disponibile – e obbligo informativo 4 anni se sopravvengono utilità ≥10%).
- Legge 3/2012 (vecchia legge sul sovraindebitamento, abrogata salvo transitorie): art. 7 L.3/2012 (meritevolezza richiesta, esclusione imprenditori fallibili); art. 12-bis (piano del consumatore, non necessità adesione creditori); art. 14-ter (liquidazione patrimonio, durata 4 anni); art. 14-quaterdecies (esdebitazione a fine liquidazione, prima limitata dal 10%). [Solo per riferimento storico].
- Decreti “sostegno” e “bilancio” recenti: L. 176/2020 (ha introdotto la esdebitazione anche per soggetti falliti con pagamento parziale 0% – poi consolidato nel Codice); Legge n.197/2022 (Bilancio 2023): art. 1 commi 231-252 (Definizione agevolata – rottamazione quater: stralcio automatico mini-debiti fino 1.000€ e rottamazione debiti 2000-2022 senza interessi/sanzioni); Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 198/2022 conv. L.14/2023): proroga termini adesione definizione agevolata in alcuni casi; Decreto Alluvioni 2023 (D.L. 61/2023 conv. L.100/2023): proroghe rottamazione per residenti in zone alluvionate; Legge n.18/2024: differimento scadenze rate rottamazione; discussioni su Rottamazione-quinquies 2025 (emendamenti in corso).
- Cassazione Civile (massime di sentenze recenti): Cass. Civ. Sez. VI ord. n. 16713/2016 – notifica atti al socio di S.n.c. (non serve notifica di accertamento al socio, sufficiente a società; socio responsabile dopo escussione patrimonio sociale); Cass. Civ. Sez. I n. 1869/2016 – ammissibilità piano del consumatore con debiti misti imprenditoriali e personali (qualifica consumatore non inficiata se debiti in parte da attività, valutando composizione finale); Cass. Civ. Sez. I n. 24214/2021 – conferma ampliamento nozione consumatore post riforma; Cass. Civ. Sez. Un. n. 3777/2013 – principio su soci S.r.l. post cancellazione: responsabilità limitata a attivo ricevuto; Cass. Civ. Sez. VI ord. n. 32729/2023 – socio unico S.r.l. cancellata non risponde di debiti se non ha riscosso nulla in liquidazione; Cass. Civ. ord. n. 33065/2022 – fondo patrimoniale: debiti d’impresa possono considerarsi per bisogni famigliari se l’attività supporta la famiglia; onere al debitore di provare estraneità ai bisogni se vuole opporre impignorabilità; Cass. Civ. n. 28625/2019 – revoca esdebitazione se dolo del debitore; Cass. Civ. n. 9097/2018 – il 10% minimo L.3/2012 incostituzionale (poi Corte Cost. 15/2020 ha sancito incostituzionalità parziale art. 14-terdecies).
- Corte Costituzionale: sentenza n. 6 del 19/01/2024 – ha definito che i beni sopravvenuti oltre 3 anni dall’apertura liquidazione controllata non vanno ai creditori, consolidando durata massima esdebitazione; sentenza n. 83/2018 – su pignorabilità pensioni (ha elevato quota minima impignorabile a 1,5x assegno sociale per tutela minimo vitale); sentenza n. 15/2020 – su sovraindebitamento (dichiarata incost. la preclusione all’accesso per chi era stato sanzionato per mala gestio, aprendo a valutazione caso per caso); sentenza n. 23/2019 – su indebito bancario (rilevante per usura sopravvenuta, ma omissibile qui).
- Prassi e dottrina: Relazione Illustrativa al D.lgs. 14/2019 (spiega ratio nuove procedure familiari e incapiente); Studio CNDCEC – Linee guida OCC 2023; Circolari Agenzia Entrate-Riscossione 2023 su rottamazione quater (portale AER); Direttiva UE 2019/1023 sull’insolvenza (recepita in parte).
Ex titolare di Internet Point con debiti? Fatti Difendere da Studio Monardo
Hai chiuso il tuo Internet Point ma ti sei ritrovato con cartelle esattoriali, debiti fiscali o contributivi?
Le banche, l’Agenzia delle Entrate o l’INPS ti inseguono nonostante l’attività sia cessata?
Molti ex titolari di attività come Internet Point si trovano oggi sovraindebitati, spesso per via di fitti non pagati, forniture, tasse non versate o contributi INPS. Ma anche dopo la chiusura dell’impresa esistono strumenti legali per difenderti, bloccare le azioni esecutive e ridurre o cancellare i debiti.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza tutta la tua esposizione debitoria, compresi avvisi, cartelle e pignoramenti
- 📌 Verifica la prescrizione dei debiti o la presenza di vizi formali negli atti notificati
- ✍️ Presenta istanza per accedere alla procedura di sovraindebitamento e bloccare i creditori
- ⚖️ Ti assiste nel piano del consumatore o nella liquidazione controllata, se compatibile
- 🔁 Richiede l’esdebitazione, ovvero la cancellazione totale dei debiti residui
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto nella difesa di piccoli imprenditori e ex titolari di esercizi commerciali
- ✔️ Specializzato in procedure di sovraindebitamento e crisi da ex attività cessate
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Anche se l’attività è chiusa, non sei senza via d’uscita.
Con il giusto supporto legale puoi bloccare i creditori, alleggerire i debiti e voltare pagina.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua ripartenza comincia da qui.