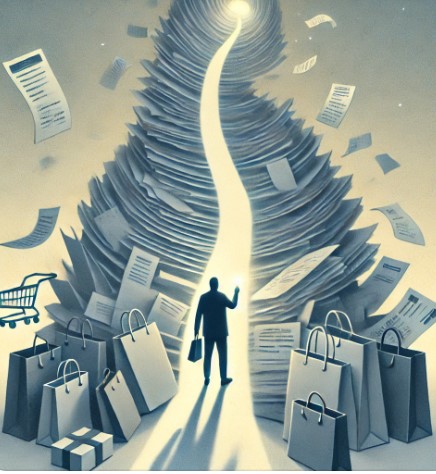Hai accumulato debiti a causa dello shopping compulsivo? Sei sopraffatta da rate, carte revolving, finanziamenti o acquisti online che non riesci più a gestire? Ti senti sotto pressione da richieste di pagamento, telefonate dai recupero crediti, notifiche di atti giudiziari?
Lo shopping compulsivo è un disturbo del comportamento che può avere conseguenze economiche pesantissime, fino a compromettere la tua serenità, la tua famiglia e il tuo futuro. Ma anche in questi casi esistono strumenti legali per difendersi e uscire dalla spirale del debito.
Cos’è lo shopping compulsivo?
– È una forma di dipendenza psicologica: si compra in modo impulsivo, non razionale, eccessivo
– Può portare a uso incontrollato di carte di credito, prestiti veloci, acquisti a rate
– Spesso viene ignorato o nascosto fino a quando non emergono i primi problemi seri di indebitamento
Quali sono le conseguenze giuridiche?
– Sovraindebitamento personale, anche se non hai un’attività d’impresa
– Cartelle esattoriali, pignoramenti, decreti ingiuntivi, segnalazioni al CRIF
– Difficoltà nei rapporti familiari, perdita della reputazione e della stabilità economica
– In certi casi, problemi di salute mentale collegati alla pressione debitoria
Come puoi difenderti legalmente?
– Puoi accedere alla procedura di sovraindebitamento per persone fisiche prevista dalla legge
– Devi dimostrare che sei una debitrice meritevole e non colpevole di dolo o frode
– Puoi presentare un piano di ristrutturazione del debito o una liquidazione controllata del patrimonio, che ti consente di:
– Bloccare pignoramenti e azioni esecutive
– Pagare solo in base alle tue reali possibilità
– Ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui
– In certi casi, puoi chiudere la posizione anche con un saldo e stralcio assistito
Cosa serve per avviare la procedura?
– Un avvocato esperto in sovraindebitamento
– Una relazione di un gestore della crisi iscritto all’OCC
– La documentazione di redditi, spese, debiti, finanziamenti e beni personali
– Una valutazione psicologica o medica, se lo shopping compulsivo ha avuto base clinica
Cosa puoi ottenere?
– Stop a interessi, anatocismi e nuove sanzioni
– Sospensione delle richieste dei creditori
– Ricominciare da zero, senza più l’angoscia dei debiti passati
– Un futuro libero, stabile e sotto controllo, con piena legalità
Molte donne si vergognano di affrontare questo problema, ma non sei sola: la legge tutela anche chi è caduto in difficoltà a causa di comportamenti compulsivi. L’importante è agire subito, con consapevolezza e con il supporto giusto.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi da sovraindebitamento e tutela della persona ti spiega come affrontare legalmente una situazione di debito causato da shopping compulsivo e come uscirne con strumenti concreti.
Hai bisogno di difenderti da pignoramenti o richieste di pagamento che non riesci più a sostenere? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo insieme la tua situazione e ti diremo quale strada puoi intraprendere per salvare il tuo presente e il tuo futuro.
Introduzione
Lo scenario: Una persona affetta da shopping compulsivo – condizione nota anche come oniomania, caratterizzata da acquisti impulsivi e incontrollati – può facilmente ritrovarsi sommersa dai debiti. Carte di credito al limite, prestiti personali, finanziamenti per acquisti non necessari: il peso finanziario diventa insostenibile e sfugge al controllo. I debiti crescono fino a superare di gran lunga le entrate e il patrimonio disponibile, configurando quella che la legge italiana definisce sovraindebitamento. Secondo la definizione della Legge 3/2012, il sovraindebitamento è “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. In parole semplici, significa non riuscire più a pagare regolarmente i debiti e le spese essenziali, a causa di un eccesso di obbligazioni finanziarie accumulatesi nel tempo.
Trovarsi in questa situazione non comporta solo conseguenze economiche, ma anche un forte impatto psicologico: ansia, stress, depressione e senso di colpa possono affliggere il debitore. Proprio per prevenire drammi personali (la Legge 3/2012 è nota come “legge salva suicidi”), l’ordinamento italiano ha introdotto strumenti specifici per aiutare chi è oppresso dai debiti a ripartire da zero in modo dignitoso. Questa guida, aggiornata a luglio 2025, offre un approfondimento avanzato – con taglio giuridico ma divulgativo – sugli strumenti legali e sulle strategie di difesa a disposizione di una persona sovraindebitata, con particolare attenzione al caso di una donna affetta da shopping compulsivo. Il punto di vista adottato è quello del debitore che cerca di tutelarsi dalle azioni dei creditori e di risolvere la propria crisi finanziaria.
Tratteremo sia le soluzioni extragiudiziali (accordi privati, negoziazioni, aiuti delle associazioni) sia le procedure giudiziali di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla normativa italiana. Verranno illustrati i requisiti, i vantaggi e gli svantaggi di ogni opzione, con riferimenti a leggi aggiornate e alla giurisprudenza più recente (sentenze di merito e di legittimità fino al 2025). Troverete inoltre casi pratici e simulazioni che aiutano a capire come questi strumenti si applicano nella realtà, tabelle riepilogative per confrontare le diverse soluzioni, e una sezione di domande e risposte frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate in fondo alla guida nella sezione Fonti.
Importante: Ogni situazione di indebitamento è diversa. Questa guida offre un orientamento generale sulle possibilità di difesa, ma non sostituisce una consulenza personalizzata. È consigliabile rivolgersi a professionisti esperti – avvocati, consulenti finanziari, Organismi di Composizione della Crisi (OCC) – per valutare nel dettaglio il proprio caso. Detto questo, vediamo come il nostro ordinamento può aiutare una persona affetta da shopping compulsivo e sommersa dai debiti a difendersi e a costruire un percorso di uscita dalla crisi.
Shopping compulsivo e debiti: riconoscimento del problema
Prima di esaminare gli strumenti giuridici, è utile inquadrare il fenomeno dello shopping compulsivo e la sua rilevanza legale. Lo shopping compulsivo è considerato una dipendenza comportamentale: il soggetto prova un impulso incontrollabile ad acquistare, spesso beni non necessari, accumulando spese ben oltre le proprie possibilità economiche. In molti casi, questa condotta è legata a bisogni emotivi o a situazioni personali difficili (depressione, stress, traumi) e può sfociare in un disturbo psichiatrico riconosciuto. Dal punto di vista giuridico, però, il semplice fatto di soffrire di shopping compulsivo non annulla automaticamente le obbligazioni contratte. I debiti rimangono validi e i creditori possono pretenderne il pagamento. Non esiste una “esenzione” generale dai debiti per chi è affetto da tale dipendenza. Tuttavia, il comportamento compulsivo e lo stato psicologico del debitore possono rilevare in due modi principali:
- Meritevolezza e buona fede: Nelle procedure di sovraindebitamento (che vedremo a breve), uno dei requisiti chiave è che il debitore non abbia causato il proprio dissesto con dolo o colpa grave. Una condotta compulsiva potrebbe essere valutata dal giudice non come dolo, ma come un comportamento problematico di tipo sanitario. Se il soggetto ha agito senza intenzione fraudolenta e ha cercato di curare il proprio disturbo, potrebbe essere considerato “meritevole” di accedere alle procedure di sollievo dai debiti. Ad esempio, in un caso recente il Tribunale di Monza ha omologato un piano del consumatore per una donna affetta da sindrome da shopping compulsivo, riconoscendo la genuinità del suo stato di crisi e ammettendola ai benefici della legge di sovraindebitamento. Il fatto che la debitrice fosse in cura presso un ospedale per il suo disturbo ha contribuito a dimostrare la buona fede e l’assenza di malafede nel sovraindebitarsi.
- Capacità di agire e protezione della persona: Nei casi più gravi, lo shopping compulsivo può compromettere la capacità della persona di gestire i propri affari economici in modo razionale. La giurisprudenza ha riconosciuto che l’oniomania può costituire un’infermità tale da giustificare la nomina di un amministratore di sostegno (Ads). Ad esempio, il Tribunale di Varese con decreto del 3 ottobre 2012 ha stabilito che si può istituire un’amministrazione di sostegno a favore di un soggetto affetto da sindrome da acquisto compulsivo, proprio per assisterlo nella gestione del denaro e frenare le condotte dissipative. L’Ads è un istituto previsto dal codice civile (artt. 404 e ss. c.c.) che consente a un giudice tutelare di nominare un tutore/supporto per persone che, pur non totalmente incapaci, hanno bisogno di aiuto in specifici ambiti. Nel caso dello shopping compulsivo, l’Ads può essere autorizzato a controllare le spese del beneficiario, autorizzare solo gli acquisti appropriati e amministrare il patrimonio, evitando così nuovi debiti. Si noti che anche il codice civile prevede la figura dell’inabilitazione per prodigalità (art. 415 c.c.) per chi dilapida il patrimonio in spese futili, sebbene oggi si preferisca utilizzare lo strumento più flessibile dell’amministrazione di sostegno. In sintesi, prima che la situazione degeneri in debiti insostenibili, i familiari di una persona affetta da shopping compulsivo possono valutare di ricorrere a un provvedimento di tutela (Ads o in casi estremi interdizione/inabilitazione) per prevenire il dissesto finanziario. Questa è una misura protettiva extra-giudiziale in senso di sovraindebitamento, ma è utile saperlo: il diritto riconosce il fenomeno come potenzialmente patologico e offre strumenti di protezione civile della persona.
Detto ciò, una volta che i debiti sono stati contratti, occorre concentrarsi sugli strumenti di difesa patrimoniale. Nei prossimi paragrafi passeremo in rassegna sia le soluzioni extragiudiziali (ovvero quelle da tentare senza coinvolgere formalmente il tribunale) sia le procedure giudiziali di composizione della crisi previste dalla normativa sul sovraindebitamento. L’obiettivo comune di queste soluzioni è evitare conseguenze irreparabili – come pignoramenti della casa o dello stipendio – e arrivare possibilmente a una ristrutturazione o cancellazione di parte dei debiti, consentendo al debitore di tornare a una vita finanziariamente sostenibile.
Quadro normativo sul sovraindebitamento in Italia
Prima di entrare nel merito delle singole soluzioni, è utile avere un quadro della normativa vigente in materia di sovraindebitamento. In Italia, le procedure specifiche per i debitori civili e i piccoli imprenditori in crisi finanziaria sono state introdotte inizialmente dalla Legge 27 gennaio 2012, n.3 (la cosiddetta “legge salva-suicidi”). Questa legge ha rappresentato una svolta: per la prima volta si è previsto che anche i soggetti “non fallibili” (ossia coloro che non possono accedere alle tradizionali procedure concorsuali come il fallimento, tipicamente i privati consumatori, i professionisti, i piccoli imprenditori sotto soglia, gli enti non profit, ecc.) potessero accedere a procedimenti per comporre la propria crisi debitoria. La L.3/2012 originariamente prevedeva tre strumenti principali: l’accordo di composizione della crisi con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio del debitore. Tali strumenti potevano essere omologati da un tribunale a beneficio del debitore, a condizione che quest’ultimo fosse in uno stato di sovraindebitamento non dovuto a sua frode o colpa grave e che rispettasse determinati requisiti di legge.
Successivamente, il legislatore ha attuato una riforma organica della materia con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), emanato con D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14. Questo Codice – entrato in vigore definitivamente dal 15 luglio 2022 dopo varie proroghe – ha abrogato la L.3/2012, riorganizzandone il contenuto e introducendo alcune novità. In particolare, il Codice della crisi ha:
- Rinominato le procedure: l’“accordo di composizione” è stato ridenominato “concordato minore”, il “piano del consumatore” è diventato “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” (pur restando spesso chiamato brevemente piano del consumatore), mentre la “liquidazione del patrimonio” è ora “liquidazione controllata”. Di fatto la sostanza di queste procedure rimane simile, ma con terminologia uniformata.
- Reso meno stringente il criterio di meritevolezza del debitore e introdotto il concetto di merito creditizio: il Codice prevede che il giudice valuti la condotta del debitore con criteri meno rigidi rispetto al passato, tenendo conto anche dell’eventuale condotta degli stessi finanziatori. In altre parole, si è stabilito che il debitore sovraindebitato non deve dimostrare di aver assunto i debiti con assoluta prudenza, ma piuttosto che non vi sia stata malafede o frode evidente. Contestualmente, è stato valorizzato il principio del merito creditizio: banche e finanziarie sono tenute per legge a valutare la solvibilità dei clienti prima di erogare credito, e se hanno concesso prestiti in spregio alla capacità reddituale del consumatore, questo elemento verrà considerato a favore del debitore in sede di procedura. Ad esempio, come vedremo, una recente sentenza della Cassazione ha negato l’omologazione di un piano del consumatore perché il debitore aveva falsato il proprio merito creditizio omettendo di dichiarare finanziamenti in corso, inducendo così la banca a sovrafinanziarlo erroneamente. Ciò dimostra che l’attenzione si è spostata sia sul comportamento del debitore sia su quello dei creditori in fase di concessione del credito.
- Ampliato la platea dei soggetti ammessi e introdotto nuove procedure: il D.Lgs. 14/2019 e i suoi correttivi (tra cui il D.Lgs. 17 giugno 2022, n.83 e il D.Lgs. 13 settembre 2024, n.136) hanno esteso l’accesso al sovraindebitamento anche a categorie prima dubbie, come i soci illimitatamente responsabili di società di persone (per i debiti non d’impresa) e le start-up innovative, e hanno predisposto procedure speciali come l’esdebitazione del debitore incapiente e le procedure familiari unificate. L’esdebitazione dell’incapiente, in particolare, è un istituto nuovo previsto dall’art. 14-quaterdecies L.3/2012 (oggi art. 283 CCII) e dall’art. 67 CCII, che consente al debitore persona fisica privo di beni o reddito di ottenere la cancellazione totale dei debiti senza offrire nulla ai creditori, purché sia “meritevole” e abbia almeno tentato una procedura di composizione. Ne parleremo diffusamente più avanti.
- Introdotto limiti agli abusi: il nuovo impianto normativo ha previsto che il debitore sovraindebitato non possa ottenere l’esdebitazione più di una volta ogni 5 anni e comunque non più di due volte in totale, in modo da evitare utilizzi reiterati e opportunistici dello strumento. Inoltre, restano cause di esclusione la condanna definitiva per reati gravi in materia di insolvenza (ad es. bancarotta fraudolenta) e il mancato deposito della documentazione completa o l’occultamento di parte dell’attivo.
In sintesi, ad oggi (luglio 2025) la disciplina del sovraindebitamento è contenuta principalmente negli artt. 65-83 del Codice della crisi (per piani del consumatore e concordati minori) e negli artt. 268-283 del Codice (per liquidazione controllata ed esdebitazione incapiente). Possono accedere a queste procedure tutti i debitori non fallibili che si trovino in uno stato di squilibrio economico tale da non poter pagare i debiti accumulati. Rientrano in questa categoria: i consumatori privati (persone fisiche che hanno debiti non professionali), i professionisti e autonomi senza fallibilità, i piccoli imprenditori commerciali sotto le soglie di fallimento, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative, gli enti non profit e simili. Sono invece esclusi coloro che potrebbero fallire o accedere a procedure concorsuali ordinarie (società medio-grandi, imprenditori sopra soglia): questi ultimi devono usare strumenti come il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale.
Quali debiti possono essere inclusi? In linea di massima, tutti i tipi di debito rientrano nel perimetro del sovraindebitamento: dalle rate del mutuo alle bollette non pagate, dai prestiti personali alle esposizioni su carte di credito, dai debiti verso fornitori fino ai debiti fiscali e contributivi. Anche i debiti verso l’Agenzia delle Entrate (imposte, IVA) e verso enti come INPS per contributi possono essere inseriti in un piano del consumatore. Questa è una differenza rispetto alle vecchie norme fallimentari: la legge sul sovraindebitamento ammette espressamente il trattamento dei debiti tributari, purché nell’ambito del piano il Fisco ottenga almeno quanto otterrebbe in una liquidazione. Ci sono però alcune eccezioni importanti: non tutti i debiti sono cancellabili con l’esdebitazione finale. In particolare, sono esclusi dalla liberazione finale (ossia restano comunque da pagare, anche dopo la procedura) i debiti per obblighi alimentari (es. assegni di mantenimento a coniuge e figli), i debiti da risarcimento di danni extracontrattuali (es. causati da fatti illeciti, come un risarcimento per lesioni causate in un incidente), e le sanzioni penali o amministrative pecuniarie (multe, ammende). Queste categorie di debiti, ritenute di particolare rilevanza sociale o derivanti da condotte illecite, non possono essere spazzate via dalla procedura e rimarranno a carico del debitore (salvo che i creditori di tali somme acconsentano diversamente, cosa improbabile soprattutto per sanzioni e alimenti).
Riassumendo il quadro normativo: la legge italiana offre oggi una rete di sicurezza per i debitori civili onesti in difficoltà. Se una persona (come la nostra ipotetica debitrice compulsiva) si trova con debiti insostenibili, può rivolgersi a un apposito organismo (OCC) e presentare al tribunale un progetto per risolvere la crisi. Durante l’iter, la legge prevede misure di salvaguardia (come la sospensione delle azioni esecutive) e, a conclusione positiva, consente di cancellare i debiti residui dando al debitore la possibilità di ricominciare senza quello “zaino di pietre” sulle spalle. Tutto questo però a condizione che il debitore agisca con lealtà e trasparenza: omissioni, frodi o comportamenti scorretti possono portare al fallimento del piano e alla ripresa immediata delle aggressioni dei creditori. Nei prossimi paragrafi esamineremo nel dettaglio le varie opzioni di difesa, partendo da quelle extragiudiziali (fuori dal processo) per arrivare poi a quelle giudiziali previste dalla L.3/2012 e dal Codice della crisi.
Soluzioni extragiudiziali: difendersi dai debiti senza andare in tribunale
Prima di intraprendere un percorso giudiziario formale, è spesso opportuno valutare se esistono soluzioni extragiudiziali per gestire o ridurre i debiti. Queste soluzioni consistono essenzialmente in accordi privati o in strumenti negoziali che si possono attivare volontariamente, spesso con l’aiuto di professionisti o enti di tutela dei consumatori, senza richiedere l’intervento diretto di un giudice (almeno nella fase iniziale). Vediamo le principali:
- Rinegoziazione diretta con i creditori: Il primo passo per difendersi dalle pressioni dei creditori può essere affrontarli apertamente proponendo una rinegoziazione. Se la debitrice riesce ancora a dialogare con la banca o la finanziaria, può cercare di ottenere un rifinanziamento o consolidamento del debito a condizioni più sostenibili: ad esempio, allungando i tempi di rimborso per abbassare la rata mensile, o chiedendo una riduzione dei tassi di interesse. Alcuni istituti, di fronte a difficoltà conclamate del cliente, preferiscono rimodulare il prestito piuttosto che procedere con un’inadempienza che potrebbe finire male per entrambe le parti. È importante però essere consapevoli che queste soluzioni dipendono dalla disponibilità del creditore e dalla credibilità del nuovo piano di rimborso proposto. In caso di shopping compulsivo, presentare evidenze di essere in terapia o di avere un piano di gestione finanziaria controllato (es. tramite un amministratore di sostegno o un consulente) potrebbe convincere di più il creditore ad accettare una rinegoziazione, poiché vede uno sforzo concreto di cambiamento.
- Saldo e stralcio: Una forma particolare di accordo extragiudiziale è il cosiddetto saldo e stralcio. In sostanza si tratta di offrire al creditore un pagamento immediato in unica soluzione di un importo inferiore al dovuto, in cambio della cancellazione del restante debito. Ad esempio, a fronte di un debito di €10.000, si potrebbe proporre il pagamento immediato di €4.000 “a stralcio” e ottenere quietanza liberatoria per l’intero. Questa strada è praticabile se la debitrice riesce a reperire una certa somma (magari aiutata da familiari) e se il creditore è consapevole che diversamente rischierebbe di recuperare poco o nulla (specie se il debitore non ha beni pignorabili). Spesso le finanziarie accettano saldi a stralcio quando il debito è già in sofferenza da tempo. Attenzione però: è fondamentale formalizzare per iscritto l’accordo, facendo ben specificare che il pagamento pattuito è a saldo definitivo del maggior importo dovuto, per evitare che in futuro il creditore (o una società di recupero crediti subentrata) avanzi pretese sul residuo. Un accordo di saldo e stralcio, se ben documentato, è vincolante quanto una transazione contrattuale.
- Intervento di un’Associazione dei consumatori o di un mediatore creditizio: Se trattare direttamente con le banche risulta difficile, ci si può rivolgere ad associazioni di tutela dei consumatori (come Adiconsum, Federconsumatori, Cittadinanzattiva, ecc.) oppure a organismi specializzati in sovraindebitamento. Questi enti spesso offrono sportelli di consulenza dove esperti legali e finanziari analizzano la situazione debitoria e suggeriscono soluzioni. In alcuni casi, l’associazione può farsi parte attiva contattando i creditori per conto del debitore e proponendo un piano di rientro concordato. Ad esempio, esistono protocolli antiusura tra istituzioni e associazioni per aiutare chi è fortemente indebitato a evitare di cadere nelle mani di usurai, magari favorendo microprestiti di emergenza o moratorie sui debiti. Anche la mediazione civile può teoricamente essere uno strumento: benché non obbligatoria per queste materie, nulla vieta di attivare una mediazione presso un organismo terzo, invitando i creditori a trovare un accordo prima di iniziare cause esecutive. Tuttavia, l’esperienza insegna che molti creditori (soprattutto banche) sono poco propensi a mediare se non intravedono una convenienza concreta. Ecco perché l’intervento di soggetti istituzionali o associativi può dare più peso alla richiesta del debitore, soprattutto se questo soggetto presenta un piano credibile e supportato dai documenti (redditi disponibili, elenco dei beni, ecc.).
- Piani del consumatore “in via stragiudiziale” (accordi volontari): Una novità introdotta dal Codice della crisi è la possibilità di predisporre, con l’ausilio di un OCC, un piano di ristrutturazione volontario e sottoporlo ai creditori prima di depositare un ricorso in tribunale. Questo è in pratica un tentativo di accordo stragiudiziale assistito: il debitore, con l’aiuto dell’Organismo di Composizione della Crisi, elabora un piano di pagamento sostenibile e lo propone informalmente a tutti i creditori. Se tutti i creditori aderiscono e lo sottoscrivono, l’accordo raggiunto (contratto) evita la necessità di andare dal giudice. Si tenga presente che anche in caso di accordo privato, è opportuno farlo con l’assistenza di un legale e dell’OCC per assicurarsi che sia valido e impegnativo per tutti. Qualora uno o più creditori non aderissero, il debitore potrà comunque decidere di trasformare la proposta in un ricorso formale di sovraindebitamento (piano del consumatore o concordato minore) davanti al tribunale. In sintesi, provare prima la via dell’accordo amichevole può far risparmiare tempo e costi se c’è collaborazione, ma è essenziale non dilungarsi troppo in trattative inconcludenti: i creditori nel frattempo potrebbero agire legalmente.
- Sfruttare eventuali moratorie o sospensioni legislative: In particolari periodi di crisi economica generalizzata, il governo può introdurre misure temporanee di sollievo. Ad esempio, durante la crisi COVID-19 sono state varate moratorie sui mutui per la prima casa e sospensioni delle attività di riscossione coattiva da parte dell’agente delle entrate. Al momento (2025) non ci sono moratorie generali attive, ma è sempre utile tenersi informati su possibili nuove iniziative (ad esempio programmi di “Rottamazione” o saldo e stralcio di cartelle esattoriali promossi per legge). Se parte del debito riguarda cartelle di pagamento per tasse o multe, verificare se rientrano in qualche definizione agevolata prevista dalla normativa vigente (come la rottamazione-quater se riaperta) può offrire uno sconto su sanzioni e interessi.
- Fondo di prevenzione dell’usura e microcredito: Lo Stato italiano, tramite il Ministero dell’Economia, finanzia un fondo di prevenzione dell’usura gestito da determinate Fondazioni e Associazioni antiusura riconosciute. Questi enti possono garantire prestiti bancari a tasso agevolato a favore di soggetti sovraindebitati “meritevoli” che rischiano di finire vittime di usura. Per accedere, occorre presentare domanda documentando la propria situazione e dimostrando di poter sostenere almeno il rimborso parziale se si ottiene questo prestito ponte. Non è una soluzione per cancellare i debiti, ma per sostituire debiti onerosi e frammentati con un unico prestito più sostenibile, con l’assistenza dell’ente antiusura. È una strada percorribile solo in casi selezionati, ma conviene sapere che esiste. Anche alcuni progetti di microcredito (sovvenzionati pubblicamente o da enti come Caritas) possono erogare piccole somme per aiutare famiglie indebitate a uscire da situazioni emergenziali (pagare affitti arretrati, bollette in scadenza, etc.) così da evitare conseguenze peggiori mentre si ristruttura la situazione.
- Difendersi dalle società di recupero crediti: Sul piano extragiudiziale, va menzionato anche un aspetto di tutela personale: spesso il debitore sovraindebitato viene fatto oggetto di insistenti solleciti, telefonate aggressive o addirittura minacce da parte di società di recupero crediti incaricate dai creditori. È importante sapere che esistono norme di legge e codici deontologici che vietano il recupero crediti molesto o intimidatorio. Il debitore può e deve far valere i propri diritti: ad esempio, può inviare una lettera raccomandata (meglio se tramite un avvocato) diffidando l’agenzia dal continuare comportamenti persecutori o scorretti, ricordando che la legge tutela la privacy e la dignità (D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 in materia di dati personali, oltre alle norme penali contro la molestia e minaccia). Se le condotte oltrepassano il lecito, si può presentare un esposto all’Autorità di Polizia o segnalarle all’IVASS (se riguardano assicurazioni) o alla Banca d’Italia (se riguardano banche/financial). In ogni caso, mantenere la calma e non farsi prendere dal panico: l’agenzia di recupero non ha poteri speciali, non può pignorare nulla senza prima che il creditore ottenga un titolo esecutivo dal giudice. Talvolta, dopo la “fase di pressing”, queste società sono esse stesse disponibili a trattare un saldo e stralcio a condizioni favorevoli, pur di chiudere la pratica.
In sintesi, le soluzioni extragiudiziali ruotano attorno al concetto di accordo volontario. I vantaggi principali sono: minor formalità, tempi potenzialmente più rapidi, minori costi (evitando contributi unificati e spese legali di una procedura giudiziale), e preservare la privacy (la procedura in tribunale invece comporta atti depositati pubblicamente, sebbene non ci sia pubblicità sui giornali per il sovraindebitamento come avviene per i fallimenti). Di contro, gli svantaggi sono che tali soluzioni richiedono la piena collaborazione di tutti i creditori: basta un creditore importante che rifiuti per vanificare l’accordo. Inoltre, gli accordi privati non offrono le stesse tutele legali delle procedure giudiziali: ad esempio, un accordo non impedisce a eventuali creditori dissenzienti di procedere con pignoramenti; solo una procedura omologata dal giudice può sospendere o bloccare le azioni esecutive di tutti i creditori. Pertanto, spesso le trattative private funzionano meglio come preludio o complemento a una procedura giudiziale. Ad esempio, un debitore potrebbe già raccogliere il consenso informale di alcuni creditori e poi presentare un piano del consumatore, sapendo di non incontrare forte opposizione in udienza.
Nel caso della nostra donna con debiti da shopping compulsivo, è opportuno che, parallelamente alla valutazione delle procedure legali, ella provi a: a) contattare i propri creditori principali per comunicare la volontà di trovare una soluzione (idealmente prima che partano azioni legali formali come decreti ingiuntivi); b) farsi assistere da un consulente o associazione per presentare un piano di rientro credibile; c) evitare di prendere nuovi finanziamenti per pagare i vecchi (questa è una tentazione diffusa ma pericolosissima: indebitarci ulteriormente con un prestito magari ad alto interesse per chiudere buchi temporaneamente – strategia che conduce spesso a un circolo vizioso). Se però la situazione è già compromessa e i creditori hanno perso fiducia, sarà necessario ricorrere agli strumenti giudiziali che ora andremo a illustrare.
Procedure giudiziali di sovraindebitamento: strumenti di difesa legale
Quando i debiti sono troppi e le trattative private falliscono o non sono praticabili, la legge offre al debitore sovraindebitato una serie di procedure formali da attivare presso il Tribunale competente. Queste procedure – introdotte come visto dalla L.3/2012 e ora disciplinate nel Codice della crisi – permettono di ottenere provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongono ai creditori una certa soluzione di compromesso, con l’obiettivo di salvaguardare la dignità del debitore e concedergli l’esdebitazione (cioè la cancellazione del debito residuo) a fine procedura. È importante sottolineare che tali procedure non sono automatiche: occorre presentare un’istanza ben documentata, seguire un iter preciso e sottostare alle valutazioni (e talvolta discrezionalità) del giudice. Inoltre, ciascuno di questi strumenti ha requisiti specifici e ambiti di applicazione differenti. Illustriamo le principali procedure di sovraindebitamento disponibili, con le loro caratteristiche:
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”)
Il piano del consumatore è la procedura probabilmente più adatta al caso tipico di debiti da shopping compulsivo, poiché riguarda esclusivamente il debitore consumatore. Per consumatore, in questo contesto, si intende la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali. Dunque, sono consumatori i privati cittadini che hanno accumulato debiti “di vita” (prestiti, acquisti a rate, bollette, mutui personali, fideiussioni per familiari, ecc.) e non debiti d’impresa. La nostra donna compratrice compulsiva rientra certamente in questa categoria, a meno che non abbia anche un’attività commerciale (in tal caso i debiti andrebbero separati in personali e di impresa).
Come funziona il piano del consumatore? In breve, il debitore elabora – con l’assistenza obbligatoria di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o di un professionista nominato – un piano di ristrutturazione del proprio debito, cioè un programma dettagliato su come intende pagare (in tutto o in parte) i crediti insoluti. Il piano può prevedere qualsiasi forma di soluzione finanziaria, ad esempio:
- la rateizzazione del debito in un certo numero di mesi/anni, sulla base delle entrate mensili disponibili;
- la dilazione di scadenze (magari prorogando mutui o finanziamenti oltre la loro scadenza originaria);
- il taglio parziale (stralcio) di alcune somme non sostenibili (ad esempio rinunciare agli interessi di mora, abbattere una quota di capitale ecc.);
- la cessione di beni non essenziali (es. vendere un’automobile secondaria e destinare il ricavato ai creditori);
- o una combinazione di tutte queste misure.
Il contenuto del piano è libero e personalizzato sulle possibilità effettive del debitore, fermo restando alcuni paletti: per esempio, se ci sono crediti privilegiati (come ipoteche, pegni, o debiti fiscali), il piano deve assicurare a tali creditori almeno quanto otterrebbero liquidando le garanzie o applicando le norme ordinarie di priorità. Il piano deve inoltre lasciare al debitore il minimo vitale per vivere: la legge esige che qualunque proposta non sacrifichi oltre misura le esigenze di sostentamento del debitore e della famiglia. In pratica, nella stesura si tiene conto di indicatori come l’ISEE, le spese medie per persona, eventuali affitti da pagare, ecc., in modo da garantire che la rata proposta sia realisticamente pagabile senza condannare la famiglia alla miseria.
Iter procedurale: Una volta redatto il piano, corredato di tutta la documentazione (elenco completo di tutti i creditori con importi dovuti, documenti di reddito, elenco dei beni di proprietà, elenco delle spese mensili, cause dell’indebitamento, ecc.), il debitore – tramite il suo avvocato e con l’attestazione dell’OCC – deposita un ricorso al Tribunale civile del luogo di residenza. Nel ricorso chiede l’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’art. 67 CCII (o art. 12-bis L.3/2012 se si cita la vecchia legge). A questo punto:
- Il Giudice esamina la domanda e, se la ritiene ammissibile (cioè se ricorrono le condizioni soggettive e oggettive di legge), fissa un’udienza entro 60 giorni. Contemporaneamente, ordina che tutti i creditori indicati siano notificati dell’avvenuto deposito del piano almeno 30 giorni prima dell’udienza. Questa notifica ai creditori è di solito curata dall’OCC o dall’avvocato e serve a informare i creditori che è in corso una procedura che li riguarda.
- Sospensione delle azioni esecutive: È una caratteristica fondamentale: dal momento in cui il giudice dichiara aperta la procedura (ammissibilità) e convoca l’udienza, può (su istanza del debitore) disporre la sospensione di tutte le procedure esecutive in corso a carico del debitore. Ciò significa che se erano in atto pignoramenti (sullo stipendio, sul conto, su immobili) oppure se l’Agente della Riscossione aveva iscritto fermi amministrativi sull’auto ecc., queste azioni vengono congelate fino all’esito dell’udienza di omologazione. Lo scopo è evitare che nel frattempo il patrimonio del debitore venga aggredito compromettendo la fattibilità del piano. Questa tutela è cruciale per “prendere fiato” e impedire ai creditori più veloci di avvantaggiarsi sugli altri.
- Udienza di comparizione: All’udienza fissata (davanti al giudice designato o al collegio, dipende dall’organizzazione del tribunale), il debitore – assistito dal legale e dall’OCC – deve comparire. I creditori hanno facoltà di intervenire per esprimere le loro eventuali osservazioni o opposizioni. Da notare: nel piano del consumatore, a differenza di altre procedure, non si svolge un voto dei creditori. Il loro consenso formale non è richiesto. Possono però contestare questioni di merito, ad esempio sostenere che il piano non conviene rispetto alla liquidazione, oppure che il debitore è stato malizioso nel creare i debiti (contestazione di meritevolezza), o ancora sollevare errori nei conteggi. Tutte queste contestazioni vengono valutate dal giudice.
- Valutazione del giudice e omologazione: Il giudice decide se omologare (approvare) il piano proposto, tenendo presenti due criteri fondamentali: (a) la fattibilità economica del piano e (b) la convenienza per i creditori rispetto alle alternative. – Fattibilità significa che il piano deve essere realistico: le entrate future previste (stipendi, pensioni, contributi di terzi) devono essere sufficienti a coprire le rate promesse, e gli eventuali eventi straordinari ipotizzati (vendite di beni, ecc.) devono essere plausibili. Il giudice fa spesso riferimento alla relazione dell’OCC, che attesta la sostenibilità del piano. – Convenienza significa che nessun creditore venga trattato peggio di come verrebbe trattato se si liquidasse tutto il patrimonio del debitore. Ad esempio, se un creditore ha un’ipoteca sulla casa e il piano prevede che quel creditore prenda meno di quanto otterrebbe pignorando e vendendo la casa, il giudice difficilmente omologherà (a meno che il creditore ipotecario stesso non sia d’accordo). In pratica, il giudice verifica che il piano dia ai creditori garantiti il rispetto delle loro cause di prelazione, e ai chirografari almeno un dividendo ragionevole in rapporto a ciò che c’è.
Inoltre, nel piano del consumatore, la legge richiede espressamente al giudice di valutare la meritevolezza del debitore: deve escludere che il sovraindebitamento sia dovuto a comportamenti fraudolenti o gravemente imprudenti del debitore. Ad esempio, se risultasse che la persona ha continuato a fare spese pazze sapendo di non poter pagare (abuso del credito), il giudice potrebbe rigettare il piano perché mancante del requisito soggettivo. Nella prassi si guarda se il debitore ha dissimulato debiti all’atto di ottenerne di nuovi, se ha tentato di frodare i creditori (vendendo beni prima della procedura), se ha un tenore di vita incoerente con il suo stato (es. guida un’auto di lusso nonostante i debiti). Nel caso del compulsive buying, il disturbo in sé non è colpa grave, ma se la persona ha accumulato 100.000 € di debiti comprando beni voluttuari senza considerare le entrate, qualche giudice potrebbe interpretarlo come “colpa grave” (grave imprudenza nell’indebitarsi). Molto dipende dalla storia raccontata nella relazione: se si evidenzia che dietro c’è una patologia e non mera superficialità, il giudice potrebbe considerarla comunque meritevole.
Se tutti i requisiti sono soddisfatti, il Tribunale emette un decreto di omologazione del piano, solitamente entro 6 mesi dal deposito del ricorso (termine indicativo, talora si va un po’ oltre, soprattutto se ci sono opposizioni). - Effetti dell’omologazione: Dal momento in cui il piano è omologato dal giudice, esso diventa vincolante per tutti i creditori anteriori indicati. Anche i creditori dissenzienti o che non si sono presentati vengono obbligati dal provvedimento: non potranno più intraprendere né proseguire azioni esecutive individuali contro il debitore per i crediti oggetto del piano. Si apre quindi la fase di esecuzione del piano: il debitore inizia a pagare secondo le modalità stabilite (ad es., versa mensilmente la somma X all’OCC o a un fiduciario perché la distribuisca ai creditori, oppure vende il bene Y entro la data Z, etc.). Durante l’esecuzione, eventuali problemi o modifiche devono essere sottoposti al giudice (è possibile richiedere lievi modifiche se cambiano le circostanze, ma non si può stravolgere il piano senza ripresentare da capo la procedura).
- Esdebitazione finale: Una volta che il debitore ha integralmente eseguito il piano omologato – ovvero ha pagato tutte le somme promesse secondo il piano – egli ha diritto di ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione di tutti i debiti residui che erano compresi nel piano e che non sono stati soddisfatti per intero. In altre parole, se dal piano risultava che avrebbe pagato, poniamo, il 50% di ogni credito chirografario, il restante 50% viene legalmente annullato: i creditori non potranno mai più pretendere nulla di più su quei crediti. L’esdebitazione avviene di solito automaticamente con il decreto che chiude la procedura, ma può anche essere richiesta con apposita istanza se serve un provvedimento formale. Da quel momento, il debitore è ufficialmente libero dai debiti pregressi (tranne quelli esclusi per legge come alimenti, ecc. come detto). Questa “fresh start” è lo scopo ultimo della procedura, per ridare una seconda chance a chi è stato oppresso dai debiti.
Pro e contro del piano del consumatore: Questo strumento presenta diversi vantaggi:
- Nessun voto dei creditori: Il fatto che non serva il consenso dei creditori è un enorme vantaggio. Significa che anche se qualche creditore è contrario, il giudice può approvare lo stesso il piano se lo ritiene equo. Ciò evita situazioni di stallo dovute a un creditore “ostruzionista”.
- Salvaguardia immediata: Già con la presentazione del ricorso si può ottenere la sospensione dei pignoramenti in corso. Questo toglie pressione al debitore e impedisce la liquidazione forzata di beni che magari il piano intende invece preservare (ad es. la casa di abitazione).
- Flessibilità: Il piano può essere cucito sulle esigenze e le possibilità del singolo. Ad esempio, può prevedere rate piccole ma protratte per molti anni (ci sono stati piani anche decennali), cosa che in un concordato fallimentare tradizionale non sarebbe possibile. Un orientamento giurisprudenziale recente ha persino ammesso che il piano del consumatore possa includere i debiti garantiti da ipoteca (mutuo casa) dilazionandoli oltre il limite standard di 1 anno di moratoria previsto dalla legge, purché i creditori ipotecari siano messi in condizione di dire la loro e il pagamento proposto sia comunque vantaggioso. La Cassazione stessa nel 2024 ha confermato che è possibile ristrutturare un mutuo immobiliare nell’ambito del piano, andando oltre i termini di legge, se il creditore garantito acconsente e la soluzione appare la migliore per tutti.
- Coinvolgimento di tutti i debiti: Nel piano si possono far confluire anche debiti verso il fisco, verso ex locatori, verso fornitori, ecc. Non c’è una categoria esclusa in partenza (salvo quelli non esdebitabili per legge, che comunque possono essere pagati in parte nel piano, pur restando l’eventuale eccedenza dovuta dopo – ad esempio le multe possono essere inserite per pagarle in parte, ma la quota non pagata non sarà cancellata).
- Protezione della casa e dei beni essenziali: Se l’obiettivo è salvare la casa di abitazione, il piano del consumatore è spesso la via migliore. Il giudice può autorizzare una moratoria delle rate del mutuo fino a 1 anno e poi riprenderle regolarmente dentro il piano, oppure allungare la durata del mutuo concordandolo con la banca. Durante la procedura, eventuali aste giudiziarie vengono sospese, dando il tempo di trovare un accordo sul bene ipotecato. All’esito, se il piano è eseguito, la casa rimane al debitore. In un’alternativa di liquidazione, la casa sarebbe probabilmente venduta.
Naturalmente ci sono anche svantaggi e limiti:
- Rigorosità dei requisiti: Circa il 40% dei piani presentati viene rigettato dai tribunali. Le cause tipiche di rigetto sono: mancanza di meritevolezza (es. il giudice ritiene che il debitore abbia colpe gravi) oppure scarsa fattibilità (il piano è troppo ottimistico o non garantisce abbastanza ai creditori privilegiati). Ad esempio, la Cassazione ha confermato il rigetto di un piano in cui il debitore, quando chiese i finanziamenti, aveva omesso di dichiarare altri prestiti in corso nel questionario sul merito creditizio: tale omissione fu vista come mala fede ed è costata l’inammissibilità del piano. È quindi fondamentale presentare un piano onesto, completo di tutte le informazioni, e dimostrare di avere agito il più correttamente possibile.
- Durata e impegno: Anche se la procedura di omologa può concludersi in pochi mesi, l’esecuzione del piano può durare anni. Durante questo periodo, il debitore deve rispettare con grande disciplina i pagamenti concordati. Un mancato pagamento o un ritardo significativo potrebbero portare alla revoca del beneficio e far riaprire le azioni esecutive (di solito il decreto di omologa stabilisce che, in caso di inadempimento, i creditori riacquistano pieni diritti). Quindi ci vuole stabilità di reddito o comunque un’attenta pianificazione. Se il debitore perde il lavoro durante il piano, occorrerà informare il giudice e cercare di modificare il piano (non semplice) o rischiare la decadenza.
- Coinvolgimento del tribunale e pubblicità: La procedura di sovraindebitamento, pur non essendo pubblicata in registri delle imprese, viene annotata in pubblici registri (Registro delle procedure di insolvenza tenuto dal Ministero Giustizia) e talvolta comunicata nei registri immobiliari se coinvolgono beni immobili. Inoltre, sebbene non ci sia un vero fallimento, si tratta comunque di una procedura concorsuale, con atti depositati e consultabili dalle parti interessate. Per alcune persone questo può rappresentare un (comprensibile) disagio sul piano reputazionale. Tuttavia, va detto che la sensibilità su queste procedure sta cambiando: sono viste come un rimedio sociale, non come un’onta.
In conclusione, il piano del consumatore è uno strumento potentissimo per chi, come la nostra debitrice compulsiva, dispone di un reddito (stipendio, pensione, ecc.) con cui può onorare almeno parzialmente i debiti nel tempo, ma ha bisogno di respiro da subito e di uno sconto sul totale. È ideale per dipendenti, pensionati o autonomi con entrate regolari, che vogliono pagare una rata commisurata alle proprie capacità. Se invece la persona è completamente priva di reddito o patrimonio, questo strumento potrebbe non essere adatto (perché non avrebbe senso un piano di pagamenti a rate se non c’è nulla da pagare: in tal caso si guarderà alla liquidazione controllata o all’esdebitazione incapiente, come vedremo). Nel caso stia leggendo questa guida proprio una persona con debiti da shopping compulsivo, il messaggio è: non scoraggiarsi se i debiti sembrano troppi, la legge potrebbe permettervi di pagarne solo una parte e liberarvi del resto, a patto di mettere sul tavolo tutto ciò che ragionevolmente potete dare e di agire in buona fede.
Concordato minore (ex accordo di composizione della crisi)
Il concordato minore è l’erede diretto dell’“accordo di composizione della crisi” previsto dalla vecchia L.3/2012. Questa procedura è pensata principalmente per i debitori che hanno partita IVA e svolgono attività d’impresa o professionale, ma che rientrano comunque tra i non fallibili. Tipicamente si tratta di piccoli imprenditori individuali, professionisti (avvocati, architetti, artigiani ecc.), soci illimitatamente responsabili di società di persone, startup non ancora “grandi”, ecc.. Spesso tali soggetti accumulano debiti sia verso fornitori/tasse (debiti da attività) sia debiti personali. Il concordato minore permette di affrontare unitariamente la crisi, mantenendo eventualmente l’attività in vita.
Principale differenza rispetto al piano del consumatore: Nel concordato minore, il debitore negozia con i creditori un accordo di ristrutturazione, che per essere valido deve essere approvato da una maggioranza qualificata di creditori. Dunque qui il consenso dei creditori è determinante (a differenza del piano consumatore). Attualmente, con la riforma, la maggioranza richiesta è almeno il 50% dei crediti (calcolati sul totale del passivo), mentre in passato era il 60%. Ciò rende un po’ più facile ottenere l’approvazione.
Funzionamento in sintesi: La procedura è simile per certi versi a un piccolo concordato preventivo:
- Il debitore, tramite OCC e avvocato, predispone una proposta di concordato minore, contenente l’elenco di tutti i creditori, l’ammontare dei debiti, e il piano di ristrutturazione con eventuali garanzie offerte. Può prevedere anche qui dilazioni, stralci, cessioni di beni, ecc., ma l’ottica è più negoziale: spesso si suddividono i creditori in classi (gruppi con posizione giuridica omogenea) e si offrono condizioni specifiche per ciascuna classe.
- Il tribunale, verificata l’ammissibilità, convoca i creditori ad un’assemblea o avvia una procedura di voto scritto. I creditori esprimono il loro voto (favorevole o contrario). Se si raggiunge la maggioranza del 50% dei crediti votanti a favore (e l’eventuale maggioranza nelle singole classi se previste), il concordato è approvato.
- A questo punto il tribunale procede all’omologazione: se non vi sono opposizioni o se quelle proposte vengono respinte, il giudice omologa l’accordo raggiunto, rendendolo vincolante anche per i creditori dissenzienti o non votanti.
- Durante la pendenza della procedura, di norma, il giudice può disporre misure protettive similmente al piano: sospensione dei procedimenti esecutivi, ecc., per dare spazio alla trattativa.
- Effetti: con l’omologa, il piano concordatario diventa obbligatorio per tutti. Il debitore deve eseguire le prestazioni previste (pagare le rate concordate, consegnare i beni se previsto, etc.). Se esegue correttamente, al termine ottiene l’esdebitazione per i debiti residui analogamente al piano del consumatore.
- Se invece la maggioranza non approva la proposta, o se l’accordo salta perché il debitore non rispetta i pagamenti, allora si torna alla normalità: i creditori potranno agire singolarmente (oppure il debitore può tentare altra procedura come la liquidazione).
Vantaggi del concordato minore: È uno strumento costruito per salvare le attività imprenditoriali piccole dalla chiusura. Permette infatti di:
- Evitare il fallimento e proseguire l’attività sotto condizioni nuove e sostenibili. Ad esempio, un artigiano che ha debiti con fornitori e banche può concordare di pagarli parzialmente in 5 anni, continuando però a lavorare e a produrre reddito con cui paga tali somme.
- Negoziare creativamente con i creditori: essendoci il voto, i creditori hanno facoltà anche di accettare proposte più originali, come conversione del credito in partecipazioni, o attendere lunghi periodi, purché convincente.
- Anche qui, bloccare azioni esecutive nel frattempo (nessun creditore può “chiamarsi fuori” e pignorare mentre è in corso la procedura, pena vanificare tutto).
Svantaggi e limiti:
- Necessità della maggioranza dei voti: se i creditori sono molti e disuniti, non è semplice ottenere il 50%. Basta un grosso creditore (es. una banca con il 60% del totale) contrario per far fallire l’accordo.
- Non disponibile ai consumatori puri: se la nostra debitrice non ha partita IVA o non è imprenditrice, non può usare questo strumento. Nel suo caso, semmai potrebbe essere coinvolto il marito imprenditore in un concordato minore, ma lei come consumatrice utilizzerebbe il piano.
- Sanzioni per inadempimento: In un concordato minore è ancora più stringente il fatto che se il debitore non rispetta l’accordo, i creditori tornano liberi. Non solo: potrebbero far valere il titolo (decreto di omologa) come titolo esecutivo immediato.
- Costi e formalità leggermente maggiori: L’iter di convocazione e voto dei creditori aggiunge complessità. Inoltre, spesso serve predisporre proposte dettagliate per classi, relazioni aggiuntive, ecc.
In pratica, per la persona affetta da shopping compulsivo il concordato minore entra in gioco solo se ella è anche un’imprenditrice (anche piccolissima). Ad esempio, se la nostra debitrice gestiva un negozio e parallelamente ha debiti personali, potrebbe dover combinare un concordato minore per i debiti d’impresa e un piano del consumatore per i debiti personali (o inserirli insieme se i creditori personali accettano di votare in un concordato, ma occorre valutare la categoria). Uno scenario misto è complicato ma possibile: il Codice consente di presentare domande congiunte o parallele se una parte del debito è consumer e una business (come nel caso di Laura nell’esempio pratico più avanti). In generale, però, se la persona non ha un’attività, questo paragrafo può essere letto a titolo informativo: il suo strumento rimane il piano del consumatore.
Liquidazione controllata del patrimonio (ex liquidazione del patrimonio del consumatore)
La liquidazione controllata è la procedura destinata a quei debitori sovraindebitati per i quali una ristrutturazione tramite rate o accordi non è praticabile o non è sufficiente. Consiste, essenzialmente, nel mettere a disposizione dei creditori tutto il patrimonio del debitore (salvo i beni indispensabili) affinché sia liquidato (venduto) e il ricavato distribuito tra i creditori, secondo le regole delle prelazioni, dopodiché il debitore viene liberato dai debiti residui. Può essere vista come l’equivalente di un fallimento personale semplificato, anche se tecnicamente non è un fallimento e non comporta stigma di insolvenza dolosa.
Chi vi ricorre? Possono accedere alla liquidazione controllata tutti i debitori non fallibili, sia consumatori sia imprenditori minori. Spesso vi si ricorre quando:
- Il debitore ha qualche bene rilevante da liquidare (es. una casa, un’auto di valore, ecc.) e la ristrutturazione dei debiti appare impossibile; oppure
- Il debitore non ha entrate per sostenere un piano di rientro, per cui l’unica via per attivare l’esdebitazione è liquidare quel poco patrimonio che ha;
- Oppure quando un tentativo di piano o concordato è fallito e si vuole comunque risolvere la situazione liquidando tutto in modo ordinato.
Come funziona in breve:
- Il debitore presenta al tribunale un ricorso per aprire la liquidazione controllata ex art. 268 CCII (ex art.14-ter L.3/2012), allegando l’inventario dei beni posseduti, l’elenco dei creditori, e la documentazione economica.
- Il tribunale, se ricorrono i presupposti, dichiara aperta la liquidazione con un apposito decreto e nomina un liquidatore (spesso un commercialista o un professionista nominato dall’OCC).
- Da quel momento, i beni di proprietà del debitore (ad eccezione di quelli impignorabili per legge, come vestiti, mobili essenziali, strumenti di lavoro essenziali, etc.) entrano nella massa attiva da liquidare. Il liquidatore prende in consegna i beni, eventualmente li inventaria e li mette all’asta o li vende in blocco, a seconda dei casi. Se il debitore ha un reddito, il giudice può stabilire che una parte di esso, eccedente il minimo vitale, debba affluire alla liquidazione per un certo periodo (di solito per tutta la durata della procedura, max 4 anni).
- Durante la liquidazione, scattano analogamente il divieto di azioni esecutive individuali e di iniziare o proseguire pignoramenti: i creditori devono presentare le loro domande di ammissione al passivo al liquidatore (un po’ come nel fallimento). Il liquidatore esamina i crediti, predispone uno stato passivo e poi un piano di riparto dei ricavi delle vendite, da sottoporre al giudice per l’approvazione.
- Una volta venduti i beni e distribuito tutto il ricavato, la procedura si chiude e il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione di quel che non è stato pagato. Una novità del CCII è che questa esdebitazione per il sovraindebitato meritevole scatta anche senza bisogno di ulteriore istanza, dopo 3 anni dalla chiusura della liquidazione, se non ci sono frodi (o anche prima se tutti i beni sono stati liquidati e ripartiti).
In altri termini, la liquidazione è: “Prendete tutto quello che ho adesso, dividetevelo, e in cambio sollevatemi dal dovere di pagarvi l’eventuale resto in futuro.” È una resa controllata. Il vantaggio per il debitore è che una volta sopportata la perdita dei beni, riparte pulito. Il vantaggio per i creditori è che si evitano lunghe attese o piani incerti: ottengono subito (relativamente) ciò che si può ricavare e sanno che almeno quell’importo verrà equamente distribuito.
Quando conviene? La liquidazione controllata è indicata in situazioni come quella di Giuseppe nel nostro esempio più avanti: persona disoccupata senza reddito, con qualche piccolo bene vendibile, ma impossibilitata a proporre qualsiasi pagamento significativo ai creditori. In tal caso, liquidare quei pochi beni e fare tabula rasa è la strada sensata. Anche nel caso in cui il debitore abbia una casa ma un reddito insufficiente a mantenere un mutuo o a fare un piano (es. ha perso il lavoro), può decidere di lasciar vendere la casa nella liquidazione invece di subire pignoramenti scoordinati.
Vantaggi della liquidazione controllata:
- Comprende ogni bene e debito: è la procedura omnibus, possono entrarci tutti i debiti (anche qui con eccezione che le sanzioni e alimenti non si estinguono, ma comunque verranno in parte soddisfatti se possibile) e tutti i beni disponibili. Il debitore collabora a una sorta di resa dei conti finale, con l’idea che poi la sua fedina economica venga pulita.
- Esdebitazione anche se i creditori ottengono poco: A differenza di un piano dove serve offrire almeno un quid ragionevole, qui i creditori prendono ciò che c’è. Se ad esempio c’è solo il 5% di attivo rispetto ai debiti, pazienza, dopo si chiude e amen. Purché il debitore abbia agito in buona fede, non importa la percentuale pagata: tutto il resto viene cancellato. Questo è un principio molto forte di tutela del debitore onesto ma sfortunato.
- Durata definita: Spesso la liquidazione si conclude in un tempo relativamente breve per la procedura in sé (1-2 anni per vendere e distribuire). Il debitore deve aspettare fino a 3 anni per l’esdebitazione automatica, ma durante quei 3 anni se non ha redditi non deve fare nulla di particolare se non magari comunicare eventuali sopravvenienze (se eredita qualcosa ad esempio, potrebbe doverlo conferire alla liquidazione aperta, perché i creditori ne abbiano beneficio). Dopo 3 anni max, è libero.
- Sospensione pignoramenti: Anche qui, come per le altre procedure, dal decreto di apertura, i pignoramenti individuali vengono bloccati e accorpati nella procedura collettiva. Questo evita corse tra creditori e vendite all’asta disordinate.
Svantaggi e implicazioni:
- Perdita dei beni: Il rovescio della medaglia ovvio è che il debitore perde la disponibilità del suo patrimonio. Se c’è una casa, verrà con alta probabilità venduta all’asta (salvo magari accordi con creditori per tenerla, ma sono eccezioni difficili). Se c’è un’auto, pure (a meno che sia indispensabile per lavoro e di modico valore, in tal caso il giudice potrebbe lasciarla fuori come bene strumentale essenziale).
- Controllo del reddito: In liquidazione, il debitore potrebbe dover vivere al minimo. Ad esempio, se lavora, di solito il giudice stabilisce che una parte dello stipendio mensile eccedente il necessario vada conferita alla procedura, analogamente a come succede nel fallimento col cosiddetto assegno di mantenimento per il fallito. Ciò può essere percepito come penalizzante (anche se nella pratica spesso i redditi bassi non vengono intaccati, mentre quelli più alti sì).
- Stigma: pur non essendo chiamato fallimento, la liquidazione è molto simile concettualmente. Il debitore subisce un’espropriazione controllata. Dovrà probabilmente lasciare la casa, o altre proprietà. Inoltre, alcuni contratti potrebbero risentirne (es. se è in affitto, a volte i proprietari storcono il naso sapendo che c’è stata una procedura concorsuale; se è amministratore di società potrebbe dover lasciare l’incarico durante la procedura, etc.).
- Incompatibilità futura: Dopo aver ottenuto l’esdebitazione, il debitore non può ottenerne un’altra per almeno 5 anni (come regola generale del Codice). Quindi la liquidazione è in genere one-shot, come anche il piano.
Per la nostra debitrice compulsiva, la liquidazione controllata sarebbe indicata solo se: (a) non ha un reddito da offrire per un piano, e (b) ha comunque qualche asset aggredibile. Se fosse nullatenente e senza reddito, si potrebbe pensare direttamente alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente, di cui ora parliamo.
Esdebitazione del debitore incapiente (procedura “a costo zero”)
L’esdebitazione del debitore incapiente è un istituto di introduzione recente (previsto dall’art. 14-quaterdecies L.3/2012 e ora dall’art. 283 CCII) e rappresenta una sorta di ultima spiaggia per chi si trova in assoluta indigenza. Consente, in via eccezionale, al debitore che non ha alcuna capacità di offrire utilità ai creditori – né beni da liquidare, né reddito aggredibile, neanche in prospettiva – di ottenere comunque l’esdebitazione totale dei propri debiti senza pagare nulla ai creditori. È una forma di “fresh start” immediato, che in passato non esisteva (prima del 2021 circa, se uno non aveva nulla non poteva far altro che portarsi i debiti a vita, perché per avere l’esdebitazione bisognava passare per un piano o una liquidazione). Ora, la legge riconosce che ci sono situazioni disperate in cui costringere comunque a una procedura liquidatoria non avrebbe senso (perché i costi supererebbero i ricavi), e allora permette di chiudere la partita liberando il debitore, purché sia accertata la sua buona fede e l’impossibilità oggettiva di pagare.
Requisiti chiave:
- Il debitore deve essere persona fisica (vale solo per individui, non per imprese).
- Deve trovarsi in condizione tale da “non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in futuro”. Cosa significa? In pratica, nessun bene di valore disponibile (né immobili né mobili di valore, forse solo effetti personali di modico valore) e nessun reddito se non magari sussidi minimi, e neanche aspettative di miglioramento imminente. Ad esempio, un disoccupato cronico senza patrimonio è un incapiente. Se invece uno ha anche solo un’auto vendibile a 5.000 €, allora non è incapiente, meglio fare la liquidazione che quell’auto la vende. La norma è pensata per chi davvero non ha nulla da dare.
- Deve aver collaborato e fornito tutti i documenti, e possibilmente aver almeno tentato una procedura di composizione. In origine c’era l’idea che prima l’incapiente dovesse provare la liquidazione e poi, se deserta (nessun attivo), chiedere l’esdebitazione. Col nuovo Codice pare possibile chiederla direttamente, ma comunque bisogna dimostrare di aver fatto valutare la situazione ad un OCC (che attesti la condizione di incapienza).
- Deve essere meritevole: quindi niente frodi, niente distrazione di beni prima di chiedere l’esdebitazione, nessuna colpa grave nel creare i debiti. L’esempio classico di meritevole incapiente: chi si è indebitato per eventi imprevedibili (malattia, perdita lavoro) e non per spese voluttuarie. Una riflessione: lo shopping compulsivo in sé non è un evento sfortunato esterno, ma un comportamento del debitore. Questo potrebbe complicare la valutazione di meritevolezza per l’incapiente: se uno ha speso e spanto e poi dice “non ho nulla”, alcuni giudici potrebbero dire “te la sei cercata” (colpa grave). Altri però, riconoscendo la natura patologica, potrebbero considerarlo comunque meritevole se ha preso coscienza del problema e non ha tenuto condotte fraudolente. In un caso reale a Bergamo, ad esempio, un debitore incapiente con 177.000 € di debiti è stato esdebitato perché il tribunale ha riconosciuto che era vittima di eventi sfortunati (perdita del lavoro, pignoramento stipendio, ecc.) e che le finanziarie stesse avevano concesso prestiti senza valutare adeguatamente la sua capacità di rimborso. Inoltre era evidente che il suo reddito era sotto il minimo vitale e non possedeva nulla se non un vecchio motorino.
Procedura: Il debitore presenta una domanda di esdebitazione incapiente al tribunale, di solito tramite OCC, allegando la documentazione che provi lo stato di nullatenenza e un resoconto delle cause dell’indebitamento. Il tribunale fissa un’udienza e sente anche i creditori se del caso. Se ritiene tutto regolare, emette un decreto di esdebitazione dell’incapiente, che dichiara inesigibili tutti i debiti del richiedente. Questo decreto può contenere condizioni, ad esempio l’obbligo per il debitore, qualora nei successivi 4 anni migliori la propria situazione (mettiamo che trovi un buon lavoro o vinca alla lotteria o riceva un’eredità), di pagare comunque ai creditori una parte di quanto ricevuto oltre il necessario al suo sostentamento. In pratica la legge prevede che l’esdebitazione dell’incapiente può essere “revocata” parzialmente se entro quattro anni dall’omologa il debitore incapiente diventa capiente inaspettatamente (sarebbe un arricchimento senza causa a scapito dei creditori se non condividesse quella fortuna inattesa). Trascorsi i 4 anni, qualunque migliorìa sarà solo sua e i creditori non potranno più rivalersi. Questa clausola serve a bilanciare il fatto di dare uno sconto totale immediato.
Effetto: Il debitore viene immediatamente liberato dai debiti senza sborsare nulla. Per i creditori è ovviamente uno scenario pessimo (prendono zero); ecco perché va concesso solo quando è chiaro che comunque non avrebbero potuto ottenere nulla, neppure pignorando vita natural durante il debitore (che magari vive di sole pensione sociale impignorabile).
Utilità pratica: L’esdebitazione incapiente è una novità di grande civiltà giuridica, perché riconosce il diritto al fallimento onesto anche a chi è poverissimo. Pensiamo a situazioni di indebitamento derivante da patologie (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, ecc.) in cui la persona ha bruciato tutto e ora vive solo di aiuti: se dimostra di aver intrapreso un percorso di cura e di ravvedimento, questa procedura le evita di rimanere perseguitata dai debiti magari per il resto della vita (il che spesso la spingerebbe in economia sommersa o disperazione). Dà la possibilità di ripartire davvero da zero anche a chi non ha nulla.
Casi pratici: Nel 2023 si sono viste le prime applicazioni. Nel caso citato di Bergamo, un debitore con famiglia a carico, pignoramenti in busta paga e reddito basso, è stato dichiarato incapiente e liberato di oltre €177.000 di debiti. Il giudice ha notato come gli istituti finanziatori avessero contribuito alla sua condizione concedendogli prestiti non sostenibili (questo ricollega al concetto di merito creditizio: non potendo biasimare del tutto il debitore se le banche lo hanno sovraindebitato). È stato dunque ritenuto equo concedergli l’esdebitazione immediata. Tutte le trattenute stipendiali sono state cessate e lui ha potuto ricominciare a usare il suo intero – seppur modesto – stipendio per la famiglia, senza più versarlo ai creditori in buona parte.
Conclusione su questo strumento: Per la nostra donna indebitata compulsiva, l’esdebitazione incapiente sarebbe la via d’uscita se davvero è rimasta senza nulla: ad esempio, ha perso il lavoro, non ha immobili, magari vive ospite di qualcuno, e i debiti (carte, prestiti) continuano a crescere di interessi. Invece di aspettare che i creditori la perseguitino inutilmente, può rivolgersi a un OCC e valutare se sussistono le condizioni per chiedere subito l’esdebitazione. Deve però mettere in conto che il tribunale guarderà con attenzione al suo comportamento pregresso: se il suo shopping compulsivo ha causato i debiti, dovrà convincere che era in preda a un disturbo e non semplicemente per frivolezza intenzionale, e che ora ha cambiato condotta (ad esempio è in terapia, ha chiuso le carte di credito, ecc.), altrimenti potrebbe emergere un dubbio di “colpa grave” che ostacolerebbe la concessione del beneficio. Se concessa, in ogni caso, si tratta di un colpo di spugna totale sui debiti. È bene ricordare che questa possibilità viene data una sola volta: la legge infatti vieta di ottenere di nuovo un’esdebitazione incapiente nei 5 anni successivi, e in generale non più di due volte in vita (per la seconda volta solo se i debiti nuovi sono dovuti a cause indipendenti dalla volontà, e comunque con più rigore). Quindi va usata come extrema ratio.
Di seguito, per maggiore chiarezza, presentiamo una tabella riepilogativa delle quattro procedure di sovraindebitamento illustrate, confrontandone i punti principali:
(Legenda: OCC = Organismo di Composizione della Crisi; CCII = Codice crisi d’impresa e insolvenza; “prelazione” = ordine di priorità tra creditori garantiti/chirografari; esdebitazione = cancellazione debiti residui.)
Come evidenziato dalla tabella, ciascuna procedura ha una logica diversa. Nel seguito, presentiamo delle simulazioni pratiche – casi esemplificativi – per capire come scegliere la strada giusta e quali risultati concreti si possono ottenere.
Casi pratici e simulazioni (esempi di applicazione)
Per rendere più concreto quanto esposto finora, immaginiamo alcune situazioni tipo che coinvolgono debiti da acquisti compulsivi e vediamo come potrebbero essere risolte con gli strumenti descritti. I seguenti esempi sono ipotetici (sebbene ispirati a casi reali) e servono a illustrare l’approccio da seguire.
Caso 1: “Elisa” – Debitrice con reddito stabile e debiti da shopping
Profilo: Elisa (nome di fantasia) ha 40 anni, è impiegata statale con uno stipendio netto di circa €1.500 al mese. In seguito a difficoltà personali (es. depressione successiva a una separazione), ha sviluppato un comportamento di shopping compulsivo. Negli ultimi anni ha accumulato circa €60.000 di debiti con varie finanziarie e banche: tre carte di credito revolving al limite, un prestito personale per spese mediche e numerosi acquisti a rate di elettronica e abbigliamento. Non possiede casa (vive in affitto) né auto di particolare valore. Il suo TFR maturato è di circa €10.000. A causa delle rate mensili complessive (€1.200 sommando tutto) Elisa non riesce più a far fronte alle spese ordinarie ed è in persistente ritardo nei pagamenti da 6 mesi. I creditori hanno iniziato a inviarle ingiunzioni di pagamento. Elisa è in cura presso uno psicologo per il suo disturbo e vuole risolvere la situazione debitoria in modo onorevole, ma non ha modo di pagare €60.000 in tempi brevi.
Opzione scelta: Piano del consumatore. Elisa si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) della sua zona e, con l’aiuto di un gestore della crisi e di un avvocato, predispone un piano di ristrutturazione. Nel piano propone di:
- consolidare tutti i debiti in un’unica soluzione di pagamento mensile;
- impegnarsi a versare €400 al mese per 5 anni (attingendo dal suo stipendio; €400 su €1500 è sostenibile, lasciandole €1100 per vivere);
- inoltre, offrire €2.000 immediatamente attingendo dal TFR (tramite anticipo autorizzato dal datore di lavoro) per dare un acconto ai creditori.
In totale, la proposta di Elisa ammonta a circa €26.000 da pagare in 5 anni, a fronte di €60.000 di debito iniziale (quindi prevede uno stralcio di oltre la metà del dovuto). Il piano mostra che €400/mese sono ciò che Elisa può pagare mantenendo un tenore di vita dignitoso e proseguendo la terapia. L’OCC redige una relazione positiva, certificando che il piano è fattibile ed evidenziando che le cause del sovraindebitamento risiedono in un disturbo compulsivo in trattamento (quindi Elisa non ha agito con dolo).
Il Tribunale ammette il ricorso e sospende immediatamente le azioni esecutive avviate dalle finanziarie. In udienza, alcuni creditori (soprattutto le finanziarie minori) contestano che 5 anni sono troppi e la percentuale di recupero è bassa (~43%). Tuttavia, il giudice valuta che:
- Elisa è meritevole, avendo agito senza malafede e anzi cercando aiuto medico.
- La sostenibilità dei €400/mese è dimostrata dal suo contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- La convenienza del piano è accettabile: se i creditori procedessero individualmente, Elisa è nullatenente e potrebbero tuttalpiù pignorarle lo stipendio per 1/5 (€300 al mese), e comunque Elisa potrebbe licenziarsi o spostarsi, rendendo lungo il recupero. Con il piano invece ottengono poco più (400€) in modo strutturato e certo.
- Non vi sono alternative migliori: la liquidazione darebbe zero (non ha beni), l’esdebitazione incapiente darebbe zero. Il piano offre 26k sicuri.
Il Tribunale quindi omologa il piano del consumatore di Elisa. Da quel momento, Elisa versa ogni mese €400 all’OCC che li ripartisce pro-quota ai creditori. Dopo 60 mesi di pagamenti puntuali (e con sacrifici ma sostenibili: Elisa ha ridotto le spese superflue e, supportata dallo psicologo, ha imparato a controllare gli impulsi di acquisto), Elisa ha versato interamente i €24.000 previsti + €2.000 iniziali (che erano già stati accantonati dal TFR). Ottiene così il decreto di esdebitazione: oltre €34.000 di debiti residui vengono cancellati. Le segnalazioni in Centrale Rischi e CRIF relative a quei crediti vengono rimosse in seguito alla comunicazione dell’avvenuta esdebitazione. Elisa può finalmente dirsi fuori dal tunnel: ha preservato il suo stipendio da pignoramenti più onerosi e ha pagato solo la parte di debito che realisticamente poteva, ottenendo la libertà finanziaria. Questo caso dimostra come un debitore con un reddito stabile ma debiti eccessivi può, tramite il piano del consumatore, azzerare oltre la metà dei debiti causati dallo shopping compulsivo, convertendo un potenziale dramma in un percorso sostenibile di rientro.
Risultato: Debiti iniziali €60.000 -> pagati €26.000 in 5 anni, nessun bene essenziale perso, debitrice esdebitata e riabilitata (anche psicologicamente, grazie al parallelismo della terapia). Senza il piano, Elisa avrebbe subito pignoramenti per anni e comunque non avrebbe mai estinto tutto il dovuto, con rischio di peggiorare la sua condizione mentale. Con il piano ha avuto uno strumento “su misura” di difesa legale.
Caso 2: “Giuseppe” – Debitore disoccupato e nullatenente, indebitato per acquisti voluttuari
Profilo: Giuseppe ha 55 anni ed è attualmente disoccupato. In passato, quando aveva un lavoro modesto, ha contratto vari finanziamenti personali per togliersi qualche sfizio (abbigliamento firmato, elettronica, piccoli elettrodomestici non indispensabili). Ha vissuto per un periodo al di sopra delle sue possibilità, accumulando circa €15.000 di debiti su 4 diversi prestiti/revolving. Ora vive da solo in affitto, non ha immobili di proprietà né auto (solo uno scooter vecchio). Ha esaurito i risparmi e sopravvive con lavoretti occasionali e con una minima indennità di disoccupazione. I creditori lo tempestano di chiamate e minacciano azioni legali. Giuseppe riconosce di aver sbagliato ma ormai è in una situazione di indigenza totale: anche volendo, non ha risorse da offrire.
Opzione scelta: Liquidazione controllata del patrimonio, finalizzata all’esdebitazione. Giuseppe, tramite uno sportello di un’associazione di consumatori, viene indirizzato a un OCC. Dall’analisi risulta che il suo unico “patrimonio” consiste in un vecchio computer e alcuni oggetti (un orologio, pochi gioielli di famiglia) di modesto valore stimabile in poche centinaia di euro. Non ha redditi mensili fissi. Un piano del consumatore sarebbe inutile, perché non avrebbe entrate per pagare rate significative. Pertanto si decide di avviare la liquidazione controllata:
- Giuseppe deposita ricorso di liquidazione al Tribunale, elencando tutti i beni posseduti (il PC, i gioielli) e tutti i debiti.
- Il Tribunale apre la procedura, nomina un liquidatore e sospende eventuali azioni esecutive (anche se in realtà i creditori non avevano ancora fatto decreti ingiuntivi, vista la situazione).
- Il liquidatore mette in vendita gli oggetti: il computer viene venduto per €100, i piccoli gioielli per €300, totale ricavato €400 circa. Queste somme, dedotte le spese, vengono distribuite ai 4 creditori in percentuale (alla fine ognuno riceve pochi decine di euro, in proporzione ai loro crediti).
- Come prevedibile, rimangono insoddisfatti circa €14.500 di debiti.
- Trascorso il periodo minimo (in questo caso solo 3 anni dalla apertura, poiché non c’erano attività complesse), Giuseppe chiede ed ottiene dal Tribunale il decreto di esdebitazione automatica: tutti i debiti residui vengono cancellati.
Alla fine Giuseppe ha perso quei pochi beni (il che non ha alterato di molto la sua vita, erano sacrificabili) ma ha guadagnato la liberazione integrale dai debiti. Ora, quando riuscirà a trovare un lavoro, il suo stipendio non potrà più essere aggredito per quei vecchi debiti: potrà ripartire pulito. Il costo emotivo è stato affrontare la procedura e ammettere il fallimento economico, ma con l’aiuto dei consulenti ha capito che era la scelta giusta per non restare schiavo di debiti impagabili fino alla pensione.
Senza la liquidazione, i creditori di Giuseppe avrebbero magari ottenuto decreti e tentato pignoramenti sul conto (vuoto) o sugli arredi, senza ricavare nulla, e Giuseppe avrebbe continuato a essere inseguito con ulteriori interessi e spese. Con la procedura concorsuale, si è fatto piazza pulita in pochi anni.
Risultato: Debito €15.000 -> realizzato €400 in liquidazione (pagato ~2.6%), esdebitato il 97.4% residuo. Giuseppe ha perso beni non essenziali per circa €400 di valore, mantenendo invece intatti i mobili di casa e i vestiti (impignorabili). Ora non ha più alcun debito sul groppone e se dovesse trovar lavoro il suo nuovo reddito gli servirà per vivere, non per ripagare l’acquisto di quello che ormai ha anche dismesso.
Caso 3: “Anna & Marco” – Sovraindebitamento familiare con debiti da shopping e mutuo
Profilo: Anna (38 anni) e Marco (40 anni) sono sposati con due figli. Anna è casalinga, Marco è impiegato con stipendio €1.800/mese. Anna, a causa di una forte crisi personale e depressione post-partum, ha sviluppato un’abitudine di shopping compulsivo online, spendendo tramite carte di credito e finanziamenti per circa €20.000 in abbigliamento, cosmetici e oggetti per la casa, il tutto all’insaputa del marito. Marco, dal canto suo, ha acceso un mutuo ipotecario ancora in corso sulla casa di famiglia (debito residuo €100.000) e ha un piccolo prestito auto in corso (€10.000 residui). La famiglia ha quindi un indebitamento complessivo di ~€130.000. Il loro bilancio mensile è appesantito: la rata mutuo €600/mese, rata auto €180/mese, e Anna ha accumulato rate per ~€400/mese sulle carte. Totale uscite per debiti €1.180/mese, il che supera la capacità di Marco (unico reddito €1.800, da cui vanno tolte le spese per famiglia). Sono in uno stato di insolvenza incipiente: se continuano così, presto non pagheranno più il mutuo o le carte.
Quando Marco scopre la situazione delle carte di Anna, la tensione familiare è altissima. Temono di perdere la casa e di non riuscire a uscire da questa trappola di debiti. Decidono di affrontare insieme la crisi e cercano aiuto.
Opzione scelta: Piano del consumatore familiare (procedura unificata). Il Codice della crisi consente, dal 2022, che più membri di una stessa famiglia, coobbligati o con debiti legati da un comune evento, possano presentare un unico piano di ristrutturazione. Anna e Marco scelgono questa via per risolvere in un colpo solo i debiti di entrambi, visto che il benessere economico del nucleo è unico. Con l’ausilio di un OCC, elaborano un piano familiare in cui:
- Sommano tutti i loro debiti finanziari (il mutuo, il prestito auto, i debiti di Anna).
- Propongono di pagare una rata complessiva di €700 al mese per 15 anni, attingendo dal solo stipendio di Marco (Anna non lavora, ma si impegna a contenere le spese e magari a cercare un lavoro part-time in futuro, che potrebbe accelerare i pagamenti). In 15 anni a €700/mese, significherebbe pagare ~€126.000.
- Questo importo coprirebbe integralmente il residuo mutuo casa (€100k) più circa 26k da ripartire tra prestito auto e creditori chirografari di Anna. In base al piano, alla fine dei 15 anni resterebbero circa €4.000 di mutuo non pagati e €10.000 di debiti minori non coperti, che verrebbero stralciati con l’esdebitazione.
- Il piano prevede inoltre che la casa non venga toccata: i creditori ipotecari (banca del mutuo) continuerebbero a ricevere la loro quota nella rata e alla fine avranno recuperato quasi tutto (hanno accettato di rinunciare a ~4k di interessi finali). I creditori delle carte di Anna invece recupererebbero circa il 50% dei loro crediti (10k su 20k) in 15 anni.
Durante l’iter, si pone il problema dei creditori ipotecari: teoricamente il mutuo prevede che se si smette di pagare per più di un anno, possono agire. Ma il piano mette in pagamento tutto il mutuo (anche se allungato) e la legge consente queste operazioni se il creditore garantito può esprimersi. Nel loro caso, la banca mutuataria non si oppone formalmente, perché vede che col piano incasserebbe regolarmente 15 anni di rate e preferisce evitare una esecuzione forzata sulla casa (che con due minori e in momento di mercato incerto potrebbe essere complicata). Gli altri finanziatori di Anna certamente preferiscono avere metà dei loro soldi in 15 anni che nulla (considerando che Marco come capofamiglia potrebbe altrimenti trovar stratagemmi per evitare pignoramenti, cambiando lavoro o simili).
Il Tribunale omologa il piano familiare. Viene sospesa qualunque eventuale azione sulla casa e sull’auto. Anna e Marco iniziano a pagare €700 ogni mese, stringendo la cinghia ma riuscendoci grazie a un rigoroso budget familiare (Anna segue anche una terapia di gruppo contro lo shopping compulsivo per evitare ricadute, come previsto nel piano). Durante i 15 anni incontrano qualche difficoltà (Marco perde il lavoro per 3 mesi ma ne trova un altro, la famiglia riceve un piccolo aiuto dai nonni per coprire due rate saltate), ma con l’affiancamento dell’OCC riescono a portare a termine il piano. Dopo 15 anni, hanno pagato circa €126.000. I pochi debiti rimasti non coperti (qualche migliaio di euro) vengono cancellati. La casa è salva, il mutuo è praticamente estinto salvo un’ultima piccola quota azzerata dall’esdebitazione, l’auto è ancora loro. I creditori ottengono chi più chi meno soddisfazione (la banca quasi tutto il dovuto; le finanziarie di Anna ~50%). La famiglia può finalmente respirare: nessun creditore busserà più alla porta.
Questo caso evidenzia come lo strumento del piano congiunto possa risolvere situazioni famigliari in cui uno dei due coniugi, magari per un disturbo come lo shopping compulsivo, ha creato un buco che l’altro da solo non avrebbe potuto colmare. La chiave è stata la cooperazione di Anna e Marco e la trasparenza: se uno dei due avesse nascosto qualche altro debito o spesa, tutto sarebbe potuto crollare. Invece, affrontando uniti la crisi, hanno potuto distribuire il peso su entrambi (in pratica Marco ha “assorbito” anche i debiti di Anna nella rata familiare) e mantenere i beni necessari alla famiglia.
Risultato: Debiti totali €130.000 -> pagati ~€126.000 in 15 anni, stralciati ~€14.000 finali. Casa conservata, famiglia fuori dal tunnel. Era una soluzione molto impegnativa (15 anni di pagamenti costanti) ma preferibile rispetto alla perdita della casa e a un futuro da inquilini indebitati.
Questi esempi dimostrano la varietà di situazioni e come le procedure possano essere adattate caso per caso. È importante sottolineare che, qualunque sia il caso, il successo dipende fortemente dalla buona fede e dalla correttezza del debitore. Occorre:
- Dichiarare tutti i debiti, anche quelli apparentemente secondari (se omettete qualche creditore, rischiate l’inammissibilità o future contestazioni).
- Non nascondere beni o entrate: tutto deve essere messo sul tavolo. Ad esempio, vendere un’auto o svuotare un conto prima di presentare il piano per non farlo vedere ai creditori è una pessima idea e se scoperto porta al rigetto per frode.
- Seguire pedissequamente le indicazioni dei professionisti (OCC/gestore della crisi, avvocato) e rispettare i tempi processuali (presentarsi alle udienze, fare le notifiche per tempo, etc., spesso se ne occupa l’OCC ma il debitore deve collaborare).
- Non fare nuovi debiti durante la procedura: se per esempio dopo aver presentato il piano continuaste a usare la carta di credito creando ulteriori esposizioni, questo sarebbe considerato indice di malafede. Idealmente andrebbero “congelate” le fonti di nuovo debito (carte, fidi) non appena deciso di intraprendere il percorso di sovraindebitamento.
Una curiosità: cosa succede se, durante l’esecuzione del piano o nei 4 anni dopo l’esdebitazione incapiente, il debitore ha un colpo di fortuna (eredità, vincita, aumento reddito)? In generale, se l’evento avviene a procedura ancora aperta, bisogna informare il liquidatore o il giudice e probabilmente destinare quella somma ai creditori (fino a concorrenza dei loro crediti residui). Se invece accade dopo la chiusura e l’esdebitazione, il debitore ormai è libero: ad esempio, se Elisa del Caso 1 vincesse alla lotteria dopo aver ottenuto l’esdebitazione, non avrebbe obblighi verso i vecchi creditori. Diverso per l’incapiente: lì la legge, come detto, pone un vincolo di 4 anni post-esdebitazione in cui se viene meno l’incapienza (cioè se arrivano disponibilità rilevanti) una parte va resa ai creditori.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo ad alcune domande frequenti che i debitori con problemi di sovraindebitamento e shopping compulsivo potrebbero porsi, riassumendo concetti chiave della guida.
D: Chi può presentare un piano del consumatore?
R: Può accedervi qualsiasi persona fisica sovraindebitata che abbia contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale. Quindi consumatori “puri”, ma anche ex imprenditori per i debiti personali rimasti (purché non soggetti a fallimento). Sono inclusi lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, casalinghe, autonomi senza partita IVA, ecc. Non possono invece usare questo strumento gli imprenditori in attività sopra le soglie di fallibilità, né le società (per loro ci sono altre procedure). In caso di dubbi sulla propria qualifica, un OCC saprà inquadrare se siete considerati consumatori o no.
D: Devo ottenere il consenso di tutti i creditori per omologare il piano?
R: No. Il piano del consumatore viene omologato dal giudice senza bisogno di un accordo formale dei creditori. I creditori vengono avvisati e possono partecipare all’udienza per contestare, ma non c’è una votazione e il loro dissenso non impedisce al giudice di approvare il piano, se lo ritiene conforme alla legge e conveniente per la massa creditoria. Questo è un grande vantaggio del piano rispetto ad altre soluzioni. (Nel concordato minore invece il consenso è richiesto tramite voto di maggioranza.)
D: Cosa succede se non mi presento all’udienza fissata dal tribunale per l’omologazione?
R: La presenza all’udienza (fisicamente o tramite il proprio avvocato se autorizzato a rappresentare) è fortemente consigliata. Se il debitore non compare ingiustificatamente, il giudice potrebbe disporre l’archiviazione o il rigetto della domanda, interpretandolo come un segno di non collaborazione. In pratica, è fondamentale seguire con attenzione il calendario: affidandosi a un legale e all’OCC, saranno loro a ricordarvi la data. In caso di impedimento serio (ad esempio malattia improvvisa), il legale deve informare il giudice e chiedere un rinvio. Non lasciate mai andare “deserta” un’udienza perché sarebbe un’occasione sprecata e potrebbe voler dire ripartire da capo.
D: Posso includere nel piano del consumatore i debiti del mutuo sulla prima casa?
R: Sì, è possibile. La legge prevede di base una moratoria massima di 1 anno sulle rate di mutuo scadute, ma la giurisprudenza ha chiarito che il piano del consumatore può anche includere il rimodulamento di un mutuo ipotecario (ad esempio, allungandone la durata o modificando il tasso) purché il creditore ipotecario sia messo in condizione di valutare la proposta e non venga trattato peggio di come sarebbe in una liquidazione. In sostanza, oggi è ammesso inserire il mutuo sulla casa nel piano e continuare a pagarlo alle nuove condizioni proposte: se la banca non si oppone o se comunque con il piano recupera almeno quanto il valore di realizzo dell’immobile, il giudice può omologare. Ad esempio, si può proporre di sospendere le rate per 6-12 mesi e poi riprenderle, oppure di pagarne solo gli interessi per un periodo e posticipare il capitale. Ogni caso va studiato, ma la risposta è sì: il mutuo prima casa può rientrare nel piano di ristrutturazione debiti.
D: E i debiti con il Fisco (Agenzia Entrate Riscossione)? Posso inserirli nel piano?
R: Sì. Una delle caratteristiche delle procedure da sovraindebitamento (fin dal 2012) è che anche i debiti fiscali e contributivi possono essere inclusi. Questo include ad esempio IRPEF, IVA, contributi INPS, bollette esattoriali, ecc. Bisogna però rispettare le regole di trattamento di questi crediti privilegiati: il piano deve assicurare al Fisco almeno quanto otterrebbe in una liquidazione (quindi se avete beni su cui Equitalia metterebbe ipoteca, dovete prevedere di dare un valore analogo) e non può prevedere stralci dell’IVA oltre certe misure (IVA è considerato debitore di diritto europeo e va soddisfatta almeno in parte con privilegio). In pratica, potete proporre ad esempio di rateizzare le cartelle e magari ridurre sanzioni e interessi, ma non pensare di annullare tutto il debito fiscale. Il giudice valuterà caso per caso, ma sappiate che non siete esclusi se avete pendenze con l’Erario: anzi, sovente il Fisco è “creditore silente” e se la proposta è ragionevole (magari dilazione lunga ma pagando interamente il capitale imposte) non si oppone.
D: Cosa significa esattamente meritevolezza del debitore?
R: La meritevolezza è un concetto chiave che indica l’assenza di comportamenti colpevoli nella genesi del sovraindebitamento. In altri termini, il debitore deve dimostrare di non aver causato la propria situazione con dolo o colpa grave. Esempi di mancanza di meritevolezza: aver accumulato debiti sapendo di non poterli pagare (come chi fa shopping folle contando di non pagare), aver frodato i creditori (es. simulando debiti inesistenti), aver continuato a chiedere prestiti occultando quelli già in essere (cfr. Cass. 6869/2025 sopra citata). Nel caso dello shopping compulsivo, si è un po’ sul filo: se il disturbo è certificato, può far propendere per la non intenzionalità del comportamento (quindi preservare la meritevolezza, essendo quasi una patologia). È importante nella relazione dell’OCC spiegare bene le cause del dissesto: descrivere l’eventuale stato psicologico o eventi negativi (es. perdita del lavoro, separazione, malattia) che hanno contribuito. La meritevolezza non richiede che siate stati perfetti: potete anche aver commesso errori finanziari, l’importante è che non vi si attribuisca malafede o leggerezza estrema. In definitiva è un giudizio di equità sul vostro comportamento. E la legge, come detto, col nuovo Codice è diventata un po’ più permissiva, lasciando al giudice un margine di apprezzamento: ad esempio, un eccesso di fiducia nel credito potrebbe non essere considerato colpa grave se dall’altra parte le banche hanno erogato con leggerezza. Quindi non scoraggiatevi: esponete con onestà la vostra storia e lasciate che il giudice valuti.
D: Devo offrire almeno una certa percentuale ai creditori nel piano? C’è un minimo che devo pagare?
R: No, non c’è una percentuale minima per legge nel piano del consumatore. A differenza dei concordati per imprese (dove normative e prassi spesso richiedono percentuali minime sui chirografari, ad esempio 20-30%), per i consumatori la legge non fissa soglie. In teoria il piano potrebbe anche prevedere di pagare molto poco ai chirografari. Tuttavia, di fatto, il giudice deve comunque valutare la convenienza rispetto alla liquidazione. Ciò significa che se proponete di pagare zero, dovreste dimostrare che anche liquidando i beni i creditori avrebbero zero. Se c’è anche un piccolo margine, converrà offrirlo. Insomma: non esiste un “minimo legale” (tipo il 10%), ma esiste un “minimo logico” dato dal paragone con le alternative. Se siete davvero senza nulla, la strada giusta non è fare un piano pagando zero (che verrebbe rigettato magari), bensì chiedere l’esdebitazione da incapiente. Se invece avete un reddito, offrire qualcosa è praticamente necessario sia per convincere il giudice della buona fede, sia per superare eventuali contestazioni dei creditori sulla convenienza. Da notare: se un creditore contesta che il piano non conviene, il giudice può comunque omologarlo se ritiene che la proposta dia almeno quanto la liquidazione. Dunque concentratevi su quell’analisi: quanto otterrebbero i creditori se si vendesse tutto? Il piano deve idealmente dare uguale o di più.
D: Quali costi comportano queste procedure? Posso permettermela se sono già piena di debiti?
R: Ci sono sicuramente dei costi, ma spesso risultano sostenibili e proporzionati al risultato. Le voci di costo sono:
- le spese vive di giustizia, cioè il contributo unificato (che per sovraindebitamento è relativamente basso, attorno a €98 attualmente) e bolli/diritti di cancelleria;
- l’onorario dell’OCC o gestore della crisi, che prepara la relazione e svolge attività (in alcuni tribunali c’è un albo con parametri di compenso in base al lavoro, spesso qualche migliaio di euro a carico del debitore ma inseribile nel piano stesso);
- l’onorario dell’avvocato che vi assiste (variabile; alcuni professionisti applicano tariffe forfettarie per queste procedure, o c’è il patrocinio gratuito se ne avete i requisiti);
- eventuali altri professionisti coinvolti (es. perizie se servono valutazioni immobiliari, etc.).
La buona notizia è che la legge prevede che le spese della procedura siano in prededuzione, quindi pagate preferibilmente ai creditori e a volte poste a carico dei creditori stessi. In soldoni: i compensi dell’OCC e le spese possono essere inglobati nel piano e assorbiti dentro la somma che il debitore paga. Spesso il tribunale, nel decreto di omologa, stabilisce che tali costi siano pagati con le risorse del piano prima di soddisfare i creditori chirografari, riducendo quindi ciò che va a questi ultimi. Quindi il debitore non deve tirarli fuori “extra” se non li ha. Inoltre, va ricordato che esiste il Patrocinio a spese dello Stato esteso alle procedure di sovraindebitamento: se il debitore ha un reddito molto basso e viene riconosciuto meritevole, può essere ammesso a questa forma di gratuito patrocinio, coprendo i costi legali e OCC con fondi pubblici. Questa è una novità inserita negli ultimi anni per favorire i più deboli. In sintesi, prima di rinunciare per paura dei costi, informatevi presso OCC e avvocati: spesso si trovano soluzioni. E tenete presente che qualsiasi cifra si parli, è comunque probabilmente inferiore a quello che paghereste continuando con saldo e stralcio non guidati o interessi di mora su mora. Piuttosto investite in un buon professionista, perché un piano fatto bene può farvi risparmiare decine di migliaia di euro di debiti.
D: Quanto tempo ci vuole per concludere una procedura di sovraindebitamento?
R: Dipende dalla procedura e dalla complessità del caso, ma mediamente possiamo dire che l’iter di omologazione dura dai 6 ai 12 mesi. Il piano del consumatore è abbastanza veloce: spesso nel giro di 4-6 mesi dall’istanza si ottiene l’omologa (salvo intoppi o rinvii per opposizioni). Il concordato minore può richiedere un po’ di più, diciamo 6-12 mesi, dovendosi svolgere la votazione dei creditori. La liquidazione controllata è più lunga: può durare diversi anni (1-3 anni) per completare la vendita dei beni, specie se ci sono immobili che vanno messi all’asta più volte. In compenso l’esdebitazione arriva subito dopo. L’esdebitazione dell’incapiente è invece rapida nell’ottenere il decreto (pochi mesi), ma poi ci sono quei 4 anni di “periodo di prova” durante i quali, se cambia la situazione, i creditori potrebbero rifarsi su nuove utilità. Durante la pendenza della procedura, tuttavia, il debitore beneficia immediatamente di protezioni: fin dal momento del deposito o dell’ammissione, può ottenere la sospensione dei pignoramenti e la sospensione delle segnalazioni negative decorso il termine di esecuzione. In altre parole, la pace finanziaria spesso comincia prima della fine formale della procedura. Certo, non bisogna aspettarsi miracoli istantanei: un minimo di qualche mese serve. Attenzione anche: se un creditore fa reclamo contro l’omologa (ad es. una banca ipotecaria potrebbe opporsi e appellare), ci sarà un prolungamento dei tempi perché la corte d’appello dovrà decidere. Ma questa evenienza non è frequentissima se la procedura è ben congegnata. Dunque, abbiate un po’ di pazienza: potrebbe volerci circa un anno per vedere la luce, ma è sempre meglio di restare a vita sotto i debiti.
D: Cosa succede dopo l’esdebitazione finale? I creditori possono ancora importunarmi?
R: Dopo l’esdebitazione, i debiti residui si considerano estinti per legge. Significa che il debitore è liberato da ogni obbligo verso quei creditori per le somme non pagate. I creditori non possono più iniziare né proseguire alcuna azione di recupero su di voi. Se qualche ufficio di recupero vi contattasse per quei vecchi debiti, potrete semplicemente comunicare gli estremi del provvedimento di esdebitazione e diffidarli dal proseguire. Inoltre, per effetto dell’esdebitazione, avviene la riabilitazione creditizia: le segnalazioni in CRIF e altre banche dati negative vengono cancellate. Tipicamente, entro qualche mese dalla chiusura della procedura, la Centrale Rischi della Banca d’Italia registrerà che i crediti sono stati estinti (o inesigibili) e dopo i tempi tecnici di conservazione (solitamente 36 mesi dall’ultima segnalazione per crediti non pagati) il vostro nominativo non comparirà più tra i cattivi pagatori. Nei Sistemi di Informazione Creditizia privati (CRIF, Experian, Cerved) la cancellazione per “rinuncia al credito” dovrebbe avvenire anche più celermente, spesso su richiesta vostra allegando il decreto di esdebitazione. Dunque, dopo l’esdebitazione si può ripartire anche per quanto riguarda l’accesso al credito: ovviamente bisognerà ricostruire la fiducia magari iniziando con piccoli prestiti o carte, ma in linea di massima non sarete più banditi dal sistema finanziario. Formalmente non ci sono ulteriori vincoli sul debitore esdebitato: non esiste, ad esempio, un divieto di aprire nuove attività o di fare investimenti (a differenza del fallito che finché dura il fallimento aveva limitazioni). Certo, è prudente evitare di ricadere negli errori che hanno causato la crisi: per esempio, se siete stati esdebitati, difficilmente vi verranno concessi di nuovo grandi affidamenti a breve, e comunque conviene essere cauti. La legge permette una nuova procedura solo dopo molti anni, quindi è bene considerare l’esdebitazione come un nuovo inizio da non sprecare.
D: Se il piano o la domanda mi viene respinta, posso riprovarci?
R: Sì, non è “one shot” in caso di rigetto iniziale. Se il tribunale rigetta la domanda o revoca l’omologa in seguito a reclamo (diciamo, vi va male la prima volta), potete, trascorso almeno 1 anno dalla decisione negativa, ripresentare un’istanza di sovraindebitamento. In quell’anno dovrete cercare di rimediare ai motivi del rigetto: ad esempio, se prima il giudice ha detto che mancava meritevolezza perché non avevate incluso un debito, ora lo includete e fate vedere che siete cambiati; oppure magari in quell’anno migliorate un po’ le disponibilità (es. trovate un lavoro) e potete offrire una rata più alta per convincere il tribunale. Il legislatore ha previsto questa possibilità per evitare che un singolo errore precluda per sempre la via della salvezza. Ovviamente, se il rigetto era per motivi insanabili (es. frode conclamata), riprovare non servirà finché quelle condizioni non cambiano. Attenzione: se invece la procedura vi è stata revocata dopo l’omologa per inadempimento, la riapertura è più difficile. Ad esempio, se avevate avuto il piano ma non avete pagato le rate e il giudice ha revocato tutto, lì non c’è diritto automatico a riprovarci: in teoria potreste provare magari la liquidazione, ma rischiate accuse di malafede. Quindi meglio far andare bene la prima! In ogni caso sappiate che un iniziale fallimento nell’accesso non vi sbarra completamente la strada, basta attendere un po’ e aggiustare il tiro.
D: Posso proteggere i miei beni (casa, stipendio) anche al di fuori di queste procedure?
R: Fuori dalle procedure concorsuali, potete solo applicare le normali tutele previste dal codice di procedura civile. Ad esempio:
- Lo stipendio e la pensione sono pignorabili solo entro 1/5 del netto mensile (salvo debiti alimentari che possono arrivare a 1/3). Quindi qualunque creditore vi pignori lo stipendio non può prenderne più del 20% ad ogni mensilità; il resto resta a voi per vivere. Inoltre esiste un minimo vitale impignorabile per le pensioni (circa 690€ al 2025, pari a 1.5 volte l’assegno sociale). Quindi, se siete dipendenti, sapete che oltre un certo limite non possono andare.
- La prima casa: se è priva di ipoteca e non di lusso, il Fisco (Agenzia Entrate Riscossione) non può pignorarla per legge (DL 69/2013). Invece i creditori privati possono tentare il pignoramento immobiliare della vostra prima casa, non c’è un divieto generale. Però spesso, se il debito è modesto e la casa ha un mutuo o è in comproprietà, molti non lo fanno perché poco conveniente. Ci sono alcune proposte di legge per estendere la non pignorabilità della prima casa anche ai creditori privati, ma ad oggi (2025) non sono realtà. Quindi, l’unica protezione certa è non avere troppa equity: se la casa vale 200k ma avete un mutuo di 180k, difficilmente qualcuno la pignora per recuperare i 20k residui.
- I beni impignorabili: la legge (art. 514 c.p.c.) elenca vari beni che non possono essere pignorati: vestiti, biancheria, letti, tavoli da pranzo, elettrodomestici di uso quotidiano (frigo, lavatrice), oggetti sacri, animali da compagnia, etc. Quindi un ufficiale giudiziario non vi svuoterà la casa dei mobili necessari. Può prendere tv ultralusso, collezioni d’arte, cose così, ma non il materasso su cui dormite.
- Se siete sposati in comunione dei beni, i debiti personali contratti da uno dei coniugi dopo il matrimonio potrebbero aggredire i beni comuni solo se contratti per bisogni della famiglia. Un debito per shopping compulsivo non è per bisogno familiare, quindi il creditore potrebbe non riuscire a pignorare ad esempio il conto cointestato se i soldi lì sono considerati della comunione e il debito è personale. Però, attenzione, queste distinzioni sono complesse e da far valere in giudizio con opposizione agli atti esecutivi se capita.
- Lo strumento del fondo patrimoniale: se prima di indebitarsi gravemente uno costituisce un fondo patrimoniale su beni immobili destinandoli ai bisogni della famiglia, i creditori per debiti estranei ai bisogni familiari (es. debiti di gioco o shopping) non possono aggredire quei beni – salvo poi impugnare per revocatoria se vedono malizia. Però costituire un fondo patrimoniale dopo che i debiti sono sorti potrebbe essere considerato atto in frode ai creditori. Quindi diciamo che è una protezione preventiva valida per alcune famiglie, ma non una soluzione ex post.
In sintesi, al di fuori del sovraindebitamento, si può limitare i danni ma non risolvere: magari vi pignoreranno “solo” un quinto dello stipendio e non la casa, ma i debiti e gli interessi continueranno a crescere. Le procedure concorsuali sono l’unico modo per arrivare a un colpo di spugna legale. Ecco perché, se il problema è grave, conviene attivarle.
D: Lo shopping compulsivo in sé può essere una difesa legale?
R: Non esattamente. Non esiste una legge che dica “se hai lo shopping compulsivo non paghi i debiti”. Tuttavia, come abbiamo visto:
- Può essere un argomento per dimostrare la meritevolezza (non eri pienamente in controllo, hai un disturbo, stai cercando di curarlo, quindi meriti clemenza).
- Può essere motivo per chiedere un amministratore di sostegno se le spese folli continuano, in modo da prevenire ulteriori danni.
- Non c’è invece possibilità di far annullare i contratti di acquisto già fatti per incapacità di intendere e volere, a meno che la persona fosse in uno stato psichico davvero tale (ma per riconoscere l’incapacità naturale in quei momenti servirebbero perizie complesse e comunque varrebbe per singoli atti). Quindi non puntate su “non ero capace di intendere quando compravo”: difficilmente attacca, a meno di situazioni cliniche gravissime.
- Può influire sulla responsabilità dei creditori: come detto, se una banca ha continuato a dare credito a una persona con evidente disturbo, quella condotta potrà pesare a suo sfavore nel giudizio di merito creditizio e magari evitare che dica “il debitore è stato truffaldino”. C’è un dovere di solidarietà: se la banca si accorgeva che facevate 10 prestiti per shopping, doveva fermarsi. Se non lo ha fatto, non può ora lamentarsi troppo.
D: Cosa posso fare per evitare di ricadere nei debiti dopo essere uscito dalla crisi?
R: Questa è forse la domanda più importante a livello personale. Una volta ottenuta l’esdebitazione, avete una seconda opportunità. Per non trovarvi tra qualche anno di nuovo sommersi (considerate che rifare una procedura è possibile solo dopo parecchio tempo e con maggiori difficoltà), è essenziale:
- Continuare (o intraprendere) il percorso di cura del disturbo compulsivo. Se è shopping, magari gruppi di supporto, terapia cognitivo-comportamentale, farmacologica se prescritta. Il recupero psicologico è fondamentale.
- Educazione finanziaria: imparare a gestire un budget, evitare l’uso smodato di carte di credito (meglio usare contante o carte di debito, così si spende ciò che si ha), tenere traccia delle spese. Ci sono corsi e risorse di educazione finanziaria (molte associazioni di consumatori li offrono gratuitamente).
- Coinvolgere magari un familiare di fiducia nella supervisione delle finanze: non c’è vergogna a chiedere a un partner o a un genitore di dare un’occhiata ai conti ogni tanto per accertarsi che non stiate riprendendo cattive abitudini.
- Evitare le tentazioni creditizie: dopo la procedura, resistete alla voglia di fare subito nuovi finanziamenti per “festeggiare” la libertà. Meglio accumulare un cuscinetto di risparmio. Se proprio serve credito, usarlo con moderazione e sempre con un piano di rimborso chiaro.
- Se la precedente crisi è dipesa da eventi esterni (es. perdita lavoro), cercare di creare d’ora in poi un fondo di emergenza: pochi mesi di spese accantonati che possano evitare di dover far debiti al prossimo imprevisto.
Ricordate: la legge vi ha dato gli strumenti per difendervi e ripartire. Sta poi a voi, una volta fuori dal buco, costruire un futuro finanziario solido. Molte storie di successo vedono persone che, dopo essere uscite dal sovraindebitamento, sono riuscite a non indebitarsi più e a condurre una vita finalmente serena e “in attivo”. È l’augurio che ci poniamo anche per la nostra lettrice affetta da shopping compulsivo: che questa guida le serva per difendersi oggi e per non avere più bisogno di difendersi domani.
Fonti
Normative:
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 – “Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (cosiddetta legge salva-suicidi, introduttiva degli strumenti per debitori civili).
- Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, artt. 65–83 (procedure di composizione per sovraindebitamento) e artt. 268–283 (liquidazione controllata ed esdebitazione incapiente).
- Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83 – Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi (ha ampliato soggetti ammissibili e affinato procedure).
- Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 – Ulteriori modifiche al Codice della crisi (in vigore dal 2025, consolidamento normativa sovraindebitamento).
- Codice civile: artt. 404–412 c.c. (amministrazione di sostegno); art. 415 c.c. (inabilitazione per prodigalità); art. 414 c.c. (interdizione per infermità di mente, per completezza).
- Codice procedura civile: art. 514 c.p.c. (beni mobili impignorabili); art. 545 c.p.c. (limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni).
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 conv. L. 98/2013: art. 52, comma 1 – Divieto di espropriazione della prima casa da parte dell’Agente della Riscossione (salvo casi di lusso o debito oltre €120.000).
- D.M. 24 settembre 2014, n. 202 – Regolamento ministeriale sugli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (stabilisce requisiti e compensi OCC).
- Direttiva UE 2019/1023 (direttiva sull’insolvenza) – recepita in parte dal D.Lgs. 83/2022, incoraggia seconde opportunità per debitori onesti.
Giurisprudenza:
- Cassazione Civile, Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6869: in materia di merito creditizio falsato, ha confermato il rigetto di un piano del consumatore poiché il debitore aveva omesso di dichiarare finanziamenti in essere nel questionario alla banca, impedendo una corretta valutazione della sua solvibilità. La Corte ha ritenuto che tale condotta decettiva integra colpa grave, escludendo la meritevolezza e giustificando il diniego dell’omologa.
- Cassazione Civile, Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150: (ordinanza) ha affermato che nel piano del consumatore è ammissibile prevedere una dilazione ultrannuale dei debiti ipotecari (mutuo fondiario), andando oltre la moratoria di 1 anno ex art. 8 L.3/2012, purché il creditore garantito sia posto in condizione di valutare e il trattamento non sia deteriore rispetto alla liquidazione. Conferma la possibilità di includere mutui sulla prima casa nel piano, con allungamento del piano di ammortamento previo consenso (anche implicito) del creditore.
- Cassazione Civile, Sez. I, 22 luglio 2020, n. 17191: (richiamata in dottrina) ha sancito che l’IVA e gli altri debiti fiscali possono essere ricompresi nel piano del consumatore, purché il trattamento proposto rispetti la soglia di soddisfacimento minima pari all’alternativa liquidatoria (recependo la L.3/2012 novellata). Sentenza di riferimento sul coinvolgimento del Fisco nelle procedure di sovraindebitamento.
- Tribunale di Varese, decreto 3 ottobre 2012 (Giudice Tutelare dott. Buffone): ha autorizzato la nomina di un amministratore di sostegno per un caso di oniomania (shopping compulsivo), riconoscendo che tale sindrome può integrare l’infermità parziale di mente rilevante ex art. 404 c.c. e disponendo misure di sostegno nella gestione del denaro del beneficiario. Prima pronuncia italiana sul tema, che ha fatto da apripista nel collegare shopping compulsivo e Ads.
- Tribunale di Monza, Sentenza 18 ottobre 2022, NRG 7/2021: (in procedimento ex L.3/2012) ha omologato il piano del consumatore di una debitrice affetta da sindrome di shopping compulsivo, indebitata per €59.000, prevedendo il pagamento rateale di parte del debito e l’esdebitazione finale. Caso reale citato in cui la giudice (dott.ssa Patrizia Fantin) ha considerato meritevole la debitrice in cura e ha concesso la falcidia di oltre il 50% dei debiti.
- Tribunale di Bari, sez. fallimentare, Sentenza 30 dicembre 2021: ha ritenuto ammissibile l’inclusione di un mutuo fondiario ipotecario all’interno di un piano del consumatore, con pagamento dilazionato oltre l’anno di moratoria ex lege, poiché il creditore ipotecario aveva la possibilità di esprimersi e il soddisfo proposto era superiore a quello ricavabile dalla vendita forzata. Conferma di merito poi avallata dalla Cassazione.
- Tribunale di Nola, ordinanza 2020: (segnalata in dottrina) sul tema della meritevolezza del consumatore, ha sollevato questione interpretativa poi risolta dalla Cassazione: ribadito che l’indagine sulla meritevolezza va condotta in concreto, valutando la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e il rispetto dell’obbligo del merito creditizio da parte degli enti finanziatori. (Questa ordinanza è nota per aver messo in luce la “babele” di criteri sulla meritevolezza, spingendo verso un approccio meno punitivo per il consumatore leggermente imprudente ma in buona fede).
- Corte di Cassazione, Sez. I, 8 maggio 2019, n. 11524: (precedente degno di nota) ha stabilito che il decreto di rigetto dell’accesso a una procedura di sovraindebitamento è reclamabile al tribunale (collegiale) ex art. 12 L.3/2012, e non ricorribile subito in Cassazione. Principio procedurale rilevante: il debitore ha uno strumento immediato per opporsi a un diniego, senza attendere un anno per riproporre (può impugnare con reclamo).
- Corte Costituzionale, sent. 15 dicembre 2020, n. 245: ha dichiarato infondata la questione di legittimità sull’art. 14-terdecies L.3/2012 (che limitava l’esdebitazione nel fallimento e nel sovraindebitamento per debiti derivanti da dolo o colpa grave), interpretandola in senso conforme a Costituzione: la norma va letta come facoltizzante il giudice a concedere comunque l’esdebitazione se ricorrono circostanze meritevoli. Indirettamente ha rafforzato l’idea di una seconda chance ampia, poi codificata meglio nel CCII.
Hai accumulato debiti a causa di spese incontrollate, acquisti online, carte revolving o finanziamenti facili? Fatti Difendere da Studio Monardo
Hai accumulato debiti a causa di spese incontrollate, acquisti online, carte revolving o finanziamenti facili?
Ti senti sopraffatta da rate, interessi e solleciti che non riesci più a sostenere?
Lo shopping compulsivo è una condizione che può portare in breve tempo a una situazione di grave sovraindebitamento. Ma non sei sola: la legge oggi prevede strumenti concreti per aiutarti a riorganizzare i debiti, bloccare i creditori e ripartire con dignità.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la tua esposizione debitoria e valuta eventuali abusi da parte di finanziarie e banche
- 📌 Verifica l’esistenza di clausole vessatorie o interessi usurari nei contratti di credito
- ✍️ Predispone una domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento
- ⚖️ Ti assiste davanti all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o al Tribunale
- 🔁 Richiede l’esdebitazione: la cancellazione totale dei debiti se non sei in grado di pagare
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in tutela delle persone sovraindebitate
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
- ✔️ Specializzato in diritto bancario, tutela del consumatore e procedure di esdebitazione
Conclusione
Anche se hai perso il controllo delle spese, non sei senza via d’uscita.
Con il giusto supporto legale puoi ricominciare, bloccare le pressioni dei creditori e liberarti dal peso dei debiti.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua rinascita personale comincia da qui.