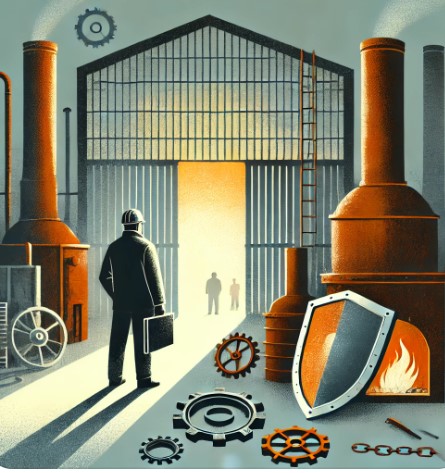Hai avuto una fonderia artigianale o industriale e oggi ti ritrovi con debiti pesanti verso Fisco, banche, INPS o fornitori? Hai chiuso l’attività o ne sei uscito, ma continuano ad arrivarti cartelle, solleciti o atti di pignoramento personali? Ti stai chiedendo come puoi ancora difenderti e se c’è un modo per uscire legalmente da questa situazione?
Molti ex titolari di fonderie, anche dopo anni di attività regolare, si trovano in gravi difficoltà economiche a causa di debiti professionali che ricadono sul patrimonio personale. Ma la legge prevede strumenti concreti per proteggersi, ridurre il debito e bloccare le azioni esecutive.
Perché rischi anche se la fonderia è chiusa?
– Se operavi come ditta individuale, sei personalmente responsabile con tutti i tuoi beni
– Se eri titolare o socio di una SNC o SAS, potresti rispondere illimitatamente dei debiti
– Se avevi una SRL, ma hai prestato fideiussioni personali, puoi essere chiamato a pagare
– I debiti con Agenzia Entrate o banche non si estinguono con la chiusura della partita IVA o della società
Quali sono i debiti più comuni in questo settore?
– Cartelle esattoriali per imposte, contributi e sanzioni
– Finanziamenti e leasing su macchinari e impianti
– Debiti verso fornitori di materie prime, energia o lavorazioni esterne
– Canoni non pagati di capannoni o spazi industriali
– Pignoramenti già avviati o notifiche di iscrizione a ruolo
Come puoi difenderti da queste richieste?
– Verifica se i debiti sono ancora esigibili o se sono prescritti
– Controlla se ci sono vizi formali o calcoli errati nelle cartelle ricevute
– Se la tua situazione economica è compromessa, valuta la procedura di sovraindebitamento:
– Blocca subito pignoramenti e riscossioni
– Ti permette di pagare solo quanto puoi, anche in percentuali ridotte
– Ti consente di salvare la casa e i beni indispensabili
– In alternativa, puoi cercare un accordo a saldo e stralcio con banche e creditori
– Se ci sono fideiussioni firmate in passato, valuta se sono contestabili o revocabili
Cosa puoi ottenere se agisci tempestivamente e nel modo giusto?
– Riduzione del carico debitorio complessivo
– Annullamento o sospensione delle esecuzioni in corso
– Protezione del tuo patrimonio familiare e personale
– Chiusura definitiva della posizione debitoria
– Possibilità di ripartire senza l’ombra dei debiti del passato
Essere stato titolare di una fonderia con debiti non significa doverli pagare per sempre o subire passivamente le azioni esecutive. Ma è fondamentale difendersi in modo tecnico e legale, perché il tempo gioca contro chi rimane fermo.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa e difesa del patrimonio personale ti spiega cosa puoi fare se sei un ex titolare di fonderia con debiti, quali strumenti legali esistono e come uscire dalla crisi.
Hai ricevuto cartelle o pignoramenti per vecchi debiti aziendali? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione e ti diremo se puoi bloccare le pretese, ridurre il debito e riprendere il controllo sulla tua vita economica.
Introduzione
Nel caso di un ex titolare di fonderia che si trovi sommerso dai debiti (banche, fornitori, fisco, previdenza, ecc.), la legge prevede strumenti di composizione della crisi finalizzati a tutelare il debitore in stato di sovraindebitamento. Il sovraindebitamento è infatti definito come «situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni». Tale situazione può riguardare sia consumatori (famiglie) sia imprenditori “imprenditore minore” (con fatturati attivi/patrimoniale entro determinati limiti) o altri soggetti che non sono sottoposti alle procedure fallimentari. L’ex titolare di fonderia rientra generalmente fra gli imprenditori (anche se l’attività è cessata), e può avere debiti d’impresa e/o personali.
La legge n. 3/2012 (c.d. “legge salva-suicidi”) ha introdotto nuovi strumenti analoghi al concordato fallimentare, riservati a soggetti sovraindebitati. In particolare, il legislatore ha previsto: (i) un accordo di composizione della crisi (art. 7 e ss. L. 3/2012), (ii) il piano del consumatore (art. 12‐bis L. 3/2012) riservato ai debitori non imprenditori o con debiti personali, (iii) la liquidazione del patrimonio (art. 14‐ter e ss. L. 3/2012) come “seconda chance” – ovvero lo scioglimento controllato dei beni per soddisfare i creditori – e (iv) procedure transizionali di liquidazione giudiziale. Questi istituti sono stati poi incorporati e riformati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019) e corretti da successivi decreti (ultimi il D.lgs. 83/2022 e il correttivo D.lgs. 136/2024). Nella prassi, queste procedure vengono gestite da speciali organismi di composizione della crisi (OCC) iscritti in apposito elenco presso il Ministero della Giustizia.
Al termine di ciascuna procedura di composizione, se il percorso ha buon esito l’effetto finale è l’“esdebitazione” del debitore, cioè la cancellazione dei debiti residui (ancorché ancora non soddisfatti) contratti anteriormente al piano. In altre parole, se il piano concordato viene eseguito, il debitore sovraindebitato ottiene la liberazione dai debiti residui verso i creditori precedenti (art. 14, comma 3, L. 3/2012). Ad esempio, la Cassazione ha ricordato che «al termine dei due procedimenti (piano e liquidazione) si ha l’esdebitazione, che libera il consumatore sovraindebitato dai debiti residui».
Di seguito analizzeremo tutti gli strumenti disponibili per il debitore (ex imprenditore, piccolo imprenditore o consumatore), evidenziando requisiti, modalità operative, effetti e conseguenze, anche alla luce delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali. Il livello è avanzato (orientato a professionisti e imprenditori), ma utilizzeremo un linguaggio chiaro e divulgativo. In coda troverete tabelle riepilogative, domande/risposte frequenti e simulazioni numeriche. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate in apposita sezione finale.
Chi è “sovraindebitato” e chi può accedere alle procedure
Un debitore si definisce sovraindebitato quando non riesce più a onorare regolarmente i propri debiti con il patrimonio disponibile. Legalmente sono ammessi alle procedure speciali di composizione della crisi i soggetti che non possono accedere al fallimento (non possono cioè richiedere il fallimento di società/impresa): in particolare il consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale/professionale) e una serie di imprenditori minori (attivo/patrimonio annuo ≤ 300.000 €, ricavi ≤ 200.000 € nei tre esercizi precedenti, debiti complessivi ≤ 500.000 €, valori aggiornabili ogni 3 anni), nonché start‐up innovative, imprenditori agricoli e simili.
Nel caso dell’ex titolare di fonderia, se l’attività era in forma individuale egli rientra nella categoria di imprenditore (anche se minore) e avrà debiti d’impresa. Se al contrario l’impresa era società (es. S.r.l.), egli potrebbe esserne responsabile in via personale solo per eventuali fideiussioni o amministrazioni. In ogni caso, se l’impresa è cessata senza seguire concordato o fallimento, il titolare rimane debitore suo malgrado delle obbligazioni contratte. Egli potrà essere ammesso a una procedura di composizione della crisi come imprenditore in difficoltà, non come “consumatore puro”, a meno che tutti i debiti non siano realmente di natura privata (circostanza rara per un ex imprenditore).
In sintesi, le categorie di soggetti ammessi agli strumenti di composizione sono:
- Consumatori: persone fisiche che hanno debiti solo per esigenze personali o familiari (art. 2, lett. e CCII, definizione confermata e ampliata dal D.lgs. 136/2024).
- Imprenditori minori e professionisti: soggetti con limitate attività economiche (rispettivamente con ricavi/patrimonio ridotti) non soggettabili a fallimento. Rientrano anche artigiani, piccoli commercianti, professionisti ecc.
- Imprenditori agricoli e start-up innovative (esplicitamente richiamati dalla legge).
- Altri debitori non fallibili: per esempio enti pubblici, enti religiosi, no-profit, che possono accedere come consumatori o con regole particolari.
Se vi sono debiti promiscui (misti tra impresa e famiglia), occorre valutare caso per caso. Se esiste anche un solo debito riconducibile all’attività imprenditoriale (ad es. fatture non pagate dall’impresa precedentemente gestita), la giurisprudenza ritiene inammissibile il piano del consumatore, perché ciò equivarrebbe a ignorare le regole riservate ai debitori non consumatori. In tal caso l’ex titolare fonderia non potrà essere considerato consumatore puro e non potrà accedere come tale a tutti i benefici del piano (ne parleremo più avanti). L’alternativa è proporre un accordo di ristrutturazione (vedi oltre) o ricorrere alla liquidazione controllata, procedure più adatte al profilo di imprenditore.
Nota: La nozione di consumatore è stringente: la Cassazione (Cass. 22699/2023) ha confermato che solo il soggetto con debiti esclusivamente privati può usufruire del piano del consumatore. Se anche un solo debito è di natura “d’impresa” (ad es. garanzie a società, oneri aziendali), il piano deve essere dichiarato inammissibile. Tale eccezione può sollevarla qualsiasi creditore. Pertanto, nell’esempio della fonderia, se il titolare ha debiti aziendali residui deve considerare procedure diverse dal piano-consumatore.
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
La legge 3/2012 e il Codice della crisi prevedono diverse procedure alternative. Di seguito le riepiloghiamo:
- Accordo di composizione della crisi (art. 7‐10 L. 3/2012) – è un accordo negoziale fra debitore e creditori volto a ristrutturare tutti i debiti. Richiede l’approvazione dei creditori (in termini percentuali) ed è depositato in tribunale per omologa. (Chi può usarlo: sia imprenditori sia consumatori, purché non vi siano debiti promiscui; occorre il requisito della meritevolezza, ossia buona fede del debitore.).
- Piano del consumatore (art. 12‐bis e ss. L. 3/2012) – procedimento semplificato rivolto al consumatore (debitore non imprenditore) che ha solo debiti di natura personale. Consiste in un piano non negoziato che il debitore propone, con l’ausilio dell’OCC, al tribunale, e che il tribunale può omologare anche senza voto dei creditori. (È accessibile solo al consumatore come definito e presuppone la “meritevolezza” del debitore; a differenza dell’accordo ordinario, non richiede il voto favorevole dei creditori – come ribadito dalla Cassazione 9549/2025.)
- Liquidazione del patrimonio (art. 14‐ter e ss. L. 3/2012) – procedura simile al fallimento, riservata al consumatore (piano di liquidazione). Nei fatti, è l’antenato della liquidazione controllata. Può essere richiesta dal consumatore solo se ha già presentato un piano (atto “last resort” per ottenere l’esdebitazione). (Qui il debitore consegna tutti i suoi beni a un liquidatore giudiziario; al termine viene esdebitato dai debiti residui.)
- Liquidazione controllata (artt. 268‐272 D.lgs. 14/2019) – nuova procedura introdotta dal Codice (in vigore dal 15/7/2022) che sostanzialmente sostituisce la vecchia liquidazione del patrimonio. È una procedura concorsuale esecutiva finalizzata a liquidare il patrimonio del debitore (anche imprenditore minore) e distribuire l’attivo ai creditori. A differenza di concordato o piano del consumatore, la liquidazione controllata si apre anche su domanda dei creditori, non richiede il consenso preventivo dei creditori né la “meritevolezza” del debitore. Il debitore partecipa sottoponendosi alla procedura e, se rispetta certi requisiti (collaborazione, soddisfazione non irrisoria, ecc.), può ottenere l’esdebitazione sui debiti residui come nelle altre procedure. (Può essere chiesta da consumatori e imprenditori minori che non superano i limiti di fallibilità del d.lgs. 14/2019. Ad esempio, la Cass. ha ammesso che la liquidazione controllata segue un iter simile alla liquidazione giudiziale**.*)
- Concordato preventivo (c.d. “concordato del debitore”, art. 67 ss. CCII) – procedimento previsto dal nuovo Codice per imprese (anche individuali o società), sostanzialmente il tipico concordato aziendale. Può consistere in un piano di ristrutturazione o liquidazione, con votazione dei creditori (maggiore complessità). (È riservato agli imprenditori commerciali che superano i limiti di fallibilità o ai quali non si applicano le procedure di sovraindebitamento).
Le due tipologie fondamentali per l’ex titolare fonderia sono dunque tipicamente l’accordo di composizione o la liquidazione controllata. L’accordo di composizione funziona come un concordato fallimentare light: il debitore propone un piano di ristrutturazione (ad es. pagamenti ridotti o dilazionati), i creditori votano e, se raggiunta la maggioranza (almeno il 60% dei crediti), il tribunale omologa l’accordo. Se l’accordo viene rispettato, al termine il debitore ottiene l’esdebitazione dal residuo. Se invece il piano fallisce o i creditori non approvano, si può aprire la liquidazione controllata, in cui non serve più alcuna maggioranza (il tribunale liquida i beni). In ogni caso, anche in liquidazione controllata il debitore può chiedere l’esdebitazione finale, salvo cause ostative.
Accordo di composizione della crisi
L’accordo di composizione dei debiti (artt. 7‐10 L. 3/2012) è uno strumento simile al concordato preventivo fallimentare, ma riservato al debitore in sovraindebitamento. In pratica, il debitore predispone un piano di ristrutturazione (revolving credit, riduzioni percentuali, rimodulazioni, ecc.) insieme a tutti i suoi creditori (banche, fornitori, Erario, INPS ecc.) e lo presenta al tribunale tramite l’OCC.
Requisiti: possono accedervi sia consumatori (ammessi al concordato cosiddetto “straordinario”) sia imprenditori che non superino i limiti di fallibilità, purché non abbiano già un piano del consumatore in corso. Il debitore deve avere agito in buona fede (meritevolezza) e, in linea generale, presentare un’offerta migliore per i creditori di quanto otterrebbero in liquidazione.
Iter: una volta depositata la proposta (con inventario beni, stato passivo dettagliato e attestazione di fattibilità da parte dell’OCC), il tribunale fissa un’udienza. Le scadenze delle azioni esecutive individuali sono sospese (divieto di iniziarne o proseguire) fino alla decisione di omologazione. In udienza, il debitore espone il piano e i creditori possono votare o contestare. Se almeno il 60% dei crediti (o il 50% per debiti del consumatore) accetta il piano, il tribunale procede all’omologa. Cassazione 4613/2023 ha ricordato che ai fini dell’omologa si richiede proprio tale quorum e che il tribunale valuta anche la meritevolezza e l’assenza di frode.
Effetti: con l’omologa, il piano diventa vincolante per tutti i creditori (anche quelli dissenzienti) e al debitore viene concesso un periodo di adempimento (di solito pluriennale). I creditori accettano, ad esempio, rateizzazioni mensili o riduzioni percentuali dei propri crediti. Una volta eseguito integralmente il piano, il tribunale pronuncia l’esdebitazione dei debiti residui. In pratica, il debitore rimane libero dal residuo passivo anteriore all’accordo.
Esdebitazione e condizioni: è un beneficio a condizione che il debitore mostri la propria buona fede e non abbia pregiudicato i creditori (art. 12 L. 3/2012). Per i consumatori è espressamente richiesto l’elemento soggettivo e oggettivo (assenza di “colpa grave” nel produrre la crisi). Per gli imprenditori minori, le condizioni sono generalmente ritenute analoghe. Molte sentenze confermano che se il piano ha successo i debiti residui sono cancellati. Ad esempio, nel caso pratico dell’ex titolare di fonderia “Claudio” (Trib. Pavia 4.6.2024), l’accordo di liquidazione proposto (250 €/mese per 36 mesi su €702.000 di passivo) è stato omologato e il debitore ammesso all’esdebitazione.
Piano del consumatore
Il piano del consumatore è un procedimento speciale riservato ai debitori consumatori (solo debiti personali). L’OCC assiste il consumatore nella predisposizione di un piano semplificato di ristrutturazione/debiti. A differenza dell’accordo, non è necessario alcun voto preventivo dei creditori: il debitore presenta il piano al tribunale e il giudice decide se omologarlo. Non serve raggiungere percentuali minime (Cass. 9549/2025 ha ribadito che non è previsto alcun quorum di voti).
Requisiti: l’esercizio è riservato alla persona fisica che abbia contratto obbligazioni per finalità estranee all’attività imprenditoriale. Deve essere veramente un consumatore: se vi è anche un solo debito “d’impresa” residuo, il piano va dichiarato inammissibile. Inoltre il debitore non deve aver già goduto di precedenti esdebitazioni negli ultimi anni (la legge richiede di norma l’assenza di procedure analoghe concluse positivamente negli ultimi 5 anni).
Contenuto del piano: il piano può prevedere pagamenti rateali parziali ai creditori, anche inferiori all’intero dovuto, secondo la concreta capacità del debitore. È consentito definire i debiti privilegiati con pagamenti differiti o parziali: secondo la Cass. 9549/2025, il termine (al massimo) di 1 anno (poi elevato a 2 anni dal d.lgs. 136/2024) non indica la scadenza finale per soddisfarli, ma il termine entro cui iniziare i pagamenti. Ad esempio, si può sospendere le rate di mutuo/ipoteca fino a 1 anno, pagando poi solo gli interessi. Inoltre è possibile concordare una falcidia (riduzione) dei crediti privilegiati, ma solo entro limiti ragionevoli. Alcuni crediti possono essere esclusi dal piano (ad es. assegni bancari, debiti per usura, doveri non pignorabili); anche i contributi INPS e certi tributi possono essere solo dilazionati (non cancellati). Se il piano prevede moratorie superiori o riduzioni significative, la Cassazione ha chiarito che ciò non attribuisce ai creditori un diritto di voto paragonabile al concordato preventivo. I creditori “privilegiati” (anche ipotecari) non partecipano alla votazione, ma possono comunque impugnare il piano tramite reclamo se ritengono la proposta insolvente (art. 12-bis, co. 4, L. 3/2012).
Iter: il piano, accompagnato da documentazione (stato patrimoniale, dichiarazioni reddituali, elenco creditori, attestazione di fattibilità), viene depositato in tribunale. Anche qui scatta il blocco temporaneo (capestro) delle esecuzioni sui beni del debitore. Il giudice valuta la validità formale e la sostenibilità economica del piano. Poiché non occorre voto, l’omologa si basa esclusivamente sulla verifica di meritevolezza del debitore e convenienza del piano rispetto alla liquidazione. Se omologato e rispettato, al termine anche questo piano consente l’esdebitazione totale dei debiti residui. Se invece il piano fallisce o non è stato omologato, si può procedere con la liquidazione controllata o con la liquidazione del patrimonio per il consumatore (alternativa “ultima spiaggia” con esdebitazione finale).
Novità giurisprudenziali: la Cass. ha recentemente precisato (Cass. 9549/2025) che nel piano del consumatore la moratoria di crediti privilegiati (art. 8, co.4, L.3/2012) va intesa come termine d’inizio pagamento, non di saldo integrale. Inoltre ha ribadito che non si può analogizzare al piano le regole del concordato preventivo (quindi no diritto di voto ai creditori privilegiati). Infine, per la qualificazione di “consumatore” la Suprema Corte ha confermato in Cass. 22699/2023 che non basta essere persona fisica, ma tutte le obbligazioni del piano devono essere estranee all’attività di impresa o professione.
Liquidazione controllata (art. 268 CCII)
La liquidazione controllata è uno strumento di ultima istanza introdotto dal Codice della crisi. Non richiede l’accordo dei creditori: il tribunale nomina un liquidatore che incamera e vende i beni pignorabili del debitore, distribuendo il ricavato secondo le priorità legali. In questo modo il procedimento somiglia molto al fallimento (“liquidazione giudiziale”), ma è destinato esclusivamente ai soggetti sovraindebitati (consumatori o imprenditori minori) che non possono però essere dichiarati falliti.
Accesso: può essere chiesto sia dal debitore che da uno o più creditori. L’unico requisito è lo stato di insolvenza o crisi del debitore. Non si richiede né il voto dei creditori né l’assenza di “colpa” del debitore. In breve, la liquidazione controllata è il rimedio residuale per il debitore che non ha alternative praticabili: deve essere dichiarata quando tutti gli altri strumenti sono incompatibili o falliti. Ad esempio, se l’accordo di composizione fallisce o non ha ottenuto i voti richiesti, o se i debiti sono talmente elevati da rendere preferibile la liquidazione.
Effetti: in apertura di procedura il tribunale dispone il blocco (semplificato) delle azioni individuali ed eventuali sequestri conservativi. Il liquidatore si sostituisce al debitore, gestisce e vende i beni (anche con aste). I creditori presentano domanda di partecipazione al concorso dei crediti. Alla fine, il tribunale chiude la procedura e può pronunciare l’esdebitazione del debitore solo se sono soddisfatti i requisiti di buona condotta (incolpevolezza) e se i creditori hanno ottenuto almeno una soddisfazione non irrisoria. Si consideri che, secondo una pronuncia del Trib. Catanzaro (marzo 2025), l’esdebitazione nella liquidazione controllata (quando si utilizza ancora la L.3/2012) è regolata dai criteri di quella legge.
Trattamento dei crediti e degli atti di esecuzione
Durante qualsiasi procedura di composizione, tutti i creditori devono essere convenuti. I crediti vengono inseriti in liste (stato passivo) e classificati: privilegiati (erariali, previdenziali, ipotecari, art. 2740 c.c.), chirografari (tutti gli altri), subordinati ecc. Le leggi in materia prevedono che nei piani sia possibile riconoscere ai creditori privilegiati anche un pagamento parziale o ritardato. In particolare, l’art. 8, comma 4, L.3/2012 consente una moratoria sino a 1 anno sui pagamenti dei creditori ipotecari/privilegiati (portato a 2 anni dal D.lgs. 136/2024). In ogni caso, i crediti contributivi e tributari di norma non possono essere cancellati, ma solo dilazionati. Ad esempio, la Cassazione ha confermato che i piani possono prevedere pagamenti rateali di contributi, ma senza poter cancellare totalmente il debito INPS o fiscale.
Nel blocco delle esecuzioni: dal deposito del piano/accordo in tribunale è vietato avviare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del debitore, nonché acquisire nuovi diritti di prelazione sui suoi beni. Questo consente al debitore di lavorare al piano senza subire il pignoramento dei pochi beni rimasti. In caso di violazione (il creditore prosegue l’esecuzione), il giudice può sospendere tale atto. Tuttavia i crediti rimangono, e il debitore “frena” solo il loro recupero finché la procedura è in corso.
Esdebitazione del debitore
Il beneficio dell’esdebitazione è il “premio finale” di questi istituti: significa che, una volta completati regolarmente piano o concordato, il debitore è liberato dai residui debiti coperti dal piano. Restano esclusi i debiti sorti dopo il piano e quelli non dichiarati (es. debiti futuri o atti fraudolenti). L’esdebitazione può essere richiesta solo a procedura conclusa e soddisfatta.
Condizioni: oltre alla buona condotta del debitore, tipicamente si richiede che il debitore abbia soddisfatto almeno parte dei creditori (di solito non nulla) e che non abbia commesso frodi o atti a danno dei creditori (art. 12 L.3/2012). Recenti pronunce (ad es. Trib. Bergamo 9/4/2025) chiariscono che non è necessario aver già versato tutto il dovuto, né possedere redditi futuri; il requisito essenziale è lo stato di necessità persistente e incolpevolezza (debitore “incapiente incolpevole”).
Aspetti pratici: la domanda di esdebitazione si presenta al tribunale; il giudice verifica i presupposti (assenza di colpe gravi, parvenza di adempimento, trasparenza nella condotta). Se li accerta, emette decreto di esdebitazione. Da quel momento il debitore è liberato dalla responsabilità personale per i debiti residui (anche titoli esecutivi, sentenze, cartelle) anteriori alla procedura, come se non esistessero più.
Cosa fare concretamente: iter e adempimenti
- Ricognizione del debito: il debitore (con l’OCC) redige un inventario completo dei debiti e del patrimonio. È fondamentale includere tutti i creditori per non rischiare esclusioni. Va preparato un prospetto analitico delle ragioni di credito e delle disponibilità.
- Richiesta all’OCC competente: ci si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente e si presenta l’istanza di accesso, accompagnata dalla documentazione (stato passivo e passivo, bilanci, dichiarazioni dei redditi, note esplicative). L’OCC valuta la fattibilità del piano.
- Deposito in Tribunale: con l’assistenza dell’OCC, si deposita al Tribunale l’accordo o il piano. Da quel momento scatta la sospensione (blocco esecuzioni, non è più possibile pignorare i beni del debitore).
- Udienza e omologa: il tribunale fissa udienza a breve (generalmente entro 60 giorni). Le controparti vengono convocate. Il giudice valuta la regolarità formale e la sostanza (fattibilità del piano). Se le condizioni sono rispettate e, nel caso dell’accordo, il quorum dei creditori è raggiunto, il tribunale omologa.
- Esecuzione del piano: dopo l’omologa, si attua il piano (pagamenti rateali, cessione di beni concordati, ecc.). Sull’esecuzione si esercita vigilanza da parte dell’OCC o di un commissario nominato.
- Esdebitazione: eseguito il piano, il debitore presenta ricorso per esdebitazione. Il giudice verifica e, se tutto è regolare, emette il provvedimento finale.
Durante l’iter, il debitore deve continuare a versare puntualmente le rate concordate: la decadenza da parte di un adempimento potrebbe far fallire l’intero piano. Va anche tenuto in considerazione che eventuali atti pregressi contestati (ad es. donazioni o pagamenti sospetti) possono essere oggetto di revoca o di violazione delle norme sull’“atto in frode dei creditori” (art. 10 L.3/2012); come visto in Cass. 4613/2023, il tribunale può verificare se atti di destinazione di beni a terzi siano fraudolenti.
Punti chiave in sintesi (tabelle)
Tabella 1: Confronto tra principali procedure di composizione
| Procedura | Soggetti ammessi | Consenso creditori | Meritevolezza richiesta | Durata max convenzionale | Esdebitazione finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Accordo di composizione | Consumatore/imprenditore minore con debiti ammessi | Sì (≥60% crediti, 50% consum.) | Sì (assenza colpa grave) | Pluriennale (a contratto) | Sì (se piano eseguito) |
| Piano del consumatore | Solo consumatore (debitore persona fisica con debiti personali) | No (solo omologa del giudice) | Sì (buona fede) | Max 3 anni (per legge) | Sì (a condizione di esecuzione) |
| Liquidazione controllata | Consumatore o impr. minore insolvable | No (procedura esecutiva) | No (non è beneficio ma liquidazione) | Fino a esaurimento beni | Sì (se soddisfatte condizioni) |
| Liquidazione del patrimonio | Consumatore (dopo piano fallito) | n.d. (è liquidazione) | n.d. | Fino a esaurimento beni | Sì (in base a L.3/2012) |
Tabella 2: Tipologie di debito e trattamento nelle procedure
| Tipo di credito | Caratteristica | Trattamento tipico |
|---|---|---|
| Creditore ipotecario/privilegiato | Banca mutuo casa, INPS/Erario (privilegio speciale), fornitore con privilegio ex art. 2756 c.c. | Pagamento con prelazione o rateizzato. Nei piani è ammessa moratoria (fino a 1 anno in L.3/2012, 2 anni nel Codice) e riduzione fino agli interessi; spesso resta in prelazione sul bene. |
| Crediti chirografari | Fornitori, finanziarie, cambiali, condominio, utenze ecc. | Vengono soddisfatti secondo quanto previsto dal piano (anche in misura parziale). Possono subire un taglio percentuale concordato. |
| Crediti tributari | Cartelle Erario, IRPEF, IVA, tributi locali | Di regola non cancellabili: il piano può prevedere pagamenti dilazionati, ma il debito residuo rimane e si prescrive secondo le norme fiscali; gli interessi possono essere rateizzati. Nei piani di consumatore, alcuni contributi e debiti tributari rimangono in privilegio e limitano la falcidia. |
| Crediti previdenziali | Contributi INPS, INAIL dovuti | Analoghi ai crediti tributari: pagabili a rate ma residua sempre il debito. |
| Credito al consumo | Finanziamenti personali, carte di credito | Può essere stralciato o ridotto nel piano del consumatore come gli altri chirografari. |
| Debiti coobbligati/fideiussioni | Cauzioni date ad esempio per leasing o altri prestiti aziendali | Se il piano non copre il debito della società principale, il fideiussore o coniuge coobbligato rimane obbligato sui residui. L’esdebitazione non si estende ai coobbligati. |
| Debiti promiscui | Miscelati impresa/famiglia | Se presenti vanno gestiti fuori dal piano del consumatore (inammissibile). Si ricorre ad altre procedure (accordo, liquidazione controllata, concordato minore). |
Domande frequenti
- D. Qual è la procedura adatta a un ex imprenditore come un ex titolare di fonderia?
R. Se ha cessato l’attività, il suo profilo è quello di un “imprenditore” con debiti. Potrà tentare un accordo di composizione (piano concordato) oppure, se i debiti sono particolarmente elevati o è difficoltoso ottenere voti, passare alla liquidazione controllata. Il piano del consumatore è in genere precluso se residuano debiti d’impresa. - D. Come si blocca temporaneamente il pignoramento dei creditori?
R. Con il deposito del piano o accordo in tribunale scatta un divieto di azioni esecutive: i creditori non possono agire finché dura la procedura. Ciò tutela il debitore da nuove ipoteche o pignoramenti durante il negoziato. - D. L’OCC dove va trovato e quanto costa?
R. Ogni provincia ha almeno un OCC (organismo di composizione della crisi). Costi e parcelle variano, ma la legge consente al tribunale di conferire incarico a professionisti abilitati che ricevono compensi stabiliti in base a tariffe minime legali (ordinanza del Ministero della Giustizia). In pratica, il debitore può sopportare spese notevoli (spesso qualche migliaio di euro) tra onorari di OCC, professionisti e tribunale. - D. I miei debiti sono rimasti con estranei (es. un garante, socio, coniuge): cosa accade?
R. L’esdebitazione non si estende ai coobbligati o garanti. Queste persone dovranno comunque pagare la loro parte residua. Ad esempio, Cass. 22699/2023 ha ribadito che l’esdebitazione riguarda solo il debitore principale e non libera i garanti. - D. E se alcuni creditori non vogliono il piano?
R. Nell’accordo di composizione è necessario il consenso dei creditori (soglia 60%/50% in valore). Se non si raggiunge, può fallire il piano. Nel piano del consumatore invece non servono votazioni: il giudice decide autonomamente. Il creditore può opporsi tramite reclamo se ritiene il piano ingiusto (art. 12-bis, co.4 L.3/2012). Nella liquidazione controllata, essendo procedura esecutiva, non serve l’accordo: la nomina del liquidatore e la decisione finale sono del tribunale. - D. Posso mantenere la casa di abitazione?
R. In linea di massima sì, purché il valore della casa non sia troppo elevato rispetto ai debiti. Nel piano si può impegnarsi a pagare almeno gli interessi del mutuo (o una quota delle rate future) senza dover venderla necessariamente. Se invece il patrimonio dei debitori è scarso, a volte la liquidazione potrebbe imporre la vendita forzata dell’immobile. Ogni caso è diverso; di solito, l’OCC valuta se il patrimonio è essenziale e quali beni possono essere venduti minimizzando l’impatto sulle necessità familiari. - D. E se non pago, quale alternativa mi resta?
R. Se i tentativi di composizione falliscono, il debitore può cadere in una procedura fallimentare individuale o collettiva (concordato del debitore). In pratica, sarà come un fallimento: un curatore venderà i suoi beni e ripartirà i proventi. Questo non consente di ottenere esdebitazione (salvo che non sia incolpevole e incapiente). L’ideale è invece sfruttare fin da subito gli istituti di “seconda chance” per evitare la procedura forzosa.
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Piano di liquidazione controllata: Supponiamo che l’ex titolare abbia 100.000 € di debiti complessivi (banche e fornitori) e dispone di un patrimonio immobiliare modesto (una casa, un’auto) e un reddito familiare basso. Il debitore decide di proporre una liquidazione controllata in tribunale, assistito da un OCC. Poiché l’ammontare dei beni ipotecati copre solo parzialmente i debiti, il liquidatore vende l’auto (1.000 €) e parte della casa (se possibile) per un ricavo di 30.000 €. Il resto dei crediti (70.000 €) viene soddisfatto proporzionalmente tra i creditori. Se il giudice ritiene soddisfatte le condizioni (pagato >0%, debitore collaborativo), allora al termine il debitore ottiene esdebitazione: i 70.000 € di debiti residui sono cancellati.
Esempio 2 – Accordo di composizione: Debiti totali = 200.000 €. Il debitore propone ai creditori un piano con pagamento di 3.000 € al mese per 72 mesi (totale 216.000 €), finanziato anche dalla vendita dell’auto. Ottiene il consenso del 70% dei crediti bancari e del 60% dei fornitori, e il tribunale omologa l’accordo. Dopo 6 anni di pagamenti regolari (per totali 216.000 € – i residui coprono interessi), il Tribunale emette provvedimento di esdebitazione: ogni debito residuo (ad es. rate arretrate di fornitore) è cancellato.
Queste simulazioni dimostrano come anche con un piano “senza capitale”, sfruttando solo risorse minime, si possa azzerare un debito ingente, se i creditori accettano la proposta o se viene eseguita la liquidazione con un minimo di soddisfazione.
Fonti normative
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 – Disposizioni in materia di usura, estorsione e composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito) – modifiche alla legge 3/2012 (introduzione del piano del consumatore).
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Titolo I (gestione sovraindebitamento).
- Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 – Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi (modifica definizioni, moratorie ecc.).
- Codice civile – Art. 2740 e segg. (privilegi sui crediti), art. 2901 (atti in frode dei creditori).
- Ordinanze ministeriali di applicazione degli articoli sulla composizione della crisi (organismi, tariffe).
Giurisprudenza e prassi aggiornata
- Cass. Civ. 11 aprile 2025, n. 9549 – chiarisce l’interpretazione del termine di moratoria (1 anno) sui crediti privilegiati nel piano consumatore e afferma che i crediti privilegiati non ottengono diritto di voto nel piano.
- Cass. Civ. 26 luglio 2023, n. 22616 – conferma l’interesse dei creditori a contestare l’ammissibilità di procedure di liquidazione (ex L.3/2012) con reclamo, e che tali decisioni possono essere impugnate in Cassazione con ricorso straordinario.
- Cass. Civ. 18 dicembre 2023, n. 22699 – ribadisce che al piano del consumatore può accedere solo colui che abbia contratto obbligazioni per scopi personali. Se anche un debito è di natura imprenditoriale, il piano va dichiarato inammissibile.
- Trib. Pavia 4 giugno 2024 (RG 186/2023) – esempio applicativo: ex titolare di fonderia azzerato €702.000 di debiti con piano di liquidazione controllata (250 €/mese per 36 mesi) e ottenimento esdebitazione.
- Trib. Catanzaro 14 marzo 2025 – conferma che per le procedure iniziabili sotto la vecchia legge 3/2012 l’esdebitazione segue la stessa normativa del 2012 (art. 390 CCII), in quanto l’esdebitazione è fase interna alla procedura.
- Altre pronunce di merito (Tribunale di Bergamo, Verona, Torino, ecc.) hanno trattato temi di meritevolezza, anticipazione esecuzioni, necessità di difensore ecc.: esse sottolineano che la domanda di esdebitazione deve essere motivata e che rimane condizionata al buon esito della procedura.
Fonti: Norme legislative e articoli di legge (Legge 3/2012, D.Lgs. 14/2019, D.Lgs. 136/2024, ecc.); sentenze e ordinanze della Cassazione e di tribunali civili italiani. Tutte le fonti citate sono riportate in nota secondo le norme di citazione giuridiche.
Ex titolare di fonderia con debiti? Fatti Difendere da Studio Monardo
Hai chiuso la tua fonderia ma ti ritrovi ancora inseguito da cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o richieste di banche e fornitori?
Temi pignoramenti o azioni legali per vecchi debiti accumulati durante l’attività?
Il settore della metallurgia è spesso colpito da crisi di mercato, costi elevati e pressioni fiscali, che possono lasciare forti esposizioni anche dopo la cessazione dell’impresa. Ma la legge offre strumenti concreti per difenderti e ridurre il peso dei debiti.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la tua esposizione debitoria, incluse cartelle esattoriali e debiti verso fornitori o banche
- 📌 Verifica la legittimità degli atti di riscossione e la possibile prescrizione dei crediti
- ✍️ Presenta ricorsi contro atti esecutivi illegittimi o sproporzionati
- ⚖️ Ti assiste nell’accesso alla procedura di sovraindebitamento per ex imprenditori non fallibili
- 🔁 Richiede l’esdebitazione per cancellare i debiti non più sostenibili
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Consulente per la difesa di ex titolari di aziende industriali e artigianali in crisi
- ✔️ Specializzato in sovraindebitamento e contenzioso con Agenzia delle Entrate-Riscossione
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Anche se la tua fonderia ha chiuso, puoi ancora difendere il tuo patrimonio e la tua serenità.
Con una strategia legale mirata puoi bloccare i creditori, ridurre i debiti e ripartire senza pressioni.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua rinascita finanziaria comincia da qui.