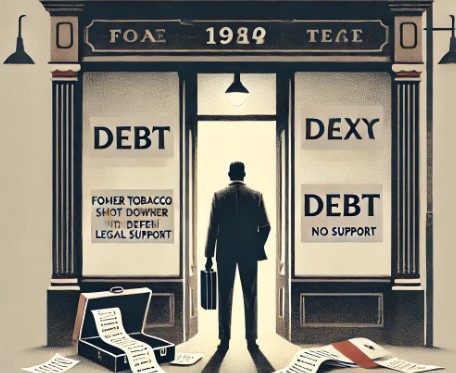Hai avuto una rivendita di tabacchi e oggi ti ritrovi con debiti fiscali, bancari o contributivi? Hai ricevuto cartelle esattoriali, richieste di pagamento, pignoramenti o segnalazioni alla Centrale Rischi? Ti stai chiedendo se sei ancora responsabile, come puoi difenderti e se esistono soluzioni per ripartire?
Essere ex titolare di una tabaccheria non significa che i debiti si cancellino automaticamente con la chiusura dell’attività. Anzi, se il carico debitorio non è stato gestito correttamente, potresti essere ancora esposto verso Agenzia Entrate Riscossione, INPS, fornitori o istituti bancari.
Quando l’ex titolare è ancora responsabile dei debiti?
– Se avevi una ditta individuale, i debiti restano tutti a tuo carico anche dopo la chiusura
– Se eri socio o garante di una società, potresti rispondere in base alle fideiussioni firmate o alle garanzie personali prestate
– Se hai ceduto l’attività ma senza liberarti formalmente dei debiti pregressi
– Se ci sono debiti personali (mutui, finanziamenti, contributi INPS non versati) legati alla gestione
Cosa puoi rischiare se non intervieni subito?
– Pignoramento dei conti correnti, dello stipendio o della pensione
– Iscrizioni ipotecarie su immobili o fermo amministrativo su veicoli
– Accesso negato a finanziamenti o blocco della partita IVA se volessi ripartire
– Sovraindebitamento cronico e aumento dei carichi con interessi e sanzioni
Come puoi difenderti e gestire i debiti?
– Verifica la natura e la prescrizione dei debiti (non tutti sono ancora esigibili)
– Controlla la regolarità di cartelle, avvisi, intimazioni e notifiche
– Valuta l’annullamento di debiti non dovuti o vizi formali nei procedimenti
– Se la situazione è grave, puoi accedere alla procedura di sovraindebitamento, prevista dalla legge per le persone fisiche e gli ex imprenditori
– Puoi ottenere la sospensione delle azioni esecutive e proporre un piano di rientro sostenibile o anche la cancellazione di parte dei debiti
Cos’è la procedura di sovraindebitamento e quando si applica?
– È una procedura legale rivolta a ex imprenditori, piccoli commercianti e persone fisiche
– Ti consente di bloccare pignoramenti e cartelle, e di trattare tutti i debiti in un’unica sede
– Puoi proporre un piano di pagamento parziale, in proporzione alla tua effettiva capacità economica
– Se non hai redditi o beni sufficienti, puoi anche ottenere l’esdebitazione senza pagare nulla
Cosa puoi ottenere se agisci subito?
– Annullamento di debiti non dovuti o prescritti
– Riduzione drastica dell’esposizione tramite accordi o procedure giudiziali
– Stop a pignoramenti, fermi, ipoteche e cartelle
– Un nuovo inizio, libero da vincoli del passato, anche se vuoi avviare una nuova attività
Essere ex titolare di un tabacchi non significa dover pagare tutto per sempre. Esistono strumenti legali per difendersi e trovare soluzioni concrete, anche se la situazione ti sembra ormai compromessa.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e crisi da sovraindebitamento ti spiega come difenderti se sei un ex tabaccaio con debiti, quando puoi annullare le pretese e come costruire un piano di uscita sostenibile.
Hai ricevuto cartelle, atti esecutivi o sei sommerso dai debiti dopo la chiusura dell’attività? Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo insieme la tua posizione e ti diremo se puoi liberarti, rinegoziare o difenderti legalmente.
Introduzione
La chiusura di un’attività commerciale, come una tabaccheria, può lasciare l’ex titolare gravato da debiti significativi verso fornitori, banche o il Fisco. Un ex titolare di tabacchi indebitato si trova dunque a fronteggiare creditori di varia natura, con il timore di azioni legali ed esecutive sul proprio patrimonio personale. Quali strumenti offre l’ordinamento italiano, aggiornato a luglio 2025, per difendersi da questa situazione debitoria? In questa guida – rivolta ad avvocati, imprenditori e privati – esamineremo in modo approfondito e aggiornato le soluzioni giuridiche disponibili, con un linguaggio tecnico-giuridico ma dal taglio divulgativo. Adotteremo il punto di vista del debitore (l’ex imprenditore), illustrando come gestire i diversi tipi di debito, quali procedure attivare per ridurre o cancellare i debiti (esdebitazione), come opporsi alle azioni dei creditori e proteggere i beni essenziali.
Saranno trattate sia le strategie extragiudiziali (accordi bonari, piani di rientro, rateizzazioni e definizioni agevolate col Fisco) sia gli strumenti concorsuali previsti dalla normativa fallimentare e di sovraindebitamento italiana (come il concordato minore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione controllata e la speciale procedura di esdebitazione del debitore incapiente). Approfondiremo inoltre gli effetti del fallimento (liquidazione giudiziale) dell’impresa sull’ex titolare e le possibilità di ottenere la liberazione dai debiti residui.
L’analisi farà riferimento alle norme italiane vigenti (Codice Civile, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche – e altre leggi speciali) e alle più recenti sentenze della giurisprudenza. Troverete tabelle riepilogative per confrontare le procedure, esempi pratici (simulazioni di casi reali) e una sezione di Domande & Risposte per chiarire i dubbi frequenti. Tutte le fonti utilizzate – incluse normative e pronunce giurisprudenziali aggiornate al 2025 – sono citate nel testo e riportate in fondo alla guida nella sezione Fonti.
Premessa fondamentale: in Italia vige il principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Ciò significa che i creditori dell’ex titolare di una ditta individuale (come una tabaccheria gestita in proprio) possono rivalersi sul patrimonio personale dell’imprenditore. Tuttavia, l’ordinamento prevede limitazioni e tutele a favore del debitore in buona fede, nonché procedure per accordarsi con i creditori o liquidare il patrimonio ottenendo la cancellazione (discharge) dei debiti residui. Proprio queste tutele – finalizzate a dare al debitore onesto ma sfortunato una “seconda opportunità” – costituiscono il fulcro della nostra guida.
Le tipologie di debiti dell’ex titolare di tabacchi
Un ex titolare di tabacchi può trovarsi esposto a diverse tipologie di debiti, ciascuna con caratteristiche giuridiche specifiche. Di seguito una panoramica dei debiti più comuni in questa situazione e delle peculiarità di ciascuno:
- Debiti fiscali e tributari: comprendono le imposte non versate (IVA sulle vendite, IRPEF o IRES se l’attività era individuale o societaria, tasse locali), nonché i debiti derivanti da cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) per imposte e contributi previdenziali non pagati. Tali debiti godono spesso di privilegi di legge (ad esempio, IVA e ritenute non versate sono crediti privilegiati dello Stato) e possono portare a iscrizioni a ruolo, con conseguenti misure come fermi amministrativi, ipoteche esattoriali e pignoramenti. Vanno considerati anche i debiti verso i Monopoli di Stato: la gestione di una tabaccheria implica rapporti di concessione con l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli (per rivendita di tabacchi, valori bollati, ecc.), e l’ex titolare potrebbe dover versare somme per forniture di tabacchi o imposte di bollo. I debiti fiscali hanno un regime proprio: lo Stato concede strumenti di dilazione (rateizzazioni anche fino a 10 anni dal 2025) e periodiche definizioni agevolate (come le rottamazioni delle cartelle), ma applica interessi di mora e sanzioni. È fondamentale verificare la natura di questi debiti (tributi erariali, contributi INPS per eventuali dipendenti, canoni concessori, ecc.) poiché alcuni carichi fiscali potrebbero essere oggetto di sgravio o di annullamento d’ufficio (ad esempio, cartelle molto vecchie sotto una certa soglia).
- Debiti verso fornitori e altre imprese: includono le fatture non pagate a fornitori di merce (sigarette, valori bollati, prodotti vari venduti in tabaccheria), bollette di utenze commerciali, e altri crediti di natura commerciale. Questi debiti chirografari (non garantiti) possono essere oggetto di azioni monitorie rapide (es. ricorsi per decreto ingiuntivo) da parte dei fornitori, seguiti da pignoramenti sui beni dell’ex imprenditore. Spesso i fornitori commerciali, una volta chiusa l’attività, cercano un accordo transattivo (ad esempio un saldo e stralcio, accettando un pagamento parziale immediato) piuttosto che avviare lunghe esecuzioni: ciò offre al debitore la chance di ridurre l’esposizione con una trattativa privata.
- Debiti bancari e finanziari: la gestione di una tabaccheria comporta di frequente l’uso di scoperti di conto, finanziamenti per l’acquisto di licenza o merci, mutui o leasing per i locali. L’ex titolare può quindi avere debiti verso banche o finanziarie – ad esempio un mutuo ipotecario sul locale commerciale o un finanziamento garantito dal MedioCredito Centrale (in caso di piccole imprese). Questi crediti possono essere assistiti da garanzie reali (ipoteche su immobili di proprietà, pegni su polizze) o personali (fideiussioni fornite da terzi o dallo stesso imprenditore su beni di familiari). I debiti bancari garantiti da ipoteca rappresentano crediti privilegiati: il creditore potrà escutere il bene dato in garanzia (es. avviare l’esecuzione immobiliare sull’immobile ipotecato). È bene sapere che dal 2023 il legislatore ha introdotto importanti novità per tutelare l’abitazione principale gravata da mutuo: nelle procedure di sovraindebitamento, se il debitore è in regola o regolarizza gli arretrati, può essere autorizzato a proseguire il pagamento delle rate del mutuo per preservare la casa, senza doverla liquidare. Approfondiremo più avanti questa possibilità.
- Debiti per canoni di locazione e utenze: se la tabaccheria operava in locali in affitto, l’ex titolare potrebbe aver accumulato morosità nel pagamento dei canoni di locazione commerciale. Il locatore ha titolo per agire per lo sfratto per morosità (ormai superfluo se l’attività è chiusa) e per un decreto ingiuntivo dei canoni scaduti. Tali crediti sono chirografari salvo eventuale cauzione prestata. Similmente, debiti verso fornitori di utenze (energia elettrica, gas, telefono) rientrano tra i crediti chirografari, ma possono sfociare in decreti ingiuntivi e segnalazioni nelle banche dati dei cattivi pagatori.
- Debiti verso dipendenti e collaboratori: nel caso di tabaccherie con personale assunto, la chiusura può aver lasciato stipendi arretrati, TFR non versato, contributi previdenziali non pagati. I crediti di lavoro (retribuzioni degli ultimi 12 mesi, TFR) godono di privilegio generale sui mobili dell’imprenditore e privilegio immobiliare speciale (su immobili, dopo le spese di giustizia) ai sensi degli artt. 2751 e 2776 c.c. Inoltre, il lavoratore può attingere, per alcune voci, al Fondo di Garanzia INPS che anticipa TFR e ultime mensilità, surrogandosi poi nei diritti del dipendente. Pertanto, questi debiti sono prioritari: in procedure concorsuali devono essere pagati prima degli altri chirografari, e in caso di esecuzione individuale su beni del debitore il privilegio ne facilita il soddisfacimento preferenziale.
- Debiti personali e altri finanziamenti: spesso l’imprenditore individuale ricorre a prestiti personali (es. cessione del quinto, prestiti di famiglia, carte di credito) per finanziare l’attività. Tali debiti extracontrattuali o consumeristici (ad esempio debito con una finanziaria per l’auto, o prestito ottenuto a titolo personale) seguono le regole ordinarie: se non rimborsati, il creditore potrà ottenere un decreto ingiuntivo e pignorare beni o quote di reddito del debitore. Se l’ex titolare ha garantito personalmente debiti della propria società (fideiussioni bancarie per un conto aziendale, ad esempio), il suo patrimonio personale è aggredibile al pari di un debitore principale una volta escussa la garanzia.
Questa suddivisione evidenzia che l’ex titolare di tabacchi tipicamente cumula debiti eterogenei: alcuni privilegiati (Fisco, dipendenti, eventualmente banca se ipoteca) e altri chirografari (fornitori, banche non garantite, privati). Tale distinzione conta molto nelle procedure concorsuali, poiché i crediti privilegiati vanno normalmente soddisfatti per intero o in misura maggiore rispetto ai chirografari, salvo accordo diverso. Inoltre, alcuni debiti potrebbero non essere eliminabili neppure tramite esdebitazione (come vedremo, certi debiti di natura personale e sanzionatoria restano esclusi dai benefici).
Importante: la prima mossa per difendersi dai debiti è fare un check-up completo della propria esposizione debitoria. Occorre quantificare ogni debito, identificare il creditore, la natura (se contrattuale, fiscale, alimentare, ecc.) e lo stato delle eventuali procedure (ingiunzioni ricevute, termini di opposizione pendenti, pignoramenti in corso, rateizzazioni attive o decadute). Solo avendo un quadro chiaro si possono scegliere le strategie appropriate per ciascun tipo di debito.
Rischi e conseguenze per il debitore: cosa può succedere se non paga
Affrontare una situazione di insolvenza senza intraprendere azioni significa esporsi passivamente alle iniziative dei creditori. Quali sono i rischi concreti per un ex imprenditore indebitato?
- Azioni giudiziarie di accertamento del credito: il creditore insoddisfatto potrebbe agire rapidamente per ottenere un titolo esecutivo. Spesso per crediti commerciali o bancari non pagati si ricorre al decreto ingiuntivo, un provvedimento che ingiunge il pagamento entro 40 giorni, emesso dal giudice su ricorso del creditore (corredato da prova scritta del credito). Se il debitore non si oppone entro tale termine, il decreto diventa definitivo e il creditore può procedere con l’esecuzione forzata. È quindi fondamentale reagire tempestivamente a eventuali decreti ingiuntivi se vi sono ragioni di contestazione del debito (ad es. merce contestata, prescrizione già maturata, calcoli errati). L’opposizione a decreto ingiuntivo apre un giudizio ordinario nel merito del credito, sospendendo nel frattempo la provvisoria esecutorietà (se concessa dal giudice) e guadagnando tempo.
- Pignoramenti ed esecuzioni forzate: ottenuto un titolo esecutivo (ingiunzione non opposta, sentenza, cartella esattoriale decorsi i termini), il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Il pignoramento può colpire:
- Beni mobili presso il domicilio o la sede: un ufficiale giudiziario può presentarsi per inventariare e sequestrare beni mobili di valore (macchinari, arredi, merci residue). Tuttavia, molti beni dell’uso quotidiano sono impignorabili (art. 514 c.p.c.), ad esempio: letti, tavoli da pranzo, frigorifero, fornelli, biancheria, abiti, oggetti sacri, alimenti e combustibile per un mese, animali da compagnia, ecc. Sono altresì impignorabili gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione del debitore, entro un certo valore (ad es. se l’ex tabaccaio avesse conservato un computer usato per la contabilità, necessario per eventuale nuova attività lavorativa, non dovrebbe essergli sottratto). I beni pignorati verranno poi venduti all’asta, e il ricavato distribuito tra i creditori procedenti secondo i gradi di privilegio.
- Conti correnti e depositi bancari: un’altra misura frequente è il pignoramento presso terzi, tipicamente del conto bancario del debitore o dei crediti verso clienti. Il creditore notifica un atto di pignoramento alla banca dove il debitore ha il conto, bloccando le somme fino a concorrenza del credito azionato. Il debitore viene citato in tribunale e, se il credito del procedente è confermato, le somme vengono assegnate al creditore. Dal 2021, con la riforma del codice di procedura civile, la procedura è stata resa più celere (udienza entro 45 giorni dal pignoramento). Attenzione: sul conto cointestato con il coniuge, generalmente si considera pignorabile solo la metà appartenente al debitore, salvo prova di diverse proporzioni.
- Stipendi, salari e pensioni: se il debitore ha nel frattempo trovato un impiego dipendente, il creditore può pignorare presso il datore di lavoro una quota dello stipendio (di regola fino a un quinto dello stipendio netto mensile per crediti ordinari, ex art. 545 c.p.c.). Analogamente, la pensione è pignorabile nella misura massima di un quinto dell’importo eccedente il minimo vitale (pari all’assegno sociale aumentato della metà). Ad esempio, nel 2025 l’assegno sociale è circa €503 mensili, quindi una pensione di €1000 potrà essere pignorata solo su €1000-€754=€246, e solo fino a 1/5 di tale parte. Per debiti fiscali verso AdER, le percentuali pignorabili di stipendio/pensione variano per scaglioni (1/10 per importi netti sotto €2.500, 1/7 tra 2.500 e 5.000, 1/5 oltre 5.000, come da D.P.R. 602/1973 art. 72-ter).
- Automezzi e veicoli: il creditore può chiedere il fermo amministrativo su veicoli di proprietà del debitore (misura tipica dell’Agente della Riscossione): il veicolo non può circolare né essere venduto finché il debito non è saldato. Inoltre, tramite un pignoramento mobiliare, è possibile giungere alla vendita forzata del mezzo. Ciò priva il debitore di un bene spesso essenziale; pertanto conviene, ove possibile, attivarsi per evitare il fermo (ad esempio richiedendo una rateizzazione del debito fiscale che sospenda la misura).
- Immobili di proprietà: il bene più prezioso – la casa – è ovviamente nel mirino dei creditori maggiori se il debito ha importo rilevante. Un creditore chirografario può iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore dopo aver ottenuto un giudizio definitivo, e successivamente promuovere un pignoramento immobiliare. I creditori con ipoteca volontaria (es. banca con mutuo) o legale sono privilegiati e spesso i primi ad avviare l’esecuzione immobiliare. Tuttavia, per i debiti fiscali dal 2013 esiste un’importante tutela sulla prima casa: l’Agente della Riscossione non può pignorare l’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore, purché non classificato di lusso, e a condizione che il debitore non sia proprietario di altri immobili. In pratica, il Fisco non può mandare all’asta l’unica casa di residenza del contribuente (può però iscrivere ipoteca se il debito supera €20.000). Questa protezione non vale per i crediti privati: una banca o un fornitore, se muniti di titolo, possono pignorare anche la prima casa (non di lusso) dell’ex imprenditore. Esistono strumenti per cercare di proteggere l’immobile, come vedremo (ad esempio un eventuale fondo patrimoniale, idoneo però solo per debiti estranei ai bisogni familiari, o il ricorso alle procedure concorsuali che possono evitare l’asta).
- Segnalazioni e pregiudizi creditizi: un altro effetto collaterale è la segnalazione nelle banche dati dei “cattivi pagatori”. Se l’ex titolare aveva rapporti bancari, il mancato pagamento di rate o sconfinamenti porta alla segnalazione in Centrale Rischi (gestita da Banca d’Italia per affidamenti rilevanti) o nei sistemi privati come CRIF. Queste segnalazioni rendono impossibile ottenere nuovo credito e permangono per anni anche dopo la chiusura dell’attività. Inoltre, una procedura concorsuale subita (ad esempio, un fallimento) viene annotata nel casellario e nei registri ufficiali, pregiudicando l’affidabilità commerciale del soggetto. Bisogna però sottolineare che affrontare i debiti tramite una procedura legale può essere preferibile all’inazione: ad esempio, ottenere un piano omologato di sovraindebitamento o una esdebitazione, pur risultando dai registri, indica ai futuri creditori che la persona ha risolto i debiti pregressi e può ripartire da zero.
- Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) da parte dei creditori: se l’ex titolare esercitava l’attività in forma individuale (ditta individuale) ed aveva superato le soglie di “piccolo imprenditore” (attivo > €300.000, ricavi > €200.000, debiti > €500.000, cumulativamente), egli è assoggettabile a fallimento (oggi denominato liquidazione giudiziale). Ciò significa che un creditore o il Pubblico Ministero possono presentare al Tribunale un’istanza per la dichiarazione di fallimento dell’ex imprenditore entro un anno dalla cessazione dell’attività (art. 10 L.F. previgente; sotto il Codice della Crisi, l’apertura di liquidazione giudiziale post-cessazione è possibile entro 1 anno dalla cancellazione dal registro imprese). Il fallimento è una procedura concorsuale che ha effetti dirompenti: spossessa il debitore dei suoi beni (che passano al Curatore fallimentare per la liquidazione), blocca tutte le azioni esecutive individuali (concentrandole nel concorso formale) e comporta possibili restrizioni personali (come l’inabilitazione all’esercizio di nuova attività imprenditoriale durante la procedura, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a suo sfavore, e l’obbligo di collaborazione con gli organi della procedura). D’altro canto, il fallimento – sebbene temuto – può anche offrire al debitore una via di uscita definitiva dai debiti, grazie all’esdebitazione post-fallimentare (ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, concessa dal Tribunale a fine procedura se il fallito ha cooperato ed è meritevole). Discuteremo in dettaglio più avanti condizioni e limiti di tale beneficio.
Riassumendo, l’ex titolare indebitato rischia in sostanza di subire passivamente la dispersione coattiva del suo patrimonio (pezzo per pezzo tramite esecuzioni individuali, o globalmente tramite una procedura concorsuale avviata da terzi) e di restare comunque con eventuali debiti insoluti se non viene attivata una procedura di esdebitazione. Inoltre, permane l’angoscia psicologica derivante da continue ingiunzioni, visite dell’ufficiale giudiziario e incertezza sul futuro economico. Per evitare questo scenario, è cruciale che il debitore adotti un atteggiamento proattivo: esistono strategie di difesa che possono alleviare e in molti casi risolvere la crisi debitoria, purché ci si muova per tempo e nella legalità. Le sezioni seguenti esplorano tali strategie, dapprima sul piano stragiudiziale (negoziazione diretta, dilazioni, ecc.) e poi sul piano giudiziale (opposizioni e procedure concorsuali di sovraindebitamento o fallimento).
Strategie extragiudiziali di difesa dal debito
Prima di intraprendere un percorso giudiziario, un ex imprenditore indebitato dovrebbe valutare le possibili soluzioni extragiudiziali, ossia accordi o strumenti volontari per regolare i debiti senza coinvolgere (se possibile) il tribunale. Tali strategie presentano il vantaggio di evitare la pubblicità e i costi di una procedura concorsuale, e possono portare a esiti rapidi e flessibili. Ecco le principali opzioni:
Verifica dei debiti e delle eventuali prescrizioni
Una difesa basilare – ma spesso fruttuosa – consiste nel controllare la legittimità e l’esigibilità dei debiti reclamati dai creditori. Domande da porsi: il debito è certo, liquido ed esigibile? È documentato? Non è magari già prescritto? In diritto italiano, molti debiti sono soggetti a termini di prescrizione (decorso dei quali il debitore può rifiutare il pagamento perché il credito si estingue). Ad esempio:
- Le bollette e forniture periodiche (utenze domestiche, canoni) hanno prescrizioni brevi (in molti casi 5 anni, alcune anche 2 anni dopo le recenti riforme nel settore energetico).
- I tributi hanno termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge (ad esempio, l’IRPEF non versata si prescrive in 10 anni dal titolo esecutivo, molti tributi locali in 5 anni).
- I crediti commerciali usualmente si prescrivono in 5 anni (salvo riconoscimento o atti interruttivi). I crediti derivanti da assegni o cambiali hanno termini propri (6 mesi dall’ultimo termine di presentazione per protestare un assegno, ma se già giudizialmente accertati valgono 10 anni).
- I contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni (salvo atti interruttivi dell’ente).
- I debiti bancari da mutuo o finanziamento – una volta risolto il contratto – sfociano in un credito che si prescrive in 10 anni (come tutti i diritti di credito riconosciuti da un titolo giudiziale).
È dunque essenziale raccogliere tutti gli estratti conto, le cartelle, le lettere dei creditori e verificare se siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione (raccomandate, intimazioni, decreti) nei termini. Se un debito risulta prescritto, il debitore può opporsi efficacemente a qualunque richiesta di pagamento in sede giudiziale, eccependo la prescrizione. Ad esempio, se una cartella esattoriale per IVA 2008 non è mai stata seguita da intimazioni entro i 5 anni successivi, potrebbe oggi essere non più esigibile. L’onere della prova degli atti interruttivi spetta al creditore; AdER spesso notifica atti a raffica, dunque serve cautela prima di confidare nella prescrizione: è opportuno richiedere all’Agente della Riscossione l’estratto di ruolo e l’elenco delle notifiche relative a quella cartella.
Allo stesso modo, è doveroso verificare che il quantum del debito sia corretto: ad esempio interessi usurari applicati da una banca possono dar luogo a contestazioni o ricalcoli; penali contrattuali troppo elevate potrebbero essere ridotte dal giudice. Anche eventuali vizi formali (una cartella notificata irregolarmente, una fattura non conforme) possono offrire spunti di opposizione. Questa fase richiede il supporto di un legale specializzato o di un consulente (es. un commercialista per i tributi), ma è un investimento utile: individuare un vizio potrebbe estinguere o ridurre sensibilmente una parte del debito.
Negoziazione e accordi a saldo e stralcio
Quando il debito è certo e il debitore riconosce di dover pagare, la via stragiudiziale principale è la negoziazione di un accordo con i creditori. Trattare con il creditore può condurre a un saldo e stralcio, ovvero all’estinzione concordata del debito mediante pagamento parziale e immediato di un importo pattuito. I creditori commerciali e le banche spesso preferiscono ottenere subito una percentuale (ad es. 30-50%) anziché rischiare di non recuperare nulla in lunghe cause o procedure concorsuali. Anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur avendo regole rigide, in alcuni casi accetta transazioni sui carichi iscritti a ruolo tramite gli strumenti normativi previsti (come la “definizione agevolata” delle cartelle).
Come procedere in pratica? Il debitore, magari assistito dal suo avvocato, può inviare una proposta scritta al creditore specificando: l’importo proposto in pagamento, la tempistica (spesso si offre un pagamento immediato entro 30-60 giorni) e la condizione che, a fronte del pagamento, il creditore rinunci al resto del credito liberando il debitore. È prudente far confermare l’accordo per iscritto al creditore (anche via PEC) e, una volta pagato, farsi rilasciare quietanza con dicitura di saldo a stralcio definitivo.
Vantaggi: il saldo e stralcio consente di chiudere rapidamente la posizione debitoria, risparmiando sul nominale dovuto. Inoltre evita spese legali future e cancella alla radice il problema (utile anche in ottica di cancellazione di segnalazioni pregiudizievoli: con la quietanza si potrà chiedere la cancellazione di segnalazioni CRIF, ad esempio).
Svantaggi/limiti: occorre disporre di una somma iniziale per convincere il creditore – non sempre il debitore ce l’ha, specie dopo la chiusura dell’attività. A volte si può negoziare un pagamento dilazionato anche nel saldo e stralcio (es. 3 rate mensili), ma più si diluisce, meno incentivo ha il creditore a fare sconto. In più, non tutti i creditori accettano facilmente: le banche, ad esempio, hanno politiche interne sul forbearance (ristrutturazione crediti) e possono preferire emettere un decreto ingiuntivo sperando di pignorare beni di valore.
Considerazioni tattiche: Un debitore con più debiti dovrebbe valutare con attenzione come distribuire eventuali risorse disponibili. Conviene puntare a transare prima con i creditori più aggressivi (per evitare azioni) o con quelli che offrono il maggiore abbattimento. Ad esempio, se un fornitore accetta 30% e la banca non scende sotto 80%, potrebbe essere meglio stralciare il fornitore e lasciare la banca per una procedura successiva (dove potrebbe recuperare meno). Occorre anche fare attenzione a non creare sperequazioni che potrebbero, in caso di successivo fallimento, essere contestate come atti preferenziali: pagare un creditore e lasciarne altri a bocca asciutta in prossimità dell’insolvenza può essere visto come atto in frode. Perciò, meglio effettuare accordi globali e trasparenti, oppure assicurarsi che i pagamenti transatti non violino la par condicio.
Piani di rientro e dilazioni private
Se il problema è la liquidità immediata, una soluzione è chiedere ai creditori una dilazione del debito. Diversamente dal saldo e stralcio (che riduce l’ammontare), qui il debitore propone di pagare l’intero dovuto (o gran parte) ma ratealmente. Ad esempio, restituire un debito di €50.000 in 36 rate mensili. Molti creditori, specie se il debitore dimostra serietà, possono accettare un piano di rientro, eventualmente con l’applicazione di un interesse sulle rate. È consigliabile formalizzare l’accordo di dilazione con un riconoscimento di debito da parte del debitore e il piano di pagamento allegato, prevedendo che in caso di mancato pagamento di una o più rate l’accordo decada (clausola risolutiva). Il vantaggio per il debitore è di evitare contenziosi e comprare tempo per reperire le risorse gradualmente (magari mediante un nuovo impiego). Il vantaggio per il creditore è avere un piano certo e vincolante (il riconoscimento di debito costituisce titolo di prova e facilita eventuali azioni future se il debitore non paga le rate).
Attenzione: durante la negoziazione di un piano di rientro privato, il debitore può trovarsi scoperto di fronte ad azioni esecutive. È buona prassi, quindi, chiedere al creditore di non procedere legalmente finché il piano è rispettato e magari di rinunciare a eventuali cause pendenti. Se il creditore ha già un titolo (es. decreto ingiuntivo), può esigere delle garanzie (cambiali, firma di un garante, ipoteca su un bene). Spesso le banche chiedono cambiali per “ingessare” il piano: in tal caso, attenzione a non fare un piano insostenibile, perché una cambiale non pagata è esecutiva immediatamente. Il piano deve essere realistico: meglio proporre una rata che si è certi di poter pagare con i redditi attuali (ad esempio, se l’ex imprenditore ha trovato un nuovo lavoro, destinare non più di 1/5 dello stipendio netto al piano, in linea col potere di pignoramento – così se onora il piano, eviterà anche un eventuale pignoramento perché già paga quell’importo).
Strumenti per i debiti fiscali: rateizzazioni e definizioni agevolate
Per quanto concerne i debiti verso l’Erario e gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione, INPS, Comuni), la via extragiudiziale passa attraverso gli istituti previsti per legge:
- Rateizzazione ordinaria delle cartelle esattoriali: il contribuente può chiedere ad Agenzia Entrate-Riscossione (AdER) di dilazionare i propri debiti iscritti a ruolo. Dal 2025 questo strumento è stato notevolmente potenziato: in attuazione della riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024), è possibile ottenere piani fino a 120 rate mensili (10 anni) per le richieste presentate nel 2025-2026. In particolare, per debiti fino a €120.000 la domanda è automatica e può arrivare ora fino a 84 rate (in precedenza 72) senza bisogno di comprovare lo stato di difficoltà; per importi superiori o in casi di comprovata situazione di grave e comprovata difficoltà, l’AdER può concedere il piano straordinario fino a 120 rate. Il vantaggio della rateizzazione è duplice: (i) pagando regolarmente le rate, il debitore evita nuove azioni esecutive da parte di AdER (viene meno lo stato di morosità attuale); (ii) alcune misure come il fermo amministrativo o l’ipoteca non vengono iscritte, o se già esistenti possono essere sospese durante il piano, e non scattano ulteriori pignoramenti. È fondamentale però non saltare le rate: la decadenza dalla rateizzazione (di solito dopo il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive) fa perdere i benefici e consente ad AdER di riprendere le azioni. La normativa recente ha previsto meccanismi per evitare la decadenza immediata e permettere di riprendere i pagamenti anche dopo un ritardo, ma conviene non fare affidamento su proroghe: il debitore deve valutare con onestà se la rata è sostenibile. In un piano a 10 anni, la rata mensile è relativamente bassa ma si pagano gli interessi di dilazione (attualmente attorno al 2% annuo).
- Definizioni agevolate (“rottamazione” delle cartelle): il legislatore negli ultimi anni ha varato diverse edizioni di saldo e stralcio fiscale. L’ultima, la “Rottamazione-quater” prevista dalla Legge di Bilancio 2023, ha permesso di definire i carichi affidati ad AdER dal 2000 al 30/6/2022 pagando solo l’imposta e i contributi, con stralcio totale di sanzioni e interessi di mora, e con possibilità di rate fino al 2027. Molti contribuenti hanno aderito (termine di adesione 30/6/2023) e stanno pagando le rate dovute nel 2023-2024. In prospettiva, è possibile che ulteriori misure di definizione agevolata vengano varate (storicamente ce n’è stata una quasi ogni due anni dal 2016 in poi). L’ex titolare dovrebbe monitorare l’evoluzione normativa: aderire a una rottamazione permette di ridurre enormemente il debito fiscale (eliminando le pesanti sanzioni) e di diluire il pagamento. Se però si hanno anche altri debiti non fiscali, bisogna coordinare la strategia generale (ad esempio, potrebbe convenire includere i debiti fiscali in un piano di sovraindebitamento invece di rottamarli, qualora non si riesca a sostenere neppure la quota capitale).
- Transazione fiscale o annullamenti per inesigibilità: all’interno di procedure concorsuali (come vedremo nel concordato minore), la legge consente di proporre una transazione fiscale all’Erario, cioè un trattamento parzialmente falcidiato anche per i crediti privilegiati dello Stato, purché l’adesione avvenga con determinate maggioranze. Al di fuori, l’AdER non può discrezionalmente ridurre il debito (se non attraverso le definizioni agevolate autorizzate per legge). Esiste tuttavia l’istituto del saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà introdotto nel 2019 per persone fisiche con ISEE < €20.000, ma è una norma una tantum del 2019. In compenso, AdER ha facoltà di annullare d’ufficio (cancellare) le cartelle molto datate e di piccolo importo: ad esempio, la L. 197/2022 ha disposto lo stralcio automatico dei debiti fino a €1.000 affidati a ruolo prima del 2015. Anche queste misure “a pioggia” vanno conosciute perché potrebbero alleggerire la posizione del debitore senza sforzo (è opportuno, ad esempio, verificare se nel proprio estratto di ruolo vi siano debiti potenzialmente annullabili perché rientranti in tali casistiche).
In definitiva, per i debiti fiscali l’ex imprenditore dovrebbe:
- Analizzare l’estratto di ruolo e l’elenco dei carichi pendenti.
- Valutare la rateizzazione (specie se l’importo è elevato e non ci sono contenziosi sulla legittimità del debito). Ad esempio, un debito totale di €60.000 con AdER potrebbe diventare €60.000 + interessi in 10 anni, rata circa €600/mese: se compatibile col reddito, ciò mette in sicurezza dai pignoramenti fiscali.
- Aderire a eventuali definizioni agevolate: se una rottamazione è in corso e si è aderito, pagare con priorità quelle rate (decadere dalla rottamazione reintroduce sanzioni e interessi!); se non si è aderito, tenersi pronti per possibili nuove finestre.
- Considerare l’inserimento del debito fiscale in una procedura concorsuale: come vedremo, nelle procedure di sovraindebitamento i debiti fiscali possono essere trattati in modo coordinato con gli altri, e talora subire riduzioni tramite cram-down fiscale (omologazione forzata nonostante il dissenso del Fisco, se l’offerta è conveniente). Cassazione ha precisato che è legittimo anche dilazionare il pagamento dei crediti tributari privilegiati oltre l’anno previsto da vecchie norme, purché lo si faccia con adeguate garanzie e consultazione. Ciò conferma un orientamento più flessibile nel gestire i debiti fiscali in via concordataria.
Evitare atti in frode e proteggere il patrimonio essenziale
È comprensibile che un debitore, vedendo minacciati i propri beni, cerchi di mettere al sicuro qualcosa per la famiglia. Tuttavia, bisogna agire entro i limiti della legalità: vendere o intestare fittiziamente i beni per sottrarli ai creditori può portare a conseguenze gravi. In particolare:
- Atti di disposizione a titolo gratuito (donazioni di immobili o denaro a coniuge/figli) compiuti quando già esistono debiti possono essere soggetti ad azione revocatoria ordinaria da parte dei creditori (entro 5 anni l’atto può essere revocato dal tribunale se lede la garanzia dei creditori ex art. 2901 c.c.). Se vi è una procedura concorsuale, il curatore può agire con la revocatoria fallimentare su atti precedenti alla procedura (con termini e presupposti specifici, ad esempio vendite sottoprezzo o pagamenti preferenziali a ridosso dell’insolvenza, ex art. 164 e ss. CCII).
- Fondo patrimoniale: alcuni imprenditori costituiscono un fondo patrimoniale su beni immobili per destinarli ai bisogni familiari, confidando che i creditori aziendali non possano aggredirli. Attenzione: il fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.) offre protezione solo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La giurisprudenza tende a considerare i debiti fiscali e d’impresa non diretti a bisogni familiari, sì, ma se il ricavato dell’attività serviva al sostentamento familiare, vi è interpretazione ambigua. In ogni caso, se il debito era pregresso o previsto al momento della creazione del fondo, ciò integra fraudolenza e il creditore potrà agire per revocarlo. Dunque il fondo può proteggere un’abitazione dai creditori futuri, ma non è efficace per debiti già sorti o strettamente legati all’attività economica.
- Trust o intestazioni fiduciarie: analogamente, trasferire beni in un trust familiare o intestare a terzi formano atti sindacabili se finalizzati a sottrarre garanzia ai creditori. Si rischia inoltre l’accusa penale di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) se i debiti sono con l’Erario ed emerge che tali manovre erano finalizzate a non pagare le tasse.
La soluzione migliore per proteggere il necessario è invece quella di sfruttare le tutele legali già esistenti (impignorabilità di beni essenziali, esonero prima casa per debiti fiscali, ecc.) e ricorrere semmai a procedure come il concordato minore in cui poter prevedere la continuazione dell’uso di beni fondamentali. Ad esempio, come anticipato, oggi la legge consente di mantenere la prima casa al debitore se continua a pagare il mutuo, includendo la relativa clausola nel piano di sovraindebitamento. Questo è un modo legittimo e sicuro di proteggere la casa, invece di tentare di trasferirla a un parente (cosa che i creditori scoprirebbero e impugnerebbero).
In generale, trasparenza e cooperazione pagano: un debitore che non nasconde nulla e si mostra collaborativo avrà maggiori chance di ottenere il beneficio dell’esdebitazione al termine della vicenda (il giudice ne terrà conto, valutando la meritevolezza). Condotte elusive o ostruzionistiche, invece, precludono l’accesso ai benefici e possono portare anche a sanzioni (ad esempio, il debitore fallito che occulta beni commette reato di bancarotta).
Difendersi dalle azioni esecutive: opposizioni e sospensioni
Quando i creditori hanno già avviato azioni esecutive (pignoramenti, vendite forzate), il debitore ha a disposizione alcuni rimedi processuali per difendersi e guadagnare tempo, in attesa magari di attivare una procedura concorsuale o di trovare un accordo.
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se il debitore ritiene che l’azione esecutiva non sia fondata (perché ad esempio il titolo è invalido, il debito è già estinto o la cosa pignorata non era pignorabile), può proporre opposizione all’esecuzione presso il giudice competente. L’opposizione all’esecuzione può essere promossa prima che inizi l’esecuzione (per contestare il diritto del creditore di procedere) o dopo, entro determinati termini dall’atto esecutivo contestato. Ad esempio, se l’AdER pignora un bene non ipotecabile per legge, il debitore può opporsi. L’opposizione all’esecuzione sospende la procedura solo se il giudice concede espressamente la sospensione (non è automatica). Bisogna quindi presentare istanza di sospensione e dimostrare il fumus boni iuris (motivi validi) e il periculum (danno grave in caso di prosecuzione). Una volta sospesa, l’esecuzione rimane ferma fino alla decisione nel merito.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): se ci sono vizi formali negli atti dell’ufficiale giudiziario o del procedimento (es. notifica irregolare, mancato rispetto di termini), il debitore può opporsi entro 20 giorni dall’atto viziato. Anche qui può chiedersi sospensione. Queste opposizioni sono di natura più tecnica, ma a volte efficaci: un vizio procedurale può comportare l’inefficacia del pignoramento.
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): uno strumento pratico se il debitore reperisce liquidità all’ultimo momento. Consiste nel diritto del debitore di chiedere al giudice dell’esecuzione di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari al credito vantato, spese e interessi inclusi. In pratica, depositando in cancelleria la somma determinata dal giudice (spesso rateizzabile in alcune quote iniziali e il resto garantito con fideiussione), l’esecuzione viene estinta e i beni liberati dal vincolo. È una soluzione drastica (bisogna avere quasi l’intero importo del debito), ma evita la vendita forzata che di solito deprezza i beni. Nel contesto di un ex imprenditore, potrebbe venire in aiuto un familiare: ad es. la moglie versa la somma per liberare la casa pignorata, poi eventualmente si farà rimborsare quando il marito otterrà l’esdebitazione (o con un piano di rientro familiare).
- Sospensione volontaria della procedura per trattativa: a volte, se debitore e creditore trovano un accordo durante l’esecuzione (es. il debitore decide di vendere da sé l’immobile a un terzo, per pagare il creditore), è possibile chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere o rinviare la vendita. L’art. 624-bis c.p.c. prevede la possibilità di sospensione su istanza congiunta delle parti o per “giustificato motivo”. Inoltre, l’art. 493 c.p.c. (come modificato nel 2021) consente al debitore di chiedere di essere autorizzato a vendere privatamente l’immobile pignorato, ottenendo tempi più lunghi e magari un prezzo migliore, col consenso dei creditori. Questa è un’innovazione rilevante: il debitore può dimostrare di avere un acquirente disposto a un certo prezzo, e se il giudice acconsente, la vendita avviene al di fuori dell’asta ma sempre sotto controllo del tribunale (il che evita atteggiamenti speculativi e realizza spesso un ricavato maggiore, nell’interesse anche dei creditori).
- Intervento nelle procedure di espropriazione: se più creditori concorrono, il debitore può talvolta giovarsi di dilazioni dovute al concorso. Ad esempio, un’esecuzione immobiliare con molti creditori può essere più lenta; inoltre, se nel frattempo il debitore apre una procedura concorsuale (es. liquidazione controllata), quell’esecuzione individuale verrà spazzata via perché subentra il concorso formale.
In parallelo a queste opposizioni, va ricordato che l’avvio di una procedura concorsuale da sovraindebitamento o fallimentare sospende ex lege le esecuzioni individuali: è l’automatic stay previsto per evitare la corsa dei creditori. Dunque, un’opzione strategica è attivare tempestivamente una procedura di composizione della crisi (concordato minore, piano del consumatore, ecc.) e richiedere al giudice le misure protettive di sospensione di tutte le azioni esecutive. Il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) consente infatti, depositando il ricorso per l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento, di chiedere la sospensione di eventuali pignoramenti in corso. Per esempio, un debitore con casa già pignorata e vendita fissata può, presentando un piano attestato di ristrutturazione del consumatore, ottenere il blocco dell’asta sino alla decisione sull’omologazione del piano. Questo è spesso l’unico modo per evitare di perdere la casa last-minute, se i creditori non accettano di buon grado di sospendere spontaneamente.
In sintesi, di fronte a un’azione esecutiva:
- Verificare subito con un legale se esistono motivi di opposizione (sostanziali o formali).
- Nel caso, proporre opposizione con istanza di sospensione per bloccare la procedura.
- Parallelamente, valutare un accordo transattivo da sottoporre anche al GE (giudice dell’esecuzione) per ottenere una sospensione in vista di un pagamento concordato.
- Considerare l’attivazione immediata di una procedura di sovraindebitamento o liquidazione, che congeli erga omnes le esecuzioni.
- Non scoraggiarsi: finché il bene non è venduto all’asta con decreto di trasferimento, c’è margine per soluzioni (dopo, recuperare un immobile venduto è pressoché impossibile, salvo irregolarità gravi). Dunque il tempo è essenziale.
Procedure concorsuali per il sovraindebitamento e l’insolvenza
Se i debiti sono troppo ingenti per essere risolti con semplici accordi stragiudiziali, oppure se i creditori non collaborano, il debitore può ricorrere alle procedure concorsuali previste dalla legge italiana per gestire la crisi in modo organizzato e, auspicabilmente, ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato), che ha riformato la materia, sostituendo in parte la vecchia legge fallimentare (R.D. 267/1942) e la legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012). Le procedure di interesse per un ex titolare di tabacchi (persona fisica) si suddividono in due filoni principali:
- Procedure “maggiori” (concorsuali classiche): riguardano l’imprenditore fallibile, ovvero soggetto a liquidazione giudiziale (ex fallimento) o a concordato preventivo, se aveva dimensioni oltre certe soglie. Nel caso di una tabaccheria, spesso il titolare è un piccolo imprenditore individuale che non supera le soglie di fallibilità, quindi non viene dichiarato fallito. Ma qualora invece l’attività fosse di dimensioni maggiori (o esercitata tramite società commerciale sopra soglia), bisogna considerare gli istituti del concordato preventivo e della liquidazione giudiziale. Ne parleremo per completezza, sebbene il focus sia sulla persona fisica ex imprenditore.
- Procedure di sovraindebitamento (o “minori”): introdotte dalla L. 3/2012 e ora disciplinate dal Codice della Crisi (artt. 65-83 e 268-283 CCII), queste procedure sono dedicate ai debitori non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, start-up innovative, imprenditori agricoli, etc.) che si trovino in stato di crisi o insolvenza e non possano accedere a concordato preventivo o liquidazione giudiziale. Comprendono:
- la Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore),
- il Concordato minore (ex accordo di composizione),
- la Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio),
- e la speciale Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (introdotta più di recente, ne parleremo a parte).
Nel seguito, esamineremo prima brevemente il fallimento (liquidazione giudiziale) e poi dettagliatamente le procedure di sovraindebitamento, che sono quelle più rilevanti per un ex tabaccaio indebitato di dimensioni modeste. Anticipiamo una considerazione chiave: l’obiettivo comune di tutte queste procedure è risolvere la crisi secondo un principio di equilibrio tra la tutela dei creditori (che devono ricevere un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria) e il favor verso il debitore meritevole di ottenere una seconda chance. Nel concreto, ciò significa che:
- Al debitore è richiesto di mettere a disposizione il proprio patrimonio o reddito futuro in misura ragionevole per soddisfare, almeno in parte, i creditori (salvo il caso dell’incapiente totale, dove non può dare nulla).
- Ai creditori viene chiesto di accettare una riduzione o dilazione dei loro crediti, secondo un piano equo e fattibile.
- Se la procedura si conclude positivamente (integralmente o anche solo parzialmente attuata secondo le regole), il debitore ottiene l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui rimasti insoddisfatti. Questo effetto può essere “automatica” in alcune procedure (ad esempio, un piano del consumatore omologato e adempiuto rende inesigibili i crediti anteriori non soddisfatti), oppure formare oggetto di un decreto finale del giudice su istanza del debitore (come nella liquidazione).
Vediamo ora in dettaglio ciascun istituto.
Liquidazione giudiziale (ex fallimento) dell’ex imprenditore
La liquidazione giudiziale è il nuovo nome del fallimento, come ridisegnato dal Codice della Crisi. Essa si applica agli imprenditori commerciali insolventi che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti da “impresa minore”. In parole povere, se l’ex titolare di tabacchi aveva un giro d’affari e debiti oltre le soglie di legge (vedi sopra: attivo > €300mila, ricavi > €200mila, debiti > €500mila), i creditori possono chiederne il fallimento.
Come funziona la procedura? Su istanza di un creditore (o su propria iniziativa, o del PM), il Tribunale accerta lo stato di insolvenza e dichiara aperta la liquidazione giudiziale. Da quel momento:
- Il debitore è spossessato dei suoi beni: tutti i beni (presenti e futuri, fino alla chiusura) formano la massa attiva affidata a un Curatore nominato dal Tribunale.
- Il debitore perde l’amministrazione e disponibilità dei beni e dei crediti verso terzi; non può pagare direttamente i creditori né subire azioni (divieto di azioni esecutive individuali).
- I creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo entro termini stabiliti, indicando il credito e gli eventuali privilegi/garanzie. Il Curatore forma lo stato passivo e il Giudice Delegato lo esamina, ammettendo o escludendo i crediti.
- Si procede poi alla liquidazione: il Curatore vende i beni mobili e immobili del fallito (rispettando eventuali prelazioni: ad esempio, vende la casa ma l’ipoteca banca va soddisfatta col ricavato prima degli altri), recupera i crediti (anche promuovendo cause o revocatorie se il fallito aveva compiuto atti pregiudizievoli prima del fallimento), e trasforma tutto in denaro.
- Periodicamente, il Curatore effettua riparti parziali distribuendo ai creditori quel che è stato incassato, secondo l’ordine delle cause di prelazione (prima i creditori prededucibili – spese di procedura – poi privilegiati, poi chirografari in proporzione).
- Al termine, si chiude la procedura con un riparto finale. Spesso i creditori chirografari ricevono poco o nulla, mentre i privilegiati possono essere soddisfatti integralmente o parzialmente a seconda dell’attivo.
Conseguenze personali per il fallito: il debitore persona fisica fallito subiva, con la vecchia legge, una serie di incapacità personali (interdizione legale, impossibilità di ricoprire cariche, sospensione dei diritti patrimoniali del coniuge in comunione, ecc.). Il nuovo Codice attenua alcune limitazioni ma sostanzialmente il fallito resta limitato nella capacità di gestire i propri beni. Tuttavia, l’aspetto più importante oggi è che la procedura di fallimento non è più vista come punitiva, bensì come fase preliminare per la riabilitazione economica del debitore onesto. Infatti, l’ex imprenditore fallito, una volta terminata la liquidazione, può chiedere al Tribunale di essere esdebitato, cioè liberato dai debiti rimasti impagati.
Le condizioni per ottenere l’esdebitazione dopo il fallimento (liquidazione giudiziale) sono elencate nell’art. 282 CCII (prima art. 142 L.F.) e includono:
- Avere cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e documenti (no reticenze).
- Non aver occultato beni o aggravato il dissesto dolosamente.
- Non aver violato obblighi (come non consegnare la corrispondenza al Curatore, ecc.).
- Non aver già usufruito di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti (10 anni sotto la vecchia legge).
- Non essere stato condannato per gravi reati concorsuali (bancarotta fraudolenta, reati contro l’economia pubblica, ecc.), a meno di riabilitazione.
Quanto al pagamento minimo richiesto, la legge fallimentare prevedeva che i creditori dovessero essere stati soddisfatti almeno in parte, senza specificare quanto. La giurisprudenza, come confermato dalla Cassazione più recente, ha interpretato ciò nel senso che basta che una porzione non del tutto trascurabile dei debiti sia stata pagata durante il fallimento, anche se alcuni creditori rimangono a zero. In altre parole, non serve un minimo prefissato (non c’è più ad esempio il vecchio 25% di soddisfazione minima abrogato nel 2006), ma se proprio nessun creditore ha ricevuto nulla (attivo zero), allora l’esdebitazione potrebbe non essere concessa. Su questo punto è intervenuta la riforma sul debitore incapiente, di cui diremo oltre, che consente in casi eccezionali la liberazione anche a chi non aveva nulla da liquidare.
Se il Tribunale concede l’esdebitazione al fallito meritevole, i crediti concorsuali residui diventano inesigibili: il debitore è libero, economicamente “pulito” e potrà intraprendere nuove attività senza il fardello dei vecchi debiti. Restano comunque esclusi alcuni debiti per loro natura (obblighi di mantenimento, risarcimenti danni da illecito e sanzioni – come vedremo più avanti).
Per un ex tabacchi, quale può essere il senso pratico del fallimento? Se l’attività era piccola, probabilmente nessun creditore chiederà il fallimento perché il legislatore esclude i piccoli imprenditori (per evitare i costi di procedure che non soddisferebbero nessuno). Qualora invece l’impresa fosse formalmente sotto soglia ma di fatto con debiti molto elevati, i creditori potrebbero provare ad argomentare l’insolvenza in tribunale. Dal canto suo, l’ex titolare potrebbe persino prendere in considerazione di presentare egli stesso ricorso per la propria liquidazione giudiziale: può sembrare controintuitivo, ma aprire un fallimento volontario a volte serve a comporre il quadro in modo ordinato e portare poi a esdebitazione. In genere però, per un ex imprenditore persona fisica è preferibile esplorare le procedure di sovraindebitamento, meno onerose e più orientate al debitore, che ora analizziamo.
Le procedure di sovraindebitamento (Codice della Crisi, Titolo V)
Il sovraindebitamento è definito (art. 2, co.1, lett. c) CCII) come lo stato di crisi o insolvenza di un debitore che non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale (fallimento) né alle altre procedure concorsuali maggiori. In pratica sono sovraindebitati:
- le persone fisiche consumatrici, cioè individui con debiti assunti per scopi personali/familiari estranei ad attività d’impresa;
- i piccoli imprenditori commerciali sotto soglia di fallibilità (come spesso l’ex tabaccaio individuale rientra);
- gli imprenditori agricoli (tradizionalmente non fallibili per legge ma ora ammessi a queste procedure);
- i professionisti e lavoratori autonomi (che non erano soggetti al fallimento ma ora rientrano nel perimetro sovraindebitamento se insolventi);
- le start-up innovative (che hanno un regime di non fallibilità temporanea ai sensi del DL 179/2012);
- le associazioni, fondazioni e altri enti non commerciali con debiti;
- gli eredi di un imprenditore defunto che hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario e si trovano a gestire i debiti ereditari.
Per tutti costoro, il Codice della Crisi (aggiornato dai correttivi 2020-2022-2023) prevede tre vie ordinarie e una straordinaria:
1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) – È l’evoluzione del piano del consumatore della L.3/2012. Riservato esclusivamente al debitore persona fisica “consumatore”, ovvero che ha contratto debiti fuori dall’attività imprenditoriale o professionale. Ad esempio, un ex tabacchi potrebbe qualificarsi consumatore solo se i suoi debiti residui riguardano ambiti privati (mutuo casa, finanziaria per auto, bollette, ecc.) e non quelli dell’ex attività. Se la maggior parte dell’indebitamento deriva dall’impresa ormai cessata, non è considerato consumatore. La ristrutturazione del consumatore consiste in un piano di pagamento dei debiti formulato dal debitore, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e soggetto all’omologazione del tribunale, senza necessità di voto dei creditori. In pratica, il consumatore onesto e meritevole (non deve aver colposamente creato la propria insolvenza) può proporre di pagare i suoi debiti secondo un certo piano (anche parzialmente) utilizzando il reddito futuro o liquidando parte dei beni, e il giudice può omologarlo anche se i creditori non sono d’accordo, purché sia garantito che il trattamento offerto è più conveniente di quello che i creditori avrebbero in una liquidazione. Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori anteriori e, se il debitore lo esegue regolarmente, ottiene l’esdebitazione per la parte di debiti eventualmente non pagata. Caratteristiche salienti:
- Niente voto dei creditori: è un grande vantaggio rispetto alle altre procedure. Il creditore può fare osservazioni ma non c’è una “maggioranza” da raggiungere.
- Meritevolezza: il giudice valuta la condotta del debitore – se, ad esempio, il consumatore ha fatto spese spropositate volontariamente o ha ottenuto credito mentendo sulle proprie condizioni, può dichiarare inammissibile il piano per difetto di buona fede. Invece se l’indebitamento è dovuto a cause sfortunate (malattie, perdita del lavoro, fideiussioni escusse per aiutare terzi, etc.), si riconosce la meritevolezza.
- Possibilità di trattamento differenziato dei crediti: il piano può prevedere stralci consistenti dei crediti chirografari e anche dei crediti privilegiati, ma questi ultimi in misura limitata. Ad esempio, i debiti con ipoteca (es. mutuo casa) di norma vanno pagati al valore di realizzo della garanzia (se la casa vale meno del debito, la parte eccedente diventa chirografaria e può essere falcidiata).
- Novità 2022: come visto, il piano del consumatore già contemplava la possibilità di mantenere il pagamento del mutuo prima casa alle scadenze originarie. Ciò significa che se il consumatore è in regola con il mutuo (o paga le rate scadute prima del piano, con autorizzazione del giudice), può tenere la casa e continuare a pagare la banca alle scadenze come se nulla fosse, escludendo quelle rate future dal concorso (perché la banca ipotecaria viene considerata soddisfatta integralmente dal ricavato potenziale della casa). Questa clausola evita che il debitore debba vendere casa per pagare i creditori, realizzando la finalità sociale di tutela dell’abitazione.
- Esecuzione e controlli: un OCC viene nominato e ha funzioni di monitoraggio nell’esecuzione del piano. Se il debitore non rispetta le scadenze o nasconde redditi, il piano può essere revocato.
- Effetti per i creditori: dalla presentazione del ricorso, il debitore può chiedere misure protettive per bloccare le azioni esecutive. Una volta omologato il piano, i creditori sono obbligati a rispettarlo: non potranno pretendere interessi né agire per somme diverse da quelle previste. L’omologazione viene iscritta nei registri e ha efficacia verso tutti.
2. Concordato minore (artt. 74-80 CCII) – È la procedura dedicata ai debitori non consumatori: piccoli imprenditori, professionisti, ditte individuali sotto soglia, imprenditori cessati, ecc. Il concordato minore ha caratteristiche analoghe a un concordato preventivo semplificato: il debitore propone un accordo di ristrutturazione ai creditori, i quali devono approvarlo a maggioranza (maggioranza dei crediti ammessi al voto), e infine il tribunale lo omologa. È dunque più “negoziale” rispetto al piano del consumatore. Punti qualificanti:
- Accesso: il debitore deve essere in sovraindebitamento e non consumatore. Deve allegare una proposta di concordato con un piano dettagliato di come intende superare la crisi (es. pagamenti parziali, cessione di beni, continuità aziendale o liquidazione).
- Ruolo dell’OCC: come in tutte le procedure di sovraindebitamento, un Gestore della crisi (OCC) aiuta a redigere la proposta, verifica la veridicità dei dati e predispone una relazione attestante la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione. L’OCC vigila poi sull’esecuzione.
- Votazione dei creditori: diversamente dal piano del consumatore, qui i creditori votano sulla proposta. Serve il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Non contano i crediti privilegiati se sono soddisfatti integralmente (possono essere esclusi dal voto), salvo che rinuncino al privilegio. Quindi, in pratica, di solito votano i chirografari e gli eventuali privilegiati falcidiati. Se la maggioranza approva, si passa all’omologazione; se non si raggiunge, la procedura viene chiusa (salvo il possibile cram-down fiscale di cui sotto).
- Omologazione giudiziale: il tribunale omologa se il concordato è approvato dalla maggioranza e rispetta la legge. Può omologare anche in caso di dissenso dell’Erario o enti previdenziali (cram down fiscale) purché la proposta assicuri il pagamento di almeno il 30% dei loro crediti (salvo riduzione a 20% in casi di particolare rilevanza sociale dell’attività). Questa soglia è stata resa più rigorosa dal correttivo 2024 (Decreto “Correttivo Ter”), in risposta all’esigenza di tutelare maggiormente i crediti pubblici.
- Distinzione continuità / liquidatorio: come nel concordato preventivo, il debitore può proporre un concordato minore in continuità (prosecuzione dell’attività, se ne ha ancora una, per pagare i creditori col ricavato futuro) o concordato minore liquidatorio (cessazione attività e liquidazione beni). Quest’ultimo è ammesso solo se il debitore apporta risorse esterne aggiuntive che aumentino di almeno il 10% l’attivo liquidabile. Ciò per evitare concordati “liquidatori” inutili (tanto varrebbe la liquidazione controllata); in sostanza, il liquidatorio puro è permesso se qualcuno (un terzo, un parente) mette soldi sul piatto per dare qualcosa in più ai creditori rispetto a una liquidazione base.
- Vantaggi per il debitore: come dice l’art. 74 CCII, il concordato minore serve a evitare la liquidazione giudiziale o le esecuzioni, assicurando ai creditori una soddisfazione almeno pari alla liquidazione. Per il debitore ciò significa poter negoziare soluzioni creative: ad es., cedere parzialmente dei beni, mantenere quelli essenziali, continuare eventualmente l’attività se profittevole. Inoltre, con l’omologazione, i crediti anteriori restano stralciati come da accordo e il debitore risponde solo del dovuto concordatario. Se poi esegue tutto, i creditori chirografari non pagati integralmente vengono comunque dischiarati inesigibili (effetto esdebitatorio automatico).
- Novità sulla casa e mutui: come già accennato, con il correttivo 2024 il legislatore ha concesso anche al concordato minore la possibilità di mantenere il mutuo sulla prima casa: se il debitore persona fisica è in regola (o autorizzato a regolarizzare gli arretrati), il piano di concordato minore può prevedere di continuare a pagare le rate a scadenza del mutuo ipotecario sulla casa principale, tenendo fuori quell’immobile dalla liquidazione. L’OCC deve attestare che il creditore ipotecario è comunque garantito (il valore della casa copre il debito) e che non c’è pregiudizio per gli altri creditori (ovvero che se vendessero la casa ricaverebbero comunque solo l’importo del mutuo). Questa innovazione rende il concordato minore molto più appetibile per i piccoli imprenditori con casa di proprietà: prima, l’alternativa era liquidare la casa o far finta di niente e rischiare il pignoramento; ora c’è una strada per salvarla legalmente.
- Effetti per i creditori: come sempre, misure protettive durante la procedura. Se omologato, il concordato minore è vincolante per tutti i creditori anteriori, compresi i dissenzienti e non votanti, che potranno agire solo secondo quanto previsto dall’accordo (ad es., se il concordato dice che riceveranno il 40% in 2 anni, dovranno accontentarsi di quello). I creditori privilegiati non consensualmente degradati mantengono la possibilità di escutere la garanzia per la parte eccedente (ma in pratica il piano deve prevedere come li soddisfa in caso contrario).
- Inadempimento: se dopo l’omologazione il debitore non rispetta gli impegni, il tribunale – su istanza dei creditori – può dichiarare risolto il concordato. A quel punto tornano azionabili i crediti per intero (dedotto quanto eventualmente già pagato). Inoltre, la risoluzione del concordato minore può portare all’apertura di una liquidazione controllata d’ufficio.
3. Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII) – Equivale alla vecchia liquidazione del patrimonio della L.3/2012, cioè una procedura concorsuale liquidatoria destinata ai debitori sovraindebitati. Si tratta in sostanza di un fallimento semplificato per chi non può fallire, col vantaggio però che al termine si può ottenere l’esdebitazione. La liquidazione controllata si attiva tipicamente quando:
- il debitore non ha una prospettiva di continuare un’attività e preferisce mettere tutto a disposizione per chiudere i conti;
- oppure quando un piano del consumatore o concordato minore non sono praticabili (per mancanza di consenso dei creditori o perché il debitore non ha entrate per sostenere un piano).
- anche i creditori potrebbero chiederla (novità rispetto alla L.3/2012: ora anche il creditore o il PM possono istigare una liquidazione controllata per un sovraindebitato non fallibile, benché ciò sia ancora poco frequente in prassi).
Come funziona: il debitore (o creditore istante) presenta ricorso e un progetto di stato passivo con l’aiuto dell’OCC. Se il tribunale dichiara aperta la liquidazione, vengono nominati un Giudice Delegato e un Liquidatore (figura simile al curatore). Da quel momento:
- Tutto il patrimonio del debitore diventa oggetto di liquidazione, esclusi i beni impignorabili per legge (quelli che già non potevano essere toccati dai creditori rimangono fuori, es. i beni di uso quotidiano, stipendio nei limiti impignorabili, ecc., come da art. 268 c.3 CCII).
- Il Liquidatore redige un inventario dei beni e invita i creditori a presentare domanda di partecipazione alla liquidazione (entro 30 giorni dall’avviso). Si forma lo stato passivo sotto controllo del GD, analogamente al fallimento.
- Il Liquidatore poi procede a realizzare l’attivo: vende beni mobili, immobili (anche qui valgon le regole simili al fallimento: si può autorizzare il debitore a cedere l’immobile fuori asta se conviene, etc.), riscuote crediti, impugna pagamenti preferenziali fatti prima (revocatoria).
- Il ricavato viene distribuito secondo le cause di prelazione ai creditori insinuati.
- Durante la liquidazione, il debitore è tenuto a collaborare (fornire info, documenti, segnalare sopravvenienze). Non subisce però le incapacità personali del fallito: ad esempio, può continuare a lavorare e guadagnare (ciò che guadagna dal lavoro corrente, al netto di quanto eventualmente pignorabile, rimane a lui, poiché i redditi futuri oltre certi limiti potrebbero essere considerati utilità sopravvenute, ma tendenzialmente solo quelli entro 4 anni per valutare l’esdebitazione).
- La procedura termina con un decreto di chiusura quando si è completata la liquidazione e ripartito l’attivo.
Esdebitazione nella liquidazione controllata: qui l’effetto non è automatico, ma la legge prevede che decorsi 3 anni dall’apertura della liquidazione controllata, il tribunale valuta d’ufficio se il debitore possa essere esdebitato (anche senza domanda, per favorire la sua emancipazione in tempi ragionevoli). Comunque, al più tardi, al momento della chiusura, il debitore persona fisica può ottenere con decreto la liberazione dai debiti rimasti. Le condizioni sono analoghe a quelle viste per il fallimento: cooperazione leale, nessuna frode o colpa grave, nessuna esdebitazione già avuta negli ultimi 4 anni, ecc. La differenza è che qui, essendo il debitore non fallibile, la valutazione di meritevolezza guarda soprattutto all’assenza di dolo o colpa nella formazione dell’indebitamento e nella condotta durante la procedura (il Codice parla di “assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave”, accertate dal giudice). Inoltre, in liquidazione controllata non c’è il requisito del pagamento di una parte dei debiti, perché a volte il piccolo imprenditore non paga nulla (attivo zero): se ha rispettato tutti i doveri, può comunque aspirare all’esdebitazione (qui il legislatore è stato più favorevole che nell’istituto del fallimento tradizionale).
Effetti: con il decreto di esdebitazione post-liquidazione controllata, tutti i debiti concorsuali (cioè sorti prima dell’apertura) residui diventano non più esigibili nei confronti del debitore. Come specificato però dall’art. 278 CCII, restano esclusi dall’esdebitazione alcune tipologie di debiti: gli alimenti e mantenimenti dovuti per legge, i debiti da risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale, e le sanzioni penali o amministrative pecuniarie non accessorie. Dunque, ad esempio, se l’ex tabaccaio avesse un debito per un incidente stradale causato (danno da illecito) o una multa, quello non viene cancellato dall’esdebitazione e resta a suo carico (il creditore potrà esigerlo). Allo stesso modo, se era obbligato a pagare un assegno di mantenimento, dovrà continuare a farlo. Queste esclusioni sono importanti: la legge vuole evitare che con la scusa dell’esdebitazione si faccia piazza pulita di debiti “sensibili” come quelli verso i figli o di natura sanzionatoria. Per il resto, i crediti ordinari e anche fiscali, contributivi etc., sono esdebitati (lo Stato non fa eccezione qui: se ha preso parte alla procedura e non è stato soddisfatto interamente, la quota residua di imposte va persa, salvo casi di frode fiscale che escluderebbero la meritevolezza).
Risultato finale: la liquidazione controllata, pur essendo dolorosa (il debitore perde i beni, salvo quelli impignorabili), offre la prospettiva di una completa liberazione dai debiti entro pochi anni. È un percorso di “purgazione”, il cui successo è attestato dal decreto di esdebitazione che consente al debitore di ricominciare. Bisogna sottolineare che l’esdebitazione può essere negata se emerge comportamento in mala fede: ad esempio, il Tribunale di Torino richiede che il debitore abbia almeno cercato lavoro nei 4 anni precedenti e non rifiutato occasioni senza motivo, come indice di diligenza. E se per ipotesi l’esdebitazione viene negata? I creditori potrebbero tornare a farsi vivi per i residui, ma in pratica dopo una liquidazione spesso il debitore rimane nullatenente e poco aggredibile – tuttavia non avrebbe la “certificazione” di liberazione e vivrebbe con quello spettro. Fortunatamente, il Codice prevede un’ultima spiaggia, di cui ora parliamo.
Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)
Questa è la procedura straordinaria e innovativa introdotta prima nella L.3/2012 (nel 2020) e ripresa dall’art. 283 del Codice. Viene colloquialmente detta “esdebitazione a zero” o esdebitazione dell’incapiente, ed è destinata al debitore persona fisica meritevole ma completamente privo di beni o capacità di pagamento. In altre parole, se un soggetto si trova schiacciato dai debiti ma non ha alcun patrimonio liquidabile né redditi aggredibili e non può offrire nulla ai creditori, può chiedere comunque di essere liberato dai debiti, senza pagare nulla, ottenendo così un nuovo inizio.
Requisiti principali:
- Il debitore deve essere persona fisica (non società) e meritevole, cioè la sua insolvenza non deve derivare da colpa grave o dolo (es. non deve aver fatto debiti per truffare i creditori o con leggerezza estrema). Il giudice verifica la storia dell’indebitamento e l’assenza di atti in frode.
- Deve trovarsi nell’oggettiva condizione di incapienza assoluta: non possiede beni né può offrire utilità neanche future ai creditori. Significa che qualunque liquidazione sarebbe inutile perché non c’è nulla da distribuire. Questa valutazione tiene conto di beni e redditi attuali, ma anche prospettive ragionevoli: se il debitore è giovane e sano, una prospettiva futura di guadagno c’è sempre; tuttavia, la legge consente l’esdebitazione ugualmente, ponendo però un obbligo condizionato di pagamento se entro 4 anni dovessero arrivare risorse significative.
- La procedura è accessibile una sola volta nella vita per ciascun debitore incapiente, essendo un beneficio eccezionale.
Come si svolge: il debitore presenta ricorso al tribunale (con l’ausilio obbligato di un OCC) chiedendo di essere ammesso al beneficio. Deve allegare:
- l’elenco di tutti i creditori e degli importi dovuti;
- una relazione OCC che illustra le cause dell’indebitamento, la diligenza o meno del debitore, e attesta la totale incapienza (nessun patrimonio vendibile, nessuna entrata pignorabile);
- documenti reddituali, stato di famiglia, ecc., e un piano di budget familiare per i prossimi 4 anni (per capire se è presumibile che resti incapiente).
Il tribunale, valutati i requisiti, può emettere un decreto di accoglimento, dichiarando inesigibili tutti i debiti del richiedente senza procedura liquidatoria. In quel decreto, però, stabilisce anche:
- l’obbligo a carico del debitore, se entro i 4 anni successivi alla pronuncia dovessero sopravvenire utilità rilevanti (vincite, eredità, aumenti di reddito), di pagare i creditori in misura non inferiore al 10% del loro debito;
- le modalità con cui il debitore dovrà annualmente comunicare al tribunale eventuali miglioramenti della sua situazione (in genere presentazione di una dichiarazione annuale di aggiornamento sul reddito, vigilata dall’OCC);
- eventualmente un termine per presentare tali dichiarazioni e l’avvertimento che, se non lo fa o se si scopre che ha mentito, il beneficio può essere revocato.
In pratica, per 4 anni il debitore esdebitato “in prova” deve condurre una vita trasparente e dedicare ai creditori eventuali entrate straordinarie. Tuttavia, non è tenuto a versare nulla se non supera la soglia del 10% di soddisfacimento. Ad esempio, se aveva €100.000 di debiti totali, e fra 2 anni ereditasse €20.000, dovrebbe destinarne almeno €10.000 (il 10%) ai vecchi creditori. Se ereditasse €200.000, ne dovrebbe destinare €100.000 (ma mai più del 100% ovviamente, il tetto è l’integrale pagamento, il 10% è la soglia minima per far scattare l’obbligo). Questa regola serve a evitare che i “furbi” si facciano pulire i debiti e poi un mese dopo vincano alla lotteria dando una beffa ai creditori.
Meritevolezza e controlli: il giudice verifica con attenzione l’assenza di colpa/dolo. Ad esempio, se risultasse che l’ex imprenditore ha dissipato volontariamente i beni per poi dichiararsi nullatenente, rigetterebbe l’istanza. L’OCC e il tribunale scrutano la storia bancaria e patrimoniale. Inoltre, se il debitore ha ottenuto in passato altre esdebitazioni (fallimentare o da sovraindebitamento), non può accedere all’incapiente per 5 anni o mai più se ne ha avute due. Questo per impedire abusi seriali.
Effetti del decreto di esdebitazione incapiente: da subito, tutti i debiti antecedenti sono inesigibili. I creditori non possono più iniziare o proseguire alcuna azione di recupero. Il nome del debitore verrà ripulito, salvo ovviamente restare nei registri per la procedura svolta. Se però emergerà nei 4 anni una violazione (debitor arricchito non paga la quota dovuta, o ha mentito), il tribunale su istanza riaprirà il caso e potrà revocare il beneficio. In tal caso i creditori riacquistano i diritti originari (anche se 4 anni dopo, i termini di prescrizione erano sospesi durante la procedura, quindi riprenderebbero a decorrere dalla revoca).
L’esdebitazione incapiente è dunque un meccanismo di ultima istanza che incarna pienamente il principio della “fresh start” in ottica sociale: permette di salvare chi è altrimenti condannato a debiti perenni senza via d’uscita. Un ex tabaccaio che, poniamo, abbia perso tutto (attività chiusa, casa in affitto, nessun bene, solo qualche migliaio di euro di risparmi) e debiti per 200mila euro, potrebbe liberarsene con questo strumento – chiaramente se la sua situazione è frutto di sventura e non di malizia.
Novità 2025 – Fondo per coprire i costi: un ostacolo pratico dell’esdebitazione incapiente era: come paga il nullatenente le spese della procedura (OCC, bolli, contributi)? Paradossalmente serviva qualche soldo per farsi dichiarare esdebitato senza soldi. Il legislatore se n’è accorto e con la Legge di Bilancio 2025 (L. 197/2024) ha istituito un Fondo pubblico per l’esdebitazione degli incapienti, con dotazione iniziale di €500.000 per il 2025. Questo Fondo, gestito dal Ministero della Giustizia, servirà a pagare le spese procedurali e i compensi degli OCC nei procedimenti di esdebitazione incapiente. In tal modo, il debitore totalmente privo di risorse non dovrà rinunciare per motivi economici. Il Fondo coprirà costi come il contributo unificato (€98) e marca da bollo, e la parcella dell’OCC (ridotta alla metà come prevede la norma, ma comunque prima a carico del debitore). Sarà il giudice, verificata l’indigenza, ad attingere al Fondo per remunerare l’OCC. Questa misura è sperimentale per il 2025 e soggetta a un decreto attuativo che ne stabilirà modalità e criteri. È un segnale molto positivo: lo Stato riconosce che aiutare i sovraindebitati a rialzarsi ha una valenza sociale ed economica (si evita l’esclusione perpetua di persone dal circuito produttivo).
In conclusione su esdebitazione incapiente: è un’ancora di salvezza per l’ex imprenditore onesto che però è letteralmente al verde. Da usare con sincerità e come extrema ratio, considerando però che non tutti i debiti spariranno (le eccezioni di legge restano) e che rimane un “periodo di osservazione” di 4 anni in cui eventuali colpi di fortuna vanno condivisi coi vecchi creditori.
Quando scegliere quale procedura?
Riassumendo le opzioni per il nostro ex titolare di tabacchi:
- Se ha ancora un minimo di capacità di pagamento o beni e vuole evitare la liquidazione totale, può provare con un piano del consumatore (se i debiti sono principalmente privati) o un concordato minore (se i debiti sono d’impresa). Queste procedure permettono di conservare eventualmente alcuni beni (specie la prima casa col mutuo, come visto) e di pagare solo parzialmente il dovuto, ottenendo esdebitazione a fine piano.
- Se invece la situazione è compromessa e non c’è modo di soddisfare i creditori se non vendendo tutto, la liquidazione controllata offre un percorso ordinato per farlo e togliersi comunque i debiti residui alla fine.
- Nel caso estremo in cui non ci sia proprio nulla da liquidare, si può chiedere direttamente l’esdebitazione incapiente, saltando la fase di liquidazione.
- La liquidazione giudiziale (fallimento) resta sullo sfondo: potrebbe intervenire d’ufficio se il debitore ne ha i requisiti, ma se questi preferisce (e può) anticipare con un concordato minore, eviterà il marchio del fallimento e gestirà lui l’iniziativa. Bisogna notare che il Codice della Crisi incoraggia la soluzione negoziata: ad esempio, se un creditore chiede il fallimento dell’ex tabaccaio, il giudice può rinviare per vedere se il debitore nel frattempo presenta un piano di ristrutturazione o concordato minore.
Di seguito, per maggiore chiarezza, presentiamo alcune tabelle riepilogative che confrontano le caratteristiche delle procedure concorsuali discusse e distinguono il trattamento delle varie tipologie di debiti.
Tabelle riepilogative
Di seguito due tabelle che sintetizzano rispettivamente le caratteristiche delle procedure concorsuali per il sovraindebitamento e le differenze di trattamento delle diverse tipologie di debito nell’ambito di tali procedure.
Tabella 1 – Confronto tra le procedure di sovraindebitamento e insolvenza (persona fisica)
| Procedura | Soggetti ammessi | Come funziona | Vantaggi per il debitore | Norme di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Persona fisica consumatore (debiti non legati ad attività d’impresa). Esempio: privato o ex imprenditore per debiti personali. | Il debitore propone un piano di pagamento (anche parziale) ai creditori. Nessun voto dei creditori: decide il giudice sull’omologazione. L’OCC certifica veridicità dei dati e fattibilità. Misure protettive durante esame. | – Mantiene i beni non destinati al piano.– Niente voto creditori: possibilità di omologa anche con creditori contrari, se piano vantaggioso.– Dopo esecuzione del piano, esdebitazione automatica dei debiti residui. | CCII artt. 67-73 (prima L.3/2012). Ultime modifiche dal D.Lgs. 83/2022. |
| Concordato minore | Debitore non consumatore sovraindebitato: piccoli imprenditori, professionisti, start-up, ex imprenditori per debiti di impresa. | Il debitore presenta una proposta di concordato (piano di rientro) sottoposta al voto dei creditori (maggioranza per valore). Se approvata (o imposta dal giudice al Fisco se requisiti), viene omologata dal Tribunale. OCC coinvolto in preparazione e vigilanza. | – Può prevedere pagamenti dilazionati o parziali ai creditori chirografari.– Possibilità di continuare attività (concordato in continuità) o liquidare parzialmente.– Casa tutelata se mutuo in regola: può continuare a pagare le rate del mutuo casa principale e non perdere l’immobile.– Esdebitazione a fine procedura omologata: il debitore resta obbligato solo nei limiti dell’accordo (debiti falcidiati sono inesigibili). | CCII artt. 74-80. Modifiche correttivo 2020 e 2024 (D.Lgs. 147/2020, 136/2024). |
| Liquidazione controllata del sovraindebitato | Ogni debitore sovraindebitato non fallibile (consumatore o non) che sia insolvente. Ammessa anche su richiesta creditori/PM. | Procedura liquidatoria simile al fallimento: nominato un Liquidatore, si spossessa il debitore dei beni (salvi quelli impignorabili) e si liquidano a beneficio dei creditori. Durata tipica 1-3 anni. I creditori concorrono nello stato passivo e ricevono riparti in base a prelazioni. | – Procedura “ordinata” e trasparente, con controllo giudiziario.– Il debitore soddisfa i creditori con tutto il possibile ma senza restare debitore oltre.– Esdebitazione: post chiusura (o dopo 3 anni) il debitore meritevole è liberato dai debiti residui, anche se i creditori non hanno ricevuto molto (basta aver cooperato). | CCII artt. 268-277 (procedura) e 278-282 (esdebitazione). Prima: L.3/2012 liquidazione patrimonio. |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persona fisica meritevole, senza beni né redditi da offrire (incapienza assoluta). Una sola volta. | Procedimento sui generis: il debitore chiede al Tribunale di essere liberato dai debiti senza attivare liquidazione, dimostrando la propria totale insolvibilità. Se accolto, il giudice emette decreto che cancella i debiti con eventuale condizione di pagamento se entro 4 anni compaiono risorse ≥10% per creditori. | – Cancellazione immediata di tutti i debiti pregressi (salvo esclusi di legge).– Nessun bene liquidato (perché non ce n’è).– Fine dell’incubo: il debitore esce dalla trappola debitoria e può ripartire, pur conscio di un monitoraggio quadriennale delle sue finanze. | CCII art. 283 (rubrica “Esdebitazione sovraindebitato incapiente”). Introdotto da L.176/2020 in L.3/2012 art. 14-quaterdecies, confermato nel CCII. Legge Bilancio 2025 istituisce Fondo spese. |
| Liquidazione giudiziale (Fallimento) | Imprenditore commerciale fallibile (oltre soglie art. 2 CCII) insolvente. Nel caso di ditta individuale tabacchi, applicabile solo se superava limiti dimensionali. | Procedura liquidatoria concorsuale “classica”: amministrazione affidata a Curatore, stop a azioni individuali, liquidazione di tutti i beni. I creditori vengono soddisfatti secondo prelazioni. | – Il debitore non deve più gestire l’ansia dei singoli creditori (cura tutto il Curatore).– Se persona fisica, può ottenere esdebitazione finale dei debiti non pagati, salvo condotte fraudolente. | CCII artt. 121-270 (prima: R.D. 267/42). Esdebitazione art. 282 CCII (prima art. 142 L.F.). |
Nota: In tutte le procedure sopra, restano esclusi dall’esdebitazione i debiti di natura alimentare, da risarcimento danni extracontrattuali e sanzioni pecuniarie. Inoltre, l’esdebitazione non toglie responsabilità a eventuali coobbligati o fideiussori del debitore: ad esempio, se un famigliare ha garantito un debito bancario, quel garante resta obbligato anche se il debitore principale è esdebitato.
Tabella 2 – Trattamento delle diverse tipologie di debito nelle procedure
| Tipo di debito | Nella procedura concorsuale | Possibilità di stralcio/riduzione | Note |
|---|---|---|---|
| Debiti chirografari (non garantiti) – Es: fornitori, carte di credito, prestiti personali non garantiti. | Partecipano al concorso come crediti chirografari (cioè senza prelazione). In piani/concordati, sono solitamente classificati in una classe e pagati parzialmente (percentuale offerta dal debitore). In liquidazione, ricevono quanto resta dopo soddisfatti i privilegiati, spesso pochi spiccioli. | Sì, stralcio significativo possibile: sono i primi candidati ad essere falcidiati nei piani. Ad esempio, un piano del consumatore può prevedere di pagare solo il 20% di questi debiti e l’esdebitazione cancella il restante 80%. Nel concordato minore, il piano deve offrire loro almeno quanto otterrebbero liquidando tutto (spesso molto poco). | La soddisfazione dei chirografari funge da ago della bilancia: devono prendere non meno di quanto prenderebbero in una liquidazione. Se il debitore ha pochi beni, il “dividendo” per chirografari può essere anche simbolico (es. 5%). Se però il piano offre meno di questo ipotetico 5%, i creditori (o il giudice) potrebbero opporsi. |
| Debiti con garanzia reale (ipotecari o pignoratizi) – Es: mutuo bancario con ipoteca su casa, leasing su auto, pegno. | Il credito è privilegiato per il valore del bene. Nel concorso, il creditore ipotecario può escutere la garanzia o attenderne la vendita: viene soddisfatto con preferenza sul ricavato dell’immobile fino a copertura del suo credito. L’eventuale parte non coperta dalla garanzia (debito > valore bene) degrada a chirografaria. Nei piani, di norma questi crediti vanno trattati separatamente: o pagando integralmente il valore di garanzia, oppure, previa perizia, cram-down se il valore del bene è minore del debito. | Possibile riduzione solo della parte non garantita: la regola è la “saturazione del valore del bene”. Esempio: mutuo €150k su casa che ne vale €100k; il piano può prevedere di pagare €100k (magari rateizzandoli) al creditore ipotecario e il restante €50k come chirografo (quindi falcidiato). Non si può normalmente offrire meno del valore di mercato del bene al creditore ipotecario senza il suo consenso. Eccezione importante: se è mutuo su prima casa e il debitore è in regola con rate, può continuare a pagare normalmente senza vendere l’immobile. | Nei concordati, dal 2024 si permette di mantenere il mutuo prima casa (salvando l’immobile) se si paga il dovuto scaduto e si dimostra che il valore copre il debito. Attenzione: se il bene viene liquidato, l’eventuale eccedenza di debito residua dopo vendita – per ipotecari – rientra tra i debiti chirografari esdebitabili. |
| Debiti privilegiati senza garanzia reale – Es: debiti da salari (privilegio generale mobiliare), debiti fiscali (privilegio speciale su beni aziendali e generale), contributi INPS, ecc. | Questi crediti hanno prelazione per legge. In liquidazione, saranno pagati con precedenza sugli altri dal ricavato generale (o su specifici beni se privilegio speciale). Nei piani, falcidiarli richiede solitamente il consenso o il rispetto di condizioni di legge. Ad esempio, i crediti per stipendi ultimi 6 mesi spesso vanno integralmente soddisfatti per ottenere l’omologa; i crediti fiscali privileggiati possono essere dilazionati o parzialmente non pagati solo col cram-down (omologa nonostante voto contrario) se offerto almeno il 30%. | Stralcio limitato: per debiti come stipendi e TFR dei dipendenti di solito no, vanno pagati al 100% (sono super-privilegi, in molti casi prededucibili se sorto prima). Per debiti fiscali privilegiati, la legge consente il taglio solo se l’Erario vota favorevolmente oppure, se dissente, il piano deve comunque dare un soddisfacimento minimo fissato (prima L.3/2012 chiedeva un apporto esterno ≥10%, ora CCII richiede consenso o soglie per cram-down). Dunque il Fisco privilegiato raramente prende meno del 30-40%. I contributi INPS seguono simile sorte. | È prassi che piani e concordati assicurino un certo “ricompenso” ai privilegiati per ottenere il via libera: ad es., pagare i debiti IVA (che sono privilegiati) interamente o quasi, perché per legge l’IVA è difficilmente falcidiabile (essendo tributo UE). Anche se formalmente falcidiare è ammesso, in concreto i giudici potrebbero rigettare se ritengono violato l’ordine delle prelazioni. Spesso, per equità, se non si può pagare integralmente i privilegiati, si offre loro una dilazione pluriennale. Cassazione ha confermato che dilazionare anche oltre 1 anno i privilegiati è legittimo, purché abbiano voce in capitolo (diritto di voto). |
| Debiti fiscali e multe (Erario, Comuni) | Rientrano nelle categorie sopra a seconda della natura: tributi con privilegio (IVA, ritenute) trattati come crediti privilegiati; tributi senza privilegio (p.es. sanzioni, interessi) come chirografari; multe e ammende non hanno privilegio (ma sanzioni pecuniarie non accessorie non si esdebitano). | Tributi privilegiati: vedi sopra (si pagano almeno in buona parte, o dilazionati, salvo accordo). Tributi chirografari: possono essere ridotti come altri chirografari. Sanzioni amministrative/penali: per legge non si cancellano con esdebitazione, quindi il piano può pure prevederne il non pagamento ma dopo la procedura resteranno dovute (il creditore – es. Comune per multa – potrà riprendere esecuzione). In pratica, conviene al debitore comunque inserirle e pagarle per quanto possibile, sennò dopo rispunteranno. | L’Agenzia Entrate e AdER spesso non votano oppure votano contro nei piani; tuttavia, grazie al meccanismo di omologa forzata (cram-down), il giudice può approvare ugualmente se il trattamento offerto è equo per il Fisco. Dal 2024, come detto, servono soglie minime più rigorose per cramdow fiscale, dunque maggiore attenzione a offrire al Fisco qualcosa di sostanzioso. Le definizioni agevolate pendenti: se il debitore ha aderito a rottamazioni, può includerle nel piano. Ad es., se aveva una rottamazione quater da pagare in 18 rate, il piano potrebbe prevedere di pagarne solo alcune con stralcio del resto, ma serve accordo dell’ente (non automatico). |
| Debiti verso banche finanziati da garanti (fideiussioni, coobbligati) | La procedura riguarda solo il debitore principale. Il creditore può insinuare tutto il credito. Se riceve pagamenti parziali, può escutere la differenza dal fideiussore esterno. | Nessun stralcio per il coobbligato: L’esdebitazione libera il debitore principale ma non il garante o coobbligato. Il fideiussore che paga però subentra (surroga) nel credito e, se la procedura è ancora aperta, potrebbe insinuarsi al posto della banca per la parte pagata. Se la procedura è chiusa ed il debitore principale è esdebitato, il fideiussore purtroppo non può più rivalersi su di lui (il regresso diventa anch’esso inesigibile, essendo debito concorsuale post-subentro). | Esempio: moglie garante del mutuo del marito. Il marito fa concordato e paga solo l’80% del mutuo, liberandosi per esdebitazione del resto. La banca potrà chiedere il 20% alla moglie garante. La moglie pagherà e teoricamente avrebbe diritto di regresso verso il marito per quel 20%, ma quel credito di regresso è un debito derivante da obbligazione precedente (la fideiussione) e quindi concorsuale: essendo il marito esdebitato, non glielo potrà chiedere. In sintesi il garante resta obbligato e finisce per pagare, senza possibilità di recupero dal debitore principale. |
| Debiti per alimenti e mantenimento (assegni a coniuge, figli) | Sono debiti personali non legati all’attività, e per giunta indisponibili: non si possono inserire in un piano per ridurli, essendo dovuti per legge periodicamente. Se ci sono arretrati, il piano potrebbe prevedere di pagarli integralmente fuori concorso. | Non esdebitabili: restano esclusi per legge dalla liberazione. | Anche dopo la procedura, il coniuge o figlio beneficiario potrà pretendere gli arretrati non corrisposti. Meglio quindi che il debitore li consideri a parte e li paghi se vuole evitare cause (peraltro questi crediti hanno prelazione sul TFR e su alcune somme). |
| Risarcimenti da fatti illeciti (sentenze di danni civili) | Il creditore danneggiato può insinuarsi al passivo come chirografo (se il fatto illecito non dà privilegio, di solito no salvo alcuni casi come lesioni da reato intenzionale su persona che danno privilegio ex art. 2754 bis c.c.). | Non esdebitabili per legge se extracontrattuali. Significa che il credito residuo per danni non viene toccato dall’esdebitazione: il danneggiato potrà continuare a chiederlo. | Non esdebitabile limita molto il beneficio per chi ha grossi debiti da risarcimento (es. incidente stradale con torto): anche dopo fallimento o sovraindebitamento, la vittima può pretendere il dovuto. Talvolta si cerca di risolvere con transazioni ad hoc con questi creditori “protetti”. |
(Legenda: CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; OCC = Organismo di Composizione della Crisi o Gestore; Piani = piano del consumatore / concordato minore; L.F. = Legge Fallimentare 1942; L.3/2012 = legge sovraindebitamento 2012.)
Come si evince dalle tabelle, la chiave di volta per l’ex titolare di tabacchi indebitato è scegliere la procedura più adatta al proprio caso, tenendo conto della composizione dei debiti e delle risorse disponibili. Se possiede ancora un immobile e un reddito, può ambire a un concordato minore conservativo; se non ha nulla, opterà per l’esdebitazione incapiente; se sta nel mezzo, la liquidazione controllata con esdebitazione finale può essere una soluzione pulita.
Esempi pratici e simulazioni
Per concretizzare quanto esposto, esaminiamo qualche scenario pratico tipico di un ex titolare di tabaccheria con debiti, illustrando le possibili soluzioni:
Esempio 1: “Mario, ex tabaccaio con debiti personali e d’impresa”
Mario era titolare di una tabaccheria individuale, chiusa nel 2024 a causa di difficoltà economiche. Si ritrova con: €20.000 di debiti con fornitori di generi di monopolio, €15.000 di debiti con il fornitore di slot machines, €10.000 di bollette arretrate, €8.000 di contributi INPS non pagati, €5.000 tra sanzioni amministrative per violazioni minori e interessi, e un mutuo residuo di €80.000 sulla casa di abitazione (valore immobile circa €90.000, rate pagate regolarmente fino ad oggi). Non ha dipendenti. Ha un nuovo impiego come commesso con stipendio €1.200/mese. Niente altri beni di rilievo. Come può procedere?
- Analisi: Debiti totali ~€58.000 (escluso mutuo). Tipologia: prevalentemente chirografari (fornitori, bollette), uno privilegiato (INPS), e varie sanzioni. Ha una casa con mutuo e uno stipendio modesto. Mario è non fallibile (piccolo imprenditore cessato) e i suoi debiti originano in parte dall’impresa. Non è “consumatore puro” per via dei debiti di fornitura/INPS. Quindi non può fare il piano del consumatore, ma può tentare il concordato minore.
- Soluzione: Mario, con un OCC, prepara un piano di concordato minore. Obiettivo: tenere la casa e proseguire il mutuo (visto che riesce a pagare la rata di ~€400/mese col suo stipendio), e offrire qualcosa ai creditori con le restanti capacità. Grazie al nuovo art. 75 co.2-bis CCII, inserisce nel piano la clausola che continuerà a pagare le rate del mutuo ipotecario sulla prima casa alle scadenze convenute, mantenendo l’immobile (OCC attesta che il debito ipotecario €80k ≤ valore casa €90k, e che ciò non lede gli altri creditori). Così la banca non partecipa al voto e resta fuori dal concorso (beneficiando comunque della prosecuzione regolare del mutuo). Per gli altri debiti (€58k): Mario propone di pagare, nell’arco di 4 anni, un totale di €20.000 così ripartiti: in 48 rate mensili da circa €416, provenienti dal suo stipendio (impegnando circa un terzo dello stipendio, che è fattibile). I €20k saranno distribuiti così: pagamento integrale dei €8.000 INPS (per ottenere il voto favorevole dell’ente e perché privilegio), pagamento integrale di €2.000 su €5.000 di sanzioni amministrative (anche se non esdebitabili, mostra buona fede pagando una parte; residuo 3k rimarrà comunque a margine, ma essendo non esdebitabile Mario sa che dovrà comunque pagarle a parte, oppure confida in un condono futuro), il restante ~€10.000 ai fornitori/bollette (che hanno €35k sommati, quindi circa il 28%). L’OCC attesta che in un’alternativa liquidazione questi creditori prenderebbero zero (perché la casa è ipotecata e stipendio sarebbe pignorabile solo parzialmente), dunque il 28% è conveniente. I creditori votano: INPS favorevole (liquidato al 100%); fornitori e altri, vedendo che se no Mario farebbe liquidazione e loro nulla, con qualche resistenza ma la maggioranza accetta. Il tribunale omologa. Mario mantiene la casa, continua a pagare mutuo e parallelamente paga le rate concordatarie. Dopo 4 anni, è debit-free: i fornitori hanno avuto il 28% e non possono pretendere altro (72% stralciato), le bollette idem, l’INPS è soddisfatta, le sanzioni residuanti 3k tecnicamente non erano esdebitate ma Mario in realtà le ha nel frattempo estinte a parte (per prudenza). La casa è salva e il mutuo prosegue. Mario ha sfruttato appieno la flessibilità del concordato minore (pagamento parziale, dilazione, casa salva).
- Alternativa: se i creditori non avessero approvato, Mario avrebbe ripiegato sulla liquidazione controllata: la casa sarebbe stata venduta all’asta (banca ipotecaria avrebbe preso 80k, residuo 10k ai chirografari) e lui dopo 3 anni avrebbe chiesto esdebitazione. Avrebbe perso la casa e i creditori avrebbero preso molto meno. Quindi tutti hanno avuto convenienza al concordato minore.
Esempio 2: “Luisa, debitrice incapiente”
Luisa, 30 anni, era socia di fatto nell’attività del marito (tabaccheria a nome di lui), che è fallito. Lei si ritrova intestati alcuni debiti personali: un prestito da €10.000 per aiutarlo, carte di credito per €5.000 e due fideiussioni firmate per fornitori per €8.000 (escusse dopo il fallimento). In totale circa €23.000. Luisa però attualmente è disoccupata, non ha beni (la casa era intestata al marito, ora all’asta), vive in affitto, due figli piccoli, campa con aiuti dei parenti. Non può proporre alcun piano di pagamento.
- Soluzione: Luisa può chiedere direttamente l’esdebitazione da incapiente. Un OCC verifica che non ha reddito, né beni, né prospettive immediate (due bimbi sotto 5 anni, difficoltà a lavorare full-time). Nel ricorso Luisa dichiara di non poter offrire nessuna utilità ai creditori, ma di voler cancellare i debiti per poter cercare lavoro in futuro senza quelle pendenze. Il tribunale valuta la sua condotta: i debiti derivano da aver garantito l’azienda familiare, atto non fraudolento; non risultano beni nascosti. Accoglie l’istanza e decreta l’esdebitazione ex art. 283 CCII. Tutti i creditori (banche, fornitori) sono avvisati che non potranno più pretendere nulla da Luisa. Nei prossimi 4 anni, Luisa dovrà comunicare annualmente la sua situazione economica. Immaginiamo che entro 4 anni riesca a trovare un part-time a €600/mese e nulla più – non avrà utilità straordinarie, dunque non dovrà versare alcunché ai creditori. I debiti restano cancellati definitivamente. Luisa ottiene così la “fresh start” totale, rimanendo solo con l’onere morale di gestire oculatamente le sue finanze d’ora in avanti. Senza questo istituto, sarebbe rimasta a vita con quei €23k pendenti e pignorabile qualora avesse trovato lavoro; ora invece può ricostruire la propria vita senza quell’angoscia.
- Nota: se per caso Luisa avesse ereditato €30.000 dalla nonna entro i 4 anni, avrebbe dovuto informare il giudice: essendo €30k > 10% di €23k, le toccava destinare almeno €2.300 (10%) ai vecchi creditori. Il giudice avrebbe potuto stabilire anche un importo maggiore secondo equità, ma non oltre il dovuto integrale. Così i creditori avrebbero ricevuto qualcosa. In ogni caso, un’eredità modesta non intacca l’esdebitazione concessa, salvo la quota da devolvere; solo una condotta fraudolenta (non dichiarare l’eredità) l’avrebbe fatta revocare.
Esempio 3: “Angelo, fallimento con esdebitazione”
Angelo gestiva la tabaccheria tramite una SRL, di cui era amministratore e garante di alcuni debiti. La SRL è stata dichiarata fallita nel 2023 con €500.000 di passivo. Angelo come persona fisica ha sul groppone le fideiussioni: una banca gli ha già notificato un decreto ingiuntivo di €100.000 (fido di cassa garantito) e un fornitore €50.000 (anche garantito). Angelo possiede una seconda casa di vacanza, che è stata ipotecata dalla banca e ora è pignorata, e nient’altro di valore (la prima casa è intestata alla moglie). Non esistono procedure di sovraindebitamento per la sua situazione, perché i debiti sono da garanzie di società fallita (lui come fideiussore è tecnicamente un consumatore, avrebbe accesso a piano del consumatore, ma l’importo è enorme e i creditori aggressivi non starebbero a guardare). Infatti uno ha già avviato esecuzione sulla casa vacanza.
- Soluzione possibile: Angelo può valutare il fallimento personale. Anche se lui come persona non è imprenditore (le fideiussioni sono di natura personale), giurisprudenza talora esclude il fallimento per i soli garanti. Tuttavia, potrebbe essere soggetto a liquidazione controllata come consumatore sovraindebitato (sì, questa è l’opzione giusta: sovraindebitamento!). Egli quindi avvia una liquidazione controllata dei propri beni: la casa vacanza verrà venduta dal Liquidatore, i crediti delle banche e fornitori saranno accertati. Supponiamo che dalla vendita della casa si ricavino €120.000: la banca ipotecaria (creditrice €100k) prende i primi €100k, rimangono €20k per il fornitore (che aveva €50k, dunque 40% soddisfatto). Dopo la chiusura, Angelo chiede l’esdebitazione. Il tribunale verifica che Angelo non ha frodato (la seconda casa l’aveva comprata anni prima regolarmente, e l’ha messa a disposizione). Ha cooperato col curatore. I creditori sono stati pagati almeno “in parte non trascurabile” (la banca integralmente, il fornitore 40%). Anche se il fornitore ha perso 60%, il giudice con ogni probabilità concede l’esdebitazione perché la condotta è stata corretta e qualcosa ha preso. Angelo così è libero dai residui €30k verso il fornitore.
- Variante: se la casa fosse valsa molto meno, ad esempio €50k, e la banca ipotecaria ne avesse assorbito tutto lasciando zero al fornitore, formalmente i chirografari non avrebbero ricevuto nulla. Cassazione dice: se nessun creditore è stato soddisfatto neppure in parte, l’esdebitazione potrebbe essere negata. Angelo rischierebbe in tal caso. Ma grazie alla norma sull’incapiente, potrebbe successivamente (dopo la liquidazione) chiedere quell’esdebitazione speciale per far cancellare anche quel debito rimasto. Oppure, se prevedeva questo, poteva offrire al fornitore un piccolo pagamento durante la procedura (es. cedere anche l’auto per ricavare 5k) così da far risultare un pagamento non affatto irrisorio e rientrare nel requisito.
Esempio 4: “Enrico, accordo stragiudiziale e CRIF”
Enrico, ex tabaccaio, ha “solo” €12.000 di debiti con due fornitori e una banca (prestito 5k) e nessun altro. Ha chiuso l’attività e trovato lavoro. Non vuole procedure concorsuali per non comparire da nessuna parte. Opta per negoziare privatamente. Offre ad entrambi i fornitori un saldo e stralcio: €3.000 a uno (che ne vantava 6k) e €2.000 all’altro (che ne vantava 4k) – circa il 50%. Risparmia quindi €5.000. La banca la ripaga integralmente ma chiede una dilazione di 2 anni senza interessi: la banca accetta perché Enrico è sempre stato cliente corretto. Con un po’ di aiuto familiare, Enrico esegue i due stralci e inizia a pagare le rate in banca. In un anno e mezzo è debt-free. Vantaggi: nessuna pubblicità, costi legali minimi, rapporto salvo con banca. Svantaggi: Enrico era stato segnalato in CRIF per alcune rate saltate durante la crisi – quella segnalazione rimarrà per 24 mesi dal saldo del debito, ma potrà chiedere sia annotato che il debito è “saldato a stralcio”. I fornitori, avendo accettato il 50% a saldo, non potranno segnalare altro (non esistono CRIF per trade credit). Enrico ha evitato la procedura formale perché l’entità dei debiti era gestibile. Se anche uno dei due fornitori avesse rifiutato, la minaccia implicita sarebbe stata: “altrimenti faccio un concordato minore e forse prendi meno” – spesso funziona come leva.
Questi esempi mostrano che ogni situazione richiede un approccio su misura, bilanciando costi, benefici e conseguenze a lungo termine. Un avvocato specializzato saprà consigliare se è preferibile una trattativa privata (quando i debiti sono pochi e circoscritti), oppure se conviene entrare in procedura concorsuale per ottenere la protezione del giudice e l’esdebitazione.
Domande frequenti (FAQ)
Domanda: Un ex titolare di tabacchi può essere dichiarato fallito anche dopo che ha chiuso l’attività?
Risposta: Sì, è possibile, ma solo se la sua impresa aveva dimensioni sopra le soglie di legge e l’istanza di fallimento viene presentata entro 1 anno dalla cessazione. In base all’art. 121 CCII, un imprenditore commerciale individuale è soggetto a liquidazione giudiziale (fallimento) se era insolvente e non rientrava nei parametri di “piccolo imprenditore”. Nel caso di una tabaccheria, spesso tali soglie (attivo > €300k, ricavi > €200k, debiti > €500k) non sono superate, quindi l’ex titolare non è fallibile. Se invece lo era, i creditori possono chiederne il fallimento finché non decorre un anno dalla cancellazione/cessazione. Dopo quell’anno, non si può più iniziare un fallimento, ma il debitore resta comunque esposto alle azioni esecutive individuali dei creditori. In ogni caso, anche qualora venisse dichiarato fallito, l’ex imprenditore persona fisica potrà successivamente domandare l’esdebitazione per liberarsi dai debiti residui.
Domanda: Qual è la differenza tra procedura di sovraindebitamento e fallimento?
Risposta: Le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) sono pensate per i debitori non soggetti a fallimento (o per i consumatori). Rispetto al fallimento, hanno alcune differenze chiave:
- Possono essere attivate volontariamente dal debitore stesso (spesso con finalità di accordo ristrutturativo, non solo liquidatorio).
- Nel caso di piani o concordati minori, c’è spazio per un accordo con i creditori e per pagare solo parzialmente il debito, cosa che il fallimento non consente (nel fallimento si liquidano i beni e fine, non c’è una “proposta”: se l’attivo paga il 20%, quello è, non c’è bisogno di consenso dei creditori).
- Le procedure sovraindebitamento sono generalmente meno stigmatizzanti: non comportano incapacità personali o restrizioni ai diritti (il fallito, ad esempio, aveva limitazioni legali, oggi attenuate, ma comunque).
- Quanto agli obiettivi, un piano del consumatore o concordato minore punta a evitare la liquidazione e trovare una soluzione sostenibile; il fallimento mira principalmente a liquidare a beneficio dei creditori, anche a costo di sacrificare tutto il patrimonio.
- Tuttavia, sia sovraindebitamento che fallimento offrono alla fine la possibilità di esdebitazione (liberazione dai debiti) del debitore meritevole. Il CCII ha unificato molto la disciplina dell’esdebitazione: oggi anche nel fallimento l’esdebitazione arriva dopo 3 anni o a chiusura, similmente alla liquidazione controllata. Quindi, in termini di risultato finale, entrambi gli itinerari possono condurre a cancellare i debiti, ma le procedure sovraindebitamento sono più flessibili e accessibili per i piccoli debitori, mentre il fallimento è riservato ai grandi (ed è più complesso, con curatore, ecc.).
In sintesi: il fallimento (liquidazione giudiziale) è l’ultima ratio per imprenditori fallibili, le procedure di sovraindebitamento sono “su misura” per i piccoli o per i privati, con strumenti come il piano del consumatore dove i creditori nemmeno votano e contano la meritevolezza e convenienza.
Domanda: Se intraprendo una procedura di sovraindebitamento, perdo per sempre la mia casa?
Risposta: Non necessariamente. Dipende dalla procedura e dalle tue scelte. Se fai una liquidazione controllata, quella è liquidatoria: tutti i beni non impignorabili, inclusa la casa di proprietà, vengono venduti per pagare i creditori. Quindi in liquidazione normalmente perdi la casa. Ma se invece presenti un piano del consumatore o concordato minore, hai margine per salvare l’abitazione principale, soprattutto se c’è un mutuo. Come spiegato, la legge oggi consente di prevedere nel piano la continuità del pagamento del mutuo ipotecario sulla prima casa, mantenendo l’immobile fuori dalla liquidazione. In pratica devi essere in regola con le rate (o pagarle subito quelle scadute) e dimostrare che lasciando la casa al debitore i creditori non vengono danneggiati (cioè quella casa ha un mutuo in linea col suo valore, quindi venderla non darebbe extra per altri creditori). Se soddisfi questi requisiti, il tribunale ti autorizza a continuare a pagare il mutuo e non ti fa vendere la casa, né i creditori possono ipotecarla oltre. Questo vale in piano del consumatore (art. 67 co.5 CCII) ed è stato esteso al concordato minore dal 2024. Quindi, in quelle procedure puoi conservare la casa. Devi però poi pagare regolarmente il mutuo fino alla fine come da contratto.
Se invece non hai un mutuo ma la casa libera, nel piano potresti decidere di tenerla offrendo ai creditori altri beni o denaro equivalenti; però è più difficile convincerli a rinunciare all’asset principale. Spesso, in assenza di mutuo, tenere la casa significa farla stimare e magari far subentrare un parente che rileva la quota di valore per dare soldi ai creditori (una sorta di apporto esterno). Insomma, salvare la casa è possibile in un concordato minore/piano, ma occorre un contraccambio per i creditori. Ricordiamo infine che se il debito è solo con AdER (Erario) e la casa è prima casa non di lusso, già per legge AdER non può pignorarla. Quindi, se i tuoi unici creditori sono fiscali e rispettano quei requisiti, forse non serve nemmeno la procedura – basta rateizzare e la casa è comunque protetta per legge.
Domanda: Quali debiti non possono essere cancellati nemmeno con l’esdebitazione?
Risposta: La legge italiana esclude dall’esdebitazione alcune categorie specifiche:
- Gli obblighi di mantenimento e alimentari dovuti per legge (verso coniuge, figli, etc.). Significa che se hai arretrati di assegni familiari, quelli non vengono perdonati: dovrai comunque pagarli, la moglie o i figli potranno esigerli anche post procedura.
- I debiti per risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale. Esempio tipico: sei stato condannato a risarcire le vittime di un incidente stradale causato da te. Quella è una obbligazione da fatto illecito (extracontrattuale) e non si estingue con l’esdebitazione – le vittime potranno sempre rincorrerti per il risarcimento.
- Le sanzioni penali o amministrative pecuniarie non accessorie. Ciò include multe, ammende, sanzioni amministrative (multe stradali, sanzioni per violazioni fiscali, etc.), a meno che siano “accessorie a debiti estinti” (ad esempio gli interessi di mora su un debito fiscale condonato, forse). In generale, però, le multe restano dovute.
Quindi, anche dopo un fallimento o sovraindebitamento chiuso con esdebitazione, questi particolari creditori possono ancora pretendere i loro soldi. Fortunatamente, sono casi relativamente ristretti. La stragrande maggioranza dei debiti – dai finanziamenti alle carte di credito, dalle fatture non pagate ai debiti bancari e fiscali (quota capitale) – si cancellano. Ad esempio, il debito con una banca per un prestito si esdebità; il debito con l’Agenzia Entrate per IRPEF non pagata si esdebità (l’IRPEF è tributo, non multa); una contravvenzione al CdS no, quella rimane.
Una nota: l’esdebitazione non copre nemmeno i debiti futuri (ovviamente). Sembra banale, ma vuol dire che se hai continuato a non pagare il mantenimento dei figli anche dopo l’apertura procedura, quell’accumulo post non è neanche teoricamente toccato. Così come le cartelle per tributi maturati dopo l’omologa, ecc.
Domanda: Ho ricevuto un atto di pignoramento: posso ancora evitare che i miei beni vengano venduti?
Risposta: Dipende dallo stadio della procedura esecutiva, ma spesso sì, ci sono strumenti. Se il pignoramento è appena iniziato, puoi opporti se vi sono vizi o motivi legali (vedi opposizione all’esecuzione e agli atti sopra). Puoi anche cercare un accordo con il creditore: ad esempio proporre di vendere tu l’immobile a un terzo e dare i soldi al creditore (il cosiddetto accordo ex art. 624-bis c.p.c. con sospensione). Il giudice può sospendere l’asta se c’è una trattativa seria in corso. Inoltre, come spiegato, puoi convertire il pignoramento depositando la somma dovuta (magari chiedendo rateazione al giudice, che può concederla fino a 36 mesi in casi eccezionali). Questo ovviamente richiede che tu abbia accesso al denaro (vendita di un bene diverso, prestito da terzi, ecc.).
Un’altra via potente è attivare una procedura concorsuale: se depositi un ricorso per sovraindebitamento e il giudice concede le misure protettive, l’esecuzione in corso deve fermarsi. Ad esempio, se la tua casa è pignorata e l’asta è fissata, ma tu presenti un piano del consumatore e ottieni dal giudice la sospensione, l’asta non potrà tenersi finché la procedura di sovraindebitamento è in corso (in pratica i creditori dovranno discutere lì dentro).
Tieni presente che prima viene assegnato o trasferito il bene, più difficile è tornare indietro: se l’immobile è già stato aggiudicato e il decreto di trasferimento emesso, la proprietà è passata e la procedura chiusa. A quel punto, neanche la procedura concorsuale te la ridà (potrai al più dare ai creditori nell’ambito concorsuale il ricavato dell’asta, ma la casa è andata). Se invece sei ancora nelle fasi iniziali (pignoramento notificato, ma neanche l’udienza di vendita fissata), hai diverse chance di sospendere e trovare soluzioni. Dunque la risposta breve è: sì, puoi evitare la vendita forzata se agisci per tempo, o trovando i soldi (accordo/convertendo) o immettendo il tutto in una cornice concorsuale protetta.
Domanda: Che succede ai debiti che ho co-firmato con un’altra persona (es. sono coobbligato o garante)?
Risposta: Se tu attivi una procedura e ottieni l’esdebitazione, il beneficio è solo tuo. Il tuo coobbligato/garante rimane obbligato per intero. Ad esempio, se hai un mutuo cointestato con tua moglie e tu fai il concordato e ne esci esdebitato, la banca potrà chiedere a tua moglie l’intero importo (non solo la metà). Lei poi, se paga più della sua parte, avrebbe diritto di regresso verso di te, ma quel regresso è un debito che affonda nella tua situazione pregressa e viene anch’esso spazzato via dall’esdebitazione. Risultato: il garante resta fregato perché paga e non può neanche rivalersi su di te.
Quindi, fondamentale: se hai garanti o cofirmatari che tieni a tutelare (es. un parente che ti ha fatto da fideiussore), devi considerarli nella strategia. Potresti ad esempio includere nel piano un trattamento anche per soddisfare indirettamente quel debito garantito, in modo da liberare il garante. In teoria la tua procedura non può direttamente esdebitare il garante (lui non è parte), ma puoi destinare fondi per pagare il debito garantito così il garante non viene escusso. Oppure, altra via, potresti consigliare anche al garante (se pure lui è in difficoltà) di attivare una sua procedura parallela. A volte succede: marito e moglie entrambi indebitati e garanti reciproci presentano procedure coordinate in tribunale.
Riassumendo: la liberazione dai debiti è personale; i debiti con obbligazioni in solido permangono sugli altri obbligati. Attenzione anche per i soci di SNC o SAS: i creditori sociali se stralci il debito della società con accordo minore (possibile se la società è minore), i soci illimitatamente responsabili restano obbligati (ma anch’essi possono accedere a sovraindebitamento personale). Bisogna far un puzzle attento in questi casi.
Domanda: Dopo l’esdebitazione, posso tornare ad avere accesso al credito? La segnalazione in CRIF scompare?
Risposta: L’esdebitazione comporta che legalmente non sei più debitore di quelle somme. Tuttavia, le tracce delle vicende creditizie restano per un po’. Le centrali rischi private (CRIF, Experian etc.) conservano i dati negativi (ritardi, sofferenze) per un certo periodo (di solito 36 mesi dal momento in cui risultano regolarizzati o chiusi i rapporti). Se i tuoi debiti vengono chiusi per esdebitazione, spesso i creditori segnalano come “saldo a stralcio” o “sofferenza chiusa senza integrale pagamento”. Questo è un segnale che rimane per qualche anno e può rendere difficile ottenere nuovi finanziamenti immediatamente. Con il tempo, però, quelle segnalazioni decadono e potrai ricostruirti uno storico creditizio positivo.
Sul versante pubblico, l’esdebitazione concessa dal tribunale viene pubblicata nel registro informatico delle procedure. Chi fa una visura fallimentare potrebbe vederla. Ma c’è da dire che un’esdebitazione concessa in sé non è un discredito, anzi attesta che hai seguito la legge e ti sei liberato legalmente dei debiti. Certo, una banca che lo scopre magari valuterà con cautela un nuovo prestito. In generale, è realistico attendere qualche anno e dimostrare di avere redditi stabili prima di riottenere facilmente credito.
Detto ciò, dal punto di vista legale nulla ti vieta di intraprendere nuove attività dopo l’esdebitazione: se eri fallito vieni riabilitato (non sei più soggetto alle incapacità). Molti ex falliti/esdebitati diventano ottimi clienti in futuro – avevano solo bisogno di ripulire il passato. Quindi, passato un periodo (2-3 anni), è assolutamente possibile tornare ad avere un mutuo o un fido, specie se nel frattempo hai lavoro e garanzie. Qualche attenzione in più può esserci: ad esempio, se presenti domanda per un finanziamento, potresti dover dichiarare di aver fatto procedura di insolvenza. Ma ogni caso è a sé e non esiste un divieto normativo di accedere al credito post esdebitazione.
Domanda: Le procedure di sovraindebitamento richiedono il coinvolgimento di professionisti? Quanto costano?
Risposta: Sì, è praticamente obbligatorio farsi assistere da un professionista (avvocato o commercialista) e dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente. L’OCC è un organismo istituito presso gli Ordini o le Camere di Commercio che nomina un gestore (professionista) per seguire il tuo caso: questi aiuta a redigere piano, raccoglie documenti, redige la relazione di fattibilità e veridicità, e vigila sull’esecuzione. I compensi dell’OCC sono stabiliti per legge con parametri (D.M. 2020) e dipendono dall’attivo/passivo e dal tipo di attività svolta. Tendenzialmente, per procedure semplici e con debiti modesti, i costi dell’OCC possono aggirarsi su qualche migliaio di euro. A ciò vanno aggiunti i costi del tuo avvocato. Non c’è contributo unificato elevato: per sovraindebitamento è circa €98 (e ora se incapiente viene coperto dal Fondo pubblico).
In concreto, i costi variano: un piano del consumatore con pochi creditori può costare sui 3-4 mila euro complessivi; un concordato minore più complesso magari 5-6 mila o più, dipende anche dal numero di creditori e beni da gestire. La liquidazione controllata è più semplice in teoria (il liquidatore prende percentuale sull’attivo liquidato). Se l’attivo è zero e sei incapiente, come detto, interviene ora il Fondo pubblico a coprire, ed è previsto che l’OCC dimezzi il suo compenso in quei casi.
Questi costi a volte spaventano i debitori, ma vanno comparati ai benefici: se con €5.000 di spese riesci a cancellare €100.000 di debiti, è un ottimo investimento sul futuro. Ci sono inoltre possibilità di rateizzare i compensi dell’OCC in alcuni casi, o dilazionare il pagamento fino alla omologa (magari prendendoli dall’attivo venduto).
In sintesi: sì, serve assistenza tecnica (non puoi presentare da solo il ricorso in tribunale, va redatto in maniera conforme e con attestazioni), e ciò comporta costi, ma sono costi proporzionati e spesso calmierati perché si tratta di procedure “sociali”. Con la recente introduzione del Fondo incapienti, nessuno deve rinunciare per impossibilità di pagare il professionista.
Domanda: È vero che con la nuova legge si può avere l’esdebitazione di diritto dopo 3 anni anche senza fare nulla?
Risposta: Non esattamente. Forse ti riferisci a una norma del CCII che dice che in liquidazione controllata o giudiziale il tribunale decorsi 3 anni dall’apertura deve pronunciarsi sull’esdebitazione. Ma ciò non significa che avvenga automaticamente “senza fare nulla”: significa che, se la procedura è ancora in corso dopo 3 anni, il giudice valuta la situazione e può già allora emettere un decreto parziale di esdebitazione o considerare esdebitato il debitore anche se la liquidazione non è conclusa. Questa è una forma di accelerazione del fresh start: non devi aspettare la fine, se dopo 3 anni hai cooperato e quel che si poteva liquidare si è liquidato (magari restano solo strascichi), puoi già essere liberato dai debiti. Ma in pratica spesso le procedure minori si chiudono entro 3 anni. Diciamo che la regola generale resta: devi passare attraverso una procedura (piano, concordato o liquidazione) e rispettare le regole, dopodiché ottieni l’esdebitazione, a volte anticipabile a 3 anni. Se “non fai nulla”, i debiti restano lì ad aumentare di interessi – quindi sedersi ad aspettare 3 anni non porta alcuna esdebitazione spontanea.
Occhio a eventuali voci confuse: c’era un’idea nella delega di prevedere esdebitazione automatica per i piccoli debitori dopo tot anni dall’insolvenza, ma non mi risulta sia stata attuata in questi termini salvo la procedura incapienti di cui abbiamo parlato (quella sì che è sorta di esdebitazione senza liquidazione). In ogni caso, qualche passo lo devi compiere tu attivamente, non c’è una sanatoria generale del tempo.
Domanda: Cosa vuol dire meritevole? E chi decide se lo sono o no?
Risposta: Meritevole, in questo contesto, significa che il debitore non ha colpe gravi o condotte fraudolente alla base del proprio indebitamento o durante la procedura. È un concetto introdotto per il piano del consumatore e ora generalizzato. Ad esempio, un debitore che ha contratto debiti in modo irresponsabile (giocando d’azzardo grosse somme, spendendo in lusso spropositato rispetto al reddito) potrebbe essere dichiarato non meritevole e quindi il suo piano rifiutato. O uno che durante la procedura nasconde un bene, effettua pagamenti preferenziali ad amici, falsifica documenti – certamente non è meritevole. La valutazione la fa il Tribunale caso per caso, spesso basandosi sulla relazione dell’OCC che deve descrivere le cause dell’indebitamento e il comportamento del debitore. Ci sono linee guida tratte dalla giurisprudenza: ad esempio Cassazione ha detto che per il consumatore la meritevolezza va vista come assenza di colpa grave nello scenario che ha portato all’insolvenza (malattia, riduzione reddito, eccesso di fiducia nel futuro vanno bene; vivere sopra i propri mezzi con leggerezza no).
Nel Codice attuale, l’art. 280 CCII elenca una serie di situazioni che escludono l’esdebitazione (quindi ti bollano come non meritevole) come: condanna per reati concorsuali gravi, aver falsificato o aggravato il dissesto, non aver collaborato, aver già avuto esdebitazioni troppo di recente, etc. Quelle sono oggettive. Per il consumatore c’è un parametro di verifica di meritevolezza all’accesso (se il giudice reputa che hai colpe gravi, non ammette proprio il piano).
Quindi è il giudice, sentito l’OCC, a decidere in base a fatti oggettivi. Esempio: se scoprisse che prima di chiedere la procedura hai regalato la macchina a tuo fratello per non farla pignorare – atto in frode, non meritevole, ti nega l’omologazione o l’esdebitazione. Oppure se vede che hai chiesto decine di prestiti sapendo di non poterli restituire – potrebbe dire che c’è dolo nel sovraindebitamento. Invece, un imprenditore fallito per la crisi economica che ha messo tutto a disposizione è considerato meritevole di esdebitazione.
In pratica, onestà, trasparenza e cooperazione sono le chiavi: se le rispetti, difficilmente ti negheranno il beneficio (che infatti è diventato di largo accesso).
Domanda: Posso includere nella procedura anche i debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione? E cosa succede alle ipoteche di Equitalia?
Risposta: Sì, tutti i debiti fiscali e verso AdER possono (anzi devono) essere inclusi nel perimetro della procedura di sovraindebitamento. Non puoi scegliere di escluderli. Quindi li inserisci nel piano o nell’elenco della liquidazione, e saranno trattati come da legge: quelli privilegiati come privilegiati, quelli chirografari come chirografari. Le ipoteche iscritte da AdER prima della procedura (es. ipoteca sulla casa per debiti) rimangono a garantire il credito di AdER. Se però tu attivi un concordato e salvi la casa pagando il mutuo, resta l’ipoteca AdER? Questo è un punto delicato: di solito, se nel piano vuoi liberare l’immobile dall’ipoteca fiscale, devi pagare integralmente il credito di AdER o ottenere la loro adesione. Se l’ipoteca è su un bene poi liquidato nella procedura, AdER prenderà dal ricavato la sua parte privilegiata. Se la procedura esdebitativa si chiude con debito fiscale ancora pendente non soddisfatto, la parte non pagata viene esdebitata (perché il debito fiscale è soggetto a esdebitazione, non è multa). Tuttavia, l’ipoteca iscritta è un diritto reale di garanzia: quello non si estingue automaticamente con l’esdebitazione del debitore, perché il credito sì è inesigibile nei confronti del debitore, ma l’ipoteca rimane sul bene vincolata al credito originario. Questa è una questione tecnica: dopo l’esdebitazione, il credito di AdER è inesigibile verso di te, ma l’ipoteca rimane come vincolo sull’immobile finché non si cancella (serve accordo o pagamento). In pratica, se tu mantieni la casa e non hai pagato AdER, l’ipoteca potrebbe formalmente restare ma AdER non può farti nulla perché tu sei esdebitato… tuttavia, se in futuro vendi la casa, quell’ipoteca creerà problemi (il notaio vedrà ipoteca iscritta e il compratore vorrà che sia cancellata, quindi in sostanza dovresti comunque trovare un accordo con AdER per toglierla).
Perciò, conviene che nella procedura gestisci l’ipoteca: o pagando quel debito AdER in misura sufficiente da ottenere la cancellazione o chiedendo al giudice un provvedimento specifico. Nelle procedure concorsuali maggiori (es. concordato preventivo) c’è una disciplina precisa sul trattamento delle garanzie pubbliche, nel sovraindebitamento è un po’ meno dettagliato ma analogicamente simile. AdER spesso non vota e subisce il cram-down, ma l’ipoteca resta giuridicamente. Potresti alla fine rivolgerti al giudice esecuzioni per farla cancellare per cessazione dell’obbligazione (questo è un terreno ancora nuovo).
In sintesi: sì includi i debiti AdER, li puoi anche ridurre/dilazionare con la procedura (cosa spesso migliore che fuori), ma fai attenzione alla presenza di ipoteche: la soluzione ottimale è prevedere con l’ausilio dell’OCC come risolverle (magari destinando una parte di soldi proprio a togliere quell’ipoteca, così la casa torna libera).
Nota: se c’è un’ipoteca di secondo grado di AdER su un immobile già ipotecato dalla banca, e tu stai continuando a pagare la banca per tenere la casa, quell’ipoteca AdER è dormiente. Potrebbe restare finché il debito non è esdebitato e poi formalmente ancora lì. Molti debitori in questi casi scelgono di pagare AdER a parte (es. con rateazione) per togliere l’ipoteca e stare tranquilli.
Domanda: Se avevo una ditta individuale e faccio sovraindebitamento, i fornitori poi possono denunciarmi per qualcosa? (tipo bancarotta fraudolenta)
Risposta: La bancarotta è reato legato al fallimento. Se tu non vieni dichiarato fallito (ma fai sovraindebitamento), non potrai essere imputato di bancarotta perché quel reato presuppone una procedura fallimentare aperta. Quindi, per il solo fatto di fare sovraindebitamento, ti sottrai al rischio dei reati fallimentari classici (distrazione di beni, documenti falsi, etc., che in fallimento sarebbero bancarotta, in sovraindebitamento non hanno uno specifico reato equivalente – a meno che siano truffe, vedi sotto).
Tuttavia, attenzione: restano applicabili eventuali reati comuni. Ad esempio, se hai frodato i creditori in generale (tipo hai sottratto beni ai creditori mentre eri insolvente), potresti incorrere nel reato di fraudolento danneggiamento dei creditori (art. 641 c.p. se non sbaglio) o in quello di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) se parliamo di Fisco. Ma questi sono scenari specifici: il tipico è chi vende i beni poco prima di attivare la procedura per non farli trovare – quello può avere rilevanza penale e inoltre fa saltare la meritevolezza.
I fornitori possono certo essere arrabbiati e magari potrebbero accusarti di truffa se ritengono che li hai deliberatamente ingannati sapendo di non pagarli. Ci sono state denunce del genere in passato: per esempio, imprenditori che fanno scorte dai fornitori a credito, poi chiudono e portano i libri in tribunale – i fornitori a volte provano a dire che è truffa (contrarre obbligazioni senza la volontà di adempierle). La truffa deve però prevedere artifizi e raggiri: se tu semplicemente non sei riuscito a pagare, non è reato. Diventa reato se hai mentito spudoratamente (es. hai falsificato bilanci per ottenere merce, o hai simulato solvibilità che non c’era). Di solito questi tentativi di criminalizzare l’insolvenza non prosperano, a meno di condotte molto dolose.
Quindi, in generale, se agisci correttamente, nessuna conseguenza penale dal sovraindebitamento in sé. Anzi, le procedure concorsuali minori non prevedono sanzioni penali specifiche. I fornitori insoddisfatti possono giusto tentare cause civili (ma se c’è esdebitazione, è finita anche lì).
Importante: se menti nella procedura stessa (ad esempio, dichiari il falso al giudice o nascondi documenti), potresti incappare in reati come falso in attestazioni o simili – ma questo vale come in ogni procedimento giudiziario (dichiarazione mendace). L’OCC e il giudice vigilano e possono fare segnalazioni se scoprisse frodi.
In pratica, seguendo la via legale del sovraindebitamento ti metti al riparo dal caos e possibili strascichi penali del fallimento. Non a caso molti preferiscono presentare loro un concordato minore piuttosto che farsi fallire e rischiare poi magari una bancarotta per qualche irregolarità contabile commessa.
Domanda: Dopo aver ottenuto l’esdebitazione, se in futuro guadagno bene, posso chiedere un mutuo o verrò giudicato male per aver “non pagato” i vecchi debiti?
Risposta: Come accennato, una volta esdebitato legalmente, sei una persona “pulita” in termini di debiti. Dal punto di vista etico-sociale, la legge ti considera meritevole di reintegrazione. Alcune banche potrebbero inizialmente storcere il naso se vedono nel tuo passato una procedura concorsuale, ma col tempo (e se dimostri di avere ora un reddito stabile e gestire bene le finanze) non dovresti avere problemi.
Per i mutui: di solito le banche guardano la CRIF e lo status occupazionale. Se sono passati, diciamo, 2-3 anni dall’esdebitazione e nel frattempo hai magari risparmiato un piccolo capitale e non hai altri intoppi, molte banche potrebbero concederti un mutuo (magari a un tasso leggermente più alto se volessero cautelarsi, ma spesso neanche).
Rammenta che viviamo in un’epoca in cui il fresh start è incoraggiato (normativamente e culturalmente). Quindi non sei marcato a vita. Ad esempio, se vai a chiedere un prestito auto, potresti dover dichiarare se sei stato insolvente in passato – questo dipende dalle policy – ma una volta esdebitato, legalmente non hai più quei debiti pendenti, quindi puoi dire di essere senza debiti. La segnalazione CR di Banca d’Italia (se eri in Centrale Rischi come sofferenza) in genere decade dopo un certo periodo dalla chiusura della sofferenza.
In conclusione, sì, potrai chiedere mutui e finanziamenti in futuro. Anzi, lo scopo dell’esdebitazione è proprio rimetterti in condizione di produrre reddito e anche di accedere al credito in modo responsabile. C’è chi, dopo un fallimento personale, ha ricominciato e ha ottenuto finanziamenti per nuove attività con successo (magari spiegando all’istituto che quell’esperienza l’ha reso più prudente e navigato).
Dunque, l’esdebitazione non è un marchio indelebile dal punto di vista creditizio: comporta qualche anno di “purgatorio creditizio”, ma poi consente la normale vita economica.
Conclusioni
La condizione di ex titolare di tabacchi indebitato può sembrare senza via d’uscita, ma come abbiamo illustrato esistono oggi molteplici strumenti giuridici per difendersi e uscirne dignitosamente. L’ordinamento italiano, adeguandosi ai principi europei, garantisce al debitore onesto la possibilità di non rimanere schiacciato dai debiti per tutta la vita, offrendo procedure di composizione della crisi e di esdebitazione. Il percorso non è privo di complessità: richiede trasparenza, collaborazione con professionisti e, spesso, qualche sacrificio patrimoniale. Ma l’obiettivo finale – il “fresh start” – giustifica lo sforzo, poiché restituisce al debitore la libertà economica e la serenità per ripartire.
È fondamentale affrontare la situazione attivamente: ignorare i creditori e procrastinare porta solo ad aggravare i problemi (interessi, more, azioni esecutive disordinate). Al contrario, informarsi sui propri diritti, valutare le opzioni (accordo stragiudiziale, piano, concordato o liquidazione) magari con l’ausilio di un legale specializzato, consente di prendere il controllo della crisi e orientarla verso una soluzione. Ogni caso è diverso – lo abbiamo visto negli esempi – perciò va studiato nel dettaglio, sfruttando le pieghe della legge più favorevoli (come la recente norma salva-casa nel concordato minore, o il nuovo Fondo per incapienti).
Dal punto di vista dei creditori, va ricordato, le procedure concorsuali garantiscono comunque il rispetto della par condicio e spesso permettono un recupero più razionale ed equo rispetto alle esecuzioni individuali. Inoltre, la presenza di un giudice e di attestazioni indipendenti (OCC) offre loro maggior trasparenza sul patrimonio del debitore. Questo talvolta li convince ad aderire a soluzioni concordate, realizzando quel bilanciamento di interessi che è alla base della filosofia del sovraindebitamento: favor debitoris (dare al debitore una seconda opportunità) senza trascurare la tutela dei creditori (che ricevono quanto il debitore può dare in base alle sue reali capacità, e non meno di quanto otterrebbero in una liquidazione).
In conclusione, l’ex titolare di tabacchi con debiti può “difendersi” efficacemente conoscendo e utilizzando gli strumenti normativi a sua disposizione. Sia che scelga di negoziare privatamente con i creditori, sia che attivi una procedura giudiziale, l’importante è agire con consapevolezza e tempestività, mantenendo un comportamento leale. Con un buon piano – costruito magari con l’aiuto di consulenti esperti – anche la situazione debitoria più pesante può essere risolta o alleviata: i debiti si pagano secondo giustizia o si cancellano, i beni essenziali possono essere messi al sicuro, e la persona può voltare pagina. La legge, aggiornamento dopo aggiornamento, oggi lo consente: sta al debitore cogliere questa chance e collaborare per il buon esito. Come recitano i principi ispiratori del Codice della Crisi, l’intento è proprio quello di reintegrare nel tessuto economico il debitore onesto ma sfortunato, evitando che resti emarginato insieme alla sua famiglia. Un fine con cui convergono non solo l’interesse individuale, ma anche quello collettivo e dello Stato.
Fonti
- Codice Civile italiano (artt. 2740, 2910, 514 c.p.c. ecc.).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dai D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024 (artt. 2, 67-83, 121-282 CCII).
- Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (vecchia legge sul sovraindebitamento) e successive modifiche (spec. L. 176/2020).
- Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 893-895 (Fondo esdebitazione incapienti).
- Giurisprudenza: Sentenza Cass. Civ. Sez. I, 23/12/2024 n. 34150 (dilazioni di pagamento oltre 1 anno ai crediti privilegiati nei piani di sovraindebitamento); Ordinanza Cass. Civ. Sez. I, 6/11/2024 n. 28505 (esdebitazione fallimentare: “soddisfatti almeno in parte” interpretato come non totalmente a zero); Cass. Civ. Sez. I, 14/02/2023 n. 4613 (meritevolezza e presupposti soggettivi); Cass. SS.UU. 18/11/2011 n. 24214 (sulla percentuale “non trascurabile” in esdebitazione fallito).
- Tribunale di Torino – Linee guida esdebitazione (sito ufficiale): condizioni e esclusioni per esdebitazione, elenco debiti non esdebitabili e requisiti di meritevolezza.
- Normativa fiscale di riferimento: D.P.R. 602/1973 (pignoramenti esattoriali), D.L. 69/2013 (impignorabilità prima casa Equitalia).
Ex titolare di tabacchi con debiti? Fatti Difendere da Studio Monardo
Hai chiuso la tua tabaccheria, ma ti sono rimasti debiti fiscali, contributivi o verso fornitori?
Ricevi solleciti, cartelle esattoriali o pignoramenti per vecchie posizioni legate all’attività?
Molti ex titolari di tabaccherie si trovano schiacciati da debiti accumulati negli anni, anche dopo aver cessato l’attività. Ma la legge offre strumenti per difendersi, bloccare i creditori e cercare una vera uscita dalla crisi.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la tua situazione debitoria e i procedimenti già avviati a tuo carico
- 📌 Verifica la regolarità delle cartelle, l’eventuale prescrizione e le responsabilità residue
- ✍️ Redige ricorsi contro atti illegittimi e ti assiste nella sospensione delle procedure esecutive
- ⚖️ Ti guida nella procedura di sovraindebitamento per ex imprenditori non fallibili
- 🔁 Richiede l’esdebitazione per liberarti definitivamente dai debiti non più sostenibili
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto nella tutela di ex imprenditori e piccoli esercenti sovraindebitati
- ✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
- ✔️ Consulente legale per ex titolari di attività commerciali con debiti fiscali e contributivi
Conclusione
Anche se la tua tabaccheria ha chiuso, non devi affrontare da solo il peso dei debiti.
Con l’assistenza giusta puoi difenderti legalmente, bloccare le azioni esecutive e ottenere una vera ripartenza.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua rinascita finanziaria comincia da qui.