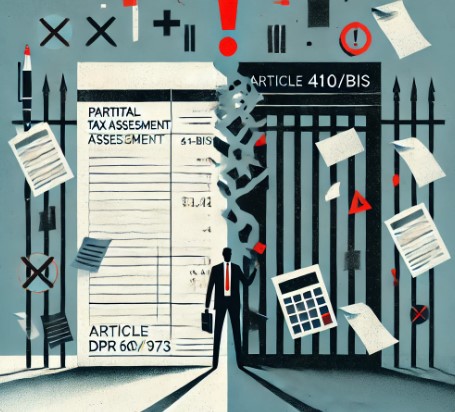Hai ricevuto un avviso di accertamento parziale ai sensi dell’art. 41-bis del DPR 600/73? Ti contestano redditi non dichiarati o elementi non coerenti sulla base di dati certi in possesso dell’Agenzia delle Entrate? Ti stai chiedendo cosa significa, cosa rischi e come puoi difenderti?
L’accertamento parziale ex art. 41-bis è una forma di accertamento “rapida” e “mirata” che consente al Fisco di contestare singole irregolarità senza dover ricostruire l’intera posizione del contribuente. Ma anche se parziale, può avere conseguenze gravi, sia economiche che penali.
Cos’è l’accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR 600/73?
– È un accertamento effettuato sulla base di dati certi e specifici in possesso dell’Amministrazione
– Si basa su elementi raccolti da terzi (banche, clienti, fornitori, notai, ecc.) o su attività istruttorie precedenti
– Non riguarda tutta la dichiarazione, ma solo una componente (es. un reddito non dichiarato, un costo non deducibile, un compenso occultato)
– Consente all’Agenzia di notificare l’avviso senza il contraddittorio preventivo, salvo che il contribuente non lo richieda
Cosa succede se ricevi questo tipo di accertamento?
– Devi versare le somme contestate entro 60 giorni, o puoi presentare ricorso alla Commissione Tributaria
– Se non reagisci, l’avviso diventa definitivo e si passa alla riscossione
– Puoi subire cartelle esattoriali, fermi amministrativi, pignoramenti e interessi
– Nei casi più rilevanti, se i redditi non dichiarati superano soglie penali, scatta la denuncia per reato tributario
Come difendersi da un accertamento parziale?
– Analizza la fonte e la qualità degli elementi usati dall’Agenzia: spesso derivano da presunzioni o dati non aggiornati
– Valuta se l’accertamento è fondato su elementi certi oppure su ricostruzioni arbitrarie
– Richiedi il contraddittorio con l’Ufficio, se non previsto nella fase istruttoria
– Presenta un reclamo o ricorso, documentando la tua versione dei fatti
– Se possibile, valuta la definizione agevolata o la conciliazione giudiziale, per ridurre le sanzioni
Quali vizi può avere l’accertamento parziale?
– Mancanza di motivazione o motivazione generica
– Dati errati o non verificati (es. versamenti ricevuti da familiari o per conto terzi)
– Mancato invito al contraddittorio, se applicabile (obbligatorio in certi casi)
– Uso di presunzioni senza riscontro concreto
– Difetto di competenza o notifica irregolare
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace?
– Annullamento o riduzione dell’accertamento se infondato o viziato
– Ricalcolo delle imposte, escludendo gli elementi errati
– Riduzione delle sanzioni in caso di conciliazione o definizione
– Sospensione delle azioni di riscossione, se il ricorso è fondato
– Tutela del tuo patrimonio e dei tuoi conti, evitando pignoramenti
L’accertamento parziale è uno strumento potente nelle mani del Fisco, ma non è infallibile né sempre legittimo. Se lo hai ricevuto, hai il diritto di opporti, difenderti e chiarire la tua posizione.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa da accertamenti fiscali ti spiega come funziona l’art. 41-bis del DPR 600/73, quando puoi impugnare un accertamento parziale e come evitare che diventi definitivo.
Hai ricevuto un avviso di accertamento parziale? Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione e ti diremo se puoi impugnarlo, annullarlo o chiuderlo in modo vantaggioso.
Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento parziale dall’Agenzia delle Entrate significa che il Fisco contesta al contribuente (persona fisica o azienda) alcune irregolarità fiscali mirate, senza tuttavia effettuare una verifica completa su tutta la posizione fiscale. In pratica, l’accertamento parziale è un procedimento mirato e rapido, che riguarda solo specifici redditi non dichiarati (o imposte non versate) emersi da controlli incrociati o altre evidenze certe, lasciando impregiudicata la possibilità di futuri accertamenti sullo stesso periodo d’imposta. Pur essendo “parziale” nell’oggetto, l’atto è definitivo per le somme contestate: se il contribuente non reagisce entro i termini di legge, l’avviso diventa definitivo e le somme diventano immediatamente esigibili, con potenziali gravi conseguenze (cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche).
Dal punto di vista del contribuente (debitore), è essenziale sapere come difendersi efficacemente da un accertamento parziale. Questa guida avanzata (aggiornata a luglio 2025) fornisce un quadro completo della normativa italiana vigente, delle strategie difensive (sia stragiudiziali che giudiziali), dei profili sanzionatori (amministrativi e penali) connessi e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia. Il taglio è pensato per avvocati, imprenditori e privati informati, con linguaggio tecnico-giuridico ma al contempo divulgativo. Troverai inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici (simulazioni) e una sezione di Domande e Risposte per chiarire i dubbi frequenti, il tutto dal punto di vista di chi subisce l’accertamento (il contribuente) e deve tutelare i propri diritti. L’obiettivo è fornire gli strumenti per affrontare con consapevolezza un avviso di accertamento parziale e scegliere la strategia più adatta per ridurre o annullare la pretesa fiscale contestata.
Cos’è l’accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/1973)
L’accertamento parziale è una particolare procedura di controllo tributario introdotta nell’ordinamento italiano come deroga al principio di unicità e completezza dell’accertamento fiscale annuale. È disciplinato principalmente dall’art. 41-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (per le imposte sui redditi) e, in materia IVA, dall’art. 54, quinto comma, del DPR 633/1972. In sostanza, tale norma consente all’Amministrazione finanziaria di emettere un avviso di accertamento limitato a una parte dell’imponibile, quando dispone di elementi certi e immediatamente utilizzabili che provano l’esistenza di redditi non dichiarati (o maggiori redditi) oppure di imposte non versate relativamente a un contribuente. A differenza di un accertamento “generale” o completo, che rivede l’intera dichiarazione, l’accertamento parziale si focalizza soltanto su specifiche voci o aspetti dove sono state riscontrate irregolarità, senza riesaminare nel complesso tutta la posizione fiscale del periodo d’imposta in questione.
Dal testo normativo di riferimento (art. 41-bis DPR 600/73) emerge chiaramente la finalità dell’istituto: permettere al Fisco una rapida emersione di materia imponibile sottratta a tassazione e un pronto recupero delle imposte evase, senza dover attendere o svolgere un accertamento completo. In pratica, quando le attività istruttorie (accessi, ispezioni, verifiche) o le banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate rivelano elementi oggettivi (ad esempio ricavi non dichiarati, fatture emesse non contabilizzate nei redditi, versamenti bancari non giustificati, ecc.), l’Ufficio può “limitarsi” ad accertare immediatamente quel maggior reddito o imposta, basandosi solo su tali elementi certi. Questo rende la procedura molto più snella e veloce rispetto a un accertamento ordinario, poiché evita di ricostruire integralmente il reddito del contribuente. Inoltre, la legge prevede espressamente che l’accertamento parziale avvenga “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43“: ciò significa che la notifica di un avviso parziale non esaurisce il potere di accertamento per quell’anno d’imposta. L’Agenzia potrà emettere successivamente altri avvisi (parziali o integrali) sullo stesso periodo, qualora emergano ulteriori evasioni, purché nel rispetto dei termini di decadenza e dei limiti previsti (come vedremo, non è consentito “recuperare” in un secondo avviso fatti già noti e non contestati nel primo).
Per fare un esempio concreto: immagina un professionista che ha emesso regolarmente fatture elettroniche (registrate ai fini IVA) per 50.000 € di compensi, ma poi non ha dichiarato quei compensi nella propria dichiarazione dei redditi. Oppure pensa a un’impresa che ha ricevuto bonifici bancari per vendite effettuate, senza però riportarli nei ricavi dichiarati al Fisco. In situazioni del genere, l’Agenzia delle Entrate dispone di dati oggettivi e documentati (fatture nel sistema SDI, movimenti bancari nell’Anagrafe dei rapporti finanziari) che indicano chiaramente un’imposta evasa. Senza dover analizzare l’intero bilancio o tutte le poste della dichiarazione, l’Ufficio può emettere rapidamente un avviso di accertamento parziale limitato ai redditi non dichiarati individuati (i 50.000 € non dichiarati, nell’esempio). Questo provvedimento contestuale conterrà il ricalcolo delle maggiori imposte dovute su quella base, le relative sanzioni e interessi, e darà al contribuente la possibilità di pagare o impugnare entro termini prefissati. Il vantaggio per il Fisco è evidente: tempestività e miratezza dell’azione accertativa. Di contro, per il contribuente può risultare un atto più difficile da contestare, poiché fondato su dati puntuali e spesso incontrovertibili (si pensi a evidenze informatiche o segnalazioni precise).
Va sottolineato, ad ogni modo, che l’accertamento parziale non è un “metodo” di accertamento autonomo distinto dalle normali procedure, ma una semplice modalità procedurale prevista dalla legge per utilizzare subito alcune risultanze istruttorie. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’accertamento parziale “segue le stesse regole” degli accertamenti ordinari ex artt. 38 e 39 DPR 600/73 e non ha un regime probatorio privilegiato: si tratta di uno strumento per anticipare la contestazione, quando gli elementi a disposizione sono già sufficientemente solidi. Ciò significa, ad esempio, che anche in sede di accertamento parziale valgono gli ordinari criteri di prova (inclusa la possibilità di basarsi su presunzioni semplici o legali) e le stesse garanzie difensive riconosciute al contribuente negli accertamenti “completi”. In passato si riteneva che il 41-bis fosse attivabile solo con “elementi certi” e non tramite ragionamenti induttivi o presuntivi. La giurisprudenza recente ha chiarito però che anche prove presuntive possono sorreggere un accertamento parziale, purché si tratti di presunzioni gravi e precise (es. movimentazioni bancarie non giustificate, che per legge sono considerate ricavi salvo prova contraria). L’essenziale è che l’elemento probatorio alla base sia già disponibile e non richieda ulteriori valutazioni complesse da parte dell’Ufficio al momento dell’emissione dell’avviso.
Riassumendo le caratteristiche chiave dell’accertamento parziale:
- Base normativa: art. 41-bis DPR 600/1973 (imposte dirette) e art. 54, co.5, DPR 633/1972 (IVA). Deroga al principio di unicità dell’accertamento annuale.
- Cos’è: un avviso di accertamento “limitato” ad alcuni redditi o imposte evase, emesso sulla base di elementi certi o dati immediatamente disponibili. Corregge parzialmente la dichiarazione senza rivedere tutto il contenuto.
- Finalità: recupero rapido di imposte evase, grazie a controlli mirati e incroci di banche dati, evitando indagini onnicomprensive. Mira a far emergere subito materia imponibile occultata.
- Presupposti: disponibilità di elementi specifici e documentati (es. dati da Anagrafe Tributaria, segnalazioni della Guardia di Finanza, incrocio fatture elettroniche, comunicazioni di altri enti) che provano omissioni di imponibile o errori evidenti. Non richiede una complessa attività valutativa ulteriore.
- Effetti sul potere accertativo: l’atto parziale è integrato e integrabile nell’accertamento complessivo. Non preclude ulteriori verifiche sullo stesso anno, ma ogni successivo accertamento dovrà basarsi su elementi nuovi (non già conosciuti e trascurati in precedenza).
- Contenuto dell’atto: vengono indicati i fatti contestati (es. importo del reddito non dichiarato), le fonti dei dati utilizzati, il ricalcolo delle imposte dovute, le sanzioni e interessi applicati, e le informazioni su modalità e termini per pagare o impugnare. La motivazione deve essere chiara e indicare da dove provengono gli elementi accertati; in caso contrario, l’atto può essere nullo per difetto di motivazione.
- Termini di notifica: deve rispettare i medesimi termini decadenziali degli accertamenti ordinari (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Non esistono termini “speciali” più ampi solo perché è parziale: la legge garantisce che anche l’avviso parziale non possa essere notificato oltre i limiti ordinari, pena la sua nullità.
- Garanzie procedurali: in linea generale, l’accertamento parziale non prevedeva (fino al 2020) un obbligo di contraddittorio preventivo, data la sua natura mirata e urgente. In molti casi l’Ufficio comunque invita il contribuente a fornire chiarimenti prima di emettere l’avviso, soprattutto dopo le riforme che hanno potenziato il contraddittorio endoprocedimentale (tutela del diritto di difesa già in fase amministrativa). Su questo aspetto torneremo in dettaglio più avanti.
Alla luce di quanto sopra, l’accertamento parziale va affrontato con la stessa serietà di un accertamento completo: non va sottovalutato perché “limitato”, in quanto i suoi effetti economici sono analoghi a un accertamento ordinario sulle poste contestate. Per il contribuente, ricevere un avviso parziale significa doversi attivare prontamente per evitare di subire conseguenze gravi. Nei prossimi paragrafi vedremo quando e come può essere emesso un accertamento parziale, come differisce da altre tipologie di accertamento, quali sono i diritti del contribuente e soprattutto come difendersi efficacemente, sia sul piano stragiudiziale (evitando il contenzioso) sia, se necessario, sul piano giurisdizionale (ricorrendo al giudice tributario). Analizzeremo anche le sanzioni amministrative connesse e gli eventuali profili penali, fornendo indicazioni pratiche e riferimenti alle sentenze più recenti che delineano i confini della legittimità degli accertamenti parziali.
Quando può essere emesso un accertamento parziale (presupposti e fonti dei dati)
L’accertamento parziale può essere attivato solo in presenza di specifici elementi informativi che rendono possibile stabilire, in modo puntuale, un’omissione o infedeltà nella dichiarazione fiscale del contribuente. La norma (art. 41-bis DPR 600/73) elenca esplicitamente le fonti di tali elementi: essi possono emergere da “accessi, ispezioni e verifiche” svolti dall’amministrazione finanziaria, oppure da segnalazioni provenienti da altri reparti dell’Agenzia (Direzioni regionali o centrali), da altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di Finanza, da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, nonché dai dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria. In pratica, ogni qual volta le attività di controllo ordinario o l’incrocio delle banche dati rivelino un reddito non dichiarato o un maggior reddito rispetto al dichiarato (oppure deduzioni/agevolazioni non spettanti o imposte non versate), l’Ufficio “può limitarsi” ad accertare immediatamente tali componenti, senza procedere a un accertamento globale.
I presupposti sostanziali per l’emissione di un accertamento parziale sono dunque: (a) la presenza di fatti o dati specifici indicativi di un’imposta evasa o di un imponibile non dichiarato, e (b) la sufficiente attendibilità e concretezza di tali elementi, tali da non richiedere ulteriori indagini complesse. La ratio è che il Fisco interviene prontamente quando ha in mano “carte vincenti”. La Cassazione ha definito questi elementi come “notizie che non necessitano di una specifica valutazione istruttoria”, contrapposti alle ricostruzioni presuntive ampie che richiederebbero un accertamento ordinario. Per esempio, un corrispettivo documentato (una fattura elettronica registrata) non dichiarato, oppure un bonifico estero segnalato attraverso lo scambio automatico di informazioni, sono dati immediatamente utilizzabili; viceversa, una generica anomalia nei margini di profitto o un sospetto basato su indici finanziari potrebbe richiedere una verifica più approfondita e non rientrare nel 41-bis se basata solo su valutazioni statistiche.
Ecco alcune delle principali fonti di dati che tipicamente innescano accertamenti parziali mirati:
- Banche dati e controlli incrociati informatizzati: L’Agenzia delle Entrate dispone di sistemi avanzati di analisi incrociata. Ad esempio, la fatturazione elettronica (tramite Sistema di Interscambio – SdI) registra tutte le fatture emesse e ricevute dalle partite IVA: una discrepanza evidente tra l’ammontare delle fatture emesse da un contribuente e i ricavi dichiarati (ad es. fatture per 100.000 € ma solo 50.000 € di ricavi in UNICO) può far scattare un accertamento parziale quasi automatico. Analogamente, il Sistema Tessera Sanitaria comunica all’Agenzia gli importi delle spese mediche detraibili: se un medico ha comunicazioni di prestazioni sanitarie per importi elevati ma dichiara redditi molto inferiori, è probabile un intervento mirato.
- Anagrafe dei rapporti finanziari (dati bancari): Tutti i movimenti su conti correnti, depositi, carte e investimenti finanziari sono registrati nell’Anagrafe tributaria finanziaria. Versamenti o bonifici non giustificati che risultano sui conti del contribuente e non trovano riscontro nei redditi dichiarati possono costituire presunzioni legali di reddito non dichiarato. Ad esempio, accrediti ripetuti da clienti o somme elevate versate in contanti sul conto, senza che vi sia un corrispondente fatturato dichiarato, forniscono un elemento oggettivo per un accertamento parziale (sarà poi il contribuente, eventualmente, a dover provare che quei movimenti non sono reddito tassabile). La legge attribuisce infatti valore di presunzione relativa ai dati bancari: l’Ufficio può considerarli ricavi occulti salvo prova contraria del contribuente.
- Comunicazioni IVA e “spesometro”/esterometro: Il Fisco incrocia i dati delle liquidazioni IVA e delle comunicazioni delle operazioni rilevanti. Se un’azienda risulta aver effettuato acquisti ingenti (crediti IVA alti) senza dichiarare vendite proporzionate, può sorgere il sospetto di sottofatturazione o economia sommersa. Allo stesso modo, lo scambio di informazioni con l’estero (esterometro, liste VIES) può segnalare operazioni attive non riportate in dichiarazione IVA.
- Segnalazioni di altri enti pubblici: Molti dati affluiscono all’Agenzia da altre PA. Ad esempio i Comuni trasmettono informazioni su contratti di locazione registrati, residenze fittizie all’estero, successioni; l’INPS segnala compensi o indennità erogate; le Camere di Commercio comunicano trasferimenti d’azienda o operazioni straordinarie. Tutti questi dati, se divergono da quanto dichiarato dal contribuente, possono generare contestazioni mirate. Esempio: un Comune notifica all’Agenzia che il sig. Rossi possiede 3 immobili affittati con canone annuo di 10.000 € ciascuno, ma il sig. Rossi dichiara al fisco redditi da locazione per soli 10.000 € in totale – è evidente un’omissione di imponibile per gli altri canoni, e l’Ufficio emetterà un accertamento parziale per tassare i canoni non dichiarati.
- Indagini e verifiche della Guardia di Finanza: Le risultanze di un PVC (Processo Verbale di Constatazione) o di verifiche parziali svolte dalla GdF possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se da un controllo mirato (ad esempio su fatture fittizie in una certa filiera di imprese) emergono elementi immediatamente utilizzabili contro un contribuente, l’Agenzia può procedere parzialmente, senza attendere magari la conclusione di un accertamento generale su tutta l’azienda.
- Informazioni da fonti estere (Common Reporting Standard): Lo scambio automatico di informazioni finanziarie internazionali (CRS) fornisce dati su conti correnti, depositi e investimenti detenuti all’estero da contribuenti italiani. Se risultano redditi esteri non dichiarati (interessi, dividendi, ecc.), l’Agenzia può intervenire con accertamento parziale per tassarli (oltre a contestare il monitoraggio fiscale, RW, se dovuto).
- Controlli formali automatizzati (36-bis e 36-ter DPR 600/73): In teoria gli esiti di controlli formali non rientrano nell’ambito del 41-bis (tanto che la norma esclude espressamente le ipotesi di cui agli artt. 36-bis e 36-ter). Tuttavia, a monte del controllo formale vi possono essere segnalazioni di disallineamenti che poi sfociano in un accertamento parziale più sostanziale. Ad esempio, se dal controllo formale emerge che il contribuente non ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente che il sostituto d’imposta ha invece comunicato, l’Ufficio potrebbe procedere direttamente a un accertamento parziale per omessa dichiarazione di quel reddito.
In generale, l’elemento comune è che l’accertamento parziale viene utilizzato quando “ci sono le prove in mano”: l’amministrazione ha già raccolto, attraverso le varie fonti, dati concreti che segnalano un’imposta evasa o un errore rilevante del contribuente. In queste situazioni, non serve svolgere ulteriori analisi sul resto della posizione fiscale; anzi, sarebbe controproducente attendere, perché il legislatore ha voluto dare all’Erario uno strumento tempestivo di contrasto all’evasione. Come osservato dagli addetti ai lavori, l’accertamento parziale è un istituto nato negli anni ’80 proprio per superare il principio di “unicità” dell’accertamento, permettendo interventi immediati a fronte di segnalazioni mirate esterne o incroci automatici. Questa connotazione originaria permane anche oggi, sebbene il campo di utilizzo si sia ampliato con l’estensione delle fonti e delle tecnologie di controllo.
È importante anche capire cosa non può giustificare un accertamento parziale. La Cassazione ha escluso che il 41-bis possa essere utilizzato quando la maggiore pretesa fiscale si fonda su mere valutazioni estimative o presunzioni semplici prive di riscontro. Ad esempio, un ufficio che rilevi un margine di ricarico apparentemente troppo basso dall’analisi degli studi di settore (ora ISA) non dovrebbe emettere un accertamento parziale basato solo su quell’elaborazione statistica: in tal caso, occorre un accertamento ordinario (magari di tipo induttivo) con contraddittorio pieno, perché manca un elemento “certo” ma solo un indice di anomalia. Allo stesso modo, non è legittimo emettere più accertamenti parziali “a tappeto” con l’intento di colmare progressivamente lacune istruttorie: la legge consente più atti per lo stesso anno solo se emergono fatti nuovi, non per frazionare una ricostruzione complessa in più provvedimenti. Un’eventuale forzatura dell’istituto – ad esempio notificare un primo accertamento parziale e poi un secondo basato su elementi che l’Ufficio già conosceva prima ma non ha contestato subito – è considerata illegittima dalla giurisprudenza. In sintesi, l’accertamento parziale “vive” di luce propria solo in presenza di evidenze mirate; diversamente, dev’essere utilizzato l’accertamento generale o integrativo a seconda dei casi. Nel prossimo paragrafo vedremo proprio come si distingue l’accertamento parziale rispetto alle altre tipologie di avviso (accertamento ordinario, accertamento integrativo) e quali vincoli esistono in caso di pluralità di atti sul medesimo anno.
Accertamento parziale vs accertamento ordinario vs accertamento integrativo
Come accennato, l’accertamento parziale rappresenta una deroga al principio per cui il Fisco dovrebbe emettere, per ciascun periodo d’imposta, un solo avviso “globale” e definitivo nei confronti del contribuente (principio di unicità e globalità dell’accertamento tributario). È utile quindi chiarire la differenza tra un avviso parziale e le altre forme di accertamento, in particolare l’accertamento “generale” (ordinario) e l’accertamento integrativo.
Accertamento ordinario (generale) vs accertamento parziale
- Accertamento ordinario: È l’avviso “classico” emesso dall’Agenzia delle Entrate all’esito di una verifica completa su una dichiarazione fiscale. Può scaturire da vari tipi di controllo (automatizzato, formale, verifiche in loco, controlli documentali su specifiche posizioni) e riguarda tutti gli elementi del tributo in esame per quell’anno. In un accertamento ordinario l’Ufficio ridetermina l’intero reddito imponibile o l’intera imposta dovuta, considerando sia le omissioni riscontrate sia tutte le altre componenti della dichiarazione, con ricalcolo complessivo dell’imposta. Per esempio, a seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia può emettere un avviso di accertamento IRPEF 2022 che rettifica l’intero reddito dichiarato dal contribuente (aggiungendo redditi non dichiarati, eliminando costi indebiti, etc.) e riliquida l’IRPEF dovuta su base globale.
- Accertamento parziale: Come visto, ha un oggetto limitato. Interviene solo su specifiche componenti non dichiarate o non corrette, senza toccare il resto. Non “riapre” l’intera dichiarazione ma integra parzialmente l’imponibile. Ad esempio, se un contribuente ha omesso di dichiarare una sola certificazione di lavoro autonomo da 5.000 €, l’accertamento parziale IRPEF aggiungerà quell’importo al reddito imponibile, calcolando la maggiore imposta su esso, ma non andrà a rivedere deduzioni, altre fonti di reddito già dichiarate, ecc.
Dal punto di vista procedurale, l’accertamento ordinario prevede spesso un percorso istruttorio più articolato: ad esempio, verifiche in azienda con redazione di PVC, obbligo di invito al contraddittorio (a partire dal 2020, per la generalità degli accertamenti “pieni” l’invito al contraddittorio è divenuto obbligatorio prima dell’atto finale, salvo casi di urgenza). L’accertamento parziale invece nasce proprio come strumento più snello: la legge stessa (art. 41-bis) non richiede formalmente la previa convocazione del contribuente, proprio in ragione della specificità degli elementi (tanto che, nella disciplina transitoria, il contraddittorio preventivo generalizzato introdotto nel 2020 escludeva espressamente gli avvisi di accertamento parziali dall’obbligo di invito a comparire – approfondiremo più avanti le novità 2024 su questo tema). In sintesi, un accertamento ordinario è di solito il risultato finale di un controllo ampio, mentre un parziale è emesso “seduta stante” sull’evidenza di un errore specifico.
- Unicità vs pluralità di atti: In linea di principio, l’Amministrazione dovrebbe emettere un solo accertamento per tributo e anno (ne bis in idem tributario). L’accertamento parziale è una deroga che consente più atti sullo stesso anno, a condizione che ciascun atto porti alla luce qualcosa di nuovo. Ci si può chiedere: il Fisco potrebbe prima fare un parziale e poi comunque fare un accertamento generale sull’anno? La risposta è sì, può farlo, perché la norma lo consente espressamente (“senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice”). Tuttavia, se l’Ufficio già possedeva altri elementi sin dall’inizio, avrebbe dovuto contestarli subito: se li tiene nel cassetto per usarli dopo, rischia l’illegittimità. La Cassazione ha chiarito che un successivo accertamento sul medesimo periodo non può basarsi su fatti già conosciuti ma non contestati nel primo atto. In pratica, l’accertamento ordinario successivo è ammesso solo per nuovi rilievi. Ad esempio: l’Agenzia fa un accertamento parziale nel 2024 per redditi 2019 non dichiarati scoperti tramite fatture; nel 2025 la Guardia di Finanza conclude una verifica scoprendo un altro reddito nero 2019 di cui l’Ufficio non era a conoscenza prima – si potrà emettere un secondo avviso (che a quel punto sarebbe un accertamento integrativo, come spieghiamo sotto) per recuperare quest’altro importo.
Tabella di confronto – Accertamento Ordinario vs Parziale:
| Aspetto | Accertamento Ordinario (generale) | Accertamento Parziale |
|---|---|---|
| Oggetto | Intero imponibile/tributo dell’anno (accertamento complessivo). | Solo specifici elementi non dichiarati o irregolari (accertamento mirato). |
| Presupposti | Esiti di controlli che richiedono rettifiche globali (es. verifica completa, gravi incongruenze generali). | Evidenze certe e circoscritte su omissioni (dati bancari, fatture, segnalazioni mirate). |
| Procedura | Più complessa: spesso preavvisi, PVC, invito a contraddittorio obbligatorio (salvo urgenza). | Snella e immediata: legge esenta da contraddittorio preventivo obbligatorio, anche se talora viene comunque avviato un contraddittorio. |
| Finalità | Emettere un unico atto definitivo per chiudere la posizione fiscale annuale (salvo integrative per nuovi fatti). | Recuperare rapidamente parte dell’evasione senza attendere fine istruttoria generale. |
| Effetti | Preclude (di norma) ulteriori accertamenti sullo stesso tributo/anno, salvo nuovi elementi ex lege. | Non preclude ulteriori atti sullo stesso anno (è integrabile con altri accertamenti). |
| Sanzioni | Stesse sanzioni proporzionali applicate sulle maggiori imposte (90-180% in caso di infedele, ecc.). | Idem come accertamento ordinario, sulle imposte parziali recuperate (sanzioni proporzionali su quell’importo). |
| Esempio | Verifica su società: accertamento ridetermina reddito imponibile totale (aggiungendo ricavi non contabilizzati, eliminando costi fittizi, ecc.) con nuovo calcolo IRES dovuta. | Incrocio dati: scova ricavi non dichiarati per 30.000 €. Accertamento parziale contesta solo quei 30.000 € omessi, calcolando IRPEF/IRES e relative sanzioni su essi. |
Accertamento integrativo vs accertamento parziale
L’accertamento integrativo è un istituto diverso: è disciplinato dall’art. 43, co.3 DPR 600/1973 (e art. 57, co.4 DPR 633/1972 per IVA) e consiste nella possibilità per l’ufficio di emettere un secondo avviso che integra o modifica un precedente avviso di accertamento, qualora sopravvengano nuovi elementi di imponibile che non erano conosciuti (né conoscibili con diligenza) al momento del primo atto. In altre parole, l’accertamento integrativo presuppone che ci sia già stato un accertamento originario per quell’anno: è un accertamento di complemento che aggiunge ulteriori somme evase scoperte successivamente. Ad esempio, se nel 2023 l’Agenzia ha notificato un accertamento IRPEF 2018 e nel 2024 emergono (da una sentenza o da altra fonte) altri redditi 2018 prima ignoti, può emettere un accertamento integrativo IRPEF 2018 per tassare i nuovi importi.
Differenze rispetto al parziale:
- Tempistica e sequenza: L’accertamento parziale spesso è il primo atto emesso (proprio perché l’ufficio, avendo elementi sicuri, li usa subito). L’integrativo invece viene dopo un altro accertamento già notificato e definitosi (o in corso di contenzioso). Si parla infatti di “integrazione” di un atto precedente.
- Presupposti: Per l’integrativo servono “nuovi elementi sopravvenuti” non conosciuti dall’Ufficio in sede di primo accertamento. Se l’elemento era già noto, non è integrativo bensì potenzialmente un illegittimo doppione. Il parziale invece può essere emesso anche per elementi già noti al Fisco da subito (infatti li utilizza immediatamente). In sintesi, l’integrativo colma scoperte tardive, il parziale anticipa contestazioni note.
- Ambito di applicazione: L’accertamento integrativo è un’eccezione procedurale per rimediare a situazioni in cui il Fisco scopre l’evasione in ritardo. È piuttosto raro, anche perché soggetto allo stesso termine di decadenza (non concede tempi extra: se un elemento emerge dopo la scadenza del termine, il Fisco non può più agire, integrativo o no, salvo il caso del c.d. raddoppio per reato). L’accertamento parziale invece è uno strumento ordinario, frequentemente utilizzato per micro-controlli annuali.
- Norme di garanzia: L’accertamento integrativo deve rispettare i limiti posti dalla legge: ad esempio non può essere usato per aggirare l’obbligo di contraddittorio o per rimediare a negligenze istruttorie. La Cassazione ha affermato che l’accertamento integrativo “non può colmare lacune istruttorie dell’Ufficio” né sanare a posteriori errori del primo accertamento. Anche in sede integrativa, eventuali elementi noti fin dall’inizio ma non contestati rendono illegittimo il secondo atto. L’accertamento parziale, dal canto suo, se usato propriamente, non viola tali principi perché nasce solo per contestare quanto è evidente e non necessita di ulteriori approfondimenti.
In molti casi pratici, l’accertamento parziale anticipa di fatto quella che poi può diventare una rettifica integrativa. Ad esempio: l’Agenzia riceve una segnalazione su redditi esteri non dichiarati e fa subito un parziale; successivamente, la Guardia di Finanza scopre nella stessa annualità altre omissioni – il secondo avviso per tali nuove scoperte avrà natura di integrativo. È importante per il contribuente sapere che potrebbe subire più avvisi per lo stesso anno (parziale + integrativo, o più parziali) ma che ciascuno di essi deve avere un oggetto nuovo. Se ritiene che un secondo accertamento replichi contestazioni che potevano essere fatte già nel primo, potrà eccepirne l’illegittimità per violazione del principio del “già giudicato” amministrativo (ne bis in idem).
Riepilogo in tabella – Accertamento Parziale vs Integrativo:
| Caratteristica | Accertamento Parziale | Accertamento Integrativo |
|---|---|---|
| Quando avviene | Può essere il primo e unico accertamento sull’anno (appena scoperti elementi certi di evasione). | Avviene dopo un primo accertamento già emesso (secondo atto su stesso anno). |
| Presupposto chiave | Elementi certi/immediati emersi (anche già noti all’Ufficio durante l’anno corrente). | Nuovi elementi sopravvenuti dopo l’emissione del primo accertamento, prima non conosciuti. |
| Base giuridica | Art. 41-bis DPR 600/73 (deroga unicità accertamento). | Art. 43 co.3 DPR 600/73 (eccezione per nuove scoperte). |
| Scopo | Rendere subito esigibili le imposte evase note, senza attendere fine indagine globale. | Completare/integrare un accertamento precedente in presenza di evasione ulteriore scoperta tardivamente. |
| Limiti | Non analizza l’intera dichiarazione; può coesistere con altri atti sull’anno (purché non duplicativi). | Consentito solo se le nuove informazioni non erano ottenibili prima; non può correggere errori del primo atto se non ci sono elementi nuovi. |
| Contraddittorio | Non obbligatorio ex lege (atto escluso da invito obbligatorio); spesso avviato comunque in via amministrativa salvo urgenza. | Idem come primo accertamento: se l’atto integrativo è un avviso ex novo, segue regole ordinarie (oggi contraddittorio obbligatorio salvo eccezioni, v. oltre). |
| Esempio | Avviso parziale IRPEF 2020: contesta redditi bancari non dichiarati 20.000 €. | Avviso integrativo IRPEF 2020 (dopo un precedente accertamento): aggiunge ulteriori 15.000 € di redditi esteri emersi successivamente (non noti prima). |
In sintesi: l’accertamento parziale è uno strumento iniziale e autonomo, che può essere utilizzato in via primaria per contestazioni mirate; l’accertamento integrativo è una appendice successiva ad un accertamento già fatto, utilizzabile solo per includere elementi nuovi scoperti dopo. Entrambi costituiscono eccezioni al principio “una volta sola” sancito dallo Statuto del Contribuente (art. 6-bis L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023) che oggi codifica espressamente il diritto del contribuente a non subire doppie imposizioni sullo stesso fatto, salvo le deroghe di legge. Parziale e integrativo rientrano tra queste deroghe legali ammesse. Per il contribuente, il rischio è la moltiplicazione dei controlli sul medesimo anno: ma come abbiamo visto, esistono paletti normativi e giurisprudenziali a tutela (ogni atto deve avere fondamento proprio e non replicare contestazioni già possibili prima). In ogni caso, qualora si ricevano più avvisi per lo stesso periodo d’imposta, è bene farli esaminare attentamente da un esperto per valutare eventuali profili di nullità (ad es. un secondo accertamento basato su elementi già noti potrebbe essere annullabile).
Contenuto e validità di un avviso di accertamento parziale
Un avviso di accertamento parziale è un atto amministrativo impositivo a tutti gli effetti, pertanto deve rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per la validità degli accertamenti tributari. Il contribuente, al momento della notifica, dovrebbe controllare attentamente il contenuto dell’avviso, verificando la presenza di tutte le indicazioni obbligatorie e l’assenza di vizi che possano inficiarne la legittimità.
In particolare, un avviso di accertamento (anche parziale) deve contenere almeno:
- Intestazione e riferimenti: l’ufficio emanante (Direzione Provinciale/Regionale dell’Agenzia), i riferimenti normativi (generalmente art. 41-bis DPR 600/73 menzionato nell’oggetto), il nome e codice fiscale del contribuente, l’anno d’imposta oggetto di rettifica e il tipo di tributo (IRPEF, IVA, ecc.).
- Motivazione chiara e dettagliata: la descrizione dei fatti accertati e delle ragioni della rettifica. Questo significa che l’atto deve spiegare quali sono gli elementi non dichiarati (o dichiarati erroneamente), come sono stati scoperti (la fonte: es. “da comunicazioni bancarie acquisite ai sensi dell’art. 32 DPR 600/73 si rileva un versamento sul conto X non giustificato”), e perché tali elementi portano ad una maggiore imposta. La motivazione può richiamare documenti esterni (es. un PVC della Guardia di Finanza, o una segnalazione) purché tali documenti siano noti o allegati al contribuente. Attenzione: l’eventuale carenza di motivazione (ad esempio se l’atto si limitasse a dire “si accertano € 50.000 di redditi in più” senza spiegare da dove vengono) costituisce un vizio grave che può portare all’annullamento in giudizio. La motivazione deve mettere il contribuente in grado di capire l’accusa e di difendersi (“giusto contraddittorio”).
- Quantificazione delle imposte, sanzioni e interessi: l’avviso parziale deve riportare il ricalcolo del maggior imponibile e il calcolo della relativa maggiore imposta dovuta, specificando le aliquote applicate. Inoltre, va indicato l’ammontare delle sanzioni amministrative irrogate (in genere espresse in percentuale sull’imposta) e degli interessi dovuti (calcolati al tasso legale o al tasso di interesse per ritardata iscrizione a ruolo, dal momento in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata). Tutte queste somme sono normalmente riepilogate in tabelle nell’atto. La chiarezza su importi e criteri di calcolo è essenziale: errori nel calcolo o omissioni possono essere motivo di contestazione, anche se spesso correggibili in sede di giudizio. Importante: se l’avviso riporta solo il maggior imponibile ma omette di liquidare l’imposta e le sanzioni, potrebbe esserci nullità (per mancanza di un elemento essenziale dell’atto impositivo).
- Termini e modalità di impugnazione/pagamento: l’atto deve indicare il termine entro cui è possibile presentare ricorso (in genere 60 giorni dalla notifica) e l’autorità giudiziaria competente (la Commissione/nuova Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). Inoltre, deve indicare la possibilità di definizione agevolata tramite adesione (accertamento con adesione) o pagamento con sanzioni ridotte (acquiescenza), entro gli stessi 60 giorni. Spesso viene allegato un modello per la richiesta di accertamento con adesione. Va anche segnalato se la riscossione è sospesa o meno in caso di ricorso (di regola oggi l’avviso di accertamento è già esecutivo trascorsi 60 giorni, il che significa che, decorso tale termine, le somme vengono iscritte a ruolo e diventano riscuotibili anche se c’è ricorso, salva la sospensione giudiziale).
- Sottoscrizione: l’avviso deve essere sottoscritto dal capo ufficio o da un funzionario delegato (art. 42 DPR 600/73). La mancanza di firma o la firma di soggetto non legittimato è causa di nullità. In caso di firma digitale (avvisi spesso notificati via PEC), occorre verificare che l’atto indichi il nominativo del dirigente responsabile.
- Notifica regolare: la notifica dell’atto deve avvenire secondo le forme previste (generalmente tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o PEC per i soggetti obbligati/abilitati, oppure tramite messo notificatore). Errori di notifica (es. invio ad un indirizzo errato, consegna a persona non autorizzata) possono rendere invalida la notifica e, se non sanati, far considerare l’atto come mai notificato. È buona norma controllare la data di notifica e la correttezza dell’indirizzo e della persona che ha ritirato l’atto.
Un accertamento parziale valido deve rispettare tutte queste condizioni. Come accennato, non esistono “sconti” formali solo perché l’atto è parziale: la Cassazione ha ribadito che l’accertamento parziale “è soggetto alle stesse regole di validità degli accertamenti completi”. Dunque, ad esempio, non sarebbe ammissibile notificare un avviso parziale oltre i termini di decadenza sperando di cavarsela – il termine è perentorio anche per il parziale e un atto tardivo è irrimediabilmente nullo. Allo stesso modo, se l’ufficio non motiva adeguatamente l’atto parziale o non allega i documenti richiamati, l’atto può essere annullato dal giudice per violazione dell’art. 7 Statuto contribuente (difetto di motivazione).
In particolare, uno dei vizi spesso oggetto di contenzioso è la tardività dell’accertamento: l’avviso parziale deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (o entro il 7° se dichiarazione omessa). Esempio: per l’anno d’imposta 2018 (dichiarazione presentata nel 2019), il termine ordinario è il 31/12/2024. Se il contribuente riceve un avviso datato gennaio 2025, questo è oltre termine – a meno che intervengano cause di proroga dei termini (ad esempio, la normativa sul raddoppio dei termini per reati tributari, di cui parleremo). È fondamentale verificare la data: se l’atto è tardivo, il contribuente deve eccepirlo subito in ricorso, altrimenti perde la possibilità di far valere la decadenza. La decadenza è un vizio insanabile ma non rilevabile d’ufficio: serve un’eccezione tempestiva.
Altre possibili cause di invalidità su cui porre attenzione:
- Uso improprio del 41-bis: se l’Ufficio chiama “parziale” un atto che in realtà riprende tutta la materia imponibile, o viceversa, questo da solo non invalida l’atto (in sostanza, la qualificazione come parziale vs integrale non è vincolante per legge). Tuttavia, se venisse emesso un “parziale” per mascherare un’attività valutativa complessa (in assenza di elementi certi), si potrebbe contestare la violazione di presupposti dell’istituto. La Cassazione di recente ha evidenziato che l’accertamento parziale è legittimo solo se l’atto si caratterizza per una minore attività valutativa: se l’Ufficio effettua ragionamenti presuntivi articolati, allora avrebbe dovuto fare un accertamento ordinario. Questa linea interpretativa può essere invocata dal contribuente in giudizio per sostenere la nullità di un atto che l’Amministrazione ha erroneamente trattato come parziale mentre richiedeva un contraddittorio pieno.
- Mancata indicazione dell’“atto relativo”: se l’accertamento parziale scaturisce integralmente da un PVC o da un atto di un’altra amministrazione (es. esito di indagine GdF), la giurisprudenza richiede che tale documento sia allegato o riprodotto per la parte essenziale, affinché il contribuente ne abbia contezza. Un avviso che si limiti a dire “visto il PVC della GdF che contesta € X di ricavi non dichiarati, si accerta…”, senza allegare il PVC, può essere viziato perché la motivazione è per relationem a un atto non conosciuto dal contribuente. In pratica, controllare se eventuali documenti citati siano stati allegati all’atto (in caso di notifica cartacea) o messi a disposizione.
- Errori di persona o di soggetto passivo: può capitare che l’ufficio invii avvisi a soggetti sbagliati (codice fiscale errato, omonimie). L’avviso è intestato correttamente al destinatario? Se il destinatario non è il soggetto obbligato, l’atto è nullo. Ad esempio, nel caso di società di persone, l’accertamento dei redditi sociali deve essere intestato alla società e per trasparenza ai soci; un errore su questo può generare nullità (ma qui entriamo in tecnicismi specifici).
- Notifica invalida: come detto, la notifica se non è effettuata secondo legge comporta inesistenza o nullità. Ad esempio, se l’accertamento è inviato via PEC ma a un indirizzo PEC non valido o non riferibile al contribuente, la notifica è inesistente (l’atto non ha mai raggiunto il destinatario). Oppure se la raccomandata AR viene consegnata a un vicino di casa non autorizzato e non viene poi perfezionata la compiuta giacenza, ecc. Tali vizi vanno sollevati subito e provati (confrontando indirizzi, ricevute di consegna, ecc.).
In definitiva, alla ricezione di un avviso parziale conviene fare un check-list dei possibili vizi: termini rispettati? motivazione chiara? importi calcolati? firma valida? notifica regolare? Ogni elemento fuori posto può costituire un tassello di difesa nel caso si decida di impugnare. Naturalmente non sempre è semplice individuare i vizi – per questo è consigliabile, soprattutto per importi rilevanti, far visionare l’atto a un professionista (avvocato tributarista o commercialista), il quale potrà anche reperire eventuali documenti correlati (ad es. il PVC o la segnalazione che ha originato l’atto) attraverso l’accesso al fascicolo.
Va ricordato che un vizio formale come la tardività, se correttamente eccepito, comporta l’annullamento totale dell’accertamento: in tal caso l’Agenzia perde definitivamente la possibilità di recuperare quelle somme (il potere impositivo resta consumato dal decorso dei termini). Dunque sono eccezioni di grande importanza. Anche la violazione del contraddittorio, laddove obbligatorio, può portare ad annullamento dell’atto (ne parleremo a breve). In sintesi, ogni accertamento parziale “fa storia a sé” e va esaminato con cura: se presenta vizi insanabili, può essere annullato integralmente in sede di ricorso, risparmiando al contribuente imposte e sanzioni indebitamente richieste.
Il contraddittorio preventivo nell’accertamento parziale
Un tema delicato in materia di accertamento parziale è quello del contraddittorio preventivo con il contribuente, ossia la possibilità per il contribuente di essere ascoltato e fornire spiegazioni prima che l’avviso venga emesso. La normativa italiana sul contraddittorio tributario ha subìto importanti evoluzioni negli ultimi anni, in parte su impulso della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione.
Situazione ante 2020: Fino a pochi anni fa, l’obbligo di contraddittorio preventivo era limitato ad alcune ipotesi specifiche (ad esempio, accertamenti conseguenti a verifiche fiscali in loco, per effetto dell’art. 12, c.7 dello Statuto del Contribuente) e non generalizzato a tutti gli accertamenti tributari. In particolare, per gli accertamenti parziali ex art. 41-bis la giurisprudenza e la prassi ritenevano non sussistere un obbligo generalizzato di invito al contraddittorio. Ciò in quanto la natura stessa del parziale (spesso basata su controlli automatizzati o incroci di banche dati) faceva rientrare questi atti tra quelli esclusi dall’obbligo di confronto preventivo, soprattutto quando l’elemento era talmente certo che il contraddittorio sarebbe risultato “pro forma”. Ad esempio, in passato la Cassazione ha affermato che, in tema di accertamenti da indagini finanziarie, il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio se non previsto espressamente.
Nel 2019, però, il legislatore ha disposto un’estensione dell’obbligo di contraddittorio: con il Decreto Crescita (DL 34/2019) e successivo DLgs. 218/1997, art. 5-ter (introdotto dal DLgs. 34/2019), è stato previsto che dal 1° luglio 2020 gli Uffici devono invitare il contribuente a comparire per un contraddittorio prima di emettere un avviso di accertamento, “se la fattispecie rientra nelle ipotesi previste”, a pena di nullità dell’atto (ex comma 5 dell’art. 5-ter). Importante: in sede di prima applicazione fu stabilito che gli accertamenti parziali fossero esclusi da tale obbligo. La Circolare AE n. 17/2020 ha chiarito che l’invito obbligatorio si applica agli avvisi “ordinari” ma non agli avvisi di accertamento parziale (né agli atti di recupero automatici, ai ruoli, ecc.). La ratio è che in molti casi il parziale ha per oggetto violazioni rilevate da incroci di banche dati (atti “automatizzati” o “sostanzialmente automatizzati”), per i quali il legislatore – in quella fase – non imponeva il contraddittorio generalizzato.
Novità dal 2023-2024: Nell’ambito della riforma fiscale (L. 111/2023 e D.Lgs. 219/2023), è stato modificato lo Statuto del Contribuente introducendo l’art. 6-bis L. 212/2000. Questa nuova disposizione, in vigore dal 2023/2024, stabilisce il principio generale che tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo, a pena di annullabilità, ad eccezione di alcune categorie di atti “automatizzati o di controllo formale” individuate con apposito decreto ministeriale. Il D.M. 24 aprile 2024 ha elencato gli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio generalizzato: tra questi, ha confermato l’esclusione proprio degli accertamenti parziali ex art. 41-bis DPR 600/73 e art. 54 co.5 DPR 633/72, quando basati esclusivamente su dati da incrocio di banche dati. In particolare, l’art. 2 del DM definisce “atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati” quelli basati su incrocio di elementi di banche dati e esclude dall’obbligo di contraddittorio, tra gli altri, “gli accertamenti parziali […] predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati”. Questo significa che, anche dopo l’entrata in vigore del contraddittorio generalizzato (30 aprile 2024), se un accertamento parziale si fonda su controlli automatizzati (es. discrepanza fatture vs dichiarato, dati anagrafe finanziaria, ecc.), l’Ufficio non è tenuto a convocare il contribuente prima della notifica.
Tuttavia, attenzione: la stessa norma precisa “se predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati”. Se invece l’accertamento parziale richiede un minimo di istruttoria valutativa, potrebbe non rientrare tra quelli esclusi. In pratica, la maggior parte dei parziali (essendo appunto basati su banche dati) resterà esclusa dall’obbligo di contraddittorio. Ma non significa che il contraddittorio sia vietato: l’ufficio può sempre attivarlo facoltativamente.
In ogni caso, dal punto di vista pratico: molto spesso, già prima del 2020, l’Agenzia aveva iniziato a inviare al contribuente una sorta di “invito a fornire chiarimenti” prima di emettere l’avviso parziale. Ad esempio, se dall’incrocio risulta un bonifico non dichiarato, l’Ufficio può inviare una lettera (invito al contraddittorio) spiegando l’anomalia e chiedendo spiegazioni o documenti entro 15 giorni. Questa prassi è andata accentuandosi dopo alcune pronunce della Cassazione che hanno valorizzato il contraddittorio come principio generale di buona amministrazione (Cass. SU n.24823/2015, ad esempio, pur affermando che la mancanza di contraddittorio non invalida l’atto se non espressamente previsto, riconosce l’importanza del confronto).
La partecipazione al contraddittorio è quasi sempre consigliabile quando offerta: consente al contribuente di “giocare d’anticipo” e chiarire eventuali fraintendimenti, o fornire all’Ufficio prove a discarico che potrebbero portare ad annullare o ridurre l’accertamento prima che venga emesso. Ad esempio, tornando al bonifico non dichiarato: magari il contribuente può dimostrare che era un prestito ricevuto da un familiare e non un ricavo, scongiurando la contestazione. Oppure, in caso di fatture attive non dichiarate, potrebbe emergere che quelle fatture erano già incluse in altro reddito dichiarato (ipotesi rara ma non impossibile).
Va detto che, in base ai nuovi orientamenti, la mancata attivazione del contraddittorio quando obbligatorio (cioè se l’atto non rientra tra le eccezioni del DM 24/4/24) costituirà motivo di annullabilità dell’accertamento. Quindi, ad esempio, qualora l’Ufficio dovesse emettere un accertamento parziale fondato non solo su meri incroci automatizzati ma anche su valutazioni complesse, senza contraddittorio, il contribuente potrebbe eccepirlo in ricorso. Sarà il giudice a valutare se l’atto rientrava nell’obbligo o meno. Al momento (2025), comunque, la linea prevalente è: per un tipico avviso parziale su dati certi, nessuna nullità per mancato contraddittorio (essendo atto escluso per legge). Se però l’avviso avesse natura diversa, la difesa potrà argomentare.
Vantaggi pratici del contraddittorio (anche quando non obbligatorio):
- Il contribuente può spiegare la propria posizione prima che l’atto sia formalizzato. Questo può portare l’Ufficio a ridurre la pretesa o addirittura archiviare il caso se le spiegazioni convincono (es. provato l’errore materiale).
- Si può guadagnare tempo: l’intervallo tra l’invito e l’eventuale emissione dell’avviso permette di preparare meglio la difesa o magari aderire con calma se si intravede convenienza. Inoltre, la richiesta di accertamento con adesione (di cui parleremo) sospende i termini per impugnare.
- In sede di eventuale contenzioso, poter dimostrare di aver fornito collaborazione e buona fede nel contraddittorio può essere utile: i giudici tributari guardano con favore ai contribuenti che hanno adottato atteggiamenti cooperativi, e ciò può riflettersi anche sulla valutazione di colpevolezza per le sanzioni (es. a parità di violazione, chi ha cercato di chiarire potrà ottenere sanzioni al minimo se c’è margine di apprezzamento).
- Il contraddittorio consente talvolta soluzioni deflative alternative: ad esempio, durante il contraddittorio l’ufficio potrebbe proporre un’adesione semplificata (definizione bonaria) con sanzioni ridotte, evitando la necessità di impugnare.
In conclusione, per gli accertamenti parziali standard (basati su incroci di dati), il quadro è: nessun obbligo di contraddittorio preventivo per l’Ufficio, ma forte opportunità per il contribuente di sfruttare ogni occasione di dialogo. Se si riceve un “invito a comparire” o una comunicazione preliminare relativa a possibili irregolarità, è buona norma non ignorarla pensando che “tanto non è obbligatoria”: al contrario, è il momento giusto per cercare di ridurre il danno.
Nel caso in cui, invece, si ritenga che l’Ufficio avrebbe dovuto attivare il contraddittorio e non l’abbia fatto (ipotesi residuale per i parziali, ma possibile ad esempio se trattasi di accertamento parziale conseguente a PVC senza urgenza), sarà opportuno sollevare in ricorso la violazione del giusto procedimento, invocando l’art. 6-bis L.212/2000 e le pronunce che tutelano il contraddittorio come elemento essenziale del procedimento. L’esito di tale eccezione non è garantito (specie visto l’attuale DM che esclude i parziali), ma in alcuni casi la giurisprudenza di merito potrebbe accoglierla se ravvisa un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento parziale
Passiamo ora all’aspetto più pratico: come difendersi e quali azioni intraprendere una volta notificato l’accertamento parziale. Il contribuente ha davanti a sé, in generale, una scelta strategica: può aderire (in tutto o in parte) alle contestazioni cercando di definire la questione in via amministrativa, oppure può contestare formalmente l’atto proponendo ricorso al giudice tributario. In aggiunta, può tentare una via “intermedia” chiedendo all’ufficio il riesame in autotutela. Esaminiamo i vari passi possibili, tenendo presente che i tempi sono stretti (molte iniziative vanno prese entro 60 giorni dalla notifica).
1. Verificare la fondatezza e la regolarità dell’atto
Appena ricevuto l’avviso, per prima cosa occorre leggerlo con attenzione e capire cosa viene contestato e perché. È essenziale comprendere se la contestazione è corretta:
- Controllo dei dati: verificare se effettivamente c’è stata l’omissione segnalata. Ad es., se l’accertamento parziale contesta redditi per € 20.000 non dichiarati derivanti da specifiche fatture, controllare la propria copia delle dichiarazioni: forse ci si accorge di aver commesso un errore di compilazione, oppure di non aver proprio inserito quei redditi. Se la violazione c’è stata, valutarne l’entità e la causa (dolo, colpa, errore tecnico?).
- Raccogliere la documentazione: tutto ciò che può spiegare o giustificare l’anomalia contestata va raccolto. Esempio: l’atto assume che un versamento bancario è un ricavo non dichiarato, ma in realtà era un prestito familiare – bisogna recuperare evidenze (un eventuale contratto di mutuo, dichiarazioni di chi ha prestato, ecc.). O se contesta costi indeducibili, recuperare le fatture e provare l’inerenza.
- Verificare vizi formali: come trattato nel paragrafo precedente, controllare termini, motivazione, firma, notifica. Ogni vizio rilevato va annotato.
- Calcoli e sanzioni: rifare i calcoli indicati per vedere se tornano (può capitare che, raramente, vi siano errori aritmetici). Verificare l’aliquota applicata, gli interessi (tasso corretto), e soprattutto la corretta applicazione delle sanzioni (es. se è un caso di infedele dichiarazione, sanzione 90%-180% del maggiore tributo; se omessa dichiarazione, 120%-240%, ecc.). Se l’ufficio ha applicato sanzioni in misura piena ignorando eventuali circostanze attenuanti (ad es. ravvedimento già effettuato in parte, o obiettiva incertezza), considerare che in sede di difesa potresti chiederne la riduzione.
Dopo questa disamina iniziale, bisogna prendere una decisione: riconoscere il debito e chiudere la pendenza (magari col beneficio di sanzioni ridotte) oppure contestare l’accertamento perché lo si ritiene sbagliato (in fatto o in diritto) o viziato.
Nel fare questa scelta, bisogna tener conto di vari fattori:
- Importo in ballo: se l’importo complessivo (imposte + sanzioni) non è elevato e la violazione c’è stata, potrebbe convenire pagare con le agevolazioni per evitare costi di un contenzioso.
- Solidità delle prove a tuo favore: hai elementi validi per contestare? Ad esempio, l’ufficio presume un ricavo non dichiarato ma tu puoi dimostrare che non era un ricavo. Se hai buona probabilità di convincere un giudice, il ricorso è opportuno.
- Costi e benefici: impugnare significa magari pagare un professionista e, se perdi, rischiare di pagare anche spese di giudizio oltre a interessi maturati nel frattempo. Invece definire subito (adesione/acquiescenza) riduce sanzioni e chiude la partita in tempi brevi. Va fatto un bilancio economico.
- Eventuali rischi penali: se gli importi evasi superano soglie di reato (es. >100.000 € imposta evasa = potenziale dichiarazione infedele), bisogna mettere in conto che contestare in giudizio l’atto tributario non elimina il procedimento penale, anzi potrebbe aggravarlo. In alcuni casi pagare subito il dovuto può attenuare od estinguere il reato (v. profili penali infra). Questa considerazione è fondamentale: se c’è di mezzo un reato tributario, definire l’accertamento con pagamento integrale può attivare la non punibilità ex art. 13 DLgs 74/2000.
Vediamo ora le opzioni operative concrete.
2. Pagare con definizione agevolata (acquiescenza)
Se, dall’analisi, risulta che l’accertamento è fondato e il contribuente intende accettarlo, la strada più semplice è procedere al pagamento di quanto richiesto entro 60 giorni, usufruendo della riduzione delle sanzioni prevista per la cosiddetta acquiescenza. L’acquiescenza (art. 15 DLgs. 218/1997) consiste nell’accettare integralmente l’avviso senza impugnarlo, con il beneficio che le sanzioni irrogate vengono ridotte ad 1/3 (un terzo) del minimo edittale. In pratica, nell’avviso l’Ufficio normalmente applica la sanzione minima (es. 90% per infedele); con acquiescenza si paga il 30%. Se l’ufficio avesse applicato una sanzione superiore al minimo (eventualità rara, di solito mettono il minimo), la riduzione sarebbe sempre al terzo del minimo legale.
Come si effettua: entro 60 giorni dalla notifica bisogna pagare tutte le somme dovute (imposta, interessi, sanzioni ridotte a 1/3) oppure, se ammesso, la prima rata in caso di rateazione. È necessario comunicare all’Ufficio l’intenzione di non ricorrere e di aver effettuato il pagamento (di solito c’è un modulo nel foglio informativo dell’atto). Con il pagamento, l’atto si definisce e non è più impugnabile.
Vantaggi: molto rapido, costi contenuti (si risparmia su 2/3 delle sanzioni e su eventuali spese legali). Evita il protrarsi di interessi e evita il rischio di sanzioni piene e spese di giudizio che si avrebbero perdendo in tribunale. Per fare un esempio, se l’atto contesta €10.000 di imposte con sanzione 90% (€9.000): con acquiescenza paghi €10.000 + interessi + sanzione ridotta al 30% (€3.000) = €13.000 + int., mentre se fai ricorso e perdi tra 2 anni dovresti pagare €10.000 + int.2 anni + €9.000 sanzione + spese.
Svantaggi: bisogna essere sicuri di voler rinunciare alla contestazione, perché una volta pagato non si torna indietro (l’acquiescenza preclude il ricorso). Inoltre occorre disporre della liquidità per pagare (anche se spesso è possibile ottenere la rateazione).
Rateazione: sugli avvisi di accertamento esecutivi è prevista la possibilità di chiedere una rateizzazione fino a un massimo di 8 rate trimestrali (se importo < €50.000) o 16 rate (oltre €50.000), come da art. 8 DLgs. 218/97. Se si intende fare acquiescenza a rate, bisogna comunque presentare istanza di rateazione entro 60 giorni e pagare la prima rata nello stesso termine. Le successive rate trimestrali avranno interesse al tasso legale. La rateazione è generalmente concessa, ma attenzione: il beneficio della sanzione ridotta a 1/3 si mantiene solo se il piano di rateazione viene rispettato sino alla fine. Il mancato pagamento di una rata fa decadere la rateazione e potrebbe far perdere l’agevolazione.
L’acquiescenza è indicata quando il contribuente riconosce la correttezza dell’accertamento o comunque giudica inutile/controproducente opporsi. È spesso il caso di violazioni effettive di modesta entità, dove un ricorso costerebbe quasi quanto il beneficio atteso. Anche in situazioni dove c’è un reato tributario, l’acquiescenza (con pagamento integrale) ha come ulteriore vantaggio quello di poter invocare la causa di non punibilità penale per estinzione del debito (se effettuata prima del dibattimento, ai sensi dell’art. 13 DLgs. 74/2000).
3. Accertamento con adesione (definizione concordata)
Se il contribuente non è totalmente d’accordo con l’accertamento ma preferisce comunque evitare un giudizio, può attivare la procedura di accertamento con adesione (disciplinata dal DLgs. 218/1997). L’adesione consiste in una trattativa con l’ufficio per rideterminare consensualmente l’imponibile e le imposte dovute, con i benefici di legge (sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo, come per acquiescenza, e possibilità di rateazione). È uno strumento deflativo del contenzioso, utilizzabile anche sugli accertamenti parziali.
Come si attiva: il contribuente deve presentare una istanza di adesione (in carta libera o utilizzando il fac-simile allegato all’avviso) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Con la presentazione dell’istanza, si sospendono automaticamente i termini per fare ricorso: i 60 giorni per impugnare restano “congelati” e ripartiranno in caso di esito negativo delle trattative (comunque per un massimo di 90 giorni di sospensione ex art. 6 DLgs.218/97). Dopo l’istanza, l’ufficio convoca il contribuente per un incontro (solitamente presso gli uffici dell’Agenzia o anche per via telematica) per discutere il caso.
Durante il contraddittorio di adesione, il contribuente (eventualmente assistito dal suo professionista) può portare elementi a suo favore e cercare un accordo sulle somme da pagare. Si può ad esempio ottenere uno sconto sull’imponibile contestato (se ci sono margini di dubbio o si adducono prove parziali): l’ufficio potrebbe riconoscere deduzioni o ridurre il quantum. Oppure, se l’imposta è quella, si può chiedere almeno la riduzione delle sanzioni (anche se già per legge verranno fissate al 1/3 del minimo in caso di adesione definita, a volte l’ufficio può ricalibrare la contestazione per escludere violazioni più gravi).
Esito: se si raggiunge l’accordo, viene redatto un atto di adesione con l’indicazione dei nuovi importi concordati (imposta, sanzione ridotta, interessi). Il contribuente firma e nelle successive 20 giorni deve versare le somme (o la prima rata). Da quel momento l’accertamento si intende definito e non impugnabile (l’adesione comporta rinuncia al ricorso). Se non si raggiunge l’accordo, o se il contribuente poi non perfeziona il pagamento, l’adesione si considera nulla e il contribuente può ancora proporre ricorso (i 60 giorni riprendono dal momento del verbale di mancato accordo o dal 90° giorno successivo all’istanza).
Vantaggi dell’adesione: permette spesso di ottenere un risultato più favorevole rispetto all’avviso iniziale (magari un imponibile ridotto) e comunque assicura la riduzione delle sanzioni ad 1/3 come per acquiescenza. In più, evita le incertezze del giudizio e consente il pagamento rateale fino a 8 o 16 rate come detto. Dal punto di vista psicologico, può essere un’occasione per negoziare: ad esempio, l’ufficio potrebbe accettare di togliere una contestazione marginale per chiudere la più grande, oppure di applicare per analogia una circolare favorevole. Con adesione, inoltre, non si pagano le spese di giudizio e si chiude in pochi mesi la pendenza.
Svantaggi: se il contribuente ritiene di aver ragione al 100%, nell’adesione comunque si finisce per “cedere” su qualcosa, accettando di pagare almeno in parte. Inoltre, una volta firmato l’atto di adesione, non è più impugnabile: quindi se anche emergessero successivamente nuovi elementi a tuo favore, avendo aderito hai precluso ogni difesa (salvo rarissimi casi di annullamento d’ufficio per errore di calcolo).
Per accertamenti parziali, l’adesione è molto frequente: data la natura spesso oggettiva delle contestazioni, il contribuente magari non può negare completamente il fatto, ma può discutere su importi o su aspetti sanzionatori. Ad esempio: l’avviso contesta ricavi non dichiarati per 100.000 €; nel contraddittorio il contribuente dimostra che 20.000 € erano duplicazioni o non imponibili – l’ufficio potrebbe concordare su 80.000 € di maggior reddito. Oppure, se contesta costi indeducibili, si può trovare un accordo a metà strada sull’importo deducibile.
È bene partecipare all’adesione ben preparati: portare documenti, tabelle, calcoli che supportino la tua posizione. Spesso i funzionari sono disponibili a ragionare, purché si portino argomenti solidi. Tieni presente che il funzionario ha interesse a chiudere con adesione (fa statistica positiva per l’ufficio) e ad evitare il contenzioso incerto: quindi c’è una leva negoziale per il contribuente, specie se la pretesa non è blindatissima.
Nota: durante la procedura di adesione, per legge l’ufficio non può iscrivere a ruolo le somme né attivare la riscossione. Quindi c’è anche il beneficio di congelare l’azione esecutiva. Inoltre, la presentazione dell’istanza di adesione estende di 90 giorni il termine di impugnazione: in pratica, se inizi adesione hai 60+90 = 150 giorni dall’avviso per eventualmente fare ricorso (questo per evitare che uno debba ricorrere mentre tratta).
4. Ricorso alla Commissione Tributaria (Giudice tributario)
Se non si intende accettare l’accertamento (perché lo si ritiene infondato o viziato) e/o se la fase di adesione non ha dato risultati soddisfacenti, l’alternativa è proporre ricorso tributario dinanzi all’organo giudiziario competente (dal 2023 denominato Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in precedenza Commissione Tributaria Provinciale). Il ricorso è l’atto introduttivo del contenzioso e va notificato all’Ufficio che ha emesso l’atto entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento (se non si è attivata l’adesione). Se si è presentata istanza di adesione, come detto, il termine di 60 giorni resta sospeso e, in caso di esito negativo, ricomincia (o si aggiungono 90 gg).
Procedura per il ricorso:
- Redazione del ricorso: è fortemente consigliato affidarsi a un professionista abilitato (avvocato tributarista o commercialista) per redigere il ricorso. Nel ricorso si espongono i motivi di impugnazione, cioè tutti i vizi di legittimità e/o di merito dell’atto: ad esempio, “violazione di legge X, errore di calcolo, carenza di motivazione, infondatezza nel merito perché il fatto contestato non costituisce reddito”, ecc. I motivi possono riguardare sia questioni formali (termini, notifiche, contraddittorio mancato) sia sostanziali (il fatto non sussiste, l’importo è minore, ecc.). Il ricorso deve anche contenere la richiesta finale (petitum), tipicamente l’annullamento totale o parziale dell’atto.
- Notifica del ricorso: va notificato tramite PEC (per l’Agenzia Entrate c’è un indirizzo PEC atti processuali) o mediante ufficiale giudiziario, entro i 60 giorni, all’ente impositore.
- Costituzione in giudizio: entro 30 giorni dalla notifica, occorre depositare (telematicamente, tramite SIGIT) il ricorso presso la segreteria della Corte Tributaria, insieme ai documenti rilevanti e alla ricevuta di notifica. Si paga anche un contributo unificato (di importo variabile in base al valore della causa, ad es. per liti fino a 50.000 € è € 120).
- Fase di merito: L’ufficio si costituirà a sua volta depositando controdeduzioni. Seguirà un’udienza (spesso solo documentale o su richiesta di discussione orale) in cui i giudici esamineranno il caso e poi emetteranno la sentenza di primo grado.
Cosa accade alle somme durante il ricorso: con la riforma del 2011, gli avvisi di accertamento sono divenuti esecutivi decorsi 60 giorni. Significa che, in pendenza di ricorso, l’Agenzia può comunque iscrivere a ruolo e chiedere il pagamento di una parte delle imposte. Nello specifico, oggi si applica l’art. 15 del DLgs. 218/97 come modificato: se il contribuente propone ricorso, deve comunque versare un importo pari al 1/3 delle imposte accertate (e interessi) entro il termine di proposizione del ricorso (ossia entro 60 gg + 30 gg), a titolo di pagamento provvisorio. In pratica: contestualmente al ricorso, l’Agenzia iscrive a ruolo un terzo del tributo, che se non versato spontaneamente verrà poi riscosso coattivamente. Questo meccanismo serve a garantire parzialmente l’Erario anche durante il contenzioso. Se poi il contribuente vince, gli verrà rimborsato.
Tuttavia, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’atto se sussiste il pericolo di un danno grave e irreparabile (art. 47 DLgs. 546/92). Ad esempio, se l’importo è elevato e il pagamento di 1/3 metterebbe in crisi l’azienda, si può chiedere di sospendere la riscossione fino alla sentenza. La sospensione può essere totale o parziale, ed è discrezionale del giudice. Dunque, è importante valutare anche questo aspetto: l’atto non si “ferma” automaticamente col ricorso, bisogna attivarsi per sospenderlo se necessario.
Vantaggi del ricorso: se il contribuente ha ragione, il giudice può annullare in toto l’atto, eliminando ogni pretesa fiscale. Oppure può annullare parzialmente, ad esempio riducendo il maggior reddito accertato. In sede giudiziale, poi, si può far valere con più forza i vizi procedurali che l’ufficio magari non avrebbe accolto in autotutela (i giudici sono terzi e quindi più imparziali). Inoltre, da luglio 2023 è stata introdotta la possibilità di conciliazione anche in appello e un generale impulso alla soluzione bonaria: spesso il contenzioso può chiudersi con una conciliazione vantaggiosa (sanzioni ridotte al 40% se conciliazione in primo grado). Il ricorso inoltre “prende tempo”: la definizione di una lite può richiedere anni, durante i quali l’eventuale esborso è limitato a un terzo (salvo sospensioni). Se il contribuente ha problemi di liquidità immediata ma spera magari in un condono futuro o comunque di dilazionare, il ricorso – pur non essendo questa la sua finalità – di fatto dilata i tempi di pagamento.
Svantaggi: costi (onorari professionista, contributo unificato), tempi e stress, incertezza sull’esito. Se si perde, oltre a dover pagare tutto (imposte, interessi, sanzioni piene), si possono essere condannati alle spese di giudizio a favore dell’Agenzia e, dal 2023, una lite temeraria può comportare sanzione fino al 5% del valore della causa (nuovo art. 15-ter DLgs. 546/92) – ipotesi estrema, ma da sapere. Inoltre, in caso di soccombenza, non c’è più la riduzione sanzioni: si pagano quelle originarie, o addirittura se il giudice ravvisa motivi per aumentare la sanzione (in rari casi potrebbe rideterminare peggiorativamente, anche se di norma non può peggiorare l’atto impugnato se non c’è appello incidentale dell’ufficio).
Quando ricorrere: certamente se l’accertamento è ritenuto errato e l’ufficio non ha accolto ragioni in adesione. Ad esempio, l’ufficio insiste nel considerare un reddito tassabile ma c’è evidenza che non lo è (donazione, risarcimento esente, ecc.). Oppure se ci sono violazioni di legge (come il mancato rispetto dei termini, contraddittorio violato se dovuto, ecc.) che un giudice potrebbe riconoscere e annullare l’atto. Anche solo per ottenere una riduzione, il ricorso può servire (in giudizio spesso il fisco perde su parti delle pretese per difetto di prova). Va però ponderato il rapporto costi/benefici e la “forza” della propria posizione.
Mediazione tributaria: va menzionato che per gli atti di valore non superiore a €50.000, il ricorso è preceduto obbligatoriamente da una fase di reclamo-mediazione (art. 17-bis DLgs. 546/92). In pratica, il ricorso stesso inizialmente vale come reclamo: l’ufficio ha 90 giorni per eventualmente accogliere in autotutela o proporre una mediazione (soluzione concordata, con sanzioni ridotte al 35%). Se entro 90 giorni non si media, il ricorso prosegue normalmente. Questo istituto potrebbe applicarsi ad un accertamento parziale sotto 50.000€. Spesso però, se hai già tentato l’adesione prima, la mediazione è solo una formalità (ma può capitare che in sede di reclamo l’ufficio riveda la posizione). In ogni caso, il contribuente deve sapere che se la controversia è piccola, deve attendere quei 90 gg di reclamo prima di avere l’udienza.
Riassumendo: il ricorso è la via per far valere le proprie ragioni fino in fondo, ma va intrapreso con preparazione e consapevolezza dei rischi. È fondamentale predisporre un ricorso ben motivato, con tutti i documenti probatori allegati, e affidarsi a consulenti esperti in diritto tributario, data la tecnicità della materia.
5. Richiedere l’annullamento in autotutela
Parallelamente (e senza escludere le opzioni sopra), il contribuente può presentare all’ente impositore un’istanza di autotutela, ossia una richiesta motivata affinché l’ufficio annulli o rettifichi spontaneamente l’avviso di accertamento perché affetto da errori palesi o da illegittimità. L’autotutela è il potere riconosciuto alla Pubblica Amministrazione di correggere o revocare i propri atti quando risultino chiaramente errati o illegittimi, anche al di fuori dei tempi di ricorso (ma comunque prima che l’atto sia definitivo salvo rari casi).
Esempi tipici in cui l’autotutela è efficace: errori evidenti e documentabili nell’accertamento. Ad esempio, l’ufficio ha contestato due volte lo stesso reddito per un duplicato di segnalazione; oppure ha calcolato male l’imposta (un errore aritmetico palese), o ancora ha emesso l’atto verso la persona sbagliata. In questi casi, presentare un’istanza di autotutela con le prove dell’errore può portare l’ufficio ad annullare o rettificare d’ufficio l’atto, senza bisogno di ricorrere.
Come procedere: l’istanza va presentata preferibilmente per iscritto (PEC o protocollo) all’ufficio che ha emesso l’atto, indicando gli estremi dell’accertamento e i motivi per cui si chiede l’annullamento (o rettifica). Bisogna allegare eventuale documentazione a supporto. Ad esempio: “Si chiede l’annullamento dell’avviso perché notificato oltre i termini di decadenza (dichiarazione presentata il…, avviso notificato il…, oltre il quinto anno), come da documenti allegati (copia dichiarazione, ricevuta notifica)”. Oppure: “…perché l’importo XY risulta già dichiarato nel quadro… come dimostrato da copia della dichiarazione allegata”.
Effetti: la presentazione di un’istanza di autotutela non sospende i termini di impugnazione né l’esecutività dell’atto. Quindi è fondamentale, se i termini stringono, presentare comunque il ricorso (o adesione) entro 60 giorni per non decaderedalla tutela, anche se si è chiesto autotutela. L’ufficio non è obbligato a rispondere entro una data (di solito lo fa in tempi amministrativi, a volte anche dopo mesi). Quindi l’autotutela va vista come un tentativo parallelo, mai sostitutivo del ricorso se il tempo sta per scadere.
Chance di successo: dipende dalla evidenza del errore. Per errori manifesti (doppia imposizione evidente, persona errata, calcolo errato) l’ufficio spesso annulla, perché sa che perderebbe in giudizio. Se invece il punto è controverso (es. “secondo me questo reddito è esente”), difficilmente l’ufficio ammetterà l’errore in autotutela – preferirà far decidere al giudice. Da notare che esistono casi in cui l’AE centralmente è intervenuta in autotutela massiva (ad es. per atti risultati contrari a sopravvenuta giurisprudenza di legittimità consolidata), ma sono situazioni particolari.
Autotutela “sostitutiva” e bis in idem: citazione interessante, la Cassazione SS.UU. 30051/2024 ha censurato la prassi dell’AE di annullare in autotutela un avviso già emesso per emetterne un altro più pesante (autotutela in malam partem), ritenendo che ciò violi il principio di unicità dell’accertamento (salvo nuovi elementi). Questo per dire che l’autotutela dovrebbe essere strumento per correggere in melius o per errori, non per aggravare la pretesa. Se un contribuente si trovasse un primo avviso annullato e sostituito da uno nuovo più sfavorevole (senza fatti nuovi), potrebbe eccepire l’illegittimità di tale operato.
In conclusione, l’istanza di autotutela va sicuramente presentata se si ravvisa un errore grossolano nell’accertamento. Non costa nulla (se non un po’ di tempo per scriverla) e talvolta risolve il problema senza contenzioso. Ma non bisogna farci totale affidamento se i motivi sono complessi: in quei casi, meglio comunque impugnare l’atto. Se l’ufficio accoglie l’autotutela, può annullare l’avviso (ti manderanno proprio un provvedimento di annullamento) o rettificarlo parzialmente. Se lo annulla completamente e questo avviene prima che tu abbia depositato il ricorso, bene (finisce lì). Se lo annulla mentre il ricorso è in atto, si potrà dichiarare cessata materia del contendere. In ogni caso, mantieni traccia scritta della presentazione (PEC ricevuta di consegna o protocollo timbrato) per eventualmente produrla in giudizio come segno di buona fede e tentativo di cooperazione.
Da notare: la presentazione dell’istanza di adesione (punto 3 sopra) già di per sé è anche una forma di sollecitazione all’autotutela, in quanto l’ufficio in sede di adesione rivede l’atto. Ma l’autotutela formale può essere chiesta anche dopo la fine del contenzioso (se emergono errori), benché più il tempo passa meno l’AE è propensa ad agire.
6. Altri strumenti (accollo, ravvedimento operoso tardivo, ecc.)
Sebbene meno comuni, ci sono situazioni particolari in cui il contribuente può ricorrere ad ulteriori strumenti:
- Ravvedimento operoso “sprint”: Tecnicamente, il ravvedimento operoso ex art. 13 DLgs. 472/97 consente di correggere spontaneamente violazioni versando il dovuto con sanzioni ridotte. Una volta notificato un accertamento, non sarebbe più spontaneo; tuttavia, fino allo spirare dei termini di pagamento dell’avviso (60 giorni), alcuni ritengono sia possibile effettuare un ravvedimento sui maggiori imponibili (con sanzione ridotta al 1/8) e chiedere l’annullamento dell’atto. In pratica è rischioso e raramente usato, perché l’ufficio di solito vuole la definizione con adesione. Ma in teoria nulla vieta che entro 60 gg il contribuente presenti una dichiarazione integrativa a suo favore e paghi (ravvedimento) su quella: se l’ufficio fosse diligente, dovrebbe annullare l’avviso per cessata materia. Questa è una situazione borderline e non esente da incertezze, per cui la citiamo solo per completezza teorica.
- Accollo fiscale e terzi interessati: se l’accertamento riguarda, ad esempio, una società di persone e i soci vogliono definire la loro quota, possono accollarsi la parte e pagare. Oppure un coobbligato solidale può intervenire. L’importante è che il pagamento in acquiescenza o adesione può essere fatto anche da un terzo (ad esempio il socio paga per la società). In caso di società di persone, ricordiamo che l’accertamento ai soci dipende da quello alla società: le strategie difensive vanno coordinate.
- Transazione fiscale (solo se fallimento o crisi): in procedure concorsuali, è possibile proporre la transazione fiscale col fisco su cartelle/avvisi, ma è un contesto specialistico (fallimenti, concordati preventivi) e non rientra nella difesa del singolo in bonis.
In generale, la difesa stragiudiziale ruota attorno a adesione, acquiescenza e autotutela, che abbiamo affrontato. Se queste non risolvono, il ricorso è il baluardo finale.
Importante: non ignorare mai l’avviso sperando che “si risolva da sé”. Trascorsi 60 giorni senza alcuna azione (né pagamento, né adesione, né ricorso), l’accertamento diventa definitivo e verrà iscritto a ruolo per l’intero. Dopo di che, arriverà una cartella esattoriale e, se non paghi, si passerà alle procedure esecutive (pignoramento di conti, stipendio, ipoteche, fermi auto). Ignorare equivale a accettare tacitamente la pretesa. Anche se pensi che l’accertamento sia sbagliato, se non fai ricorso in tempo, perdi il diritto di contestarlo. Dunque, la prima regola di difesa è: agire tempestivamente entro i 60 giorni con una delle opzioni.
Riassumiamo in un semplice schema le possibili azioni difensive e i relativi pro e contro:
- Pagamento con acquiescenza (entro 60 gg) – Pro: sanzioni ridotte a 1/3, niente contenzioso. Contro: riconosci il debito integralmente, perdita diritto ricorso.
- Adesione (istanza entro 60 gg) – Pro: possibile riduzione imponibile e sanzioni 1/3, dilazione, niente processo. Contro: bisogna scendere a compromesso; se accordo, rinuncia ricorso; se fallisce, tempo perso (ma termini sospesi quindi non si perde possibilità ricorso).
- Ricorso (entro 60 gg o 150 se adesione) – Pro: chance di annullamento/riduzione da giudice, fai valere vizi formali, dilazione nel tempo. Contro: costi legali, rischio di perdere (allora paghi tutto + spese), 1/3 subito da pagare (salvo sospensione).
- Autotutela (tempistica libera, ma preferibilmente entro 60 gg) – Pro: se accolto, risolve senza costi né sanzioni (annullamento atto). Contro: discrezionale dell’ufficio, non sospende termini; da usare solo per errori evidenti.
Spesso una combinazione è ideale: ad esempio, presenta adesione (per trattare) e intanto prepara ricorso (se adesione fallisce, depositi ricorso). Oppure, fai ricorso e comunque tenti una conciliazione in corso di causa (lo prevede la legge). L’importante è non restare passivi.
Profili sanzionatori: sanzioni amministrative nell’accertamento parziale
Ogni avviso di accertamento, incluso quello parziale, comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative tributarie a carico del contribuente, qualora venga accertata un’imposta non pagata o un’imposta indebitamente rimborsata. Le sanzioni tributarie relative alle dichiarazioni dei redditi e IVA sono disciplinate prevalentemente dal DLgs. 471/1997.
Nel contesto di un accertamento parziale, le situazioni più comuni sono due:
- Dichiarazione infedele (art. 1, c.2 DLgs. 471/97): si ha quando il contribuente ha presentato una dichiarazione infedele, ossia con redditi in misura inferiore al dovuto o con indebite detrazioni/deduzioni che riducono l’imposta. Ad esempio, non ha dichiarato parte dei ricavi, oppure ha dedotto costi inesistenti. In tal caso, la sanzione amministrativa prevista è pari al 90% della maggiore imposta o del minor credito derivante dall’accertamento. Se però l’imposta evasa supera certe soglie e condizioni, oltre alla sanzione amministrativa scatterebbe il profilo penale (reato di dichiarazione infedele, vedi dopo). Per l’amministrazione, comunque, la sanzione da applicare nell’atto è il 90% (minimo) fino al 180% (massimo) della differenza d’imposta accertata. Nella prassi, l’ufficio applica quasi sempre il minimo edittale (90%), salvo casi di particolare gravità (ha facoltà di aumentare, ma raramente lo fa perché in adesione tanto riduci al terzo del minimo). Esempio: Accertati €50.000 di redditi non dichiarati IRPEF al 43% = €21.500 di imposta evasa. Sanzione 90% = €19.350 (minimo) che l’ufficio metterà in atto. In totale €21.500 imposte + €19.350 sanzioni + interessi.
- Omessa dichiarazione (art. 1, c.1 DLgs. 471/97): caso meno frequente per accertamento parziale, perché se uno non ha presentato affatto la dichiarazione di solito l’ufficio fa un accertamento d’ufficio (ex art. 41 DPR 600/73, distinto dal parziale). Comunque, se per ipotesi un accertamento parziale riguardasse un’imposta non dichiarata perché la dichiarazione era omessa (non impossibile – ad es. un soggetto ha presentato la dichiarazione IRPEF ma non la dichiarazione IVA, l’ufficio potrebbe fare parziale IVA), la sanzione sarebbe più pesante: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di €250. Anche qui, in genere l’ufficio applica il minimo (120%). Esempio: Omessa dichiarazione IVA su €10.000 di IVA dovuta => sanzione 120% = €12.000.
Ulteriori sanzioni possibili nel contesto parziale:
- Indebita detrazione IVA (art. 6, c.6 DLgs. 471/97): se l’accertamento riguarda un credito IVA indebito esposto in dichiarazione, la sanzione è 90% del credito non spettante.
- Violazioni formali: l’accertamento parziale in sé di solito non concerne violazioni formali, ma solo sostanziali di dichiarazione. Quindi tratta le sanzioni sopra.
Le sanzioni amministrative sono, salvo eccezioni, di carattere tributario (non penale) e come tali possono essere definite in misura ridotta tramite gli strumenti deflativi:
- Adesione: sanzioni ridotte a 1/3 del minimo previsto. Ad es., infedele 90% -> con adesione paghi 30%.
- Acquiescenza: sanzioni ridotte a 1/3 del minimo (stessa misura dell’adesione).
- Conciliazione giudiziale: se durante il processo si concilia, sanzioni ridotte a 1/2 (in appello 2/3). Dal 2023, la riforma ha portato in primo grado al 35% (circa 1/3) se conciliazione entro le udienze preliminari, ma è dettaglio tecnico.
- Ravvedimento operoso: se uno riuscisse a ravvedersi prima dell’accertamento, la sanzione sarebbe ridotta proporzionalmente al momento (ma dopo la notifica di pvc o comunque a ridosso dell’accertamento il ravvedimento è con riduzione minima 1/5).
Un concetto importante è l’attenuante della collaborazione e buona fede: come anticipato, se il contribuente durante il contraddittorio o l’adesione fornisce elementi, l’ufficio spesso decide di tenere la sanzione al minimo edittale (90%) e non contestare aggravanti (tipo continuatività). Inoltre, se il contribuente paga subito (ravvedimento) prima di notifica avviso, può evitare del tutto la sanzione penale e magari ottenere sanzioni amministrative ridotte.
Le sanzioni tributarie sono di regola “proporzionali” e non dipendono dall’elemento psicologico: anche un errore in buona fede comporta la sanzione (magari poi il giudice può applicare il minimo). Esiste però la possibilità di non applicare sanzioni in casi di obiettiva incertezza normativa o errore scusabile. Ad esempio, se la questione era molto dubbia e c’era un cambio interpretativo, il contribuente in sede di ricorso può chiedere l’esimente dell’obiettiva incertezza (art. 6 DLgs. 472/97), che se riconosciuta azzera le sanzioni. L’ufficio raramente riconosce queste cause, ma il giudice a volte sì.
Cumulo giuridico: se più violazioni (es. più imposte, IRPEF e addizionali), si applica sanzione unica cumulo. Ma in un parziale di solito c’è una violazione per tributo.
Rapporti con il penale: sul lato amministrativo, indipendentemente dal penale, l’ufficio applica sanzione 90%. Se poi c’è reato, il penale seguirà la sua strada (vedi prossimo paragrafo). Le due sanzioni (amministrativa e penale) coesistono: non c’è principio di ne bis in idem, perché sono considerati piani diversi. Se però il contribuente ottiene una causa di non punibilità penale (es. paga tutto prima del dibattimento), rimangono le sanzioni amministrative ma viene estinto il reato.
Pagamento delle sanzioni: viene richiesto contestualmente alle imposte. Con la definizione (adesione, ecc.) le sanzioni sono ridotte come detto. Se si va in giudizio, il giudice può anche ridurre le sanzioni valutando circostanze (ha facoltà di applicare il minimo o diminuire per circostanze attenuanti, art. 7 DLgs. 472/97). Ad esempio, se riconosce che il contribuente ha agito senza dolo, potrebbe mantenere la sanzione al minimo (lo era già magari). Oppure se solo parte dell’imposta viene confermata, la sanzione va proporzionata alla nuova imposta.
In definitiva, dal punto di vista del debitore, è cruciale sapere che pagando presto e aderendo si risparmiano grosse cifre sulle sanzioni. Nell’esempio sopra: sanzione 19.350 € -> con adesione la riduci a ~6.450 €, un risparmio di ~13k€. Se invece fai ricorso e perdi, paghi i 19k interi più interessi sul ritardo. Anche se vinci parzialmente, magari ti rimangono da pagare sanzioni non ridotte. Dunque, la convenienza economica spesso spinge a definire bonariamente.
Una volta divenute definitive (perché non impugnate o dopo sentenza passata in giudicato), le sanzioni tributarie sono riscosse come le imposte, e se non pagate possono portare a iscrizioni a ruolo e misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) e coattive come per le imposte. Non si va in carcere ovviamente per sanzioni amministrative, però possono pesare molto economicamente.
Esempio finale su sanzioni: Mario riceve un accertamento parziale per €10.000 di IRPEF evasa e €9.000 sanzioni. Se Mario aderisce, paga €10.000 + €3.000 (1/3 di 9k) + interessi, risparmiando €6.000. Se Mario fa ricorso e perde due anni dopo, dovrà €10.000 + €9.000 + int. su 10k per due anni + eventuali spese legali: il tutto può superare di molto quanto avrebbe pagato aderendo. D’altro canto, se Mario ha ragione e vince in giudizio, paga 0 (e forse ottiene rimborso spese). La scelta va ponderata con questa bilancia.
Profili penali connessi all’accertamento fiscale parziale
L’accertamento parziale, di per sé, è un procedimento amministrativo. Tuttavia, le violazioni fiscali sottostanti possono assumere rilievo penale tributario se superano determinate soglie di gravità previste dal D.Lgs. 74/2000 (il testo che disciplina i reati tributari). In altre parole, se l’accertamento porta alla luce un’evasione d’imposta molto significativa o realizzata con condotte fraudolente, oltre alle sanzioni amministrative viste sopra, il contribuente potrebbe dover affrontare un procedimento penale per reato tributario.
I principali reati tributari che possono collegarsi ad un accertamento parziale sono:
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi, in modo da evadere imposta oltre una certa soglia. Le condizioni attualmente (dopo la riforma del 2019) sono: imposta evasa > 100.000 € e contemporaneamente elementi attivi non dichiarati > 10% di quelli dichiarati o > 2 milioni €. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, scatta il reato. La pena prevista è la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi. Esempio: Tizio dichiara €1.000.000 di ricavi ma ne ha in realtà €1.300.000 (evaso 300k di ricavi). Se l’imposta evasa su quei 300k supera 100k (supponiamo 120k di IVA evasa) e 300k > 10% di 1.000.000 (sì, è 30%), reato di dichiarazione infedele. In un accertamento parziale, la situazione tipica è l’omissione di alcuni redditi: se l’imposta evasa su questi supera la soglia, l’ufficio (o la GdF) presenterà denuncia penale alla Procura per dichiarazione infedele.
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): reato in cui incorre chi non presenta affatto la dichiarazione annuale, con imposta evasa > 50.000 €. La pena è reclusione 2 a 5 anni (aumentata nel 2019). Un accertamento parziale in senso tecnico su omessa dichiarazione è raro (di solito è accertamento d’ufficio), ma se per dire l’ufficio ha fatto un parziale IVA perché non hai presentato dichiarazione IVA, allora sicuramente c’è reato se imposta >50k.
- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri artifici (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000): riguardano condotte più gravi, in cui il contribuente inserisce elementi fittizi (fatture per operazioni inesistenti) o usa artifici fraudolenti. La soglia per il reato di frode mediante fatture (art. 2) è semplicemente l’utilizzo di fatture false per abbattere l’imponibile (non c’è soglia minima di imposta, quindi basta qualsiasi importo); la pena va da 4 a 8 anni. Per la frode mediante altri artifici (art. 3) c’è una soglia di imposta evasa > 30.000 € e l’alterazione di documenti/registri; pena 3 a 8 anni. Questi reati emergono tipicamente da verifiche più ampie; un accertamento parziale potrebbe far emergere una singola fattura fittizia (ma di solito se c’è fattura falsa, la GdF avvia subito il penale). Ad ogni modo, se l’ufficio scoprisse anche solo un componente fittizio che configura reato, scatterebbe la segnalazione penale.
Nel contesto dell’accertamento parziale, spesso ricorre il reato di dichiarazione infedele, perché è il tipico caso di redditi non dichiarati scoperti. Occorre chiarire che la soglia di 100.000 € è riferita all’imposta evasa (non ai redditi) per singolo tributo e anno. Quindi bisogna calcolare l’imposta evasa: ad esempio, se hai occultato €300.000 di imponibile con aliquota 24% IRES = 72.000 € di imposta evasa, non scatta il reato (perché < 100k), anche se 300k > 2 milioni? No, 300k < 2M, e comunque serve imposta > 100k. Invece se evasi 500k di imponibile al 24% = 120k imposta, reato sì (perché >100k e 500k > 10% dich attivi supponendo dich attivi <5M). Nel caso IVA, soglia 100k di IVA evasa (che può capitare con somme evase nemmeno altissime se IVA 22%). Le soglie attuali sono frutto di un rialzo nel 2015 (prima era 50k imposta e 2M attivi omessi al 10%, poi portato a 100k e 2M, come da L.157/2019).
Procedimento penale: di solito, come funziona: quando l’ufficio accertatore (Agenzia o GdF) riscontra elementi di reato, trasmette una notizia di reato alla Procura della Repubblica competente. Ad esempio, un funzionario AE che emette un avviso parziale constatando imposta evasa di 150k manderà segnalazione alla Procura per dichiarazione infedele. Da quel momento, il penale segue la sua strada, con indagini, eventuale processo, ecc. Il procedimento penale è indipendente dal contenzioso tributario: il contribuente potrebbe vincere nel tributario ma intanto doversi difendere nel penale, o viceversa.
Tuttavia, l’esito del procedimento tributario può influire sul penale in termini di elementi probatori: se in giudizio tributario viene accertato che quell’imponibile in realtà non era dovuto, ciò potrebbe essere usato dalla difesa nel penale per escludere l’imposta evasa (magari il penale archivia se il fatto non sussiste). Ma formalmente, sono autonomi. Non c’è un automatismo “se pago allora niente penale” (tranne quanto diremo sull’art. 13).
Raddoppio dei termini di accertamento: la presenza di un reato ha un riflesso importante sui termini di decadenza dell’accertamento. Fino al 2015 vigeva il “raddoppio dei termini” integrale: se vi è una violazione tributaria che comporta obbligo di denuncia penale, i termini raddoppiano (quindi 5 -> 10 anni). Oggi la norma (art. 43, c.3 DPR 600/73 come modificato) prevede che i termini sono prorogati (non esattamente raddoppiati, ma di norma raddoppiati – in realtà c’è discussione) in presenza di reato tributario, a condizione che la denuncia penale sia presentata entro la scadenza del termine ordinario. In pratica, se l’ufficio scopre un reato e fa denuncia in tempo, ha più tempo per accertare. Questo spiega perché alcuni accertamenti parziali arrivano quasi al limite: l’ufficio magari ha presentato denuncia e sfrutta un paio d’anni in più per notificare. Ad esempio, per il 2017 termine ordinario 31/12/2023; se scoperto reato e denunciato entro fine 2023, l’ufficio poteva notificare fino a 31/12/2025. Cassazione ha però chiarito che il raddoppio è condizionato e se poi il reato risulta non sussistente o sotto soglia, il raddoppio non opera. Ad esempio Cass. n. 5501/2022 ha escluso il raddoppio se la soglia penale non è integrata. Dunque, se l’AE tenta un accertamento tardivo invocando il reato ma poi l’imposta evasa era 90k (sotto soglia), quell’accertamento è tardivo e annullabile.
In sede di accertamento parziale, il contribuente deve essere consapevole se il suo caso ricade in ambito penale. Spesso l’avviso stesso lo indica: ad esempio, alcuni avvisi recano una dicitura tipo “Violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi art. 331 c.p.p. (art.4 DLgs 74/2000)”. Oppure lo capisci dall’importo. Se vedi che l’imposta evasa contestata è enorme (>100k), è quasi certo che è stata fatta denuncia penale. Talvolta, ancor prima dell’avviso, si viene a sapere di indagini penali (per es. perquisizioni GdF).
Diritti della difesa in sede penale: qualora scatti il penale, il contribuente (ora imputato) potrà difendersi nel processo penale con i suoi legali. Le valutazioni nel penale sono un po’ diverse: serve il dolo specifico di evasione per condannare (cioè che l’omissione è stata volontaria, non errore; se fu errore involontario, non c’è reato). Ad esempio se si dimostra che fu un errore contabile, niente penale (ma resta sanzione amministrativa). Inoltre, i reati fiscali hanno cause di non punibilità:
- Pagamento integrale del debito: l’art. 13 DLgs. 74/2000 prevede che se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente versa integralmente le imposte, interessi e sanzioni amministrative dovute per i tributi evasi, il reato di dichiarazione infedele (o omessa dich.) è estinto per condotta riparatoria. Ciò significa che, se entro quella fase (grossomodo, entro il processo penale) paghi tutto ciò che devi al fisco, non vieni punito penalmente per quei reati. Questo è un forte incentivo a definire l’accertamento e pagare, se c’è il penale. Attenzione: vale per infedele e omessa (reati “non fraudolenti”). Per i reati di frode, il pagamento comporta solo attenuanti ma non estingue il reato.
- Cause di esclusione: come detto, errori di valutazione sotto il 10% non contano penalmente, violazioni meramente formali non integrano reato (es. errori di competenza temporale, se i componenti reddituali sono comunque esistenti e indicati altrove). Ad esempio la Cassazione penale ha stabilito che se un contribuente omette di dichiarare criptovalute non supera soglie, ecc. (casi specifici). Questi aspetti penali sono dettagliati e non direttamente oggetto dell’accertamento, ma vale sapere che non tutto porta a reato: certe soglie e clausole salvaguardano piccole differenze o divergenze di interpretazione.
Coordinamento difese: se sei soggetto a un accertamento parziale e sai di avere un procedimento penale in corso per lo stesso fatto, è opportuno coordinare la strategia difensiva tributaria e penale. Ad esempio, in alcuni casi potrebbe convenire definire subito il tributario per poter usufruire dell’art. 13 (non punibilità) nel penale. Oppure, se nel penale puntate a dimostrare che il fatto non sussiste, attenzione a non contraddirvi in sede tributaria (es. accettando di pagare). Solitamente i legali tributaristi e penalisti collaborano per scegliere la via migliore. Una volta tanto, l’interesse del contribuente è spesso pagare il dovuto al fisco il prima possibile se c’è rischio di condanna penale, perché nessun risparmio d’imposta vale una fedina penale sporca o addirittura la detenzione.
Prescrizione penale: i reati tributari hanno tempi di prescrizione relativamente lunghi (dich. infedele, 6 anni; omessa, 6 anni; frode, 8 anni, aumentati con interruzioni). Quindi non fare troppo affidamento sulla prescrizione come via d’uscita rapida.
In sintesi, dal punto di vista del contribuente-debitore:
- Se l’accertamento parziale riguarda somme ingenti, informati subito se c’è un procedimento penale parallelo. L’ufficio a volte lo indica, altrimenti si può chiedere.
- Valuta seriamente il pagamento integrale come strumento per evitare guai penali (specie per infedele/omessa). Può sembrare controintuitivo pagare e magari litigare meno nel tributario, ma la libertà personale è più importante di un po’ di soldi risparmiati. La legge premia chi paga: l’art.13 è chiaro su questo.
- Non fare ammissioni inconsulte: se c’è penale, ogni scritto che mandi al fisco può finire in mano al PM. Meglio farsi seguire da avvocati che sanno bilanciare le dichiarazioni. Ad esempio, in sede di adesione non dire “sì ho nascosto volutamente quei ricavi”, perché poi è una confessione usabile nel penale. Mantieni una linea difensiva coerente (spesso: “c’è stato un errore, ora correggo e pago”).
- Sappi che la definizione fiscale (anche se in adesione o conciliazione con sanzioni ridotte) copre tutto il debito tributario ai fini dell’art.13 penale: cioè se aderisco e pago il concordato, dovrò comunque versare anche le sanzioni amministrative residue, perché la norma chiede pagamento imposte + interessi + sanzioni amministrative. Quindi attenzione: in caso di reato, per estinguerlo bisogna pagare pure le sanzioni (ridotte ok, ma vanno pagate). Non basta pagare la sola imposta. Questo è un punto critico: se fai adesione, ti restano 1/3 delle sanzioni da pagare – devi pagarle se vuoi immunità penale. Se fai ricorso e vinci sul penale, ok, ma se perdi poi devi pagare tutto e hai perso la chance di non punibilità perché magari il processo è andato avanti.
Un aspetto positivo: grazie alla definizione amministrativa, spesso in sede penale si può ottenere un patteggiamento con pene ridotte, o la sospensione condizionale, soprattutto se è la prima volta. I giudici penali guardano molto al fatto che il contribuente abbia risarcito il danno erariale (cioè pagato le imposte evase): in tal caso, anche se il reato c’è, tendono a concedere benefici (sospensione pena, attenuanti generiche). Viceversa, chi continua a non pagare può subire condanne più severe.
Va evidenziato che non tutti gli accertamenti parziali implicano reati: anzi, la maggioranza riguarda evasioni sotto soglia. Per importi modesti (ad es. fino a decine di migliaia di euro di imposta) c’è solo sanzione amministrativa. Quindi non bisogna allarmarsi inutilmente: verificare le cifre e le percentuali. L’importante è sapere che c’è questa dimensione penale possibile e regolarsi di conseguenza.
Esempi pratici di difesa da accertamento parziale
Per rendere più concreti i concetti esposti, proponiamo di seguito un paio di scenari ipotetici con la descrizione di come un contribuente potrebbe difendersi in ciascun caso.
Caso 1: Professionista con fatture attive non dichiarate
- Situazione: Il Dott. Bianchi, medico dentista, nell’anno d’imposta 2021 ha emesso regolarmente fatture per prestazioni odontoiatriche per €120.000 (risultanti dal Sistema Tessera Sanitaria). Tuttavia, per un errore del suo commercialista, nella dichiarazione dei redditi 2022 (anno imposta 2021) ha dichiarato solo €80.000 di compensi. A dicembre 2024 riceve un avviso di accertamento parziale dall’Agenzia Entrate: contestano €40.000 di ricavi non dichiarati, sulla base dei dati del Sistema TS incrociati con quanto indicato in dichiarazione. Imposta IRPEF evasa calcolata €17.600 circa (aliquota media 44%), più addizionali €1.000, totale €18.600 di imposte. Sanzione applicata 90% = €16.740. Totale richiesto (imposte+sanzioni+int.) circa €37.000.
- Analisi difensiva: Bianchi verifica subito e si accorge che effettivamente c’è stato l’errore: €40.000 di compensi non inseriti. Non ha giustificazioni per contestare nel merito (la pretesa è fondata). Non emergono vizi formali nell’atto (notificato nei termini, motivato con dettaglio fatture, importi corretti). Quindi, impugnare significherebbe solo prender tempo o sperare in uno sconto sanzioni dal giudice, ma con rischio di spese. Inoltre, l’imposta evasa (18.600) è < 100k, quindi niente reato (dichiarazione infedele sotto soglia). Bianchi decide di evitare il contenzioso e definire.
- Azione: Presenta subito (entro 30 gg) istanza di accertamento con adesione per vedere se può ottenere qualche riduzione. All’incontro, spiega che c’è stato un errore involontario, porta documentazione sui costi sostenuti (per evidenziare che il suo margine di guadagno non era così alto – anche se irrilevante ai fini IRPEF, può fare leva emotiva). L’Ufficio, dati gli importi chiari, non può concedere sconti sull’imponibile (il fatto è oggettivo), ma, tenuto conto della collaborazione, propone di chiudere in adesione confermando i €40.000 di reddito aggiuntivo con sanzione ridotta: 1/3 del 90% = 30%. Quindi imposte €18.600 + sanzioni €5.580 + interessi. Totale circa €24.500. Bianchi accetta e firma l’adesione.
- Esito: Bianchi paga l’importo pattuito (magari chiede 8 rate trimestrali, che gli vengono concesse: ~€3.100 a trimestre). L’accertamento si chiude. Bianchi non subisce ulteriori controlli su 2021 (aveva solo quello errore). Nessuna conseguenza penale essendo sotto soglia. Ha evitato un contenzioso e ottenuto uno sconto sulle sanzioni di circa €11.000 rispetto all’atto iniziale. Inoltre, grazie alla definizione, l’Agenzia non gli addebiterà le spese di notifica né procederà con cartelle.
Caso 2: Ditta individuale con movimenti bancari non giustificati (soglia penale)
- Situazione: La sig.ra Rossi gestisce un negozio di abbigliamento (ditta individuale). Nel 2020, a fronte di ricavi dichiarati per €200.000, sul suo conto bancario personale l’Agenzia riscontra versamenti in contanti per €100.000 non giustificati da prelievi cassa o altro. L’Agenzia presume siano ricavi in nero. A giugno 2025 notifica un avviso di accertamento parziale per il 2020 contestando €100.000 di ricavi non dichiarati. IRES evasa €24.000 (aliquota 24%), IRAP evasa €3.900 (aliq.3.9%), totale imposte ~€27.900. Sanzione infedele 90% = €25.110. Totale ~€53.000 più interessi. Nota: Imposta evasa 27.9k, sotto soglia penale 100k, quindi formalmente niente reato infedele. Tuttavia, essendo movimenti sospetti, l’ufficio ha segnalato la cosa anche alla GdF per eventuali approfondimenti su riciclaggio (ma questo esula).
- Analisi difensiva: Rossi sa che ha versato in banca soldi non provenienti dall’attività (in realtà, erano risparmi di famiglia non dichiarati, ma non ha prove). Non riesce a dimostrare una fonte lecita esente. Dal punto di vista tributario, è difficile vincere in giudizio: la legge considera i versamenti non giustificati come ricavi salvo prova contraria. Valuta possibili vizi: l’accertamento è stato notificato nel giugno 2025, ma il termine ordinario per il 2020 era 31/12/2025 – quindi nei termini. Nessun altro vizio palese. Rossi teme di spendere in un contenzioso e comunque dover pagare.
- Azione: Decide di percorrere la via della mediazione/ricorso perché magari punta a un piccolo sconto e a guadagnare tempo per pagare. Entro 60 gg presenta un ricorso (con reclamo) chiedendo l’annullamento parziale: invoca che una parte di quei versamenti erano girofondi non imponibili (affermazione non facile da provare, ma ci prova) e contesta anche la mancata indicazione specifica delle date dei versamenti (cerca un vizio di motivazione: l’atto raggruppa per mese i versamenti, lei lamenta che non tutti sarebbero ricavi). È un motivo un po’ debole, ma serve come leva in mediazione. Nel reclamo, propone di definire riducendo l’imponibile contestato del 20% (da 100k a 80k).
- Mediazione e accordo: L’ufficio esamina il reclamo. Visto che l’importo evaso non è enorme e per decongestionare il contenzioso, offre una mediazione: riduzione del reddito non dichiarato a €85.000 e sanzione ridotta al 35% (come da DLgs. 546/92 per mediazione). In pratica, imposte dovute su €85k (
€23.700) e sanzione 35% (€8.295). Totale €32k circa + interessi. Rossi valuta e accetta, perché ottiene un taglio di oltre €20k rispetto all’atto iniziale. Firma l’accordo di mediazione e paga secondo i termini (1/3 subito, rate sul resto, come da prassi). - Esito: L’atto viene definito in via di mediazione tributaria. Rossi paga meno imposte e sanzioni e soprattutto ha dilazione (le norme attuali permettono 8 rate anche per mediazione). Ha evitato il processo e contenuto i danni. Non c’è reato in quanto imposta evasa < 100k. I risparmi di famiglia li ha comunque dovuti “giustificare” così, pagando tasse su di essi, ma almeno senza condanne. Resta un rischio: se in futuro emergesse che quei contanti provenivano da attività illecite, potrebbe esserci altro, ma questo esula. Dal punto di vista fiscale, la sua vicenda 2020 è chiusa.
Caso 3: Società con fattura falsa e reato tributario
- Situazione: La Alfa Srl nel 2019 ha annotato a bilancio una fattura di €300.000 per consulenze risultata poi essere falsa (operazione inesistente). L’Agenzia delle Entrate scopre la frode tramite incroci (fornitore fittizio) e ad aprile 2025 notifica un avviso di accertamento parziale IVA 2019 per recuperare l’IVA indebitamente detratta (€66.000) e indeducibilità del costo ai fini IRES (€300k di reddito in più, imposta 24% = €72.000). Totale imposte €138.000. Sanzioni: per utilizzo di fattura falsa c’è il reato di dichiarazione fraudolenta, ma lato amministrativo si applica sanzione del 90% su IRES (€64.800) e 90% su IVA (€59.400), totale sanzioni €124.200 (a rigor di legge potrebbe essere il 90% del sommato o distinto, cmq simile). Totale atto ~€262.200 più interessi. Penale: qui sicuramente è scattata denuncia ex art.2 DLgs.74/2000 (fatture false non hanno soglie). La Alfa Srl e il suo amministratore sono indagati per dichiarazione fraudolenta (pena 4-8 anni).
- Analisi difensiva: Caso grave. La società sa che la fattura è falsa (l’ha usata per abbattere utili). La priorità è limitare le conseguenze penali per l’amministratore. Il legale consiglia di pagare il dovuto per poter chiedere un trattamento più mite in penale (per reati fraudolenti, il pagamento integrale non estingue reato ma sarà elemento favorevole per magari patteggiamento e pena sospesa). L’accertamento è molto consistente, però se non pagano, in penale il giudice può essere più severo. La Alfa Srl valuta le finanze: può recuperare fondi per pagare, magari vendendo un cespite.
- Azione: La società avvia subito adesione per tentare di ridurre almeno le sanzioni. Durante l’adesione, però, l’ufficio è poco flessibile data la natura fraudolenta: al massimo potrebbe ricalcolare l’IRES considerando quell’importo distribuito su più anni (ma qui no, è su anno singolo). Tuttavia, vista la collaborazione, l’ufficio concorda di applicare sanzioni al minimo edittale (che già erano) e non cumulare oltre (c’era ipotesi di contestare anche indebita compensazione ecc., decidono di non farlo). Praticamente confermano tutto l’imponibile. L’adesione si chiude quindi su €138.000 imposte e sanzioni ridotte 1/3 (su 124.200) = €41.400. Totale da pagare €179.400 + interessi. La società paga immediatamente (magari rate per legge possibili, ma qui vuole chiudere subito).
- Esito: L’Agenzia incassa. L’amministratore, nel processo penale imminente, può dimostrare di aver integralmente versato il dovuto al fisco (imposte, interessi e anche sanzioni amministrative). Chiede quindi alla Procura un patteggiamento a 2 anni (pena minima ridotta per attenuanti generiche del pagamento). Il giudice concede la pena di 2 anni sospesa. L’amministratore evita il carcere e la società evita ulteriori accertamenti su 2019. Naturalmente, 300k di costo falso hanno generato forse altri reati (es. se l’hanno usata per stornare utili ai soci, possibili implicazioni). Ma fiscalmente, la posizione è definita. Questo esempio mostra come pagare il fisco è cruciale per mitigare il penale. Se la Alfa Srl avesse litigato in giudizio tributario e perso 3 anni dopo, l’amministratore nel frattempo rischiava detenzione. Così invece ha risolto in via negoziata, subendo un esborso grande ma salvando la fedina.
Questi esempi dimostrano l’importanza di valutare caso per caso la strategia: in vicende semplici conviene definire, in altre con margini si può contrattare o ricorrere. In situazioni penalmente rilevanti, la priorità è spesso pagare e chiudere col fisco per poi gestire il penale.
Domande frequenti (FAQ) sull’accertamento parziale
D1: Che cos’è esattamente un accertamento parziale?
R: È un avviso di accertamento “limitato” ad alcuni redditi o imposte non dichiarati, emesso ai sensi dell’art. 41-bis DPR 600/1973. Invece di rivedere tutta la dichiarazione, il Fisco corregge solo le specifiche irregolarità emerse da controlli mirati (per esempio redditi non dichiarati scoperti tramite banche dati, fatture, movimenti bancari). Si chiama parziale perché non copre l’intera posizione fiscale dell’anno, ma ha comunque effetto definitivo sulle somme contestate (se non impugnato diventa definitivo come qualsiasi accertamento).
D2: In quali casi l’Agenzia delle Entrate emette un accertamento parziale?
R: Quando dispone di elementi certi e immediati che provano un’imposta evasa o un reddito non dichiarato senza bisogno di ulteriori indagini. Tipicamente dopo incroci di banche dati (es. fatture elettroniche, anagrafe conti, tessera sanitaria), segnalazioni da altri enti (es. Guardia di Finanza, Comuni), controlli formali che evidenziano omissioni evidenti, ecc. Ad esempio, se risultano fatture emesse ma non dichiarate o versamenti bancari non giustificati sul conto, l’Ufficio può intervenire parzialmente su quei componenti senza fare un accertamento generale.
D3: L’accertamento parziale preclude altri controlli sullo stesso anno?
R: No, non li preclude. La legge dice espressamente “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice”. Ciò significa che il Fisco può emettere successivi accertamenti (parziali o integrali) sul medesimo periodo d’imposta, purché per contestare altri elementi non trattati nel primo atto. Ad esempio potrebbe prima notificare un parziale su redditi bancari, e poi farne un altro su un diverso rilievo (o un accertamento integrativo) se emergono fatti nuovi. Non può invece duplicare la contestazione sugli stessi elementi: un secondo accertamento basato su elementi già noti ma non contestati inizialmente sarebbe illegittimo.
D4: È obbligatorio essere sentiti prima (contraddittorio) per un accertamento parziale?
R: In generale no (salvo alcuni casi particolari). La normativa sul contraddittorio preventivo obbligatorio introdotta nel 2020 esclude esplicitamente gli accertamenti parziali basati su incroci di dati dall’obbligo di invito. Quindi l’Ufficio può notificare direttamente l’avviso senza aver convocato il contribuente. Ciò detto, spesso l’Agenzia invia comunque un invito a comparire o una richiesta di chiarimenti prima di emettere il parziale, per dare modo al contribuente di spiegare (pur non essendo tenuta). Dal 30/4/2024 il contraddittorio è divenuto regola generale, ma un decreto ha mantenuto fuori i parziali automatizzati. In sintesi: non c’è un diritto assoluto al contraddittorio per il 41-bis (di regola no), tranne che per quegli atti parziali che non siano basati solo su dati certi (ipotesi rara).
D5: Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento parziale?
R: Non ignorarlo! Entro 60 giorni devi decidere come reagire. Le opzioni sono:
- Pagare con acquiescenza (entro 60 gg) per chiudere subito beneficiando di sanzioni ridotte a 1/3.
- Chiedere accertamento con adesione (istanza entro 60 gg) per trattare con l’ufficio, sospendendo i termini e magari ottenendo uno sconto.
- Presentare ricorso alla Commissione Tributaria (entro 60 gg, o 150 se adesione in corso) se ritieni l’atto infondato o viziato.
- Chiedere autotutela all’ufficio (meglio entro i 60 gg) se c’è un errore evidente, sperando in un annullamento interno.
Spesso la scelta migliore è avviare l’adesione (per guadagnare tempo e discutere) e, se fallisce, fare ricorso. In ogni caso va analizzato l’atto con un professionista per decidere la strategia ottimale entro i 60 giorni.
D6: Cosa succede se ignoro l’accertamento parziale e non faccio nulla entro 60 giorni?
R: L’avviso diventa definitivo. Significa che accetti implicitamente tutte le somme contestate. L’Agenzia iscriverà a ruolo l’importo dovuto (imposte, sanzioni, interessi) decorso il termine. Ti arriverà quindi una cartella esattoriale per la riscossione coattiva. Se continui a non pagare, dopo ulteriori 60 giorni potranno scattare azioni di recupero: pignoramento di conti correnti, pignoramento dello stipendio/pensione, iscrizione di ipoteca su immobili, fermi amministrativi su auto, ecc.. Ignorare l’atto equivale a perdere ogni possibilità di difesa e a dover pagare integralmente, spesso con aggravio di spese. Pertanto è fortemente sconsigliato restare inerti.
D7: Posso pagare a rate le somme di un accertamento parziale?
R: Sì. Sia in caso di definizione (adesione o acquiescenza) sia in caso di cartella post-ricorso, la normativa consente la rateazione. Con adesione/acquiescenza puoi chiedere fino a 8 rate trimestrali (16 se importo > €50.000). La prima rata va versata entro 20 gg (adesione) o 60 gg (acquiescenza) e le altre a seguire con interessi. Anche le somme in cartella esattoriale possono essere rateizzate (fino a 72 rate mensili ordinariamente). Quindi se non hai liquidità immediata, puoi diluire il pagamento. Attenzione solo che, per ottenere la riduzione sanzioni con adesione/acquiescenza, devi rispettare il piano di rate: se decadi dalla rateazione, perdi i benefici.
D8: Quali sanzioni amministrative si applicano in un accertamento parziale?
R: Prevalentemente le sanzioni per dichiarazione infedele: il 90% della maggiore imposta dovuta (minimo, massimo 180%). Se si tratta di imposta completamente omessa (dichiarazione mancata per quel tributo), la sanzione è 120%–240% dell’imposta. L’atto in genere indica la norma violata e la sanzione in percentuale. Ad esempio, per redditi non dichiarati avrai sanzione 90% sull’IRPEF accertata. Queste sanzioni possono essere ridotte: a 1/3 in caso di adesione/acquiescenza, a 2/3 o 1/2 in caso di conciliazione giudiziale, ecc. Se invece fai ricorso e perdi, pagherai la sanzione intera (di solito il 90% se l’ufficio aveva messo il minimo). Va ricordato che l’imposta e la sanzione vanno pagate insieme. Le sanzioni amministrative non comportano casellario giudiziale (non sono penali), ma economicamente sono gravose.
D9: L’accertamento parziale può avere conseguenze penali?
R: Sì, se gli importi evasi superano le soglie di reato previste dal D.Lgs. 74/2000 o se sono utilizzati mezzi fraudolenti. Ad esempio, dichiarazione infedele diventa reato se l’imposta evasa > 100.000 € e gli elementi occultati > 10% del dichiarato o > 2 milioni €. Omessa dichiarazione è reato se imposta evasa > 50.000 €. Fatture false o frodi sono reati a prescindere dalla soglia. In caso di contestazioni molto elevate (o condotte fraudolente), l’ufficio di solito trasmette denuncia alla Procura. Ciò significa che, parallelamente all’accertamento fiscale, potresti subire un procedimento penale per evasione. È importante saperlo perché in tal caso conviene attivarsi per pagare il dovuto: pagando integralmente imposte, interessi e sanzioni amministrative prima del dibattimento penale, si ottiene la non punibilità per infedele/omessa (art. 13 DLgs.74/2000). In pratica, se rientri nelle soglie di reato, consulta subito un esperto penalista: spesso la strategia migliore è definire col fisco il più presto possibile e usare il pagamento come attenuante o esimente nel penale. Se gli importi evasi sono sotto soglia, invece, non c’è reato penale tributario, solo sanzioni amministrative pecuniarie.
D10: L’accertamento parziale può essere annullato per vizi formali (es. ritardo, difetto di motivazione)?
R: Sì. L’accertamento parziale è soggetto alle stesse regole degli altri atti, quindi un vizio procedurale o formale può renderlo nullo. Ad esempio, se è notificato oltre il termine di decadenza (5 anni, o 7 in caso di omessa dich.), è nulla e va annullato su eccezione del contribuente. Oppure, se manca la motivazione (non spiegano da dove escono le somme contestate) si può far annullare per difetto di motivazione. Un altro vizio potrebbe essere la notifica irregolare (se dimostri che non ti è stata notificata correttamente). Anche la mancata sottoscrizione da parte del dirigente competente è motivo di nullità. Dunque, se riscontri un vizio del genere, va sollevato nel ricorso e il giudice, se confermato, annullerà l’intero avviso, a prescindere dal merito (è come un vizio di forma che travolge l’atto). La tardività in particolare è un’eccezione frequente e vincente, purché non ci siano cause di proroga (come un eventuale raddoppio termini per reato: verifica se c’è stata denuncia penale, in quel caso l’ufficio può avere più tempo, ma solo se la denuncia è avvenuta tempestivamente e il reato sussiste). In sintesi: sì, i vizi formali/di procedimento contano eccome anche per i parziali.
D11: Che differenza c’è tra accertamento parziale e accertamento integrativo?
R: L’accertamento parziale è un atto autonomo, emesso spesso come primo (e magari unico) controllo sull’anno, limitato a certi elementi. L’accertamento integrativo invece aggiunge nuovi importi a un precedente accertamento già emesso, quando emergono elementi non conosciuti prima. In pratica, il parziale non presuppone che ce ne sia uno precedente (può essere l’unico atto su quell’anno), mentre l’integrativo arriva dopo un primo avviso se spuntano nuove informazioni. Inoltre, il parziale segue le stesse regole degli accertamenti normali (ma consente più atti per anno), l’integrativo è espressamente previsto dall’art. 43 DPR 600 in deroga al principio del “una volta sola” per i nuovi elementi sopravvenuti. Un parziale può essere seguito in futuro da un integrativo se l’Ufficio scopre altro. Esempio: parziale oggi su redditi bancari, poi nel 2025 scoprono un altro reddito occulto -> integrativo. L’importante è che l’integrativo non può riguardare cose che l’ufficio già sapeva al tempo del primo atto. In sintesi, parziale e integrativo sono entrambi eccezioni al ne bis in idem tributario, ma il parziale è uno strumento iniziale di controllo rapido, l’integrativo serve a rimediare a posteriori per fatti nuovi.
D12: Dopo aver pagato/definito un accertamento parziale, sono al riparo da altri controlli?
R: Sei al riparo solo per quanto riguarda le somme specificamente contestate in quell’atto, che vengono definite una volta per tutte. Ma per lo stesso anno d’imposta potresti subire altri controlli su altri aspetti non toccati da quell’accertamento. Ad esempio, se hai definito un parziale sui ricavi non dichiarati, nulla impedisce all’Agenzia, se scopre in seguito che avevi anche utilizzato una fattura falsa, di farti un altro accertamento (integrativo) per recuperare quello. Quello che l’Amministrazione non può fare è riprendere ciò che è già stato definito: se hai chiuso col fisco su un certo imponibile, non te lo possono richiedere un’altra volta (principio del divieto di doppia imposizione). Quindi, concluso un parziale, conserva gli atti di definizione. In caso di altro accertamento sullo stesso elemento, potrai opporre che era già stato definito. Ma su elementi diversi, sì, è possibile. E ricorda che c’è sempre la possibilità di controlli su altri tributi correlati: ad esempio un parziale IRPEF definito non esclude un successivo accertamento IVA per lo stesso fatto se inizialmente non era stato contestato l’IVA (anche se di solito li includono insieme). Dopo il decorso dei termini (5 anni) e definito eventuale integrativo, allora quell’anno è concluso definitivamente.
Conclusioni
L’accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/1973 è uno strumento potente in mano al Fisco per colpire in tempi rapidi specifiche sacche di evasione, e può riguardare imprese, professionisti o privati. Dal punto di vista del contribuente (debitore), ricevere un avviso di accertamento parziale non va mai preso alla leggera: comporta infatti una pretesa immediata di imposte, sanzioni e interessi su un determinato reddito non dichiarato, con effetti potenzialmente molto gravosi (anche penali nei casi più seri). Abbiamo visto che il contribuente ha diritti e strumenti per difendersi efficacemente, a patto di attivarsi tempestivamente e con cognizione di causa.
In questo percorso di difesa, è fondamentale:
- Comprendere a fondo l’atto, valutandone la legittimità formale e sostanziale (con il supporto di esperti), per scegliere se aderire o ricorrere.
- Sfruttare le opportunità deflative (contraddittorio preventivo quando disponibile, accertamento con adesione, acquiescenza con sanzioni ridotte) per trovare soluzioni rapide e vantaggiose, evitando quando possibile un contenzioso lungo e costoso.
- Conoscere i propri limiti: se l’accertamento è fondato, ostinarsi in giudizio può peggiorare la situazione economica (sanzioni piene, interessi, spese legali). In tali casi conviene optare per una definizione agevolata e voltare pagina. Viceversa, se l’atto è viziato o infondato, occorre far valere con decisione i propri diritti in sede di ricorso.
- Tenere conto dei profili penali: laddove in gioco ci sono reati tributari, modulare la difesa considerando anche l’esito sul procedimento penale (spesso pagando il dovuto si ottiene la non punibilità o attenuanti). In tali frangenti, la strategia va concordata tra difensore tributario e difensore penale.
- Agire con tempestività: i 60 giorni volano. Non attendere l’ultimo momento – contatta subito un professionista, analizza l’atto, invia eventualmente l’adesione (per guadagnare tempo) e prepara le memorie. La tempestività può fare la differenza tra un atto annullato e uno divenuto definitivo per inerzia.
- Documentare tutto e mantenere la buona fede: presentare memorie, documenti e partecipare al dialogo con il Fisco denota atteggiamento collaborativo. Ciò può aiutare tanto in fase amministrativa (l’ufficio potrebbe accogliere in parte) quanto davanti ai giudici (che guardano con favore il contribuente diligente). Al contrario, la negligenza o la reticenza spesso giocano a sfavore.
In conclusione, l’accertamento parziale rappresenta sì un momento di confronto serrato con il Fisco, ma non è una sentenza irrevocabile: è un atto che si può discutere, correggere, eventualmente combattere con successo. Come abbiamo illustrato, esistono molteplici vie di difesa, calibrabili sul caso concreto. Un contribuente informato e ben assistito può evitare il peggio, riducendo sanzioni, dilazionando pagamenti o addirittura azzerando pretese illegittime. Dal punto di vista del debitore, “difendersi con metodo” (magari facendosi affiancare da professionisti esperti in diritto tributario) significa salvaguardare sia il proprio patrimonio sia la propria serenità: affrontare l’accertamento attivamente e consapevolmente è sempre preferibile a subirne passivamente le conseguenze.
Ricorda: anche un accertamento fiscale “parziale” merita una difesa totale dei tuoi diritti di contribuente.
Fonti
- Corte di Cassazione – Sez. Trib., Ordinanza n. 7461 del 20 marzo 2024 (Pres. Giudicepietro, Rel. Lume) – Massima: l’accertamento parziale non è un metodo autonomo ma una modalità procedurale soggetta alle medesime regole degli accertamenti ordinari, e la prova può fondarsi anche su presunzioni legali.
- Gazzetta Ufficiale – Decreto MEF 24 aprile 2024, “Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’art. 6-bis L.212/2000” (GU Serie Gen. n.100 del 30-04-2024) . Elenca gli atti esclusi dal contraddittorio generalizzato, includendo gli accertamenti parziali basati su incrocio di dati.
- D.P.R. 600/1973 – art. 41-bis (testo aggiornato al 2025) . Normativa di riferimento per l’accertamento parziale: presupposti (elementi da istruttorie, segnalazioni, ecc.), facoltà dell’ufficio di limitarsi ad accertare il reddito non dichiarato senza pregiudizio per ulteriori accertamenti.
- D.Lgs. 74/2000 – art. 4 e art. 5 (come mod. da D.L. 124/2019 conv. L.157/2019) . Definisce il reato di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione: soglie di punibilità (100k imposta evasa e >10%/2M per infedele; 50k per omessa), pene previste.
- Cassazione Civile – Sez. Trib., ordinanza n. 18398 del 04/09/2020; ordinanza n. 31012 del 02/11/2021 . Riconfermano principi su accertamento parziale (non metodo autonomo, segue regole ordinarie).
- Cassazione Penale – sentenza n. 37335/2014 . Sancisce che presunzioni induttive pure non bastano per il penale: importanza di riscontri fattuali (rilevante per capire che in penale serve dolo e prova piena, differenze con livello amministrativo).
- Agenzia Entrate – Circolare n. 16/E del 28/04/2016 (non citato sopra, ma inerente) sul raddoppio dei termini post L.208/2015: chiarisce che denuncia penale entro termini è condizione, e se soglia non integrata raddoppio non opera (recependo orientamento Cass.).
- Commissione Tributaria Pescara – Sent. 926/2017 . Caso pratico di accertamento parziale annullato perché atto firmato da funzionario non delegato correttamente (vizio di sottoscrizione): conferma che anche per parziali vale art.42 DPR 600/73 sulla firma.
- Statuto del Contribuente – L. 212/2000, art. 6-bis (introdotto da D.Lgs. 219/2023) . Stabilisce il diritto generale al contraddittorio per atti impugnabili (con eccezioni DM 2024). Principio di una sola azione accertatrice per periodo salvo disposizioni specifiche (art. 9-bis L.212/2000, anch’esso introdotto nel 2023, citato in Monardo 2025 guida integrativo/parziale).
Accertamento parziale art. 41-bis/600? Fatti Difendere da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento parziale da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Ti contestano redditi non dichiarati sulla base di segnalazioni, controlli bancari o dati incrociati?
L’accertamento parziale ai sensi dell’art. 41-bis del DPR 600/73 consente al Fisco di notificare un avviso senza previo contraddittorio se emergono elementi certi e specifici di redditi non dichiarati. Ma anche in questi casi puoi difenderti e far valere le tue ragioni.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’avviso ricevuto e le fonti degli elementi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate
- 📌 Verifica la legittimità dell’accertamento parziale e la corretta applicazione dell’art. 41-bis
- ✍️ Redige memorie difensive, richieste di annullamento o opposizione all’atto
- ⚖️ Ti rappresenta nel ricorso tributario per contestare l’illegittimità o l’infondatezza della pretesa fiscale
- 🔁 Ti guida nel definire eventuali irregolarità tramite ravvedimento o adesione agevolata
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e contenzioso da accertamenti parziali
- ✔️ Specializzato nella tutela del contribuente in caso di presunzioni, dati bancari o segnalazioni automatiche
- ✔️ Consulente legale per professionisti, imprese, autonomi e contribuenti con conti controllati
Conclusione
Un accertamento parziale ex art. 41-bis può arrivare all’improvviso, ma non significa che tu debba accettarlo senza difenderti.
Con il supporto giusto puoi contestare l’atto, far valere i tuoi diritti e ridurre o annullare quanto richiesto.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa fiscale comincia da qui.