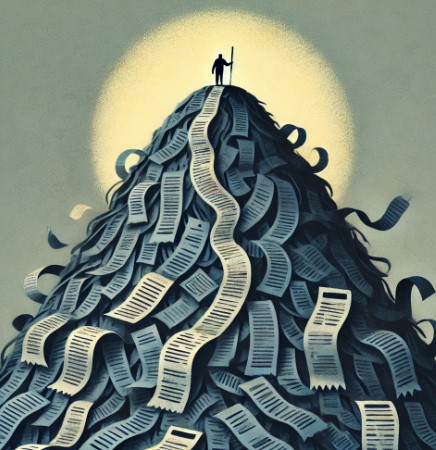Ti senti soffocato dai debiti e non riesci più a far fronte a rate, bollette, cartelle esattoriali o pagamenti arretrati? Ti stai chiedendo come uscire da una situazione di sovraindebitamento senza perdere tutto?
Se le entrate non bastano più a coprire le spese e sei inseguito da banche, Fisco, finanziarie o fornitori, sei in una condizione di sovraindebitamento. Ma non sei solo. La legge italiana ti offre strumenti concreti per liberarti dai debiti e ripartire.
Cos’è il sovraindebitamento?
È la situazione in cui una persona – anche ex imprenditore, artigiano, professionista, pensionato o lavoratore dipendente – non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti.
Riguarda chi non può accedere al fallimento o alla liquidazione giudiziale tradizionale.
Quando puoi ricorrere alle procedure per uscire dal sovraindebitamento?
– Se hai debiti accumulati con il Fisco, INPS, banche o privati
– Se sei un ex titolare di ditta individuale o di piccola impresa
– Se sei stato garante di finanziamenti aziendali o familiari
– Se hai subito crolli del reddito per malattia, separazioni, perdita del lavoro
– Se hai tentato di pagare ma la situazione è diventata insostenibile
Quali sono le soluzioni previste dalla legge?
– Piano del consumatore: per chi ha solo debiti personali e vuole conservarsi i beni essenziali
– Accordo di composizione: per trattare direttamente con i creditori e ridurre l’esposizione
– Liquidazione controllata: per liberarsi totalmente dai debiti, anche vendendo parte del patrimonio
– Esdebitazione del debitore incapiente: se non hai beni o redditi, puoi chiedere la cancellazione integrale dei debiti
Cosa puoi ottenere con queste procedure?
– Il blocco immediato di pignoramenti, ipoteche e azioni esecutive
– La sospensione di interessi, sanzioni e nuovi atti di riscossione
– La riduzione dei debiti anche fino all’80%, o la cancellazione totale
– La possibilità di conservare la casa, l’auto o altri beni fondamentali
– Un nuovo inizio senza l’incubo dei creditori
Come si avvia la procedura?
– Verifica con un avvocato esperto se possiedi i requisiti previsti
– Prepara l’elenco dei debiti, dei creditori e della tua situazione economica
– Affidati a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e presenta l’istanza al Tribunale
– Una volta omologato il piano, i creditori non potranno più agire contro di te
Attenzione: non aspettare che la situazione diventi irreversibile. Ogni giorno che passa può aggravare il debito e aumentare le conseguenze. Agire subito è la scelta migliore.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento e tutela del debitore ti spiega come uscire da una situazione di crisi economica, cosa puoi chiedere al giudice e come ripartire senza più debiti sulle spalle.
Hai cartelle esattoriali, rate non pagate o pignoramenti in corso? Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione e ti diremo qual è la soluzione migliore per uscire dal sovraindebitamento in modo legale e definitivo.
Introduzione
Il sovraindebitamento è definito dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) come lo stato di crisi o insolvenza del debitore non fallibile che non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. In altre parole, si tratta di una situazione in cui privati cittadini, piccoli imprenditori o professionisti si trovano schiacciati da debiti divenuti insostenibili, senza poter accedere alle ordinarie procedure concorsuali riservate alle imprese maggiori (fallimento o liquidazione giudiziale).
L’ordinamento italiano, sin dal 2012, offre a questi debitori una via d’uscita legale: attraverso specifiche procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il debitore onesto ma sfortunato può ristrutturare o cancellare i propri debiti e ottenere la cosiddetta esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non pagati. Tali procedure sono state introdotte inizialmente con la Legge 3/2012 (nota come “legge salva-suicidi”) e oggi sono confluite e disciplinate nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che ha sostituito integralmente la Legge 3/2012. Il CCII ha rafforzato e ampliato gli strumenti a disposizione dei debitori sovraindebitati, introducendo anche importanti novità (come la esdebitazione del debitore incapiente) e prevedendo tempi più rapidi per il fresh start (ad esempio, il debitore persona fisica ottiene oggi l’esdebitazione di diritto trascorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, mentre in passato l’attesa era di almeno quattro anni).
In questa guida forniremo un quadro aggiornato a luglio 2025 di tutte le procedure previste dal CCII per uscire dalla crisi da sovraindebitamento, con un taglio avanzato ma dal punto di vista pratico del debitore. Analizzeremo le condizioni di accesso, lo svolgimento e gli effetti delle diverse soluzioni (piano di ristrutturazione per il consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente, nonché la procedura familiare), citando la normativa italiana vigente e la più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici, e una sezione Domande e Risposte per chiarire i dubbi più frequenti. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali menzionate sono riportate in fondo alla guida nella sezione Fonti e Riferimenti, per consentire eventuali approfondimenti.
Quadro normativo e principi generali
Normativa di riferimento. Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono oggi disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato da ultimi interventi correttivi nel 2020, 2021 e 2024). Il Codice è entrato in vigore il 15 luglio 2022, abrogando la previgente Legge 3/2012. Pertanto, tutte le domande presentate a decorrere da tale data seguono le nuove regole del CCII. Le disposizioni del Codice si applicano sia ai casi di crisi incipiente sia alle situazioni di insolvenza conclamata del debitore non fallibile. Il legislatore del 2019 ha sostanzialmente confermato gli istituti introdotti dalla Legge 3/2012, introducendo però alcune significative innovazioni:
- una disciplina organica integrata con le procedure concorsuali delle imprese “maggiori” (fallimento diventato liquidazione giudiziale, concordato preventivo, ecc.);
- definizioni più chiare dei soggetti ammessi e condizioni di meritevolezza;
- l’introduzione dell’esdebitazione del debitore incapiente (ossia la cancellazione dei debiti per chi non ha alcuna risorsa da offrire);
- una riduzione dei tempi per ottenere l’esdebitazione (ad es. esdebitazione di diritto dopo 3 anni nella liquidazione controllata);
- semplificazioni nelle procedure (possibilità di reclamo anche contro provvedimenti di inammissibilità, maggiore chiarezza sui criteri di ammissibilità e fattibilità dei piani, ecc., grazie anche al Decreto “Correttivo ter” del 2024).
Le recenti riforme correttive del CCII – in particolare il D.Lgs. 13 settembre 2024 n.136 (cosiddetto “Correttivo ter”) – hanno ulteriormente affinato la disciplina. In tema di sovraindebitamento, il correttivo ter ha tra l’altro modificato la nozione di consumatore, confermando l’esclusione dal concordato minore per l’imprenditore individuale che abbia cessato l’attività, e introdotto una regolamentazione dei tempi per l’eventuale apertura della liquidazione controllata. Tali novità saranno evidenziate nei paragrafi seguenti, ove rilevanti, alla luce della normativa vigente a luglio 2025.
Finalità: la seconda opportunità per il debitore. Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è garantire al debitore meritevole una “seconda chance”, senza però sacrificare oltremodo i diritti dei creditori. Il principale beneficio per il debitore è la possibilità di ottenere l’esdebitazione, cioè l’eliminazione (legale) dei debiti residui insoddisfatti al termine della procedura. Ciò consente al debitore di ripartire da zero, reinserendosi attivamente nel circuito economico e sociale senza il peso insostenibile delle esposizioni pregresse. Dal lato dei creditori, le procedure mirano comunque a comporre i rapporti debitori nella maniera più efficiente e paritaria possibile, assicurando il miglior soddisfacimento delle loro pretese rispetto allo scenario del recupero individuale. Il CCII bilancia questi interessi richiedendo che ogni piano o accordo proposto dal debitore sia conveniente per i creditori: in particolare, nessun creditore, soprattutto se privilegiato (p.es. garantito da ipoteca), può essere trattato peggio di come sarebbe trattato in caso di liquidazione del patrimonio del debitore. La Corte di Cassazione ha chiarito questo principio affermando che un accordo di ristrutturazione non può essere omologato se pregiudica un creditore ipotecario, assicurandogli meno di quanto otterrebbe nell’alternativa liquidatoria. Il giudice, in sede di omologazione, deve quindi verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, respingendola se risulta dannosa per i creditori dissentienti (c.d. best interest test).
Ruolo dell’OCC e del Tribunale. Le procedure di sovraindebitamento prevedono l’intervento di un organismo specializzato: l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Si tratta di enti terzi, imparziali e indipendenti (istituiti presso enti pubblici, Ordini professionali, o altri organismi autorizzati) cui il debitore deve rivolgersi per avviare la procedura. L’OCC, ricevuta l’istanza, nomina un Gestore della crisi (professionista abilitato) il quale assiste il debitore nella predisposizione del piano o nella scelta della soluzione migliore. Il Gestore verifica la documentazione, aiuta a formulare la proposta ai creditori e redige una relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento e sulla condotta tenuta dal debitore (valutando la sua meritevolezza), nonché sulla fattibilità della proposta e sulla convenienza per i creditori. Questa relazione dell’OCC è un elemento chiave, soprattutto per il piano del consumatore, dove funge da riferimento per il giudizio di omologazione (essendo il piano privo di voto dei creditori).
Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il procedimento si svolge in camera di consiglio (ovvero in modo semplificato e non pubblico). In genere, dopo il deposito della proposta di piano o di liquidazione, il Tribunale può adottare immediatamente misure a tutela del debitore – come la sospensione delle azioni esecutive individuali dei creditori (“stay” o misure protettive) – per evitare che il patrimonio venga aggredito durante la pendenza della procedura. Tali misure protettive, se richieste, sono di norma concesse dal momento dell’ammissione alla procedura o anche già con il deposito dell’istanza (salvo diversi provvedimenti in caso di urgenza).
Il Tribunale (nella persona di un Giudice Delegato nominato) sovrintende alla procedura: esamina l’ammissibilità della domanda, omologa il piano o l’accordo se ne ricorrono i presupposti, oppure, in caso di liquidazione, emette la sentenza di apertura della liquidazione controllata e nomina un Liquidatore (figura analoga al curatore fallimentare). Durante la procedura, il debitore rimane normalmente spogliato dell’amministrazione dei propri beni (soprattutto in caso di liquidazione) e ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione deve essere autorizzato. Al termine, il Tribunale emette il provvedimento di chiusura e dichiara (oppure nega, in casi eccezionali) l’esdebitazione del debitore.
È importante sottolineare che il debitore sovraindebitato ha precisi obblighi di lealtà e trasparenza: deve fornire all’OCC e al giudice un quadro completo e veritiero della propria situazione patrimoniale, reddituale e debitoria, e non deve aver compiuto atti in frode ai creditori. La legge infatti esclude l’accesso o il beneficio dell’esdebitazione al debitore che abbia agito con dolo o frode, ad esempio nascondendo beni o contraendo obbligazioni col solo fine di ritardare o danneggiare i creditori. Anche comportamenti gravemente imprudenti o scorretti possono incidere: per il consumatore è previsto uno specifico requisito di meritevolezza, come vedremo, mentre per le altre categorie la Cassazione ha affermato che, pur non essendovi un esplicito richiamo normativo alla condotta pregressa, il giudice deve comunque valutare l’affidabilità e la serietà del debitore ai fini dell’accesso alla procedura. In pratica, un uso abusivo degli strumenti di sovraindebitamento (debitori in mala fede che cercano di approfittare della legge per frodare i creditori) viene impedito sia da queste verifiche preliminari, sia da possibili sanzioni penali: ad esempio, il debitore che dolosamente omette di dichiarare beni ai fini della procedura, o che presenta documentazione alterata, commette reato punibile con la reclusione e multa (art. 344 CCII, già art.16 L.3/2012).
Soggetti che possono accedere. Le procedure da sovraindebitamento sono rivolte ai debitori civili e agli imprenditori di piccole dimensioni, cioè coloro che non sono soggetti alle ordinarie procedure concorsuali (fallimento, ora liquidazione giudiziale, o concordato preventivo). In particolare, l’art. 65 CCII specifica che vi rientrano:
- le persone fisiche consumatori, ossia chi ha contratto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (privati cittadini, famiglie);
- gli imprenditori minori, ovvero imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità (attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000, ricavi annui ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000 negli ultimi 3 esercizi);
- gli imprenditori agricoli (esclusi per legge dal fallimento);
- le startup innovative (che godono di esenzione temporanea dalle procedure maggiori);
- gli imprenditori cessati (che hanno chiuso l’attività ma restano con debiti d’impresa non onorati);
- i soci illimitatamente responsabili di società di persone (per i debiti sociali rimasti a loro carico);
- i professionisti (avvocati, commercialisti, artisti, lavoratori autonomi in genere);
- le società professionali e le associazioni tra professionisti;
- le società semplici costituite per esercizio di attività professionali;
- gli enti privati non commerciali (es. associazioni non profit, fondazioni non commerciali).
In breve, chiunque si trovi in stato di sovraindebitamento può avvalersi di queste procedure, tranne le imprese soggette a fallimento o altre procedure concorsuali maggiori. Va aggiunto che anche un lavoratore dipendente può accedere – ad esempio un socio accomandatario di una S.a.s. inattiva, come chiarito dal Tribunale di Mantova 23.1.2025 – oppure un ex imprenditore per chiudere tutte le sue pendenze pregresse.
Cause di inammissibilità. La legge pone alcuni paletti per evitare abusi o usi ripetuti delle procedure di sovraindebitamento:
- Non può accedere chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda. Se dunque un debitore ha beneficiato di una cancellazione dei debiti meno di cinque anni fa, deve attendere tale periodo per poter richiedere nuovamente una procedura (questo vale sia che l’esdebitazione sia avvenuta in procedura concorsuale ordinaria, sia in sovraindebitamento). Inoltre, dopo due esdebitazioni ottenute in qualunque tempo, non è comunque ammessa una terza volta. L’idea è che l’esdebitazione rappresenti un rimedio eccezionale, da non poter invocare infinite volte.
- È escluso il debitore che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. In particolare, il consumatore che abbia gravemente colpe nel causare la propria insolvenza non può accedere ai piani di ristrutturazione (per lui resta semmai la possibilità della sola liquidazione controllata). Questa previsione codifica il requisito di meritevolezza già presente nella Legge 3/2012: il consumatore deve essersi indebitato senza frode e senza un’imprudenza talmente grave da rasentare il dolo. Ad esempio, se la crisi debitoria è dovuta a spese voluttuarie sproporzionate rispetto alle proprie entrate, o ad aver assunto nuovi debiti in mala fede sapendo di non poterli onorare, il giudice potrà dichiarare inammissibile il piano del consumatore per difetto di meritevolezza. Anche per il debitore non consumatore vige un principio analogo: la legge menziona espressamente gli atti diretti a frodare i creditori come causa di esclusione dal concordato minore, e la giurisprudenza ritiene che pure in assenza di una “meritevolezza” codificata, il tribunale debba valutare l’eventuale abuso o la grave scorrettezza del debitore come motivo di non ammissione. In sostanza, le procedure di sovraindebitamento sono riservate ai debitori onesti ma sfortunati, non a quelli che cercano di sottrarsi fraudolentemente alle proprie obbligazioni.
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Il Codice della crisi prevede diverse procedure attraverso cui il debitore sovraindebitato può cercare di risolvere la propria situazione. Tali procedure si distinguono essenzialmente in due categorie:
- Procedure di accordo o ristrutturazione – in cui il debitore propone un piano di pagamento (anche parziale) ai creditori, da attuarsi sotto controllo del tribunale, evitandogli così la liquidazione integrale del patrimonio. In queste rientrano:
- il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (riservato ai debitori persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale);
- il Concordato minore (per debitori che esercitano – o hanno esercitato – un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, non fallibili, e anche per enti non commerciali).
- Procedura liquidatoria – in cui il patrimonio del debitore viene sottoposto a liquidazione controllata da parte di un liquidatore nominato dal Tribunale, con successiva ripartizione del ricavato ai creditori secondo le regole concorsuali. In questa rientrano:
- la Liquidazione controllata del sovraindebitato (accessibile a qualsiasi debitore sovraindebitato, consumatore o non consumatore, ove non sia percorribile o praticabile un piano/accordo).
Accanto a queste, il Codice introduce due ulteriori possibilità speciali:
- L’Esdebitazione del debitore incapiente, che è una forma di esdebitazione “a costo zero”, accordata una tantum al debitore persona fisica privo di beni e risorse, senza aprire una procedura di liquidazione formale.
- Le Procedure familiari, ossia la facoltà per membri della stessa famiglia di presentare un’unica procedura congiunta di sovraindebitamento (unificando, ad esempio, il piano del marito e della moglie in un solo procedimento), quando i debiti abbiano un’origine comune o i familiari siano conviventi.
Di seguito, analizziamo nel dettaglio ciascuna di queste soluzioni.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il piano del consumatore – oggi denominato dal CCII “procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore” (artt. 67-73 CCII) – è lo strumento pensato per i debitori civili e i consumatori, cioè individui che hanno debiti derivanti da esigenze personali o familiari, non legati ad attività d’impresa. Si tratta dell’equivalente aggiornato del “piano del consumatore” introdotto dalla Legge 3/2012. Vediamone le caratteristiche salienti dal punto di vista del debitore:
- Natura e contenuto della proposta: Il consumatore sovraindebitato, con l’assistenza dell’OCC, può proporre ai creditori un piano che prevede specificamente tempi e modalità di rimborso dei debiti, anche in forma parziale e differenziata tra i creditori. Il contenuto del piano è libero: può prevedere qualunque forma di soddisfacimento dei creditori, come ad esempio pagamenti rateali, stralcio di parte dei crediti (remissione parziale), conversione dei debiti in altre obbligazioni, vendita di alcuni beni con distribuzione del ricavato, mantenimento di mutui in essere ecc. Ad esempio, un consumatore con debiti totali per €100.000 potrebbe proporre di pagarne €40.000 nell’arco di 5 anni, liberando così il restante 60%. Non vi sono soglie di pagamento minimo fissate per legge: il piano può prevedere anche una soddisfazione parziale significativa, purché sia sostenibile per il debitore e più conveniente per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Mancanza di voto dei creditori: Peculiarità fondamentale del piano del consumatore è che non richiede l’approvazione preventiva dei creditori. Diversamente dai concordati o accordi, qui i creditori non votano sul piano. Sarà il Tribunale a valutare d’ufficio la proposta e, in caso di esito positivo della valutazione, ad omologare il piano rendendolo obbligatorio per tutti i creditori. Ciò rende questa procedura molto vantaggiosa dal punto di vista del debitore: non occorre cercare il consenso (spesso difficile) di una maggioranza di creditori, ma è sufficiente convincere il giudice della fattibilità e meritevolezza della soluzione. In pratica, dunque, anche se alcuni creditori fossero contrari perché subiscono una decurtazione del credito, il giudice può ugualmente omologare il piano ed essi saranno comunque vincolati ad accettare quanto previsto (subiranno la falcidia del credito, ma in modo legittimo e definitivo). Attenzione: l’assenza di voto non significa che il punto di vista dei creditori sia ignorato: essi possono comunque far pervenire osservazioni o opposizioni al piano, e in sede di omologazione il tribunale dovrà tenere conto di eventuali contestazioni – ad esempio un creditore potrebbe eccepire che il piano lo danneggia e non è conveniente rispetto alla liquidazione. Tuttavia, la decisione finale spetta al giudice.
- Requisito di meritevolezza: Per l’omologazione del piano del consumatore, la legge richiede espressamente che il giudice valuti la meritevolezza del debitore. In base all’art. 69 CCII, il tribunale verifica che il consumatore non abbia assunto volontariamente obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che non abbia colposamente determinato il proprio indebitamento oltre ogni capacità di rimborso. In pratica, si scruta la storia finanziaria e personale del debitore per capire se la situazione di insolvenza è frutto di eventi sfortunati indipendenti dalla sua volontà (perdita del lavoro, malattia, crisi economica generale, fideiussioni escusse, ecc.) oppure di condotta gravemente imprudente o scorretta (es. ricorso al credito per spese voluttuarie sproporzionate, gioco d’azzardo compulsivo, frodi). Se emerge dolo, malafede o colpa grave, l’accesso al piano è precluso. Il concetto di “colpa grave” è meno stringente del dolo: ad esempio, un consumatore che abbia accumulato debiti per investimenti finanziari ad alto rischio e scopo speculativo, poi risultati fallimentari, potrebbe essere ritenuto non meritevole di una protezione; al contrario, l’eccessivo indebitamento derivante da circostanze sfortunate ma affrontate con trasparenza (es. sovraindebitamento causato da garantire debiti altrui, o dal dover mantenere familiari in difficoltà, ecc.) non inficia la meritevolezza. La giurisprudenza recente ha ulteriormente sottolineato che la meritevolezza va valutata in concreto con equilibrio, senza punire oltremisura errori veniali del debitore, ma sanzionando chi ha tenuto comportamenti dolosi. Ad esempio, Cass. 22900/2023 (procedura ex L.3/2012) ha evidenziato che la nozione di meritevolezza serve a escludere chi abbia colpe qualificabili come dolo o frode, non il semplice indebitamento derivante da scelte di vita discutibili ma non fraudolente. In ogni caso, la relazione dell’OCC accompagna il piano proprio con un giudizio sulle cause dell’indebitamento e sul grado di diligenza del debitore nel determinarlo, fornendo al giudice gli elementi per valutare la meritevolezza.
- Fattibilità e convenienza: Oltre alla meritevolezza, il tribunale deve verificare che il piano offra concrete garanzie di fattibilità e convenienza rispetto alla liquidazione. La fattibilità attiene alla sostenibilità finanziaria del piano: le risorse promesse (redditi futuri, contributi di terzi, realizzo di beni messi in vendita, ecc.) devono essere realistiche. Il giudice si avvale anche di un’attestazione di fattibilità predisposta dall’OCC. La convenienza significa, come detto, che ai creditori deve essere assicurato un trattamento non deteriore di quello che avrebbero ottenuto liquidando i beni del debitore. Questo implica, ad esempio, che se un creditore ha garanzia reale (ipoteca su un immobile), il piano non può proporgli di ricevere meno del valore ricavabile dall’eventuale vendita di quell’immobile in liquidazione. La Cassazione ha ribadito che va sempre effettuato un giudizio comparativo: il piano è omologabile solo se migliorativo o almeno non peggiorativo per i creditori rispetto all’alternativa del concorso generale. Una pronuncia importante, la Cass. 4613/2023, ha proprio cassato l’omologazione di un accordo (ex L.3/2012) che prevedeva una falcidia di un creditore ipotecario senza garantirgli il valore di realizzo del bene dato in garanzia, affermando il principio che il creditore ipotecario non può essere pregiudicato – deve ricevere almeno quanto conseguirebbe dalla vendita forzata del cespite gravato. Nei piani del consumatore, questa valutazione spetta al giudice in sede di omologa, essendo assente il voto dei creditori: se il piano non supera il test di convenienza per i creditori, l’omologazione sarà rifiutata.
- Procedimento e omologazione: Il consumatore avvia la procedura depositando il ricorso presso l’OCC o direttamente al Tribunale (in alcuni tribunali è ammesso il deposito tramite l’OCC stesso). Al ricorso vanno allegati tutti i documenti indicati dalla legge, tra cui: l’elenco completo di tutti i creditori e degli importi dovuti, l’elenco del patrimonio, l’indicazione di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, le ultime dichiarazioni dei redditi, e un piano dettagliato con la proposta di ristrutturazione. L’OCC elabora la relazione particolareggiata (art. 68 CCII) e la trasmette al tribunale assieme alla proposta di piano. Una volta valutata l’ammissibilità (assenza delle cause ostative come procedure pendenti, dolo, ecc.), il Tribunale fissa un’udienza. Nel frattempo, può emettere provvedimenti urgenti di sospensione delle azioni esecutive. All’udienza, i creditori e l’OCC possono esporre eventuali osservazioni. Se non vi sono opposizioni rilevanti, o comunque se il giudice ritiene soddisfatti i requisiti (meritevolezza, fattibilità, convenienza), omologa il piano con decreto. Il decreto di omologa viene comunicato o notificato alle parti; da tale momento il piano diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori.
- Impugnazioni: Contro il decreto di omologa (o di diniego di omologa) è ammesso il reclamo al tribunale o corte d’appello competente, entro il termine perentorio di 15 giorni (vecchia L.3/2012) o 30 giorni (nuove disposizioni CCII dopo correttivi). Occorre precisare che, secondo la Cassazione n.34158/2024, se il decreto di omologa non è stato né notificato né comunicato, il termine di reclamo è quello lungo di 6 mesi ex art.327 c.p.c., non trovando applicazione analogica il termine breve di 10 giorni dell’art.26 l.fall.. In altri termini, la Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di notifica del provvedimento, il reclamo può essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione dell’omologa, per garantire ai creditori un adeguato lasso di tempo per attivarsi. Questa pronuncia tutela i creditori (specialmente quelli eventualmente rimasti ignari) evitando decadenze troppo brevi; d’altronde il Correttivo ter ha reso più chiara la disciplina delle impugnazioni, sancendo espressamente la reclamabilità dei decreti di inammissibilità e coordinando i termini con le norme generali. Infatti oggi anche un decreto che dichiara inammissibile una proposta (senza esaminarla nel merito) è reclamabile, e la legge puntualizza che tale provvedimento non preclude al debitore di ripresentare una nuova proposta corretta. La Cassazione (sent. n.30542/2024) ha confermato che un provvedimento di mera inammissibilità non ha natura decisoria su diritti e dunque non è ricorribile per Cassazione, ma il debitore può proporre reclamo e soprattutto può riprovare con un nuovo piano modificato. Ciò rafforza l’idea che l’ordinamento favorisca una seconda chance: il debitore non viene bloccato al primo errore di formulazione del piano, ma può presentare una proposta migliorativa per ottenere l’omologa.
- Effetti dell’omologazione: Con l’omologa, il piano diviene vincolante per tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore. Ciò significa che: (i) eventuali procedure esecutive individuali in corso sono definitivamente bloccate e sostituite dall’adempimento secondo il piano; (ii) i creditori non possono iniziare nuove azioni esecutive o cautelari; (iii) i pagamenti e gli atti dispositivi devono essere effettuati secondo le modalità e i tempi previsti dal piano, sotto la supervisione dell’OCC o del liquidatore nominato (se il piano prevede la liquidazione di beni, il tribunale nomina un liquidatore ad hoc). Il debitore in sostanza mantiene i beni non destinati al piano e continua la propria vita economica, dovendo però rispettare rigorosamente gli obblighi di pagamento fissati. Un aspetto notevole: se il piano prevede che il debitore continui a pagare regolarmente le rate di un mutuo ipotecario in corso (senza falcidiare il credito garantito), è possibile mantenere ad es. la propria casa senza venderla, a differenza di quanto accadrebbe in una liquidazione. La legge consente che il piano disponga la moratoria fino a 1 anno per iniziare a pagare i crediti privilegiati e anche la continuazione del pagamento delle rate a scadere di mutui, purché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori chirografari (in pratica l’importo delle rate moratorie deve essere conteggiato ai fini della convenienza). La Cassazione n.34150/2024 ha giudicato ammissibile che un piano del consumatore preveda una moratoria nel pagamento dei crediti ipotecari anche oltre l’anno dall’omologa, a condizione che sia garantito il regolare pagamento degli interessi nel frattempo e che il differimento non leda i diritti del creditore.
- Adempimento del piano ed esdebitazione: Il debitore deve quindi eseguire il piano omologato, sotto vigilanza. Al termine dell’esecuzione, se egli ha adempiuto tutte le obbligazioni come stabilito (ad esempio ha pagato le somme promesse ai vari creditori), è liberato da tutti i debiti residui anteriori. L’esdebitazione in questo caso è un effetto automatico: avendo i creditori accettato o subito la falcidia e i pagamenti parziali previsti, non possono pretendere oltre. Il decreto di omologa stesso fa stato dell’effetto esdebitatorio a fine procedura. Se alcuni creditori non vengono integralmente soddisfatti (come previsto), la parte di credito eccedente è cancellata e diviene inesigibile. In sintesi, completando il piano, il debitore ottiene la cancellazione definitiva dei debiti pregressi (salvo quelli eventualmente esclusi per legge dall’esdebitazione, come le obbligazioni alimentari, le sanzioni penali pecuniarie o i debiti per risarcimento da fatti illeciti, che rimangono comunque dovuti anche dopo).
- Inadempimento del piano: Se invece il debitore non rispetta le obbligazioni del piano (ad esempio salta delle rate importanti senza giustificazione), il Tribunale – su istanza dei creditori – può dichiarare la risoluzione del piano. La risoluzione fa venir meno l’efficacia del piano e fa rivivere i debiti originari al netto di quanto eventualmente già pagato. In tal caso, il debitore perde la protezione: i creditori potranno riprendere le azioni esecutive individuali per recuperare i loro crediti, dedotto l’importo incassato in conto piano. È anche possibile, a questo punto, che il debitore chieda l’apertura di una liquidazione controllata come extrema ratio, per cercare comunque l’esdebitazione (magari fruendo del fatto che parte del debito è stato ridotto dai pagamenti parziali già fatti). Il CCII consente la conversione di un piano non eseguito in liquidazione controllata a richiesta del debitore, purché ne ricorrano i presupposti (in pratica se sopravviene l’insolvenza nell’esecuzione del piano). Questa possibilità costituisce una rete di sicurezza per il debitore: se il piano si rivela non sostenibile per circostanze sopravvenute, il debitore onesto può comunque accedere alla liquidazione e non perde del tutto la chance di esdebitazione (anche se, chiaramente, in liquidazione perderà i beni non ancora liquidati e dovrà sottostare ad una procedura concorsuale completa).
Esempio pratico – Piano del consumatore: Mario, privato cittadino, ha debiti per 60.000€ (20.000€ di finanziamenti personali insoluti, 15.000€ di debiti verso fornitori per una passata attività artigianale cessata, 5.000€ di bollette arretrate, 20.000€ di cartelle esattoriali per multe e tributi locali). Mario è proprietario con il coniuge della casa di abitazione gravata da mutuo ipotecario residuo di 80.000€ (rate regolari) e percepisce uno stipendio netto di €1.600 mensili. Con l’aiuto dell’OCC, Mario elabora un piano che prevede: mantenimento del mutuo con regolare pagamento delle rate (quindi la casa e l’ipoteca restano fuori dal piano attivo, continuando a pagare la banca); pagamento ai restanti creditori di €400 al mese per 5 anni, da ripartire proporzionalmente tra tutti (per un totale di €24.000 pagati). Ciò comporta una soddisfazione del 40% circa dei debiti chirografari. L’OCC attesta che il piano è fattibile (Mario può destinare €400/mese, conservando il minimo per il mantenimento familiare) e che, in una liquidazione della casa, i creditori chirografari non riceverebbero nulla (poiché la casa è in comproprietà e gravata da ipoteca capiente). Il Tribunale, riscontrata la meritevolezza (Mario si è indebitato per far fronte a spese familiari, senza condotte fraudolente) e la convenienza (il 40% è comunque meglio dello zero di un fallimento personale, e nessun creditore viene trattato peggio di così), omologa il piano. Mario esegue puntualmente i pagamenti mensili per 5 anni. Al termine, i creditori chirografari hanno incassato parte dei loro crediti e non possono più pretendere il residuo 60% impagato, che viene cancellato. Mario esce così dal sovraindebitamento, liberando il proprio stipendio da pignoramenti e potendo continuare a pagare il mutuo della casa come previsto originariamente.
Concordato minore
Il concordato minore (disciplinato dagli artt. 74-83 CCII) è la procedura di composizione negoziata della crisi riservata ai debitori non consumatori, cioè a coloro i quali i debiti derivano in prevalenza da un’attività d’impresa, commerciale o professionale. È l’evoluzione di quello che, sotto la Legge 3/2012, si chiamava “accordo di composizione della crisi”. Il termine “concordato” evidenzia l’analogia con il concordato preventivo delle imprese maggiori, sebbene qui in dimensione “minore” (per soggetti di minori dimensioni) e con alcune peculiarità. Dal punto di vista del debitore sovraindebitato imprenditore/professionista, ecco i punti chiave:
- Soggetti ammessi: Possono proporre un concordato minore gli imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale (fallimento) perché di dimensioni sotto soglia, nonché i soggetti non commerciali (professionisti, enti non profit) e in genere chiunque non sia “consumatore” e abbia debiti da attività economica. Importante: il CCII esclude espressamente che il consumatore utilizzi il concordato minore, perché per il consumatore c’è il suo piano dedicato. D’altro canto, se un soggetto ha una posizione “promiscua” (debiti sia personali sia da attività d’impresa cessata), la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile il concordato minore come soluzione unitaria. Ad esempio, un artigiano che ha chiuso bottega ma si ritrova debiti professionali e debiti personali potrà avvalersi del concordato minore (purché non qualificabile come consumatore puro). La riforma 2024 ha confermato però che l’imprenditore individuale cancellato dal registro imprese, dunque che ha cessato completamente l’attività, non può accedere al concordato minore. Nella pratica, ciò significa che l’ex imprenditore con debiti residui potrà comunque fare un concordato minore solo se prevede un apporto di risorse esterne (vedi oltre) o, in mancanza, dovrà optare per la liquidazione controllata. Infatti, il Codice prevedeva già che se l’attività non prosegue, il debitore può proporre concordato minore solo a condizione di apportare risorse esterne aggiuntive a beneficio dei creditori.
- Continuità aziendale vs cessazione: Il concordato minore può avere due forme: con prosecuzione dell’attività o con cessazione. Se il debitore intende continuare l’attività imprenditoriale o professionale, il concordato minore è uno strumento per ristrutturare i debiti mantenendo in vita l’azienda (simile a un piccolo concordato preventivo in continuità). In tal caso, la proposta di concordato avrà un piano industriale alla base: tempi e modalità per superare la crisi, riorganizzando l’impresa e pagando i creditori in misura parziale o dilazionata, ma evitando la liquidazione. Se invece il debitore non prevede di continuare l’attività, ossia se è destinato a cessare, allora la legge – come accennato – consente comunque il concordato minore ma solo con l’apporto di risorse esterne significative. Ciò significa che il debitore, ad esempio, fa intervenire un terzo (un familiare, un investitore) che immette nuova finanza o beni da destinare ai creditori, in modo da aumentare l’attivo disponibile in maniera apprezzabile rispetto a quanto si otterrebbe liquidando i beni già esistenti. Questa condizione è pensata per evitare concordati “liquidatori” mascherati, in cui non c’è reale differenza con la liquidazione se non a vantaggio del debitore. In presenza di risorse esterne, invece, i creditori hanno un motivo per preferire il concordato (incassano di più di quanto ricaverebbero dal solo patrimonio del debitore).
- Contenuto della proposta e classi: La proposta di concordato minore, similmente al piano del consumatore, può prevedere qualsiasi forma di soddisfacimento dei crediti, anche parziale, inclusa la ristrutturazione dei debiti, dilazioni, stralci, ecc.. L’importante è che descriva in modo dettagliato come il debitore intende superare la crisi e con quali risorse pagherà i creditori. Non vi è un pagamento minimo stabilito ex lege (ad es. non esiste più l’obbligo di pagare almeno il 20% ai chirografari come nel vecchio concordato preventivo, obbligo peraltro eliminato anche lì). Tuttavia, dovrà comunque essere rispettato il test di convenienza: nessun creditore può ricevere meno di quanto avrebbe in liquidazione. Nella proposta, il debitore può suddividere i creditori in classi se opportuno (per trattare in modo differenziato creditori con posizioni giuridiche omogenee o interessi economici similari). Ad esempio, potrebbe classare separatamente i fornitori strategici (per pagarli magari in percentuale maggiore, essendo importanti per la prosecuzione dell’attività) oppure i creditori privilegiati da quelli chirografari. La formazione di classi nel concordato minore non è obbligatoria ma facoltativa; qualora vi siano classi, ciascuna voterà separatamente (servirà la maggioranza in ogni classe, salvo eventuale cram-down giudiziale se previsto per dissenso di classi minoritarie: il CCII consente l’omologazione anche con il voto contrario di classi dissenzienti se la proposta li soddisfa comunque meglio della liquidazione, ma questo aspetto è più raro nel concordato minore, applicandosi di norma la semplice regola della maggioranza sul totale crediti votanti).
- Voto dei creditori: A differenza del piano del consumatore, il concordato minore richiede l’approvazione dei creditori. In particolare, è necessario il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La maggioranza è calcolata per valore (somme dovute) e non per teste. Si considerano solo i voti espressi: il silenzio equivale a voto negativo? In base alla disciplina generale del concordato, il mancato voto entro il termine è considerato dissenso (nel concordato preventivo lo era); nel CCII per il concordato minore si applicano in quanto compatibili le norme del concordato preventivo, dunque i creditori sono convocati o consultati e hanno un termine per esprimersi, trascorso il quale chi non ha votato si intende contrario. Occorre ottenere oltre il 50% del totale dei crediti votanti (escludendo quelli non aventi diritto di voto, come i correlati o postergati). Nota: I creditori privilegiati (p.es. ipotecari) votano solo se la proposta ne prevede un pagamento non integrale o alterazioni dei loro diritti. Se un creditore privilegiato è soddisfatto integralmente (o viene lasciato estraneo, come una banca mutuante che continua a essere pagata fuori piano), di regola non ha voto in quanto non incide la proposta sui suoi diritti. Questo dettaglio è importante: spesso per facilitare l’approvazione, il debitore può decidere di non falcidiare alcuni privilegiati, così da escluderli dal voto (ma deve essere in grado di pagarli fuori dalla procedura). Ad esempio, il concordato potrebbe lasciare intatto il debito ipotecario verso la banca continuando a pagare le rate: la banca in tal caso, ricevendo il 100% sia pure dilazionato, non avrebbe diritto di voto. Cassazione n.30538/2024 ha ribadito che nel caso di crediti tributari la legittimazione al voto spetta all’Ente impositore (Agenzia delle Entrate) e non all’agente della riscossione. Dunque, in presenza di debiti fiscali, il piano deve prevedere l’eventuale transazione fiscale (stralcio o dilazione dei tributi) e in sede di voto si esprimerà l’Erario. La mancata indicazione del privilegio in sede di voto da parte del creditore privilegiato non implica rinuncia: un creditore che non dichiari di essere ipotecario al momento del voto non perde tale qualifica e può opporsi in omologazione se il piano omologato lo pregiudica.
- Procedimento di approvazione e omologa: Il debitore presenta il ricorso per concordato minore presso l’OCC/Tribunale, allegando il piano e la relazione dell’OCC (art. 76 CCII). Il giudice verifica i requisiti e, se la proposta è ammissibile, ordina che l’OCC la comunichi ai creditori perché esprimano il loro voto entro un termine. La votazione può avvenire per via cartolare (con espressione del voto per iscritto via PEC) oppure in adunanza dei creditori convocata dal giudice (modalità decisa dal Tribunale). Raggiunta la maggioranza richiesta, il Tribunale fissa l’udienza di omologazione. In tale fase, i creditori dissenzienti o esclusi dal voto possono proporre opposizione contestando l’omologa (ad es. eccependo la mancanza dei requisiti di legge o la lesione dei propri diritti). Il giudice, se accerta che: (i) la procedura è regolare, (ii) c’è la maggioranza di legge, (iii) la proposta è fattibile e conveniente, (iv) il debitore meritevole (non ha compiuto atti in frode, ecc.), omologa il concordato minore con decreto motivato. Può anche omologare nonostante il voto contrario di creditori muniti di prelazione, purché siano soddisfatti almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione. Questa è una forma di cram-down prevista dall’art. 80 CCII: il giudice può superare il dissenso di creditori privilegiati o pubblici se ritiene la proposta equilibrata e più vantaggiosa per loro rispetto all’alternativa liquidatoria (sostanzialmente applicando il best interest test). In ogni caso, se un creditore privilegiato ha espresso voto contrario ed è previsto che riceva meno del suo intero credito, l’omologa richiede che il piano gli assicuri almeno quanto il valore di mercato del bene su cui ha garanzia (principio già sottolineato da Cass. 4613/2023 sopra citata). Se tale condizione non fosse rispettata, il tribunale non omologherebbe, in quanto il creditore garantito sarebbe pregiudicato.
- Impugnazioni: Contro il decreto di omologa del concordato minore è ammesso reclamo (entro 30 giorni) in Corte d’Appello, analogamente al concordato preventivo, da parte dei creditori dissenzienti. Anche qui vale quanto detto sulla Cassazione: se il decreto non è notificato, termine lungo ex art.327 c.p.c.. Un provvedimento di diniego di omologa o di inammissibilità della proposta è parimenti reclamabile. La Cassazione 22797/2023 ha statuito che è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che decide sul reclamo in materia di omologa di accordo ex L.3/2012, chiarendo quindi i rimedi processuali anche in questi casi.
- Effetti dell’omologa: Una volta omologato, il concordato minore diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori, analogamente al piano del consumatore. L’art. 81 CCII dispone che i creditori anche non votanti sono vincolati dai termini del concordato omologato, subendo le eventuali riduzioni o dilazioni ivi previste. Tutte le azioni esecutive individuali restano vietate (divieto già operante dalla fase di ammissione: l’apertura della procedura sospende i pignoramenti in corso). Il debitore prosegue l’attività se previsto in continuità sotto il regime del piano, oppure, se è un concordato liquidatorio con apporto di terzi, si procederà alla liquidazione dei beni promessi in vendita secondo il piano (di solito svolta dal liquidatore nominato). In generale, durante l’esecuzione del concordato, il patrimonio del debitore è sotto controllo: i beni che il piano destina alla soddisfazione dei creditori vengono liquidati o gestiti secondo quanto stabilito, e il debitore non ne ha libera disponibilità fino a completa esecuzione. Se l’attività continua, spesso il piano prevede che il debitore mantenga la gestione sotto la supervisione dell’OCC, con obbligo di destinare ai creditori gli utili concordati.
- Adempimento ed esdebitazione: Compiuta l’esecuzione del concordato minore, il debitore ottiene l’integrale esdebitazione dai debiti concorsuali residui. Anche qui l’effetto è automatico: i creditori, avendo accettato (o subìto per effetto dell’omologa) una certa soddisfazione parziale, non possono più pretendere la differenza. Ad esempio, se un creditore chirografario aveva €10.000 e dal concordato ha ricevuto il 30% (€3.000), i restanti €7.000 sono cancellati definitivamente. Il tribunale emette il decreto di chiusura attestando che il concordato è stato correttamente eseguito e che il debitore è libero dai debiti pregressi.
- Risoluzione per inadempimento: Se però il debitore non adempie alle obbligazioni assunte nel concordato, ciascun creditore può chiedere al Tribunale la risoluzione del concordato (art. 82 CCII). È necessario che l’inadempimento sia grave (ad esempio, mancato pagamento di una percentuale rilevante del dovuto, o violazione di obblighi essenziali). Una volta pronunciata la risoluzione, gli effetti dell’omologa cessano: i creditori riacquistano il diritto per l’intero credito originario, detratto solo quanto eventualmente ricevuto a titolo di acconto. Tuttavia, i creditori privilegiati conservano quanto eventualmente incassato e rientrano nei limiti del loro credito residuo. Dopo la risoluzione, il debitore può trovarsi esposto nuovamente alle azioni individuali oppure può valutare di accedere alla liquidazione controllata (spesso la risoluzione del concordato minore conduce alla liquidazione concorsuale, come valvola di sfogo). Il CCII prevede che, se vi è risoluzione o annullamento del concordato minore, il tribunale possa su istanza del debitore aprire la liquidazione controllata ex officio (per evitare un vuoto di tutela).
Esempio pratico – Concordato minore in continuità: Alfa è una piccola impresa artigiana (ditta individuale) con 300.000€ di debiti: 50.000€ verso dipendenti e INPS (privilegiati), 100.000€ verso banca con ipoteca su laboratorio, 150.000€ chirografari (fornitori, ecc.). L’attivo è: laboratorio del valore stimato 120.000€, macchinari 30.000€, credito d’imposta 20.000€, più l’avviamento dell’attività. Alfa vuole evitare di chiudere; presenta un concordato minore proponendo: continuare l’attività per 5 anni, periodo in cui genererà flussi per pagare integralmente i dipendenti e contributi (50.000€ in 5 anni), pagare la banca ipotecaria al 70% (70.000€ dilazionati in 5 anni, garantendo che il valore attuale del laboratorio è circa 120.000€ ma realizzabile in liquidazione forse 100.000 al netto oneri, quindi banca accetta 70%), e pagare i chirografari al 20% (30.000€ in 5 anni) liberando il resto. Per far ciò, Alfa prevede di ottenere nuova finanza: un parente investe 30.000€ subito per liquidità di start. La proposta è articolata in classi: dipendenti/INPS (classe A, 100%); banca (classe B, 70%); chirografari (classe C, 20%). I creditori votano: classe A vota sì (ovviamente, avendo 100%); classe B (banca) vota sì preferendo 70% al rischio d’asta; classe C – supponiamo il 60% in valore vota sì, 40% no (i fornitori realisticamente preferiscono 20% a zero). Si raggiunge comunque la maggioranza (es. 60% su totali chirografari). Il tribunale omologa: risulta che nessuno prende meno che in liquidazione (in liquidazione ipotizzando vendita forzata del laboratorio e beni, forse i chirografari avrebbero zero, qui hanno 20%). Alfa esegue il piano: continua a lavorare, paga stipendi correnti e quote di riparto ai creditori secondo scadenze concordate. L’OCC sorveglia i flussi. Dopo 5 anni, Alfa ha onorato il piano: dipendenti e INPS saldati, banca incassato 70k (il residuo 30k di ipotecario è stralciato), fornitori incassato 20% (il restante 80% = 120k è cancellato). L’azienda ha superato la crisi e prosegue l’attività libera dai debiti vecchi.
Esempio pratico – Concordato minore con cessazione e risorse esterne: Beta è un ex imprenditore che ha cessato l’attività commerciale, con debiti per 200.000€ (in parte fiscali e verso fornitori). Non possiede immobili, solo beni mobili di modesto valore. Un familiare è disposto a mettere 20.000€ per aiutarlo. Beta propone un concordato minore liquidatorio: si impegna a versare ai creditori quei 20.000€ come soddisfazione complessiva (pari a un 10% dei debiti) in tempi brevi. Divide i creditori in due classi: Erario (100.000€ di cui 50.000 di IVA, privilegio ex art. 2752 c.c.) e chirografari (100.000). Offre al Fisco il pagamento del 5% sui crediti privilegiati e del 0% su IVA? Attenzione: l’IVA non può essere falcidiata integralmente in un concordato salvo la transazione fiscale approvata; supponiamo Beta offra 10% sull’IVA e 10% sugli altri. I creditori votano: l’Agenzia delle Entrate (unica nella classe Erario) accetta la transazione al 10% (ipotesi), i chirografari votano in maggioranza sì perché prendono 10% piuttosto che nulla. Il tribunale, verificato che Beta non ha agito con dolo (ha chiuso per crisi di mercato) e che la soddisfazione è maggiore di quanto avrebbero (se Beta facesse liquidazione controllata probabilmente ricaverebbero quasi zero, qui c’è il contributo terzo di 20k), omologa. Beta (tramite il familiare) versa i 20.000€ all’OCC che li distribuisce pro-quota ai creditori come da piano. Beta ottiene l’esdebitazione per i restanti ~180.000€. (Nota: un concordato di questo tipo “misto liquidatorio” è ammissibile solo grazie all’apporto esterno, sennò Beta avrebbe dovuto fare la liquidazione controllata; di fatto qui la differenza è sottile perché Beta ha comunque messo tutto quel che poteva – nulla di proprio salvo il contributo di terzi – ma la procedura concordataria ha permesso la chiusura più rapida dell’insolvenza con il consenso dei creditori).
Liquidazione controllata del sovraindebitato
La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura concorsuale liquidatoria riservata al debitore sovraindebitato. È l’analoga, per i non fallibili, della liquidazione giudiziale (ex fallimento) delle imprese maggiori e corrisponde alla “liquidazione del patrimonio” prevista dalla Legge 3/2012, ora integrata e rinominata. Si ricorre alla liquidazione controllata quando non è praticabile o non ha successo una soluzione di accordo (piano del consumatore o concordato minore), oppure quando il debitore stesso preferisce questa strada per liberarsi dei debiti cedendo ai creditori tutto il proprio patrimonio disponibile. Dal punto di vista del debitore, la liquidazione presenta pro e contro:
Vantaggi per il debitore:
- È una procedura che porta comunque (se il debitore coopera lealmente) alla esdebitazione, quindi alla cancellazione dei debiti residui. Anzi, nel CCII è prevista un’esdebitazione “automatica” dopo 3 anni dall’apertura della liquidazione per il debitore persona fisica meritevole. Ciò significa che il debitore persone fisica otterrà di diritto la liberazione dai debiti insoddisfatti trascorsi tre anni dall’apertura della procedura, anche se la liquidazione dei beni non si fosse ancora conclusa in quel momento (il tribunale emette un decreto formale di esdebitazione al compimento del triennio, previa verifica del comportamento del debitore). Questo termine triennale è più breve di quello previsto dalla vecchia legge (quattro anni). Dunque la liquidazione offre un percorso temporizzato verso il fresh start.
- Consente di gestire in modo ordinato e unitario l’intero patrimonio e i debiti, sospendendo tutte le azioni individuali. Da subito, con l’apertura della liquidazione, scatta il divieto di azioni esecutive o cautelari individuali su tutti i beni del debitore. Il debitore non è più assillato da pignoramenti multipli: i creditori devono presentare le loro domande nello stato passivo della liquidazione.
- È accessibile anche quando un piano o accordo non sarebbe approvabile (perché il debitore non ha entrate sufficienti per offrire un pagamento parziale apprezzabile, o i creditori non sarebbero collaborativi). In liquidazione non serve il consenso dei creditori: è un procedimento giudiziario che si apre su istanza del debitore (o eccezionalmente anche di creditori o del PM, ma nella sovraindebitamento classico di regola è volontario) e prosegue d’ufficio.
- Permette al debitore di espiare i propri debiti cedendo tutto ciò che ha, ma salvaguardando i beni impignorabili e lasciandolo con il minimo vitale. La legge infatti esclude dalla liquidazione i beni e crediti impignorabili per legge (es. stipendi nei limiti di legge, beni di stretta necessità, pensioni minime, ecc. – art. 268 richiama le norme sulle impignorabilità).
- Se il debitore persona fisica non ha nulla o quasi da liquidare, comunque può ottenere l’esdebitazione (in tal caso potrebbe valutare direttamente la procedura di debitore incapiente, v. oltre). In altre parole, la liquidazione può avere un fine essenzialmente “esdebitatorio” più che distributivo: i creditori magari non prendono nulla se il debitore è nullatenente, ma il debitore esce comunque dalla spirale debitoria.
Svantaggi e oneri per il debitore:
- La liquidazione comporta la spoliazione del patrimonio: tutti i beni del debitore (presenti al momento dell’apertura) vengono destinati ai creditori, con l’affidamento a un Liquidatore giudiziale che li amministrerà e venderà. Il debitore perde la disponibilità dei suoi beni sin dalla dichiarazione di apertura (effetto analogo al fallimento). Ciò include, attenzione, anche i beni sopravvenuti durante la procedura, cioè quelli che il debitore potrebbe acquisire prima della chiusura della liquidazione (es. eredità, vincite). L’art. 142 CCII, applicabile, prevede infatti che rientrano nell’attivo anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura. Su questo punto si è posta però una questione: per quanto tempo dopo l’apertura rimangono acquisibili i sopravvenienti? La vecchia L.3/2012 fissava un limite di 4 anni dal deposito della domanda (art. 14-undecies L.3/2012). Il nuovo CCII non aveva inizialmente fissato un termine esplicito, generando il dubbio se i beni sopravvenuti fossero catturati sine die. La Corte Costituzionale con la sentenza n.6/2024 ha affrontato proprio la legittimità di questa mancanza di limite temporale. Il Tribunale di Arezzo aveva sollevato questione di costituzionalità lamentando che l’assenza di un termine potesse portare a liquidazioni di durata indefinita, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo e di uguaglianza rispetto ai procedimenti ante CCII (dove c’era il limite 4 anni). La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato non fondate le censure (sent. 6/2024), ritenendo che spetti al legislatore l’eventuale introduzione di un termine e che l’interprete può nel frattempo ancorare la durata all’orizzonte del conseguimento dell’esdebitazione (ossia 3 anni) o comunque evitare durate irragionevoli caso per caso. In pratica, ad oggi, la prassi è di considerare che dopo l’esdebitazione di diritto a 3 anni, eventuali beni sopravvenuti non vadano oltre quel termine se non già compresi nel programma. E infatti alcuni tribunali (es. Trib. Savona 23.1.2025) hanno ritenuto ammissibile che la liquidazione possa proseguire oltre il triennio solo per completare la liquidazione di beni già acquisiti, ma non per catturare nuove utilità ulteriori. Il debitore deve essere consapevole che, dall’apertura e fino alla chiusura o almeno fino all’esdebitazione, i suoi sopravvenuti reddituali (stipendi, ecc. oltre il necessario per il mantenimento) possono essere in parte prelevati dal liquidatore per i creditori.
- La liquidazione è un percorso più invasivo e “stigmatizzante”: sebbene non vi sia più il termine infamante “fallito”, di fatto il debitore subisce conseguenze simili al fallimento. Ad esempio, la sentenza di apertura viene pubblicata e comunicata, i creditori si insinuano come in un fallimento, il debitore può essere interrogato sulle cause dell’insolvenza, deve consegnare libri e documenti, etc. Inoltre, tutti i contratti pendenti del debitore possono essere sciolti o fatti proseguire dal liquidatore, con possibili impatti (ad esempio un contratto di locazione: il liquidatore può scioglierlo se inutile, lasciando però il debitore conduttore a rispondere in prededuzione dei danni).
- Durata della procedura: La liquidazione controllata può durare diversi anni, a seconda della complessità dell’attivo da liquidare. Pur prevedendo l’esdebitazione dopo 3 anni, ciò non chiude automaticamente la procedura: il liquidatore può proseguire oltre per completare vendite e riparti, se l’attivo lo richiede (la Corte Cost. 6/2024 non ha imposto un termine fisso di chiusura). Quindi il debitore potrebbe trovarsi sotto procedura per più tempo, sebbene dopo 3 anni ottenga la liberazione dai debiti. Durante la procedura, la sua vita economica è sorvegliata e limitata (eventuali entrate straordinarie vanno in prededuzione spese e creditori).
- Il debitore deve comunque sostenere i costi della procedura (compenso del liquidatore e OCC, spese di giustizia), sebbene questi siano pagati in prededuzione coi fondi ricavati dall’attivo liquidato. In caso di attivo insufficiente, può talora operare il patrocinio a spese dello Stato per le spese vive: la Corte Costituzionale n.121/2024 ha infatti dichiarato illegittima la norma che non prevedeva l’ammissione del gratuito patrocinio per la procedura di liquidazione controllata priva di attivo. Ora dunque, se il giudice delegato attesta che non vi sono attivi per le spese, la procedura può essere ammessa al patrocinio statale (come avviene per i fallimenti) e le tasse di registro, contributi unificati, spese di notifica, ecc. possono essere poste a carico dello Stato. Ciò rimuove un disincentivo: un debitore nullatenente non rischia più di vedersi negata la procedura per impossibilità di pagare le spese iniziali. Rimangono eventualmente i reati in caso di frode: il debitore anche in liquidazione può incorrere nei reati di bancarotta semplice o fraudolenta (estesi pure ai soggetti sovraindebitati dal richiamo del CCII), qualora abbia distratto beni, tenuto contabilità irregolare ecc. Però per il piccolo debitore persona fisica questi casi sono rari.
Come si svolge la liquidazione controllata:
- Accesso alla procedura: La liquidazione può essere aperta su istanza del debitore sovraindebitato (modalità più frequente) oppure su istanza dei creditori o di un pubblico ministero, ma quest’ultima ipotesi è possibile solo se il debitore è un imprenditore minore e sussistono i presupposti per la liquidazione giudiziale ma è escluso da essa (art. 270 CCII). In sostanza, i creditori possono chiedere la liquidazione di un piccolo imprenditore insolvente che non abbia spontaneamente attivato procedure, analogamente a un fallimento d’ufficio, ma trattasi di situazioni eccezionali. Nella normalità, è il debitore stesso che domanda l’apertura della liquidazione controllata, magari perché non riesce a predisporre un piano fattibile. Il ricorso si presenta al Tribunale competente con l’assistenza dell’OCC (è obbligatorio farsi assistere da un OCC anche qui). Va allegata la medesima documentazione dettagliata che si richiede per un piano (elenco creditori, inventario beni, redditi, atti degli ultimi anni, ecc.), in modo da dare subito un quadro completo al giudice.
- Apertura e organi: Verificati i presupposti (stato di sovraindebitamento, competenza, assenza di atti in frode, ecc.), il Tribunale dichiara aperta la liquidazione con sentenza (anziché decreto). La sentenza di apertura viene pubblicata e notificata al debitore e creditori. Con essa, il Tribunale nomina un Giudice Delegato e un Liquidatore (che può essere lo stesso gestore OCC già nominato o altro professionista). Da quel momento: (i) il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni presenti (vengono “cristallizzati” all’attivo); (ii) gli atti dispositivi compiuti dopo l’apertura sono inefficaci; (iii) le azioni esecutive individuali sono sospese e ne è vietata l’iniziativa ex novo; (iv) tutti i creditori anteriori devono far valere i propri crediti insinuandosi nel passivo della liquidazione. Il Liquidatore predispone infatti l’invito ai creditori a presentare domanda di ammissione al passivo entro un termine. Segue la formazione dello stato passivo (come nel fallimento: verifica delle domande, riconoscimento di privilegio, ecc.) con decreto del Giudice Delegato. Da notare: l’art. 270 CCII consente, se la domanda di liquidazione è stata presentata da creditori ma poi il debitore in sede di prima udienza propone una procedura di concordato minore o piano, di sospendere la liquidazione e lasciar tentare quell’accordo. Ciò incoraggia il debitore a cercare soluzioni concordate anche all’ultimo momento per evitare la liquidazione coatta.
- Amministrazione del patrimonio: Il Liquidatore nominato redige un programma di liquidazione (entro 60 giorni) in cui elenca i beni da vendere e le modalità. Il giudice approva il programma e quindi il Liquidatore procede a liquidare l’attivo: vendere immobili (tramite procedure competitive analoghe alle aste giudiziarie), incassare crediti, proseguire eventuali cause pendenti del debitore, ecc. (agisce con i poteri del curatore fallimentare). Il debitore può collaborare e fare proposte per facilitare la liquidazione (es. trovare acquirenti). Durante la procedura, il debitore persona fisica ha diritto a mantenere una quota dei suoi redditi necessari al mantenimento suo e della famiglia (il giudice di solito fissa questa somma impignorabile caso per caso). La parte eccedente di stipendi o pensioni, invece, viene prelevata periodicamente dal liquidatore e accumulata per distribuirla ai creditori. Ad esempio, se il debitore ha uno stipendio netto di €1.500 e il giudice fissa €1.200 come necessario per il mantenimento, €300 al mese confluiranno nella massa attiva per tre anni. Per i beni immobili, il liquidatore prima di vendere notifica ai creditori ipotecari l’intenzione di vendita, in modo che siano informati (norma analoga al fallimento). La liquidazione ricade sotto la vigilanza del Giudice Delegato e di un eventuale comitato dei creditori (non sempre nominato se il caso è semplice).
- Riparto ai creditori: Una volta realizzati i beni, il Liquidatore effettua i riparti distribuendo le somme ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo. Ciò vuol dire che i creditori privilegiati vengono soddisfatti prioritariamente sul ricavato fino a concorrenza (ad es. se c’è un immobile ipotecato venduto, il ricavato va prima alle spese prededotte, poi all’ipotecario fino al suo soddisfo, eventuale residuo a altri creditori). I creditori chirografari ricevono solo se avanza qualcosa dopo tutti i privilegiati e prededucibili. In molti casi di sovraindebitamento, l’attivo può coprire solo una piccola percentuale del passivo – ed è per questo che le procedure negoziali (piani) sono interessanti, perché possono offrire ai chirografari qualcosina in più magari attingendo a redditi futuri. Ma se il debitore non dispone nemmeno di redditi per un piano, la liquidazione resta l’unica via.
- Chiusura della procedura ed esdebitazione: La liquidazione controllata si chiude quando sono terminati i riparti dell’attivo o comunque quando, a giudizio del tribunale, sono esaurite le possibili operazioni (ad es. non ci sono beni appetibili o tutti i beni venduti). La chiusura è dichiarata con decreto del tribunale. Tuttavia, prima della chiusura opera già l’esdebitazione di diritto: l’art. 282 CCII stabilisce che trascorsi 3 anni dall’apertura della liquidazione controllata, il debitore persona fisica è automaticamente esdebitato dai debiti concorsuali non soddisfatti, salvo che tale beneficio sia revocato per comportamento fraudolento. In pratica, il tribunale dopo il triennio emette un decreto di esdebitazione (salvo opposizioni di creditori per eventuali scorrettezze del debitore). Da quel momento, il debitore torna libero dai debiti, pur potendo la procedura proseguire per liquidare altri beni già acquisiti. Se per caso emergessero nuovi beni dopo l’esdebitazione? Teoricamente, post esdebitazione, i creditori non possono pretendere nulla in più, quindi anche se comparisse un bene, quel patrimonio dovrebbe tornare al debitore perché i debiti sono stati cancellati. Su questo aspetto, dottrina e giurisprudenza discutono, come accennato: c’è chi sostiene che eventuali utilità sopravvenute nel quadriennio (vecchio parametro) dall’inizio vadano comunque ai creditori fino al 10% (riprendendo l’analogia col debitore incapiente, v. infra). Ma formalmente, se l’esdebitazione è concessa, i creditori non hanno più diritti salvo l’obbligo specifico del debitore incapiente (caso distinto). Quindi dopo l’esdebitazione, il debitore può ricominciare la propria attività economica senza il fardello del passato. Ricordiamo che sono esclusi dall’esdebitazione (come nel fallimento) alcuni tipi di debito: obblighi di mantenimento e alimentari, debiti da risarcimento danni per fatti illeciti e multe, sanzioni penali o amministrative di carattere pecuniario non vengono cancellati (art. 275, richiamato da art.280 CCII, analoghi a vecchio art. 14-terdecies L.3/2012). Ad esempio, le somme dovute per alimenti all’ex coniuge, o una condanna per danni da reato, resteranno a carico del debitore anche dopo la liquidazione (i creditori potranno agire su eventuali futuri redditi per tali titoli). Tutti gli altri debiti invece sono inesigibili: il debitore non può più essere perseguito per essi e eventuali garanzie reali residue si estinguono.
Esempio pratico – Liquidazione controllata: Tizio, consumatore, ha debiti per 80.000€ (banche, finanziarie, fisco) e non è in grado di offrire un piano perché disoccupato; possiede solo un’auto usata e qualche risparmio. Tizio chiede la liquidazione controllata. Il Tribunale la apre, nomina un Liquidatore. L’auto viene venduta per 5.000€, i risparmi 3.000€ acquisiti, totale attivo 8.000€. I creditori insinuati per 80.000€ ricevono un riparto pari al 10% circa dei loro crediti. Dopo tre anni dall’apertura, Tizio – che nel frattempo ha trovato un modesto impiego – viene dichiarato esdebitato per i restanti 90% di debiti non pagati. La procedura si chiude (non avendo altri beni). Tizio è libero dai debiti pregressi e può tenersi i redditi futuri (eccetto che, poniamo, aveva 5.000€ di multa penale per reato: quella no, dovrà pagarla, essendo esclusa dall’esdebitazione). Avrà comunque subìto la perdita totale del patrimonio iniziale, ma ha riacquistato una situazione finanziaria pulita.
(Caso particolare: se Tizio durante la procedura riceve un’eredità di 10.000€ entro i 3 anni, quella somma verrà presa dal liquidatore e ripartita ai creditori, aumentando il dividendo. Se però l’eredità arriva dopo la chiusura e l’esdebitazione, essa rimane a Tizio perché ormai i debiti sono cancellati.)
Esdebitazione del debitore incapiente
Una delle più rilevanti novità introdotte nel Codice della Crisi (art. 283 CCII) è la possibilità per il debitore persona fisica sovraindebitato, meritevole e “incapiente” di ottenere l’esdebitazione senza dover prima liquidare alcun patrimonio. Si parla anche di “esdebitazione a zero” o esdebitazione del nullatenente. Questa procedura costituisce un ulteriore allargamento della seconda opportunità, pensata per chi non ha alcuna risorsa da mettere a disposizione dei creditori, neppure in prospettiva futura.
Chi può accedervi: Il debitore incapiente è definito come colui che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”. In altre parole, non possiede beni liquidabili né ha un reddito disponibile da destinare ai creditori, né prospetta miglioramenti a breve. Tipicamente potrebbe trattarsi di un disoccupato, privo di beni intestati, magari con carico di famiglia, che vive di sostegno economico altrui o redditi minimi impignorabili. Oppure di un piccolo imprenditore fallito la cui attività è azzerata e non ha nulla di intestato, con debiti pregressi ingenti. In passato, costoro non potevano beneficiare di alcuna liberazione se non dopo aver comunque aperto una procedura di liquidazione (che finiva per chiudersi senza attivo, ma intanto passavano anni). Ora, la legge consente di saltare direttamente alla fine: l’esdebitazione dell’incapiente è una procedura semplificata in cui il debitore chiede al Tribunale di essere liberato dai suoi debiti senza dover aprire concordati o liquidazioni.
Condizioni e limiti: Questa esdebitazione “immediata” è soggetta a rigorose condizioni per evitare abusi:
- Il debitore dev’essere persona fisica (non società né ente) e deve soddisfare i requisiti soggettivi generali (non fallibile, ecc.).
- Deve essere meritevole: i concetti di dolo, colpa grave, frode nella formazione dell’indebitamento si applicano a maggior ragione qui. Infatti l’art. 283 co.1 richiama la necessità della buona fede e correttezza del debitore. Chi ha colpe gravi nel sovraindebitamento non può usare questa scorciatoia.
- Non deve poter offrire nessuna utilità nemmeno indiretta ai creditori. Ciò significa ad esempio: se ha parenti disposti ad aiutarlo (utilità indiretta, come risorse di terzi) o se ha chance di reimpiego a breve, non è considerato incapiente; in tal caso meglio un piano con quell’aiuto. L’incapienza deve essere vera e assoluta. La valutazione è affidata all’OCC e al giudice caso per caso.
- Può essere richiesta una sola volta nella vita. È un “colpo” unico: se poi il debitore dovesse indebitarsi di nuovo, non potrà tornare ad avvalersene (dovrebbe semmai usare le procedure ordinarie di liquidazione o piani).
- Il beneficio è revocabile in caso di dolo o frode del debitore scoperti dopo.
Procedura: Il debitore presenta un ricorso al Tribunale (con l’assistenza OCC) spiegando la propria situazione, l’assenza di attivo utile e chiedendo l’esdebitazione. Allega, come per le altre procedure, l’elenco dei creditori e la documentazione patrimoniale, in modo da provare di non avere nulla. L’OCC redige una relazione evidenziando le cause dell’indebitamento e attestando la condizione di incapienza e meritevolezza. Il Tribunale, sentiti i creditori (che possono comparire per contestare eventualmente la sussistenza di attivo occulto), se ritiene che i presupposti siano soddisfatti, accoglie l’istanza e dichiara l’esdebitazione immediata di tutti i debiti. L’ordine di cancellazione dei debiti viene comunicato ai creditori.
Effetti e obblighi post-esdebitazione: Il debitore incapiente così ottiene in tempi rapidi (qualche mese) la liberazione dai debiti pregressi, come se avesse svolto e chiuso una liquidazione, ma senza aver pagato nulla. Tuttavia, la legge impone un vincolo: se nei 4 anni successivi al decreto di esdebitazione sopravvengono utilità rilevanti nel patrimonio del debitore, allora scatta l’obbligo di pagamento verso i vecchi creditori, fino a concorrenza di un certo importo. In particolare, se entro 4 anni il debitore beneficia di entrate o acquisti che permetterebbero di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10% del dovuto, egli deve attivarle per pagare i creditori in quella misura. Ad esempio: Caio ottiene l’esdebitazione incapiente su 100.000€ di debiti. Due anni dopo vince alla lotteria 50.000€. Poiché ciò consentirebbe di pagare almeno il 10% (in realtà il 50%) dei debiti originari, Caio ha l’obbligo legale di destinare quella somma, fino a coprire il 100% del debito o comunque almeno 10%, ai vecchi creditori. Se Caio non ottempera spontaneamente, i creditori potrebbero agire per far valere quell’obbligo (per esempio chiedendo la revoca dell’esdebitazione o l’esecuzione forzata su quelle somme). Se invece Caio nei 4 anni non ottiene nulla di significativo (come di solito per un vero nullatenente), nulla gli è richiesto e i creditori resteranno definitivamente insoddisfatti. Questo meccanismo serve a temperare il beneficio: funge da clausola di “riserva di attivo” in caso di svolte fortunate. Tetto: l’obbligo riguarda utilità tali da permettere complessivamente almeno il 10% ai creditori. Ciò evita di dover rincorrere piccole entrate: se il debitore trova un lavoro modesto, difficilmente in 4 anni genererà risorse per il 10%, quindi non scatta obbligo (potrà tenersi i suoi redditi). Ma se, poniamo, eredita una casa, allora sì, dovrà liquidarla in favore dei creditori.
Trascorsi i 4 anni, anche questo vincolo cessa e il debitore rimane definitivamente libero. Da notare, come già detto: questa procedura non è replicabile. Se un debitore incapiente ottiene oggi l’esdebitazione e poi fra qualche anno accumula di nuovo debiti, non potrà dire “sono ancora incapiente, cancellatemi di nuovo i debiti” – dovrà semmai passare per una liquidazione controllata classica.
Tutela dei creditori e rischi per il debitore: I creditori possono opporsi all’istanza di esdebitazione in prima battuta, adducendo magari che il debitore non è meritevole (“ha dissipato lui il patrimonio, perché regalargli l’esdebitazione?”) oppure segnalando beni occulti. Il giudice valuterà. Se dopo la concessione si scopre che il debitore ha mentito (aveva beni nascosti) o che ha dolosamente occultato risorse, l’esdebitazione può essere revocata. Inoltre, l’aver beneficiato di questo istituto risulta a livello storico e se in futuro emergessero frodi commesse prima, il debitore ne risponderà (anche penalmente, per falso nelle dichiarazioni).
Esempio pratico: Sempronio, ex lavoratore autonomo, ha debiti per 50.000€, nessun bene intestato (vive in casa in affitto con la famiglia), disoccupato, zero risparmi, sopravvive con aiuti di parenti. Presenta istanza di esdebitazione incapiente, allegando ISEE basso, nessun immobile, nessuna auto, nulla. OCC conferma che Sempronio non ha nulla da offrire e che il sovraindebitamento è dovuto alla chiusura forzata dell’attività per la pandemia, senza sua colpa. Il Tribunale concede l’esdebitazione. I creditori (banche, fornitori) vedono i loro crediti azzerati. Dopo due anni, Sempronio trova un lavoro a 1.200€/mese: ciò gli consente a malapena di mantenersi, non genera eccedenze per pagare il 10% ai creditori (€5.000) entro i 4 anni, quindi non scatta obbligo. Dopo quattro anni, i creditori originari non possono più vantare nulla. Sempronio ha ricominciato una vita finanziaria normale. Se invece ad esempio entro 3 anni Sempronio avesse ereditato €10.000, avrebbe dovuto notificare la cosa e destinare almeno €5.000 (il 10%) ai creditori in proporzione, altrimenti quell’esdebitazione sarebbe revocabile per inadempimento della condizione.
L’esdebitazione incapiente è stata definita una “novità di civiltà” perché consente di affrontare anche il dramma dei debitori totalmente nullatenenti, spesso vittime di eventi sfortunati, evitando che rimangano per sempre in una trappola debitoria senza via d’uscita (fenomeno legato anche al sovraindebitamento da usura o da altre cause sociali). Naturalmente, è un istituto da applicare con cautela per non ledere eccessivamente il principio di responsabilità patrimoniale: perciò il legislatore ne ha circoscritto l’uso e previsto la “tagliola” del quadriennio di monitoraggio per utilità sopravvenute.
Procedure familiari (sovraindebitamento congiunto)
Il CCII, all’art. 66, introduce la possibilità di trattare unitariamente la crisi da sovraindebitamento di più membri della stessa famiglia. Si parla di “procedure familiari”. Questo consente, per esempio, a marito e moglie indebitati entrambi, o a padre e figlio con debiti comuni, di presentare un unico progetto di risoluzione (piano o concordato) con evidenti vantaggi di economia processuale e di coerenza nelle soluzioni.
Quando è ammessa: Occorre che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- I familiari debitori siano conviventi (stessa residenza e stato di famiglia).
- I debiti abbiano un’origine comune (es: coniugi garanti l’uno dell’altro, o entrambi coinvolti nelle stesse obbligazioni, o contratti cointestati, ecc.).
Per familiari si intendono, oltre al coniuge, i parenti fino al 4° grado, affini fino al 2°, e le parti di unione civile o conviventi di fatto ex L.76/2016. Quindi rientrano non solo i legami stretti (genitori-figli, fratelli, nonni-nipoti), ma anche i conviventi more uxorio.
Come funziona: Se queste condizioni sussistono, i membri della famiglia possono proporre un’unica procedura di sovraindebitamento. In pratica, presentano un ricorso congiunto e un progetto unitario di soluzione della crisi. Tale progetto può assumere forma:
- di piano del consumatore familiare, se tutti i debitori coinvolti sono consumatori;
- oppure di concordato minore familiare, se almeno uno dei debitori non è consumatore.
La legge infatti stabilisce che “Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul Concordato Minore”. Ciò significa che, ad esempio, se abbiamo coniuge A consumatore e coniuge B piccolo imprenditore, il loro piano congiunto dovrà seguire le regole del concordato minore: dunque prevedere il voto dei creditori, maggioranza, ecc. (anche se per la parte consumatore di solito non servirebbe, qui il legislatore preferisce uniformare al regime più rigoroso). Viceversa, se i familiari sono tutti consumatori (es. marito e moglie lavoratori dipendenti), potranno presentare un piano senza votazione dei creditori come un normale piano del consumatore, solo che riguardante entrambi.
Vantaggi delle procedure familiari:
- Unica procedura invece di due o più separate: ciò riduce costi (un solo OCC, un solo tribunale, costi procedurali condivisi) e tempi.
- Coordinamento delle soluzioni: se due coniugi hanno molti debiti in comune (es. mutui cointestati), è più efficiente trattarli assieme. Un unico piano può tenere conto delle risorse familiari globali e proporre una soluzione unitaria. Ad esempio, i flussi di reddito di entrambi i coniugi possono confluire in un’unica proposta di pagamento pro-quota ai creditori.
- Per i creditori, c’è chiarezza e un’unica sede dove far valere le proprie ragioni rispetto a entrambi i debitori.
Esempio: marito e moglie indebitati insieme (mutuo cointestato + debiti personali vari) presentano un piano familiare del consumatore: sommano i loro redditi e propongono di pagarvi i creditori comuni e individuali secondo un piano unico. L’OCC gestisce la pratica congiuntamente. Il giudice omologa (valutando meritevolezza di entrambi). Tutti i debiti di entrambi vengono trattati contestualmente e l’esdebitazione finale riguarderà entrambi.
Oppure, padre pensionato e figlio piccolo imprenditore presentano insieme un concordato minore familiare: integrano attivi (pensione + eventuali beni del padre, e l’attività del figlio) in un’unica proposta. Qui si voterà (perché c’è il figlio imprenditore non consumatore). I creditori di entrambi votano sul pacchetto complessivo. Se omologato, libera entrambi dai debiti.
Accortezze:
- Tutti i partecipanti devono soddisfare i requisiti soggettivi (nessuno di loro dev’essere fallibile grande impresa, ecc.).
- Se uno ha, ad esempio, già fatto un’esdebitazione 3 anni fa, quell’uno non può accedere e quindi forse preclude la procedura familiare se è condizione necessaria includerlo (in tal caso quel membro sarebbe escluso).
- Se la procedura familiare è in concordato minore e c’è prosecuzione attività per uno dei membri imprenditore, valgono per tutti le condizioni di quell’uno (es. se quell’imprenditore prevede cessazione senza apporti esterni, allora il concordato familiare non sarebbe ammissibile, credo).
- Responsabilità solidale: interessante capire se i debiti comuni vengono trattati come crediti verso la “massa familiare” o se comunque distinti. In genere, i debiti cointestati figureranno in ciascuna posizione, ma il piano li affronterà con pagamento unico. Il soddisfacimento di un debito comune in sede di concordato/piano familiare libera entrambi i coobbligati.
- Proceduralmente, un solo Gestore OCC, un solo giudice delegato decidono per tutti.
Le procedure familiari sono una novità applicativa, la cui casistica è in evoluzione. Esse rispondono all’evidenza che il sovraindebitamento spesso coinvolge intere famiglie (es. genitori garanti per figli e viceversa, coppie indebitate insieme). Trattarle congiuntamente rende più organica la soluzione e riduce costi duplicati.
Nota sulle imprese familiari e coobbligati: Oltre alla procedura familiare formalizzata, ricordiamo che resta possibile che coobbligati o fideiussori presentino procedure separate coordinate. Ad esempio, due soci di snc illimitatamente responsabili, ciascuno come persona fisica può accedere alle procedure: potrebbero fare due accordi paralleli. In certi casi conviene invece la procedura familiare se rientrano nel concetto di famiglia (es. moglie fideiubente per debito del marito, qui è letteralmente famiglia). Se i co-debitori non sono familiari (es. soci non parenti), non possono fare procedura unica, ma le loro procedure saranno distinte (magari dinanzi allo stesso giudice per connessione). Alcuni tribunali hanno comunque cercato di coordinare procedure connesse per evitare difformità (es. ammettere un unico OCC per entrambe le procedure parallele, se i regolamenti lo permettono).
Domande frequenti (FAQ)
D1: Chi può ottenere l’esdebitazione?
R: L’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) è ottenibile da tutti i debitori persone fisiche che abbiano completato una delle procedure di sovraindebitamento con successo o nei termini di legge. In particolare: nel piano del consumatore e concordato minore l’esdebitazione avviene al termine, dopo che il debitore ha eseguito la sua parte (pagato le somme concordate); nella liquidazione controllata l’esdebitazione scatta di diritto dopo 3 anni dall’apertura per il debitore persona fisica meritevole; infine il debitore incapiente può ottenere esdebitazione immediata (previa valutazione) senza pagare nulla, salvo obblighi se nei 4 anni successivi acquisisce utilità significative. Le società e gli enti, invece, non ottengono esdebitazione (il beneficio è riservato alle persone fisiche). Inoltre, alcuni debiti particolari non sono coperti dall’esdebitazione (obblighi alimentari, risarcimenti per danni da fatto illecito, sanzioni penali/amministrative pecuniarie). Ad esempio, un debito per multa stradale o per assegno di mantenimento al figlio non viene cancellato: il creditore potrà pretenderlo anche dopo. Tutti gli altri debiti antecedenti sono invece cancellati.
D2: Posso includere nel piano o nella liquidazione anche i debiti fiscali (Agenzia Entrate Riscossione)?
R: Sì. La normativa sul sovraindebitamento consente di ricomprendere anche i debiti tributari e contributivi. Essi vengono trattati secondo le loro caratteristiche: i debiti tributari privilegiati (es. IVA, ritenute) possono essere oggetto di dilazione nel piano (anche oltre un anno, vedi Cass. 34150/2024) ma non di falcidia se il Fisco non acconsente; per includere stralci su tali debiti è necessaria la transazione fiscale, ossia l’accordo con l’ente impositore (Agenzia Entrate/Agenzia Riscossione). Nel concordato minore il Fisco partecipa al voto come gli altri creditori (vota l’Agenzia delle Entrate, non il concessionario). In liquidazione, i debiti fiscali privilegiati vengono soddisfatti secondo ordine di prelazione (es. l’IVA ha privilegio generale sui mobili, secondo l’ordine). Dunque è sicuramente possibile includere le cartelle esattoriali in un piano: tipicamente, si proporrà una percentuale di saldo e stralcio da approvare (ad esempio, pagamento del 30% delle cartelle). Va ricordato che l’Agenzia Entrate-Riscossione è vincolata, nel dare il voto, dal parere dell’ente creditore (Entrate, INPS, Comune ecc.), e che se la proposta prevede di pagare almeno quanto risulterebbe da liquidazione, il tribunale può omologare anche in caso di voto negativo (cram-down fiscale, art. 80 co.7 CCII, in analogia all’art. 63 DL 69/2013 che già lo prevedeva).
D3: Ho un mutuo sulla prima casa: rischio di perderla?
R: Dipende dalla procedura scelta e dal piano fattibile. Nel piano del consumatore, è possibile prevedere di continuare a pagare il mutuo ed escludere la casa dalla liquidazione. Ad esempio, se il valore di mercato della casa è pari al debito residuo, conviene continuare i pagamenti regolari: la banca non subirà pregiudizio ed il giudice potrà omologare il piano in cui la casa rimane al debitore. Spesso i tribunali ammettono piani in cui il debito ipotecario non viene toccato (né falcidiato né dilazionato oltre i termini contrattuali), così il debitore mantiene l’immobile e la banca è soddisfatta fuori piano. Se però il mutuo è molto elevato e la casa ha equity disponibile, il debitore può valutare di venderla nell’ambito del piano per pagare parzialmente i creditori (oppure dare la casa alla banca in datio in solutum a copertura del mutuo, se la banca accetta, liberandosi così). Nel concordato minore, analogamente, il debitore può scegliere se conservare la continuità dei pagamenti del mutuo (escludendo di fatto l’immobile dal concorso) oppure inserirlo nel piano con eventuale rinegoziazione. La Cassazione ha confermato che nel piano/concordato del sovraindebitato è lecito prevedere che le rate a scadere di un mutuo ipotecario vengano pagate alle scadenze originarie (moratoria ultrannuale), purché si paghino gli interessi nel frattempo. In liquidazione controllata, invece, l’immobile diventa parte della massa attiva: verrà venduto dal liquidatore e dal ricavato sarà soddisfatta prima la banca mutuante (creditore ipotecario) e solo l’eventuale eccedenza andrà agli altri creditori. Quindi la casa si perderebbe. Dunque, se l’obiettivo primario del debitore è salvare la casa, è preferibile tentare una ristrutturazione (piano/concordato) piuttosto che la liquidazione, sempre che il piano sia sostenibile. Si noti che anche col piano, se l’esposizione è troppo alta, qualche sacrificio potrebbe essere necessario (ad esempio, vendere la casa per affittare un alloggio più modesto e con il surplus pagare i creditori: questa è una scelta spesso valutata dall’OCC con il debitore).
D4: Quali beni posso tenere anche se faccio la liquidazione?
R: In liquidazione controllata, il debitore conserva tutti i beni che per legge non possono essere pignorati. Ciò ricalca l’art. 545 c.p.c. e altre norme speciali. Ad esempio: gli abiti, i beni di uso quotidiano, i mobili essenziali di casa non si toccano; stipendi e pensioni sono prelevabili solo nella misura della quota pignorabile (di regola un quinto del netto, salvo diversi limiti per pensioni minime); gli strumenti indispensabili per l’attività lavorativa del debitore (se ad esempio è un artigiano o professionista con beni strumentali di modesto valore) potrebbero essere lasciati fuori se strettamente necessari alla sopravvivenza economica sua e della famiglia, anche se su questo decide caso per caso il giudice; eventuali crediti per risarcimenti per danno morale, assegni di mantenimento che il debitore percepisce, ecc., sono impignorabili quindi esclusi. Insomma, il debitore non viene privato dei mezzi di sostentamento minimi. Il giudice delegato di solito fissa un budget mensile impignorabile per il debitore persona fisica e la sua famiglia, in base al tenore di vita essenziale, e solo l’eccedenza va ai creditori. Se il debitore ha beni di valore affettivo ma anche economico (es. fede nuziale d’oro), questi tecnicamente potrebbero essere liquidati se non rientrano nelle esclusioni, ma spesso i liquidatori evitano di porre in vendita oggetti di scarso valore commerciale o di particolare valore morale, a meno che i creditori lo pretendano. In ogni caso, non potrà essere liquidata la nuda proprietà dell’abitazione principale se su di essa c’è diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c., né i beni sui quali sussistono cause legittime di prelazione di terzi non debitori (es. un bene in trust a favore di terzi, bene altrui in possesso del debitore, etc. vengono esclusi). Nelle procedure di piano o concordato, invece, il debitore mantiene in pieno la titolarità dei propri beni salvo quelli che volontariamente destina ai creditori nel piano (nessuno lo obbliga a vendere tutto, purché il piano sia conveniente e approvato).
D5: È obbligatorio rivolgersi a un OCC o posso fare da solo?
R: La legge prevede espressamente l’intervento obbligatorio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) in tutte le procedure di sovraindebitamento. Il debitore non può presentare autonomamente un piano o un’istanza senza la relazione di un OCC (fa eccezione, a rigore, il caso in cui non ci sia un OCC disponibile nel circondario: allora il debitore può chiedere al tribunale la nomina di un professionista “gestore” individuale ad hoc, ma si tratta pur sempre di un ausiliario con funzioni analoghe all’OCC). Quindi sì, è necessario passare tramite OCC. L’OCC svolge una funzione fondamentale di assistenza e controllo: nomina il gestore della crisi (che tipicamente sarà un commercialista o avvocato esperto in materia concorsuale), il quale analizza la situazione debitoria, consiglia la via più adatta (piano, concordato o liquidazione) e prepara la relazione. Anche per l’esdebitazione incapiente serve la relazione OCC. Il costo dell’OCC è regolato da tariffari ministeriali che tengono conto della complessità e dell’attivo/passivo. Spesso è richiesto un acconto iniziale (ad es. molte Camere di Commercio chiedono un acconto standard, es. €200-300). Il compenso finale dell’OCC è di solito a carico del debitore/procedura, ma può essere pagato dilazionato nell’ambito del piano stesso o prelevato dall’attivo liquidato. Se il debitore ha i requisiti per il gratuito patrocinio, può chiedere l’ammissione per farsi assistere da un avvocato a spese dello Stato nelle fasi giudiziali, ma l’OCC ha comunque un costo tecnico. Va detto però che il CCII ha cercato di rendere l’accesso più agevole: come accennato, la Corte Cost. 121/2024 ha reso possibile il patrocinio a spese dello Stato per coprire certe spese vive di procedura prive di attivo. Alcuni OCC pubblici (come quelli delle Camere di Commercio) hanno tariffe calmierate, mentre altri (OCC presso Ordini professionali) possono avere onorari più elevati. In ogni caso il debitore può valutare a chi rivolgersi: c’è un Registro nazionale OCC sul sito ministeriale, e conviene scegliere un OCC nel circondario del proprio tribunale.
D6: Cosa succede se emergono frodi del debitore durante la procedura?
R: Se durante la procedura (piano, concordato o liquidazione) emerge che il debitore ha occultato deliberatamente beni o falsificato informazioni, le conseguenze sono serie. In un piano del consumatore, l’omologazione può essere revocata su istanza dei creditori se scoprono che il debitore ha agito in frode (art. 70 CCII prevede la revoca dell’omologa e la conversione in liquidazione in caso di atti in frode non conosciuti) – ad esempio se ha nascosto un immobile o trasferito soldi a terzi prima del piano. Nel concordato minore, parimenti, l’omologa può essere revocata e il concordato annullato per dolo del debitore (art. 83 CCII, analogia con 137 l.fall., annullamento per atti di frode scoperti dopo). In liquidazione, se il debitore nasconde attivo o rende dichiarazioni false, può subire la revoca dell’esdebitazione (art. 280 CCII: il beneficio è escluso a chi tiene comportamenti dolosi). Inoltre, tali condotte possono costituire reati. Il CCII estende al sovraindebitato molte fattispecie penali del vecchio fallimento: ad esempio, occultare beni ai creditori configura ricorso abusivo al credito o insolvenza fraudolenta, presentare documenti falsi all’OCC o al giudice costituisce reato (fino a 2 anni di reclusione). Se viene accertato il reato di bancarotta fraudolenta (applicabile a imprenditori minori se parificati a falliti in caso di frode), vi sono pene severe e interdizioni. In sintesi: la scoperta di frodi comporta la perdita di ogni beneficio per il debitore e possibili implicazioni penali, quindi è fondamentale agire con trasparenza e buona fede.
D7: Quanto tempo ci vuole per uscire dai debiti?
R: I tempi variano secondo la procedura: un piano del consumatore o concordato minore può essere omologato in tempi relativamente brevi, indicativamente da 4 a 12 mesi dall’istanza (dipende dai carichi del tribunale e dalle eventuali opposizioni). Dopo l’omologa, se il piano prevede pagamenti dilazionati, il debitore dovrà rispettare quelle scadenze (possono essere uno o più anni): l’esdebitazione effettiva arriva solo a completamento del piano. Quindi, ad esempio, un piano che prevede pagamento rateale su 4 anni, significa che dal deposito istanza all’esdebitazione passeranno circa 4-5 anni (ponendo 1 anno per omologa + 4 anni di pagamenti). Se però il piano prevede un pagamento in unica soluzione (es. vendita di un immobile immediata), l’esdebitazione può arrivare prima, a esecuzione avvenuta. Nella liquidazione controllata, l’esdebitazione di diritto avviene dopo 3 anni dall’apertura. Dall’istanza di liquidazione all’apertura formale può trascorrere qualche mese (poniamo 3-6 mesi), poi si contano 3 anni: quindi circa in 3 anni e mezzo il debitore persona fisica è liberato. La procedura di liquidazione però potrebbe restare aperta ancora se ci sono beni da vendere, ma il debitore a quel punto ha già il beneficio. Nell’esdebitazione incapiente, il tempo è quello della decisione del tribunale: potrebbe essere questione di pochi mesi (diciamo 6 mesi medi) per ottenere il decreto di esdebitazione, dopodiché c’è l’attesa quadriennale ma senza pendenze (serve solo a monitorare eventuali utilità). Quindi, potenzialmente, un debitore incapiente può essere “pulito” formalmente dai debiti nell’arco di un anno circa. In sintesi, i percorsi più rapidi sono il piano con pagamento immediato e l’esdebitazione incapiente; la liquidazione ha il vincolo fisso di 3 anni; i piani rateali possono durare diversi anni secondo la sostenibilità. Vale sempre la pena considerare che i creditori durante la procedura sono bloccati: quindi il debitore, pur non ancora esdebitato, vive già più serenamente dal momento in cui il tribunale sospende le azioni esecutive. Ad esempio, se un pignoramento sul conto viene sospeso subito, il debitore può tornare a disporre delle entrate correnti e condurre la propria vita mentre esegue il piano.
D8: Dopo l’esdebitazione, rimarrò segnalato come “cattivo pagatore”?
R: L’esdebitazione non cancella automaticamente le segnalazioni nelle banche dati creditizie private (CRIF, Cerved etc.), ma costituisce un elemento importante. In genere, trascorsi un certo periodo dall’esdebitazione, il nominativo viene aggiornato come “debito estinto per esdebitazione” e dopo ulteriori mesi/anni la segnalazione viene rimossa secondo i regolamenti delle banche dati (di solito le sofferenze vengono cancellate decorso 36 mesi dal loro aggiornamento finale). Il debitore esdebitato può anche attivarsi per far valere il suo diritto all’aggiornamento delle informazioni: ad esempio, allegando il decreto di esdebitazione per chiedere alla centrale rischi privata di aggiungere che quei crediti non sono più dovuti. Formalmente, l’esdebitazione è una causa di estinzione delle obbligazioni, quindi il debitore riacquista capacità finanziaria e potrebbe teoricamente accedere a nuovo credito (anche se le banche valuteranno il suo passato). Non esiste un pubblico registro degli esdebitati consultabile dalle banche; tuttavia le procedure concorsuali sono annotate in alcuni archivi (il registro delle procedure del tribunale o il casellario fallimentare per fallimenti, ma per sovraindebitamento c’è meno pubblicità). Quindi, la “nomea” di ex sovraindebitato non è di pubblico dominio oltre la durata della procedura. Per prudenza, molti intermediari finanziari possono essere riluttanti a concedere credito immediatamente dopo l’esdebitazione, ma col tempo, dimostrando di aver una situazione stabile, il debitore potrà riabilitarsi creditiziamente. In particolare, un’esdebitazione consente di ottenere la cancellazione dai ruoli esattoriali per i debiti abbonati e di rimuovere eventuali ipoteche giudiziali o pignoramenti iscritti (grazie al decreto del giudice che chiude la procedura). Il debitore potrà dunque, ad esempio, tornare proprietario di beni senza timore che i vecchi creditori iscrivano vincoli, e potrà certificare di non avere insoluti legali in corso.
D9: Se sono un ex imprenditore fallito (ditta o società fallita), posso usare la legge sul sovraindebitamento per i debiti personali rimasti?
R: Sì, un imprenditore cessato e anche un socio illimitatamente responsabile di società fallita può far ricorso alle procedure di sovraindebitamento per gestire i debiti residui che gli competono personalmente. Questo caso è frequente: ad esempio, fallita la SNC, i soci rimangono con debiti personali verso i creditori sociali insoddisfatti; oppure il fallimento di una srl non copre fideiussioni che l’ex amministratore aveva rilasciato. Tali debiti post-fallimentari (nel senso che eccedono quanto pagato dalla procedura fallimentare) possono essere oggetto di un accordo o di liquidazione da sovraindebitamento. Bisogna attendere la chiusura del fallimento di solito, per avere il quadro dei debiti rimasti. Va notato che il CCII prevede anche l’esdebitazione dell’imprenditore fallito (ora liquidazione giudiziale) direttamente ex art. 278: quindi un ex fallito onesto può già ottenere esdebitazione nel fallimento stesso. Tuttavia, se ciò non avviene o se restano debiti esclusi (es. fideiussioni non emerse in fallimento), nulla vieta di ricorrere al sovraindebitamento. Il Correttivo ter 2024 però ha ribadito che un imprenditore che ha chiuso l’attività e cancellato la partita IVA non può fare il concordato minore, salvo apporto esterno. In pratica in molti casi un ex imprenditore si troverà a dover scegliere tra: (a) liquidazione controllata, se ha ancora beni; (b) esdebitazione incapiente, se proprio è nullatenente; (c) raramente un piano del consumatore, perché se i debiti derivano dall’impresa cessata, lui non è “consumatore” rispetto a quei debiti (sono debiti professionali). Quindi spesso un ex imprenditore userà la liquidazione controllata. Ad esempio: Tizio, ex commerciante individuale, fallito 3 anni fa, chiude il fallimento con un passivo non soddisfatto di 200.000€. Ora ha un lavoro dipendente modesto. Potrà chiedere la liquidazione controllata dei suoi debiti residui personali, con esdebitazione in 3 anni. Oppure, se proprio disoccupato e nullatenente, l’esdebitazione incapiente.
D10: Quali sono le sentenze più importanti che riguardano il sovraindebitamento negli ultimi tempi?
R: Numerose pronunce di merito e di legittimità hanno chiarito punti applicativi del CCII e della legge precedente. Tra le Corti di Cassazione recenti ricordiamo:
- Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2023 n. 4613 – Ha stabilito il principio che un accordo o piano non può pregiudicare un creditore ipotecario assicurandogli meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione, ponendo un deciso freno a piani con falcidie eccessive dei garantiti.
- Cass. civ. Sez. I, 27 novembre 2024 n. 30538 – Ha affermato che, anche in assenza di una previsione normativa di meritevolezza per il concordato minore (ex L.3/2012), il tribunale deve valutare il comportamento pregresso del debitore per giudicarne l’affidabilità e l’accesso alla procedura. Inoltre ha chiarito che per i crediti tributari il voto spetta all’Agenzia delle Entrate e non all’agente della riscossione.
- Cass. civ. Sez. I, 19 gennaio 2024 n. 4326 – (Non citata sopra, ma correlata, presumibilmente) Ha trattato della decorrenza dei termini di reclamo in caso di comunicazione integrale del provvedimento via PEC (accennata in un riferimento su Unijuris).
- Cass. civ. Sez. I, 23 dicembre 2024 n. 34158 – Ha chiarito che se il decreto di omologa non è notificato, il termine per impugnare decorre per 6 mesi ex art.327 c.p.c. (termine lungo) e non quello breve dei reclami fallimentari, assicurando maggiore tutela ai debitori e creditori ignari dell’esito.
- Cass. civ. Sez. I, 27 novembre 2024 n. 30543 – Ha ribadito la necessità che, se un accordo prevede pagamento non integrale di un creditore privilegiato, l’omologa è possibile solo verificando che la proposta sia più vantaggiosa della liquidazione. Ha anche chiarito che un creditore privilegiato dissenziente non perde il suo diritto di far valere il privilegio in sede di opposizione solo perché non lo ha dichiarato al voto.
- Cass. civ. Sez. I, 27 luglio 2023 n. 22797 – (Citata su Unijuris) Ha affrontato la tematica dell’impugnazione in Cassazione di un provvedimento di reclamo sull’omologa e il trattamento dei privilegiati in caso di pagamento dilazionato, confermando la possibilità di ricorso per Cassazione e la necessità di considerare gli interessi dei privilegiati nell’omologa.
- Cass. civ. Sez. I, 23 dicembre 2024 n. 34164 – (Da Unijuris) Ha deciso che se, dopo l’omologa di un accordo ex L.3/2012, in fase di esecuzione il debitore propone una modifica della proposta, tale modifica va comunicata a tutti i creditori, anche a quelli già soddisfatti, che vanno rimessi in condizione di esprimersi. Ciò a tutela della trasparenza e partecipazione di tutti i creditori al modificato equilibrio.
- Cass. civ. Sez. I, 6 ottobre 2023 n. 22699 – (Menziodata altrove, nota come questione “debito promiscuo”) Ha qualificato i criteri per distinguere il consumatore dall’imprenditore quando i debiti hanno natura mista, affermando che prevale l’attività svolta: se i debiti sono in larga parte collegati all’impresa, niente piano consumatore. Questa pronuncia ha guidato tribunali come Milano nel negare la qualifica di consumatore a chi aveva debiti sia personali sia d’impresa (debito promiscuo).
- Cass. civ. Sez. III, 26 luglio 2023 n. 22715 – (v. ricerca Professionistidellacrisi) Riguardante presumibilmente aspetti procedurali (non dettagliato qui).
- Corte Costituzionale 19 gennaio 2024 n. 6 – Ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sull’art. 142 CCII in tema di mancanza di limite temporale di apprensione dei sopravvenuti in liquidazione controllata, rimettendo al giudice la gestione caso per caso e al legislatore l’eventuale intervento.
- Corte Costituzionale 24 giugno 2022 n. 123 – (non citata sopra ma importante) Ha dichiarato incostituzionale, sotto la vigenza L.3/2012, la norma che impediva al debitore esdebitato di riproporre una procedura prima di 5 anni, limitatamente al caso di accordo/piano non omologato (questo portò il DL 137/2020 a introdurre la possibilità di ripresentare subito una nuova proposta se la prima era inammissibile). Oggi il CCII permette infatti nuova proposta corretta in caso di prima inammissibilità, in linea con quell’indicazione.
Queste e altre sentenze (citate in corsivo nel testo) delineano un orientamento generale: da un lato tutela della buona fede e della convenienza per i creditori (no omologhe che li danneggino ingiustificatamente), dall’altro favor secondi tentativi per il debitore onesto (possibilità di ripresentare proposte, esdebitazione automatica, gratuito patrocinio esteso). Le Fonti e Riferimenti sottostanti includono link ai testi citati per approfondimenti.
Fonti e Riferimenti
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14) – Normativa vigente dal 15 luglio 2022, artt. 65-83 (procedure di composizione da sovraindebitamento) e 268-283 (liquidazione controllata ed esdebitazione).
- Camera di Commercio di Frosinone-Latina – “Le diverse procedure” (OCC) – Sintesi istituzionale delle procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione incapiente, procedure familiari.
- Camera di Commercio di Reggio Calabria – “Crisi d’impresa e Sovraindebitamento” (OCC) – FAQ e guide pratiche OCC (agg. giugno 2025) con definizioni di sovraindebitamento, debitore incapiente, chi può accedere e chi no, ruolo OCC.
- Corte di Cassazione – Ordinanza 14/02/2023 n. 4613, Sez. I Civ. – Principio di diritto: “L’accordo del sovraindebitato non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario assicurandogli meno di quanto conseguibile nell’alternativa liquidatoria.”.
- Corte di Cassazione – Ordinanza 27/11/2024 n. 30538, Sez. I Civ. – Importanza della valutazione dell’affidabilità del debitore (meritevolezza implicita) anche nell’accordo ex L.3/2012 e chiarimenti sul voto nei crediti tributari (vota l’Agenzia delle Entrate, non l’agente della riscossione).
- Corte di Cassazione – Sentenza 23/12/2024 n. 34158, Sez. I Civ. – Termini di reclamo: in mancanza di notifica/comunicazione del decreto di omologa, si applica il termine lungo di 6 mesi ex art. 327 c.p.c. e non quello breve analogico.
- Corte di Cassazione – Ordinanze 27/11/2024 nn. 30542 e 30543, Sez. I Civ. – (30542) Non decisorietà della pronuncia di inammissibilità di un piano/accordo: il debitore può ripresentare proposta e non è ricorribile per Cassazione. (30543) Necessità del test di convenienza per omologa con falcidia di crediti privilegiati; il dissenso del creditore privilegiato non comunicato in voto non implica rinuncia al privilegio.
- Corte Costituzionale – Sentenza 19/01/2024 n. 6 – Sovraindebitamento, liquidazione controllata: questione di legittimità sull’assenza di un limite temporale di durata della procedura per l’acquisizione dei beni sopravvenuti. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo non irragionevole la disciplina e demandando al legislatore eventuali limiti.
- Corte Costituzionale – Sentenza 21/06/2024 n. 121 – Patrocinio a spese dello Stato nella liquidazione controllata: dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma che non consentiva l’ammissione del gratuito patrocinio e la prenotazione a debito delle spese di giustizia nelle procedure di liquidazione controllata prive di attivo.
- Fonti normative previgenti: Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (abrogata) – utile per lavori comparativi (ad es. art. 14-undecies L.3/2012, sopravvenienze 4 anni; art. 12-ter e 12-quinquies, omologa piano/accordo; art. 14-terdecies, esdebitazione e debiti esclusi). La nuova disciplina ne riprende in parte il contenuto con modifiche.
Come uscire da una situazione di sovraindebitamento? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai accumulato debiti che non riesci più a gestire?
Ogni mese fai fatica a pagare rate, mutui, bollette, prestiti o cartelle esattoriali?
Quando le entrate non bastano più e i debiti superano la tua reale capacità di rimborso, sei in stato di sovraindebitamento. Ma la legge oggi ti tutela: puoi ottenere la sospensione dei pagamenti, bloccare i creditori e perfino cancellare i debiti non più sostenibili.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza nel dettaglio la tua esposizione verso banche, finanziarie, Fisco e fornitori
- 📌 Verifica i requisiti per accedere a una delle tre procedure previste dal Codice della Crisi
- ✍️ Redige il piano del consumatore, la ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata
- ⚖️ Ti assiste davanti all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e al Tribunale
- 🔁 Ti guida fino all’esdebitazione, cioè la liberazione completa dai debiti non più pagabili
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto del sovraindebitamento e tutela dei soggetti non fallibili
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
- ✔️ Specializzato nell’assistenza di privati, famiglie, piccoli imprenditori e lavoratori in difficoltà economica
Conclusione
Il sovraindebitamento non è la fine, ma può essere un nuovo inizio.
Con l’assistenza giusta puoi bloccare i pignoramenti, sospendere i pagamenti e ottenere una vera liberazione dai debiti.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua rinascita finanziaria comincia da qui.