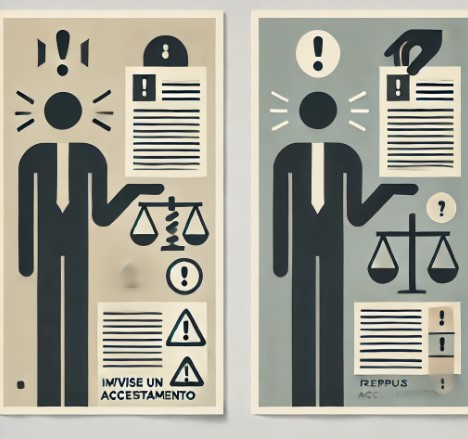Hai ricevuto un avviso di accertamento integrativo e ti stai chiedendo perché il Fisco è tornato ad accertarti, cosa significa questo nuovo atto e come puoi difenderti efficacemente?
L’avviso di accertamento integrativo è uno strumento che consente all’Agenzia delle Entrate di modificare un precedente accertamento già notificato, quando emergono nuovi elementi o fatti non conosciuti al momento del primo atto. Ma questo potere ha limiti precisi e può essere contestato se esercitato in modo illegittimo o abusivo.
Cos’è un avviso di accertamento integrativo?
– È un nuovo accertamento che integra o modifica uno precedente, già emesso e notificato
– Si basa su nuove fonti di prova, dati bancari, controlli incrociati, segnalazioni o documenti sopraggiunti
– Può riguardare redditi non dichiarati, costi indeducibili, crediti d’imposta o IVA, anche se già oggetto di altro accertamento
– Può avere lo stesso periodo d’imposta del primo atto, ma nuove contestazioni o importi
Quando è legittimo un accertamento integrativo?
– Quando il Fisco non poteva conoscere i nuovi fatti all’epoca del primo accertamento
– Se ci sono nuovi documenti acquisiti dopo la notifica del primo atto
– Se le modifiche sono legate a fatti diversi e non già valutati nel primo accertamento
– Se viene rispettato il termine di decadenza ordinario (normalmente 5 anni, prorogabili a 7)
Quando è illegittimo e contestabile?
– Se si limita a ripetere le stesse contestazioni con nuovi importi
– Se manca un reale elemento nuovo e si usa lo strumento per rimediare a errori del primo atto
– Se viene notificato oltre i termini di legge
– Se viola il principio del ne bis in idem, cioè se accerta due volte lo stesso fatto
– Se non è preceduto dal contraddittorio obbligatorio, nei casi in cui è previsto
Come puoi difenderti da un accertamento integrativo?
– Richiedi l’accesso agli atti per valutare quali nuovi elementi sono stati utilizzati
– Verifica se le contestazioni sono davvero nuove o solo una riproposizione
– Controlla il rispetto dei termini di notifica e dei limiti temporali
– Se il primo accertamento è già pendente in giudizio, valuta la riunione o sospensione del secondo procedimento
– Presenta ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni, se l’atto è infondato
– Valuta anche un’istanza di autotutela, se l’errore è evidente
Cosa puoi ottenere con una buona difesa?
– L’annullamento totale o parziale dell’atto integrativo
– La sospensione della riscossione e delle azioni esecutive
– La protezione del tuo patrimonio e la riduzione delle sanzioni
– Il riconoscimento dell’illegittimità dell’accertamento e la vittoria nel contenzioso
L’accertamento integrativo non è sempre legittimo: può essere uno strumento abusivo se usato per correggere errori o aumentare somme già accertate. Ma con l’assistenza giusta puoi bloccare ogni pretesa indebita e salvaguardare i tuoi diritti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa del contribuente ti spiega cosa fare se ricevi un avviso di accertamento integrativo, come valutare la legittimità dell’atto e quali strategie usare per difenderti.
Hai ricevuto un secondo accertamento per gli stessi anni già contestati? Non sai se è legittimo o come reagire? Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo se il Fisco ha rispettato i limiti di legge e come bloccare ogni abuso a tuo danno.
Introduzione
Un avviso di accertamento integrativo è un secondo atto impositivo, emesso dall’Agenzia delle Entrate dopo un precedente avviso “originario”, allo scopo di integrare o modificare in aumento la pretesa fiscale relativa a un medesimo periodo d’imposta. Si tratta di uno strumento eccezionale, ammesso solo nel rispetto di precise condizioni di legge: in particolare la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi non noti all’ufficio al momento del primo accertamento. In questa guida analizzeremo in dettaglio cos’è un avviso integrativo, quando può essere emesso e con quali limiti, e soprattutto come il contribuente può difendersi efficacemente. Adotteremo un linguaggio giuridico ma chiaro, con un taglio pratico rivolto a avvocati, professionisti, imprenditori e privati che si trovino ad affrontare un secondo accertamento fiscale. Verranno esaminate le norme italiane rilevanti (aggiornate al 2025), i diritti del contribuente nella fase istruttoria (rapporti con l’Agenzia delle Entrate), le strategie di difesa (dall’autotutela agli strumenti deflattivi e al contenzioso in Commissione/Corte di Giustizia Tributaria), nonché le più recenti sentenze giurisprudenziali sul tema. Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione Domande & Risposte per chiarire i dubbi più comuni. Il punto di vista adottato è quello del contribuente (debitore), evidenziando come far valere i propri diritti e contestare un eventuale accertamento integrativo illegittimo.
Che cos’è un avviso di accertamento integrativo
Un avviso di accertamento integrativo è un atto emanato dall’Amministrazione finanziaria successivamente a un precedente avviso di accertamento (detto anche “avviso originario” o “principale”) riguardante lo stesso periodo d’imposta. Esso non sostituisce né annulla il primo accertamento, ma si aggiunge ad esso, aumentando la base imponibile o le imposte dovute in virtù di elementi ulteriori che l’ufficio ha scoperto dopo la notifica del primo atto. In altre parole, l’accertamento integrativo integra o modifica in aumento la pretesa fiscale originaria, recuperando a tassazione nuovi redditi o imponibili non considerati nel primo avviso.
Dal punto di vista normativo, per le imposte dirette l’istituto è disciplinato dall’art. 43 del DPR 600/1973, mentre per l’IVA dalla norma analoga di cui all’art. 57 del DPR 633/1972. Tali disposizioni stabiliscono che, fino alla scadenza dei termini di accertamento, l’ufficio “può integrare o modificare in aumento” un precedente avviso mediante nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, che devono essere specificamente indicati nell’atto a pena di nullità. Il principio generale del nostro ordinamento tributario è quello della unicità e globalità dell’accertamento per ciascun periodo d’imposta (il contribuente ha diritto a non essere vessato da una molteplicità di atti impositivi sullo stesso anno). L’accertamento integrativo costituisce una deroga eccezionale a tale principio, ammessa appunto solo se emergono elementi nuovi, oggettivamente e temporalmente sopravvenuti, che giustificano un’ulteriore azione impositiva.
Da quanto detto derivano già due corollari importanti: (1) l’avviso integrativo è legittimo solo se vi sono effettivamente “nuovi elementi” scoperti dopo il primo accertamento; (2) esso deve essere notificato entro gli stessi termini di decadenza previsti per l’accertamento originario (non estende né riapre il periodo accertabile). Approfondiremo a breve entrambe le condizioni. Prima, però, è utile chiarire la differenza tra accertamento integrativo e altre tipologie di accertamento o strumenti con cui spesso viene confuso.
Accertamento integrativo vs accertamento “parziale” e altri atti
L’accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/1973 per le imposte dirette, art. 54, c.5 DPR 633/1972 per l’IVA) è un istituto differente dall’integrativo, sebbene anch’esso porti alla notifica di più atti sullo stesso anno fiscale. L’accertamento parziale è tipicamente un primo accertamento “veloce” e limitato, emesso quando l’ufficio dispone già di alcuni dati certi su specifici redditi o imponibili non dichiarati (ad esempio da segnalazioni o verifiche parziali). Esso non esaurisce il potere di accertamento sull’anno, tanto che l’ufficio può successivamente emettere un accertamento ordinario (generale) o altri parziali sul medesimo periodo per gli elementi non ancora contestati. In pratica, l’accertamento parziale “non chiude definitivamente il discorso” sull’annualità: è un atto circoscritto ad alcuni rilievi, utilizzato per far emergere subito materia imponibile facilmente accertabile, mantenendo la possibilità di ulteriori interventi (anche senza nuovi elementi, sui profili non esaminati inizialmente).
L’accertamento integrativo, invece, presuppone che vi sia già stato un accertamento completo o comunque un atto definitivo (anche un accertamento parziale definito in adesione, come vedremo) sul periodo considerato. A differenza del parziale, l’integrativo aggiunge nuove contestazioni sulla stessa materia già oggetto del primo atto, ed è perciò vincolato alla presenza di elementi sopravvenuti. Se l’Ufficio aveva già a disposizione certi dati durante il primo accertamento, non può limitarli per poi riutilizzarli in un secondo momento con un integrativo, perché ciò eluderebbe il principio di unicità e la tutela dell’affidamento del contribuente sulla stabilità dell’atto ricevuto. Dunque, in presenza dei presupposti per emettere subito un accertamento parziale (dati immediatamente utilizzabili), l’Amministrazione normalmente segue quella strada, che prevale sull’integrativo e non richiede la prova di “nuovi elementi” sopravvenuti. L’integrativo rimane residuale, utilizzabile solo per rettificare o integrare un atto già notificato in seguito alla scoperta postuma di ulteriore materia imponibile.
Un’altra distinzione da fare è tra accertamento integrativo e autotutela sostitutiva da parte dell’Amministrazione. L’autotutela è il potere dell’ente impositore di annullare o rettificare d’ufficio un proprio atto illegittimo o erroneo, senza attendere il giudice, sia su istanza del contribuente sia di propria iniziativa. In passato, la giurisprudenza discuteva se l’Ufficio potesse revocare un avviso già emesso e sostituirlo con un altro più gravoso (c.d. autotutela in malam partem), anche senza nuovi elementi, semplicemente per correggere un errore di valutazione. Alcune pronunce di Cassazione sostenevano che ciò fosse possibile entro i termini di decadenza e in assenza di giudicato, ritenendo l’autotutela uno strumento generale non soggetto al limite dei “nuovi elementi”. Altre decisioni invece negavano questa facoltà, richiamando appunto l’art. 43 DPR 600/73 che consente modifiche dell’accertamento solo se emergono elementi nuovi, salvo il caso in cui il primo avviso venga annullato in autotutela (ad esempio perché viziato) e dunque sostituito integralmente. Oggi la questione è risolta dal legislatore: con il D.Lgs. 219/2023, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, è stato introdotto nello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) un nuovo art. 10-quater che impedisce l’autotutela peggiorativa. Gli Uffici possono annullare o correggere d’ufficio un atto solo in bonam partem, cioè a favore del contribuente, per correggere errori (anche sostanziali) che lo abbiano indebitamente pregiudicato. Non è più ammessa l’emissione di un secondo avviso più oneroso semplicemente per riparare a carenze del primo atto (in assenza di fatti nuovi). Questa riforma rafforza il principio di unicità dell’accertamento e costringe l’Amministrazione a rispettare rigorosamente la regola dei nuovi elementi sopravvenuti per poter legittimamente integrare un avviso precedente.
In sintesi, l’avviso di accertamento integrativo si configura come atto aggiuntivo (non sostitutivo) emesso dopo un accertamento originario valido, per lo stesso tributo e periodo d’imposta, allo scopo di ampliarne la portata impositiva sulla base di nuove scoperte. Va distinto sia dagli accertamenti parziali (che sono primi atti limitati a pochi rilievi, e non richiedono elementi nuovi per eventuali successivi ampliamenti), sia dalle rettifiche in autotutela (ormai limitate ai soli casi favorevoli al contribuente dopo la riforma 2023/24). In tutti i casi, comunque, l’integrativo è soggetto a condizioni stringenti, trattate nella sezione seguente.
Presupposti di legittimità e limiti dell’accertamento integrativo
Come anticipato, la legge pone tre condizioni fondamentali perché un avviso integrativo sia valido:
- 1) Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi: l’Ufficio deve aver scoperto nuovi fatti, dati o prove dopo la notifica del primo avviso, che incidono sulla base imponibile o sull’imposta dovuta per lo stesso periodo.
- 2) Indicazione puntuale nell’atto: i nuovi elementi (nonché gli atti o le fonti da cui provengono) devono essere specificamente indicati nell’avviso integrativo, a pena di nullità. In pratica, l’atto deve motivare espressamente cosa c’è di nuovo e come è venuto a conoscenza dell’ufficio.
- 3) Rispetto dei termini di decadenza: l’integrativo deve essere notificato entro i termini ordinari di accertamento previsti dalla legge per quell’anno e tributo (non si ha alcuna proroga solo perché c’è stato un avviso precedente).
Analizziamo in dettaglio ciascun aspetto, perché rappresentano anche i principali profili di difesa su cui il contribuente può fare leva per contestare un integrativo illegittimo.
“Nuovi elementi” sopravvenuti: nozione e onere della prova
Il requisito dei “nuovi elementi” è la pietra angolare dell’accertamento integrativo. Esso va inteso sia in senso temporale che oggettivo:
- Novità temporale: l’elemento (informazione, documento, dato) deve essere entrato **nella sfera di conoscenza dell’ufficio finanziario **solo dopo la data in cui il primo avviso è stato emanato/notificato. In altre parole, non doveva essere conosciuto né conoscibile dall’ufficio con la normale diligenza durante la fase istruttoria precedente l’atto originario. Ad esempio, una segnalazione della Guardia di Finanza giunta all’ufficio dopo il primo accertamento, oppure un nuovo riscontro emerso da controlli successivi su conti bancari, può costituire elemento temporaneamente nuovo. Viceversa, se l’elemento era già noto o facilmente accessibile all’Ente impositore prima, non può fondare un integrativo.
- Novità oggettiva: il nuovo elemento deve essere significativo, tale da comportare un maggior imponibile o maggior imposta da accertare. Non basta una diversa valutazione di fatti già considerati, né un mero ricalcolo su dati preesistenti: deve trattarsi di informazioni ulteriori, non valutate nel primo atto, che incidono sull’“oggettività del presupposto d’imposta”. Ad esempio, la scoperta di ulteriori ricavi occultati rispetto a quelli già contestati, oppure la rilevazione di nuovi beni/asset non dichiarati, di fatture false aggiuntive, ecc., costituisce elemento oggettivamente nuovo. Invece, semplici errori di calcolo o di valutazione giuridica del precedente accertamento non legittimano un integrativo (semmai andrebbero corretti in autotutela, ma – come detto – solo se a favore del contribuente nel nuovo regime).
Importante: l’onere di provare la “sopravvenuta conoscenza” dei nuovi elementi grava sull’Amministrazione finanziaria. È l’Ufficio che, in caso di impugnazione, dovrà dimostrare (anche documentalmente) che l’informazione è effettivamente emersa dopo il primo atto e che non era ragionevolmente ottenibile prima, nonostante l’ordinaria diligenza in sede di verifica. Proprio per questo la legge impone la motivazione dettagliata nell’avviso integrativo: se questa manca o è carente, l’atto è nullo. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che un integrativo privo di qualsiasi riferimento ai nuovi elementi è illegittimo. Inoltre, se l’ufficio già possedeva quei dati (o avrebbe potuto facilmente raccoglierli) prima, l’accertamento integrativo è illegittimo. Su questo punto la giurisprudenza è chiara: “deve considerarsi illegittimo l’accertamento integrativo quando l’ufficio accertatore risultava già in possesso degli elementi su cui si basa al momento della notifica del primo atto”.
Tuttavia, attenzione: “posseduto dall’amministrazione finanziaria nel suo complesso” non equivale sempre a “conosciuto dall’ufficio accertatore”. La Cassazione ordinanza n. 10226/2024 ha precisato che anche dati già noti ad un diverso ufficio o ente (es. alla Guardia di Finanza, o ad altro ufficio dell’Agenzia) possono costituire ‘nuovi elementi’ per l’ufficio che emette l’integrativo, se non erano effettivamente a disposizione di quest’ultimo al momento dell’accertamento originario. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un secondo avviso pochi giorni dopo il primo, basandolo su risultanze investigative della GdF non ancora trasmesse all’ufficio accertatore durante il primo atto; la Corte ha ritenuto legittimo l’integrativo, poiché l’ufficio non era in possesso di quei dati prima, e ciò soddisfa il requisito della novità. Dunque, in giudizio potrebbe doversi valutare in concreto quando e da chi erano conoscibili le informazioni: il contribuente, per contestare l’atto, potrà cercare di dimostrare che i supposti “nuovi elementi” erano in realtà già noti o segnalati all’Amministrazione prima dell’accertamento principale. Se riesce a provarlo, l’avviso integrativo sarà annullato per violazione dell’art. 43 DPR 600/73.
Esempio pratico: Tizio riceve un accertamento integrativo per il 2020, con cui l’Agenzia gli contesta ulteriori €50.000 di ricavi non dichiarati emersi da nuovi controlli bancari. Già un anno prima Tizio aveva subito un accertamento (definito in adesione) basato su un PVC che riportava anche estratti conto. Nel ricorso contro l’integrativo, Tizio rileva che quei conti bancari erano già stati esaminati dalla Guardia di Finanza nel PVC originario: non c’è nulla di “sopravvenuto”. L’onere passerà all’Ufficio: se i nuovi €50.000 provengono in realtà da movimenti bancari già noti nel primo controllo (magari semplicemente non contestati allora), l’integrativo sarà illegittimo. Viceversa, se si tratta di altri conti scoperti successivamente (ad esempio tramite indagini partite dopo l’adesione), l’atto regge: quei dati sono nuovi in senso proprio.
Termine di decadenza: fino a quando può arrivare l’integrativo?
L’accertamento integrativo non estende i tempi dell’accertamento: deve rispettare i medesimi termini di decadenza previsti per l’accertamento “ordinario” relativo a quel periodo. Entro quando l’Agenzia può quindi notificare un integrativo? In generale, i termini attuali (a regime dopo le modifiche della legge di Stabilità 2016) sono:
- 5 anni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale, per avvisi riguardanti periodi in cui la dichiarazione è stata regolarmente presentata (termine al 31 dicembre del quinto anno successivo).
- 7 anni dal termine di presentazione, se per quel periodo la dichiarazione fiscale è stata omessa oppure è considerata nulla (termine al 31 dicembre del settimo anno successivo).
Questi termini si riferiscono a imposte dirette e IVA (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72) e valgono per i periodi dal 2016 in poi, a seguito dell’estensione di un anno introdotta dalla L. 208/2015. In precedenza, per i periodi d’imposta fino al 2015, il termine era di 4 anni (dichiarazione presentata) o 5 anni (omessa). La modifica ha creato un regime transitorio: ad esempio, anno d’imposta 2015 (dichiarazione 2016) si prescriveva al 31/12/2020, mentre anno d’imposta 2016 (dichiarazione 2017) si prescrive al 31/12/2023 (5° anno) se dichiarazione presentata, oppure al 31/12/2024 (7° anno) se omessa. La seguente tabella riepiloga i termini di decadenza per le annualità più recenti:
Tabella 1 – Termini di notifica degli avvisi di accertamento (ordinari o integrativi)
| Periodo d’imposta | Dichiarazione | Termine ordinario (dich. presentata) | Termine omessa dichiarazione |
|---|---|---|---|
| Fino al 2015 | Dich. 2016 o prec. | 4° anno successivo (es: 31/12/2020 per il 2015) | 5° anno successivo (es: 31/12/2021 per il 2015) |
| Dal 2016 in poi | Dich. dall’2017 | 5° anno successivo (es: 31/12/2024 per il 2018) | 7° anno successivo (es: 31/12/2025 per il 2018) |
Nota: In caso di dichiarazione integrativa a favore presentata dal contribuente, la legge (art. 43-bis DPR 600/73) prevede lo slittamento di 1 anno dei termini di accertamento limitatamente agli elementi integrati. Inoltre, eventi eccezionali (es. la sospensione COVID nel 2020) hanno in passato prorogato alcuni termini di decadenza – ma al 2025 tali effetti straordinari si possono considerare esauriti.
Un avviso di accertamento integrativo deve dunque arrivare entro i suddetti limiti. Ad esempio, per l’anno d’imposta 2019 (dichiarazione presentata a giugno 2020), il termine era il 31 dicembre 2025: oltre quella data non può esserne notificato né l’accertamento “base” né alcun integrativo. La notifica tardiva rende l’atto nullo per decadenza del potere accertativo.
È bene evidenziare che l’integrativo non “eredita” il termine dal primo avviso: conta sempre e solo l’anno oggetto di accertamento. Quindi, anche se l’Amministrazione emette un primo avviso molto prima della scadenza (ad esempio 3 anni prima), l’eventuale integrativo può comunque essere notificato fino al 5°/7° anno. Non esiste un limite di “90 giorni prima della decadenza” o simili – salvo il fatto che, dal 2024, vige l’obbligo di contraddittorio preventivo (vedi oltre) che, se attivato a ridosso della scadenza, posticipa di max 120 giorni il termine finale. Ma in assenza di tale evenienza, basta che l’atto integrativo parta entro il 31 dicembre dell’anno di decadenza perché sia tempestivo.
Esempio: Caio riceve un primo avviso per il 2017 notificato a ottobre 2021. Nel 2022 emergono nuovi elementi e a novembre 2022 l’Agenzia invia un integrativo sul 2017. Il termine di decadenza per il 2017 dichiarato (5 anni) è il 31/12/2023, quindi l’atto del 2022 è tempestivo. Se invece Caio ricevesse un integrativo nel gennaio 2024 (oltre il termine del 31/12/2023), esso sarebbe decaduto e andrebbe annullato. In caso di contestazione, sarà il contribuente a eccepire immediatamente la tardività (indicando data di notifica e riferimento del termine di legge); il giudice, verificata la scadenza, dichiarerà nullo l’avviso per intervenuta decadenza.
Motivazione e contenuto dell’avviso integrativo
Un avviso di accertamento integrativo deve contenere, oltre agli elementi normalmente richiesti in ogni atto impositivo (indicazione del tributo, anno, imponibile accertato, aliquote, maggiore imposta, sanzioni, interessi, istruttoria svolta, ecc.), una motivazione specifica in relazione ai nuovi elementi sopravvenuti. La mancata indicazione di tali elementi comporta la nullità insanabile dell’atto. Questa regola è una garanzia fondamentale per il contribuente: consente di capire perché si subisce un secondo accertamento e su quali basi fattuali. Ad esempio, nell’avviso integrativo dovrà essere chiaramente scritto qualcosa come: “Successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento n. XXX, l’ufficio è venuto a conoscenza – in data … – dei seguenti elementi nuovi: [descrizione dettagliata: es. accrediti su conto estero non comunicato, emersione di documenti contabili extra, etc.]. Tali nuovi elementi derivano da [fonte: es. processo verbale della GDF del …, risposta a rogatoria internazionale, archivio informatico pervenuto il …]. In base a ciò, per l’anno … si accertano ulteriori …”. Una motivazione vaga o tautologica (es. “si emette integrativo per maggiore imponibile emerso”, senza spiegare cosa sia emerso né come) rende l’atto annullabile.
La completezza della motivazione va valutata anche rispetto al rapporto con il primo avviso: l’atto integrativo dovrebbe esplicitare il collegamento o la differenza rispetto all’atto precedente. Talvolta l’integrativo è denominato come “avviso di accertamento n. XY integrativo dell’avviso n. XZ” e richiama il precedente per relazione. Non è strettamente richiesto indicare gli importi già accertati in origine, ma è buona prassi farlo per chiarezza (specie se il calcolo di sanzioni e interessi cumulati può creare confusione). In ogni caso, l’integrativo non annulla il precedente: quest’ultimo resta valido per la parte di imponibile originariamente contestata. Se invece l’intento dell’ufficio fosse di correggere il primo avviso (ad esempio annullandolo in parte e sostituendolo con importi diversi), non siamo nell’ambito dell’integrativo, bensì – potenzialmente – di un’autotutela sostitutiva (che però dal 2024, come detto, può avvenire solo se favorevole al contribuente). In pratica, l’integrativo aggiunge nuova pretesa tributaria oltre a quella del primo avviso, e deve motivare il perché di questa aggiunta straordinaria.
Casi di illegittimità dell’accertamento integrativo
Riassumendo i requisiti visti sopra, possiamo schematizzare alcune situazioni tipiche in cui un accertamento integrativo risulta viziato e dunque annullabile, se il contribuente le fa valere in sede di ricorso:
- Mancanza di nuovi elementi: se l’atto si fonda su fatti già noti all’ufficio in sede di primo accertamento (o conoscibili con normale diligenza), oppure se non indica affatto quali sarebbero questi elementi sopravvenuti, esso è illegittimo. Esempio: integrativo emesso “a tavolino” pochi giorni dopo il primo avviso, senza che nulla di nuovo sia intervenuto – la Cassazione ha confermato l’annullamento in casi simili. L’ufficio non può semplicemente rimediare a una carenza istruttoria inviando un secondo atto.
- Difetto di motivazione sui nuovi elementi: collegato al punto precedente, se l’avviso non specifica (o lo fa in modo generico/insufficiente) quali nuovi elementi giustificano la rettifica in aumento, è nullo per violazione dell’art. 43 DPR 600/73.
- Notifica oltre i termini di decadenza: qualsiasi avviso (anche integrativo) notificato oltre il termine ultimo previsto (5° o 7° anno) è radicalmente nullo. La tardività va eccepita dal contribuente nel ricorso introduttivo e il giudice la rileva, comportando l’annullamento integrale dell’atto impositivo per decadenza.
- Violazione del contraddittorio endoprocedimentale (quando obbligatorio): dal 2024, come vedremo meglio più avanti, la legge impone all’ufficio di attivare il contraddittorio preventivo prima di emettere la gran parte degli avvisi di accertamento (integrativi compresi, in generale), salvo eccezioni. Se l’Agenzia delle Entrate non ha invitato il contribuente a interloquire nei casi in cui era tenuta a farlo, l’avviso emesso potrebbe essere dichiarato annullabile per violazione del procedimento – a condizione che il contribuente sollevi tale motivo nel ricorso (non è rilevabile d’ufficio). Ad esempio, se l’ufficio emette integrativo nel 2025 senza aver inviato il previo invito a comparire nonostante non ricorressero situazioni di urgenza o atti automatizzati, il contribuente potrà far valere l’omesso contraddittorio come vizio procedurale.
- Altri vizi formali o sostanziali: l’avviso integrativo, al pari di ogni atto impositivo, può essere affetto da altri vizi (errata intestazione, mancanza di firma del capo ufficio, notifica inesistente, errori sul soggetto passivo, ecc.). Questi esulano dalla specificità “integrativa” ma costituiscono comunque motivi di nullità/annullabilità. Vanno valutati caso per caso (ad es., se l’avviso integrativo viene notificato al contribuente sbagliato o reiterando un’imposta già corrisposta – casi non comuni ma possibili – esso è ovviamente contestabile per tali ragioni).
Riepilogo dei principali requisiti e vizi:
| Requisito legittimità | Se non rispettato | Effetto sull’avviso integrativo |
|---|---|---|
| Nuovi elementi conosciuti dopo il primo atto | Nessun elemento realmente sopravvenuto, oppure elementi già noti prima | Atto illegittimo (violazione art. 43 DPR 600/73) |
| Indicazione dettagliata dei nuovi elementi | Mancata o insufficiente indicazione | Nullità dell’atto per difetto di motivazione |
| Termine di notifica entro decadenza | Notifica oltre il termine previsto | Nullità per decadenza (atto inefficace) |
| Contraddittorio endoprocedimentale (se dovuto) | Omesso contraddittorio preventivo | Annullabilità per vizio procedurale (se eccepito) |
| Competenza e altre formalità (firma, motivi ecc.) | Errori su soggetto competente, firma mancante, motivazione incoerente, ecc. | Nullità/Annullabilità a seconda del vizio (es. nullità se atto non firmato dal funzionario competente) |
Come si vede, i primi tre profili (nuovi elementi, motivazione e termini) attengono proprio alla natura dell’integrativo e sono quelli su cui più spesso ci si focalizza per verificarne la legittimità. Dal punto di vista difensivo, il contribuente che riceve un integrativo dovrà immediatamente controllare questi aspetti e, se riscontra irregolarità, farle valere tempestivamente. Nel prosieguo della guida vedremo come muoversi in concreto e quali strumenti utilizzare per tutelarsi.
La fase istruttoria: rapporti con l’Agenzia delle Entrate prima dell’avviso
Un elemento cruciale per prevenire o comunque gestire al meglio un accertamento (anche integrativo) è la fase istruttoria, ossia quel periodo in cui l’Amministrazione finanziaria raccoglie informazioni, documenti e riscontri sul contribuente, prima di emettere l’atto impositivo. Dal punto di vista del contribuente (“debitore”), è importante conoscere i propri diritti e doveri durante questa fase e collaborare strategicamente con l’ufficio, al fine di evitare, se possibile, un secondo accertamento o di porre solide basi difensive qualora l’atto venga comunque notificato.
Vediamo i principali aspetti dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate in fase pre-accertativa, alla luce anche delle più recenti riforme (2023/2024) che hanno ampliato le garanzie di partecipazione del contribuente al procedimento.
Comunicazioni, inviti e contraddittorio preventivo
Tradizionalmente, prima di emettere un avviso di accertamento l’ufficio può interagire col contribuente attraverso vari strumenti: questionari, inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, processi verbali di constatazione (PVC) in caso di verifica sul campo, ecc. Questi atti istruttori sono previsti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) e dal DPR 600/1973: ad esempio, l’art. 32 DPR 600 consente di inviare questionari o inviti a produrre documenti; l’art. 33 impone a Agenzia Entrate e Guardia di Finanza di scambiarsi informazioni, e così via.
Una garanzia fondamentale sancita dallo Statuto (art. 12, c.7 L.212/2000) riguarda le verifiche fiscali sul luogo (es. accessi in azienda della GdF): il contribuente ha diritto, una volta chiusa la verifica e ricevuto il PVC, ad almeno 60 giorni di tempo per presentare osservazioni e memorie difensive, prima che l’ufficio possa emettere l’avviso di accertamento. L’eventuale notifica dell’atto ante tempus (cioè senza aspettare i 60 giorni) lo rende nullo, salvo casi di particolare e motivata urgenza (come il fondato pericolo per la riscossione). Questo contraddittorio “endoprocedimentale” post-PVC è una tutela importante, perché consente al contribuente di contestare le risultanze della verifica e magari convincere l’ufficio a non emettere accertamento su alcuni punti o a rettificarne il contenuto.
Oltre a ciò, fino a pochi anni fa non vi era un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti “a tavolino” (ossia basati su controlli d’ufficio senza accessi). La giurisprudenza nazionale (Cass. SS.UU. 24823/2015) aveva ritenuto che, in assenza di una norma specifica, il contraddittorio non fosse obbligatorio tranne che nei casi previsti (come appunto i PVC da verifica in loco, o per alcuni tributi UE come i dazi doganali) – a differenza di quanto affermato invece dalla Corte di Giustizia UE che vede nel contraddittorio un principio generale. Questa situazione però è mutata con la riforma del 2023. Il D.Lgs. 218/2023 (attuativo della delega fiscale, L. 130/2022) ha introdotto un nuovo art. 6, comma 3-bis, dello Statuto del Contribuente, che estende l’obbligo di contraddittorio preventivo a tutti gli atti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e atti di recupero) emessi dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dal tributo e dal tipo di controllo. Fanno eccezione soltanto:
- i controlli automatici e formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73, 54-bis DPR 633/72) e altri atti “automatizzati” individuati da un DM (in pratica, le comunicazioni di irregolarità e simili – che non riguardano accertamenti veri e propri);
- i casi di motivata urgenza per pericolo per la riscossione (ad esempio, rischio concreto di fuga del contribuente o depauperamento dei beni).
Al di fuori di queste ipotesi, prima di emettere l’avviso l’ufficio deve notificare al contribuente una comunicazione di avvio del procedimento contenente uno schema di atto impositivo e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni e difese. Entro lo stesso termine il contribuente può anche richiedere un incontro (di solito formalizzato come invito al contraddittorio) per discutere la pretesa e, se del caso, attivare la procedura di accertamento con adesione (vedi oltre). Durante questi 60 giorni l’atto definitivo non può essere emesso. Se però il termine di decadenza è imminente e cadrebbe prima dei 60 giorni, la norma consente all’ufficio di notificare comunque lo schema di atto e posticipare la scadenza dell’accertamento di 120 giorni oltre il termine decadenziale, per dare modo di espletare il contraddittorio.
Questa procedura deve essere effettiva e sostanziale, non una mera formalità: l’ufficio è tenuto a esaminare le osservazioni presentate e a motivare nell’eventuale avviso definitivo le ragioni per cui decide di non accoglierle. In caso ideale, il dialogo può portare anche all’archiviazione totale o parziale della pretesa, evitando l’emissione dell’atto se il contribuente fornisce chiarimenti risolutivi.
Impatto sugli accertamenti integrativi: questa nuova disciplina del contraddittorio si applica anche agli avvisi integrativi. Dunque, dal 2024 in poi, se l’Agenzia intende emettere un integrativo, dovrà in generale prima inviare un “invito al contraddittorio” con allegato lo schema di atto integrativo, attendere i 60 giorni per eventuali controdeduzioni, e solo poi notificare l’avviso integrativo definitivo. L’inosservanza di tale obbligo espone l’atto alla sanzione di annullabilità in giudizio. È importante, tuttavia, che il contribuente eccepisca nel ricorso l’omessa attivazione del contraddittorio (se avvenuta), altrimenti tale vizio procedurale non potrà più essere fatto valere (la legge lo qualifica come causa di annullabilità relativa, non rilevabile d’ufficio dal giudice).
In pratica, oggi il contribuente è più protetto rispetto al passato: anche per un accertamento integrativo è probabile che venga convocato prima di ricevere l’atto, con la possibilità di discutere e difendersi, magari fornendo elementi che evitino l’emissione dell’integrativo (ad esempio dimostrando che i “nuovi elementi” non sono tali, o che certe somme sono esenti/tassate altrove, ecc.). È fortemente consigliato sfruttare questo spazio di interlocuzione: presentarsi all’incontro (anche con il supporto di un consulente o difensore), presentare memorie scritte, chiarire eventuali fraintendimenti. Ciò può portare, nei casi migliori, a un ripensamento dell’Ufficio (archiviazione o riduzione dei rilievi). Oppure, se l’atto verrà comunque emesso, il contribuente avrà già posto in atti le sue difese, che torneranno utili in un eventuale contenzioso.
Vale la pena segnalare che, oltre al contraddittorio “formale” appena descritto, esistono altre forme di interlocuzione durante l’istruttoria: ad esempio, se si riceve un questionario dall’Agenzia (che chiede spiegazioni o documenti su specifiche operazioni), rispondere in modo completo e documentato può evitare che l’ufficio proceda con un accertamento. Anche la collaborazione in sede di verifica (fornire i documenti richiesti, spiegare le voci anomale, ecc.) è fondamentale: un contribuente cooperativo durante l’audit fornisce meno appigli per successive contestazioni. In sintesi, mantenere un dialogo aperto e trasparente con l’Amministrazione, nei limiti del possibile, è spesso la strategia migliore per prevenire sviluppi sfavorevoli.
Documentazione e nuove scoperte: come nascono gli integrativi
Da dove provengono tipicamente i “nuovi elementi” che danno luogo a un accertamento integrativo? Comprenderlo aiuta il contribuente a monitorare la propria posizione ed eventualmente anticipare le mosse del Fisco. Le situazioni frequenti sono:
- Indagini finanziarie successive: può accadere che dopo un primo accertamento (specie se definito in adesione, quindi senza contenzioso), l’ufficio prosegua l’istruttoria su altri fronti. Un caso classico: a seguito di segnalazioni, vengono autorizzate indagini bancarie sui conti del contribuente (o di familiari/società collegate) che non erano state effettuate prima. Se da queste analisi emergono ulteriori versamenti non giustificati, l’Agenzia può emettere un integrativo basato sulle movimentazioni scoperte. È quanto avvenuto ad esempio nella vicenda decisa dalla Cassazione 10817/2023: dopo un accordo di adesione su un primo PVC, la GdF svolge nuove verifiche bancarie e fornisce elementi per un integrativo, ritenuto legittimo in presenza di fatti nuovi sopraggiunti.
- Incrocio di banche dati e nuove informazioni esterne: l’Amministrazione finanziaria aggiorna costantemente le proprie banche dati. Un integrativo può scaturire da dati arrivati successivamente da altre autorità: es. un elenco di clienti/fornitori rilevato in un’altra indagine, informazioni ottenute via scambio internazionale (pensiamo ai dati sul conto estero X arrivati grazie alla cooperazione fiscale internazionale), o esiti di un processo penale nel frattempo conclusosi con elementi utili al fisco. Se tali dati riguardano il periodo già accertato e ne aumentano la base imponibile, l’ufficio li considererà “nuovi” e li utilizzerà.
- Errori o omissioni riscontrati dal contribuente stesso: curiosamente, può succedere che sia il contribuente, in una fase successiva, a presentare dichiarazioni integrative “a favore” o istanze di rimborso che segnalano importi differenti. In teoria questo potrebbe offrire all’ufficio spunti per rivedere in peius la posizione (anche se è più raro). Comunque, se un contribuente evidenzia elementi mai dichiarati prima, quella comunicazione potrebbe costituire un nuovo elemento per l’Amministrazione.
- Segnalazioni di altri Enti o reparti interni: un Comune che segnala all’Agenzia, con ritardo, una plusvalenza immobiliare non registrata; l’INPS che comunica contributi non versati (rilevanti ai fini fiscali), ecc. – tutte queste info, se arrivano post accertamento originario, possono alimentare integrativi. All’interno dell’Agenzia stessa, talvolta i reparti antifrode o l’Anagrafe tributaria fanno emergere dati che l’ufficio periferico ignorava durante il primo controllo.
- Evasione parziale scoperta a posteriori: se il contribuente, ad esempio, ha nascosto più redditi ma durante la prima verifica ne sono stati scoperti solo alcuni, ulteriori investigazioni protratte nel tempo potrebbero far emergere il resto. Il fisco può aver voluto colpire subito la parte certa con un accertamento (magari parziale), e intanto continuare a scavare per il residuo. In questi casi, se l’azione accertatrice iniziale non era qualificabile come “parziale” in senso tecnico, l’ufficio per recuperare gli ulteriori redditi dovrà comunque rispettare l’art. 43 e quindi configurare un integrativo con nuovi elementi.
Per il contribuente, essere consapevole di questi meccanismi significa: non abbassare la guardia dopo aver ricevuto un primo avviso (specie se sono note altre potenziali irregolarità non contestate che potrebbero venire a galla), e cercare di chiudere in modo più ampio possibile eventuali accordi. Ad esempio, se si aderisce a un accertamento, valutare se pretendere dall’ufficio una dichiarazione liberatoria su tutti gli aspetti controllati, per evitare sorprese. Tuttavia, come vedremo, la legge stessa prevede alcune tutele in tal senso quando c’è stata una definizione con adesione.
Accertamento con adesione e integrativo: attenzione alle eccezioni
Un caso particolare di interazione tra contribuente e ufficio è l’Accertamento con Adesione (disciplinato dal D.Lgs. 218/1997). Si tratta di una procedura deflattiva del contenzioso in cui il contribuente, ricevuto un avviso (o un PVC), può avviare un confronto con l’ufficio per giungere a un accordo transattivo sull’imponibile e sulle imposte, beneficiando di sanzioni ridotte (1/3 del minimo) e chiudendo la pendenza. Ora, se un contribuente definisce in adesione un primo avviso, può l’Amministrazione in seguito emettere un integrativo sullo stesso periodo? Il principio generale sarebbe di no, perché l’adesione dovrebbe “pacificare” completamente l’anno accertato. Tuttavia, vi sono eccezioni espressamente previste dalla legge. L’art. 2, comma 4, D.Lgs. 218/97 stabilisce che la definizione per adesione non preclude un ulteriore accertamento (entro i termini di legge) nelle seguenti ipotesi:
- (a) Sopravvenienza di nuovi elementi di cui l’ufficio non era a conoscenza al momento dell’adesione, purché tali elementi configurino un’evasione superiore al 50% dell’imponibile accertato con l’atto definito e a più di €77.468 (importo fissato dalla norma). Questa soglia intende evitare che per piccoli scostamenti si possano riaprire annualità già definite. Se però emergono elementi rilevanti che superano tali margini, l’ufficio può procedere con un integrativo. È la situazione standard: nuovi fatti importanti = integrativo ammesso (questa previsione è in linea col concetto di nuovi elementi visto finora).
- (b) Accertamento parziale definito con adesione: se l’atto definito era un accertamento parziale (ex art. 41-bis) e il contribuente lo ha chiuso in adesione, ciò non impedisce ulteriori accertamenti sullo stesso periodo, indipendentemente da nuovi elementi. In pratica, la legge chiarisce al contribuente che definire un parziale non gli garantisce che quell’anno sia “blindato”: l’ufficio può comunque emettere un altro avviso (anche generale) per altri imponibili residui. Questa è esattamente la situazione esaminata dalla Cassazione, ord. n. 788/2025: una società aveva definito in adesione un primo accertamento parziale su interessi attivi; l’ufficio poi emise un secondo avviso (parziale) per interessi passivi indeducibili. La CTR lo annullò sostenendo che servivano nuovi elementi sopravvenuti, ma la Cassazione ha cassato tale decisione, affermando il principio che nel caso di accertamento parziale definito, un successivo accertamento è consentito ex lege senza necessità di nuovi elementi (in base alla lettera b) dell’art. 2, c.4 cit.). Dunque, in presenza di primo atto parziale, l’integrativo in senso tecnico nemmeno è soggetto al vincolo dei nuovi elementi – perché la fattispecie rientra in un’altra categoria prevista dalla legge.
- (c) Redditi di partecipazione in società di persone o accertamenti a carico di soggetti collegati: la lettera c) di art. 2, c.4 contempla i casi in cui, definito con adesione l’accertamento su una società di persone (trasparenza fiscale) o su un soggetto legato, ciò non impedisce accertamenti correlati su altri soggetti per lo stesso periodo. Ad esempio, se un socio definisce il proprio maggior reddito da partecipazione, l’ufficio può accertare la società per rettificare i redditi totali. Oppure se Tizio definisce un accertamento IRPEF che includeva redditi di una sua ditta, l’ufficio potrebbe accertare separatamente l’IVA di quella ditta. Insomma, questa previsione mira a evitare che l’adesione di un soggetto “copra” situazioni connesse riguardanti altri soggetti o altri tributi.
Al di fuori di queste ipotesi, la regola è che l’adesione preclude ulteriori accertamenti sul medesimo periodo d’imposta e tributo. In pratica, se il contribuente ha firmato un accordo di adesione su un avviso di accertamento ordinario (non parziale) e non emergono elementi nuovi di una certa rilevanza, non dovrebbero più arrivare integrativi. Si noti: “non emergono elementi nuovi” implica che se emergono, si ricade nella lettera a). Quindi in realtà la distinzione chiave è: accertamento definito completo → serve comunque nuovo elemento (cfr. lett. a) per avere integrativo; accertamento definito parziale → vale la lettera b), integrativo senza nuovi elementi ammesso.
Suggerimento pratico: se state definendo un accertamento con adesione, chiedete chiarimenti all’ufficio circa la portata dell’accordo. In alcuni verbali di adesione viene inserita una frase del tipo “la definizione ha per oggetto i rilievi XYZ e non preclude l’emissione di ulteriori atti ai sensi dell’art.2 c.4”. Non è piacevole leggerlo, ma almeno chiarisce le intenzioni. Se possibile, cercate di estendere l’adesione a tutti gli aspetti già emersi (ad esempio, se l’ufficio ha in corso accessi bancari, concordate di attendere l’esito e fare un unico accordo globale). Ricordate comunque che, in caso di integrativo post-adesione, valgono sempre le regole generali: l’atto dovrà indicare i nuovi elementi sopravvenuti dopo l’adesione e rispettare i termini. Se l’ufficio tenta di riaprire questioni già note al momento dell’adesione, il contribuente avrà buone chance di far annullare l’integrativo per violazione dell’accordo e assenza di novità. In giurisprudenza, situazioni borderline sono arrivate: ad esempio, Cass. 10817/2023 (citata sopra) ha confermato legittimo un integrativo post-adesione basato su nuovi PVC bancari; di contro, Cass. 21992/2015 (e altre) hanno annullato integrativi quando l’ufficio aveva semplicemente rivalutato diversamente gli stessi fatti già oggetto dell’adesione (tentando di “fare il bis” senza vere novità).
Come difendersi da un avviso di accertamento integrativo: strategie e strumenti
Passiamo ora al cuore pratico della guida: cosa deve (e può) fare un contribuente che si vede notificare un avviso di accertamento integrativo. Affronteremo la questione in ordine logico-temporale:
- Verifiche preliminari sull’atto – da compiere subito, all’arrivo dell’avviso.
- Scelta della via difensiva – strumenti deflativi (adesione, acquiescenza, autotutela) o diretto ricorso in giustizia tributaria.
- Tutela nel processo – come impostare il ricorso, richiedere sospensione, ecc., in caso si vada in contenzioso.
- Casi particolari – gestione degli importi richiesti, pagamenti frazionati, definizioni agevolate ove esistenti.
Vedremo ogni punto in dettaglio, tenendo presente che l’obiettivo è annullare o ridurre la pretesa fiscale indebita, oppure comunque mitigarne gli effetti (ad esempio tramite riduzioni sanzioni, dilazioni di pagamento).
1) Verifiche preliminari appena ricevuto l’avviso
Quando viene notificato un avviso di accertamento integrativo (in genere tramite PEC, raccomandata o ufficiale giudiziario), il contribuente deve attivarsi prontamente. I passi immediati consigliati sono:
- Controllare la data di notifica e segnare le scadenze: la prima cosa è stabilire con certezza il giorno di notifica dell’atto (farà fede, a seconda dei casi, la ricevuta PEC, l’avviso di ricevimento postale, o la data riportata dall’ufficiale giudiziario/messo). Da essa decorrono i 60 giorni per impugnare l’avviso davanti alla giustizia tributaria. Inoltre, se si intende eventualmente presentare un’istanza di accertamento con adesione, quella va fatta entro lo stesso termine di 60 giorni – ma ricordiamo che presentandola si ottiene una sospensione di 90 giorni dei termini di ricorso. Annotare anche la scadenza dei 60 giorni per il pagamento (termine entro cui, se non si presenta ricorso, bisogna pagare per evitare successiva iscrizione a ruolo). Attenzione ai mesi estivi: dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi (c.d. sospensione feriale), quindi una notifica a luglio allunga la scadenza utile. Esempio: avviso notificato il 10 luglio – i 60 gg arriverebbero al 8 settembre, ma dal 1 al 31 agosto sono sospesi, quindi la scadenza effettiva diviene il 8 ottobre.
- Leggere attentamente la motivazione e gli elementi nuovi addotti: confrontare quanto scritto nell’avviso integrativo con il precedente atto (se disponibile). Verificare quali nuovi elementi l’ufficio dichiara di aver scoperto, e quando/come li ha ottenuti. Questo è cruciale per valutare se i presupposti di legge sono rispettati. Ad esempio, se l’atto dice: “a seguito di indagini bancarie autorizzate il 10/01/2024 si accertano ulteriori ricavi…” – allora sappiamo che la novità temporale c’è (indagine post accertamento originario). Se invece leggiamo motivazioni fumose, ad esempio: “si è ritenuto di rideterminare in aumento il reddito d’impresa tenuto conto di ulteriori elementi emersi” senza ulteriori dettagli, siamo di fronte a un probabile difetto di motivazione.
- Verificare la presenza di eventuali vizi formali evidenti: ad esempio, l’atto è firmato dal capo ufficio o da altro funzionario delegato? (la mancanza di firma o firma di soggetto non titolato può invalidarlo); è stato notificato al contribuente giusto (persona fisica, società, eredi, ecc.)? contiene gli allegati citati? (se nell’avviso si menziona un PVC GdF, in teoria andrebbe allegato, o comunque deve essere già noto al contribuente); riporta il calcolo dettagliato di imposte e sanzioni? (una motivazione carente sul quantum può essere contestata).
- Verificare il rispetto dei termini di decadenza e procedurali: controllare l’anno d’imposta oggetto dell’accertamento e la data di notifica rispetto ai termini di legge (vedi Tabella 1 sopra). Se risulta notificato oltre il termine decadenziale, si ha già un motivo di ricorso semplice e “assoluto”. Inoltre, valutare se l’ufficio ha rispettato il contraddittorio: avete ricevuto un invito a comparire o una comunicazione prima dell’avviso? Se l’integrativo arriva senza alcun preavviso ma magari riguarda un accertamento completamente nuovo (non semplicemente la prosecuzione di un PVC per cui i 60 gg erano già stati dati), potrebbe profilarsi l’omissione del contraddittorio obbligatorio (per gli atti dal 2024, come detto).
- Quantificare gli importi e le eventuali sovrapposizioni: l’integrativo potrebbe contenere importi aggiuntivi che sommandosi a quelli già richiesti col primo atto danno un totale considerevole. Bisogna capire se l’Agenzia ha tenuto conto di quanto eventualmente già pagato o definito con il primo accertamento. In linea di massima, l’integrativo dovrebbe riferirsi solo al nuovo, quindi ad esempio se il primo avviso chiedeva €50.000 e l’integrativo chiede altri €20.000, il contribuente non deve pagare nuovamente i 50 (ma solo i 20, salvo ovviamente gli interessi/sanzioni su quei 20). Tuttavia, è opportuno verificare che non vi siano errori di duplicazione. In caso di dubbi, si può anche contattare l’ufficio per chiarimenti sul calcolo.
Completate queste verifiche, il contribuente (magari con l’ausilio di un fiscalista o avvocato) potrà farsi un’idea della forza dell’accertamento e delle eventuali ragioni oppositive. A questo punto occorre decidere come procedere: pagare, cercare un accordo o fare ricorso. Ne discutiamo nei prossimi paragrafi.
2) Possibili azioni difensive: autotutela, adesione, acquiescenza
Prima di arrivare al contenzioso, esistono diverse opzioni “deflattive” che consentono di evitare o limitare il ricorso e talvolta di ridurre sanzioni o ottenere sconti. Esaminiamo le principali:
a) Richiesta di autotutela: L’autotutela è, come detto, il potere dell’ente impositore di annullare o rettificare i propri atti senza bisogno del giudice. Il contribuente che ritenga l’accertamento integrativo palesemente illegittimo (ad es. per errore di persona, doppia imposizione, errore di calcolo, ecc.) può presentare istanza di autotutela all’ufficio, esponendo i motivi e chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’avviso. Con la riforma 2023, l’autotutela è stata rafforzata: l’art. 10-quater L.212/2000 ora elenca i casi di autotutela obbligatoria (atti manifestamente illegittimi che l’ufficio deve annullare: errore su persona, errore di calcolo, errore sul presupposto d’imposta, doppia imposizione palese, ecc.). Se l’integrativo rientra in uno di questi casi (ad esempio, richiede un’imposta già pagata con il primo avviso, configurando doppia imposizione, oppure è intestato al soggetto sbagliato), l’ufficio dovrebbe attivarsi d’ufficio. In ogni caso, l’istanza di parte è utile per segnalare il problema. L’autotutela facoltativa (art. 10-quinquies) resta possibile in altre circostanze, ma solo in bonam partem: significa che difficilmente l’ufficio userà l’autotutela per togliere un avviso se nutre dubbi interpretativi (non essendo obbligato). L’istanza di autotutela non sospende né interrompe i termini di ricorso o pagamento, e il rifiuto (espresso o tacito) è ora impugnabile in Commissione Tributaria ma solo per i casi obbligatori. Quindi è uno strumento che va usato con cautela: presentare autotutela non evita di dover fare ricorso entro 60 giorni, a meno che l’ufficio annulli l’atto nel frattempo. Dunque, consigliamo: presentare istanza di autotutela immediatamente se si ravvisa un vizio macroscopico; ma parallelamente prepararsi al ricorso, salvo conferma scritta dell’annullamento prima della scadenza. In caso di accoglimento (l’ufficio annulla), il problema è risolto senza contenzioso.
b) Istanza di accertamento con adesione: L’accertamento con adesione è uno strumento molto utile di difesa ante giudizio. Consiste nel presentare, entro i 60 giorni dalla notifica dell’avviso, un’istanza di adesione all’ufficio (Direzione Provinciale) che ha emesso l’atto. Questa istanza – anche semplicemente in carta libera citando gli estremi dell’avviso – ha due effetti automatici: sospende per 90 giorni i termini per impugnare, e induce l’ufficio a convocare il contribuente per avviare la procedura di adesione (generalmente con un invito a comparire). Nel corso dell’adesione, contribuente e funzionari dell’AE discutono i rilievi e cercano una mediazione sulle somme dovute. Si tratta di una negoziazione: l’ufficio può rivedere parzialmente le pretese (ad esempio riconoscendo alcune spese, riducendo ricavi presunti, ecc.) e il contribuente può accettare di pagare quanto concordato. Se si raggiunge l’accordo, si sottoscrive un atto di adesione con i nuovi importi; il contribuente dovrà poi versare quanto concordato entro 20 giorni (in unica soluzione o prima rata) e beneficerà delle sanzioni ridotte ad 1/3 (invece che intere). L’adesione chiude ogni pendenza sull’atto (diventa definitivo e non più impugnabile).
Nel contesto di un integrativo, l’adesione può essere molto opportuna soprattutto se parte della pretesa è riconosciuta come fondata, ma si vogliono ridurre sanzioni e trovare un compromesso sul resto. Ad esempio, se l’integrativo contesta €100k di imponibile su basi discutibili, il contribuente potrebbe puntare in adesione a far ridurre la contestazione a magari €50k, evitando il contenzioso lungo, e pagando sanzioni ridotte. Attenzione: aprire un’adesione non significa ammettere la colpa; è semplicemente un tentativo di definizione. Si può sempre abbandonare la trattativa se non soddisfa, senza perdere il diritto di far ricorso (che riprenderà a decorrere terminati i 90 giorni sospesi). Durante quei 90 giorni l’ufficio non può iscrivere a ruolo le somme, quindi c’è un congelamento anche sul fronte riscossione.
Da luglio 2024 in poi, la procedura di adesione è stata integrata nel contesto del contraddittorio obbligatorio: quando l’ufficio invia l’invito al contraddittorio (schema atto), deve contestualmente invitare il contribuente anche a valutare la definizione in adesione. In pratica, contraddittorio e adesione possono convergere. Se avete già avuto un invito e discussione pre-avviso, è comunque possibile chiedere l’adesione dopo la notifica formale (magari la posizione dell’ufficio è più chiara e si vuole addivenire a transazione).
Vantaggi dell’adesione: sospende i termini di ricorso (dando più tempo per prepararsi), può evitare del tutto il giudizio se accordo, riduce significativamente le sanzioni (1/3 invece del 100% in caso di soccombenza in giudizio). Svantaggi: se non si trova un accordo, il tempo comunque passa (ma c’è la sospensione ad hoc), e intanto gli interessi sul dovuto maturano; inoltre, per ottenere sconti bisogna pur sempre accettare di pagare qualcosa – non è adatta se si vuole contestare tutto per principio. Strategia: anche se si è propensi ad andare in causa, talvolta presentare l’adesione è utile per capire meglio le prove in possesso dell’ufficio e sondare eventuali aperture. L’importante è non lasciar scadere poi il termine per ricorrere (che come detto sarà prorogato di 90gg).
c) Acquiescenza (definizione agevolata ex art.15 D.Lgs. 218/97): L’acquiescenza consiste nel pagare interamente e tempestivamente quanto richiesto dall’accertamento, beneficiando in cambio di una riduzione delle sanzioni del 1/3. È una scelta adatta se il contribuente riconosce come fondato l’accertamento (o comunque non intende impugnarlo) e vuole semplicemente chiudere il prima possibile risparmiando qualcosa sulle sanzioni. Tecnicamente, per fare acquiescenza occorre: non presentare ricorso entro 60 giorni, pagare le somme (imposte + interessi + sanzioni ridotte a 2/3 del minimo) entro lo stesso termine di 60 giorni. L’avviso integrativo di solito contiene già, nel prospetto liquidazione, l’indicazione dell’importo da versare per definire in acquiescenza. Attenzione: l’acquiescenza impedisce future impugnazioni (equivale a una tacita accettazione dell’atto). Quindi va scelta solo se si è convinti di non aver ragioni valide di contestazione, o magari se le somme sono modeste e non giustificano un contenzioso.
Nel contesto di un integrativo, l’acquiescenza potrebbe essere usata ad esempio se l’ufficio, avendo colto un errore effettivo, chiede una cifra bassa: si paga e pace, evitando aggravi. Talvolta l’acquiescenza può sommarsi a sanatorie: in anni recenti ci sono state definizioni agevolate (condoni) per avvisi non impugnati con pagamento solo imposte, ecc. Al 2025, per integrativi notificati ora, non vi sono specifiche definizioni agevolate di legge (salvo eventuali nuove norme future).
d) Altri strumenti deflattivi: Oltre a quanto sopra, segnaliamo che dopo l’eventuale deposito del ricorso esiste la conciliazione giudiziale (strumento per transare la lite in corso davanti al giudice, con sanzioni ridotte al 50% in primo grado, o al 60% in appello, ex art. 48 D.Lgs. 546/92). Con la riforma 2022-2023, la conciliazione è divenuta anche obbligatoria in certi casi su invito del giudice. Se non si è chiuso prima con adesione, la conciliazione può essere un secondo momento per negoziare col fisco durante il processo.
Ricapitolando le opzioni pre-contenzioso in una tabella:
| Strumento | Cosa comporta | Vantaggi | Svantaggi / Note |
|---|---|---|---|
| Autotutela (istanza d’ufficio) | Richiesta all’ente di annullare l’atto per errori palesi o illegittimità manifeste. Non sospende termini. | Se accolto, annulla subito l’atto senza costi. Con riforma 2023, obbligatorio in casi evidenti. | Discrezionale (soprattutto fuori dai casi obbligatori). Il diniego tacito si può impugnare solo in pochi casi. Va presentata subito e comunque predisposto ricorso in parallelo. |
| Adesione (D.Lgs.218/97) | Istanza entro 60gg → sospensione termini 90gg → incontro con ufficio per accordo. Se accordo: firma e pago con sanzioni 1/3. | Evita giudizio se accordo. Sospende termini, permette dialogo e spesso riduzione imponibile. Sanzioni ridotte (1/3). | Se niente accordo, si riparte con ricorso (tempi più lunghi). Comporta accettare di pagare almeno parte del dovuto. |
| Acquiescenza (art.15 D.Lgs.218) | Pagamento integrale di imposte + interessi + sanzioni ridotte a 2/3 entro 60gg. Rinuncia al ricorso. | Chiude subito la partita. Sanzioni ridotte del 1/3 (paghi 2/3). Niente spese legali, niente processo. | Perdi ogni possibilità di contestare l’atto. Devi avere liquidità per pagare subito. Se emergono errori dopo, non puoi più far nulla (salvo eventuale autotutela). |
| Nessuna azione deflattiva (si va a ricorso) | Non si usa adesione né si paga: si prepara direttamente il ricorso. | Se l’atto ha vizi forti, si punta all’annullamento totale. Si conserva ogni motivo di ricorso. | Niente riduzione sanzioni (potrai avere spese legali, rischi di soccombenza con sanzioni piene). |
Ogni situazione è a sé stante. Consiglio pratico: valutare con lucidità le chances di vittoria in giudizio e il rapporto costi/benefici. Se l’accertamento integrativo appare chiaramente infondato o viziato, conviene preparare un buon ricorso e confidare nell’annullamento totale, magari sfruttando l’adesione solo per guadagnare tempo (senza accordarsi). Se invece la pretesa ha qualche fondamento e l’esito in causa è incerto, forse è meglio tentare l’adesione o la conciliazione, ottenendo sconti sulle sanzioni e limitando il danno, piuttosto che rischiare in tribunale (tenendo a mente che con la nuova legge, perdere in primo grado espone a dover pagare subito tutto, vedi oltre). In ogni caso, non adottare la tattica dell’inerzia: ignorare l’avviso porterebbe a cartelle esattoriali e riscossione forzata, senza aver sfruttato alcuno sconto.
3) Il ricorso al giudice tributario: come impostarlo e cosa aspettarsi
Se si decide (o si arriva alla necessità) di impugnare l’avviso di accertamento integrativo, si entra nell’ambito del processo tributario. Dal 2023, con la riforma operata dalla L. 130/2022, il contenzioso tributario presenta alcune novità importanti, ma resta sostanzialmente strutturato su due gradi di merito: la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) e la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (ex Commissione Regionale), più l’eventuale ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.
Termini e atti introduttivi: come detto, il ricorso va notificato all’ente impositore entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (salvo sospensioni per adesione o feriale). La notifica ormai avviene telematicamente via PEC (Processo Tributario Telematico) oppure, in mancanza, può farsi tramite raccomandata o ufficiale giudiziario. Successivamente, il ricorso notificato va depositato telematicamente presso la CGT (tramite apposito portale) entro 30 giorni. È altamente consigliato affidarsi a un difensore abilitato (avvocato tributarista, dottore commercialista, ecc.), in quanto oltre i €3.000 di valore è obbligatorio. Nel ricorso si devono indicare l’atto impugnato, i motivi di ricorso (i vizi che si lamentano) e le richieste (annullamento totale/parziale).
Motivi di ricorso specifici per integrativo: qui si sfrutta tutto quanto discusso in precedenza. I motivi tipici saranno, ad esempio:
- Violazione dell’art. 43 DPR 600/73 – assenza di nuovi elementi sopravvenuti: da argomentare se, nella vicenda concreta, l’ufficio ha riutilizzato elementi già noti. Si porteranno prove/documenti per mostrare che tali dati erano nel PVC originario, o in atti interni, o addirittura nello stesso primo avviso. Si può citare giurisprudenza (Cass. n….) a sostegno che l’assenza di novità rende nullo l’atto.
- Violazione dell’art. 43 – motivazione insufficiente sui nuovi elementi: se l’avviso non espone chiaramente la novità o non allega gli atti da cui proviene, si eccepirà il difetto di motivazione e la conseguente nullità dell’atto.
- Violazione dei termini di decadenza: se il termine è scaduto, questo motivo da solo dovrebbe far cadere l’atto (si allegano le norme e il calcolo dei termini).
- Violazione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 6, co.3-bis L.212/2000): se applicabile, si argomenta che l’ufficio non ha inviato alcun invito preventivo né osservato i 60 gg, e che ciò ha leso il diritto di difesa del contribuente, comportando annullabilità dell’atto.
- Nel merito – inesistenza della pretesa tributaria aggiuntiva: ovviamente, oltre ai vizi formali, si può contestare anche nel merito la fondatezza dell’accertamento. Ad esempio, se l’integrativo presume ricavi non dichiarati da versamenti bancari, si dimostrerà che quei versamenti erano già tassati altrove o erano movimentazioni infragruppo non imponibili, ecc. Anche in sede di ricorso ci si difende sulla sostanza: il giudice tributario può annullare l’atto anche se ritiene che il maggior imponibile non esiste o è inferiore (in tal caso, annulla o ridetermina). Quindi vanno spiegate tutte le ragioni di fatto e diritto per cui il contribuente ritiene di non dover quei tributi.
Richiesta di sospensione: presentando ricorso, il debito tributario non è automaticamente sospeso. L’Agenzia, decorso il termine di 60 gg dalla notifica, può iscrivere a ruolo 1/3 delle imposte accertate (regola vigente per atti fino al 2022) – ma attenzione: la riforma ha cambiato le cose. Con decorrenza dalle liti instaurate dal 2023, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva al 100%, e pare che anche prima della sentenza l’iscrizione provvisoria sia del 50% dell’imposta (per avvisi emessi dopo il 2022). Per sicurezza, conviene agire come segue: se l’importo è elevato e il pagamento immediato arrecherebbe un danno, il contribuente può richiedere la sospensione dell’atto impugnato (sospensione cautelare). La domanda si fa con istanza motivata da presentare contestualmente al ricorso o anche dopo (entro la prima udienza). Bisogna dimostrare gravi e irreparabili danni dall’esecuzione (es. situazione finanziaria precaria, rischio fallimento se costretto a pagare subito) e il cosiddetto fumus boni iuris (cioè che il ricorso non è pretestuoso ma ha fondamento). La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado fisserà un’apposita udienza entro 30 giorni per decidere sulla sospensione. Se la concede, l’atto è “congelato” (non si possono esigere le somme) fino alla decisione di merito. Se nega, l’Agenzia può procedere a riscuotere nella misura prevista (in passato 1/3, oggi potenzialmente 50% – occorre verificare nel caso concreto quale normativa transitoria si applica).
Iter del giudizio: il processo tributario, specie in primo grado, dura in media 1-2 anni (ma dipende dalla regione, dal carico di lavoro delle corti…). Durante questo periodo, il contribuente può depositare memorie aggiuntive, l’ufficio deposita controdeduzioni, si possono produrre documenti e prove (non testimoniali, perché la testimonianza è vietata, ma documenti sì; anche perizie di parte). All’udienza di merito, il giudice decide se accogliere il ricorso (annullando l’atto in tutto o in parte) oppure respingerlo. Grazie alla riforma, oggi abbiamo in organico anche giudici tributari professionali, c’è un rafforzamento di terzietà, e in caso di questioni tecniche la figura del Consulente Tecnico d’Ufficio è ammessa (prima era dubbio). Quindi il giudice può ad esempio disporre una perizia contabile se necessario.
Esito e costi: se il ricorso viene accolto (anche parzialmente), l’avviso integrativo sarà annullato o ridotto di conseguenza. Il contribuente vincitore può chiedere la rifusione delle spese legali (di regola liquidate secondo tariffe, se c’è soccombenza totale dell’ufficio). Se invece il ricorso viene respinto, la nuova normativa prevede che la sentenza sia esecutiva immediatamente per l’intero importo dovuto. Cosa significa? Che l’Agenzia potrà riscuotere tutte le somme (imposte, sanzioni, interessi) subito dopo la sentenza di primo grado, senza aspettare l’appello, a meno che il contribuente ottenga un’ulteriore sospensione in appello. Ciò rende più “pericoloso” perdere in primo grado rispetto al passato – prima si pagava solo 1/3 e l’eventuale resto dopo, ora si rischia di pagare tutto e poi dover sperare di vincere in appello per avere il rimborso. Infatti, se in appello poi il contribuente vince, l’amministrazione dovrà restituire le somme indebitamente incassate, con interessi. Ma intanto la liquidità potrebbe essere uscita. Questa modifica spinge ancor di più a cercare soluzioni conciliative o ad essere molto sicuri del proprio caso prima di portarlo fino in fondo.
Appello: chi perde in primo grado (totalmente o parzialmente) può appellare la sentenza entro 60 giorni (o 6 mesi se la sentenza non è stata notificata). L’appello, presso la CGT di secondo grado, rivede il merito della causa. Nel frattempo, come detto, la sentenza di primo grado è esecutiva salvo sospensione. In appello valgono procedure analoghe (memorie, udienza, ecc.). Dopo l’appello, l’ultima istanza è la Corte di Cassazione, ma solo per motivi di diritto (non rivede i fatti).
Conciliazione in corso di causa: in qualsiasi momento fino alla decisione di secondo grado, le parti possono trovare un accordo e conciliare la lite: si formalizza con verbale davanti al giudice e si pagano le somme concordate con sanzioni ridotte (40% del totale in primo grado, 50% in appello). La conciliazione chiude il contenzioso e non è più impugnabile. Questa può essere un’opzione se, a processo avviato, emergono possibilità di mediazione (anche alla luce degli orientamenti dei giudici).
Conclusione della difesa giudiziale: l’obiettivo finale è ottenere una sentenza favorevole che annulli l’integrativo (o lo riduca a quanto magari già definito). Se ci si riesce, il contribuente nulla deve (o solo quanto rideterminato). In caso di vittoria definitiva, ha diritto al rimborso di eventuali somme provvisoriamente versate in pendenza di giudizio, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato. Se invece, alla fine, l’esito è sfavorevole, l’accertamento diviene definitivo e si dovrà pagare, oltre alle imposte, anche le sanzioni e interessi. Non di rado, tuttavia, prima di giungere alla fine, subentrano norme di definizione agevolata delle liti pendenti (in passato ve ne sono state nel 2019, 2023, ecc.) che permettono di chiudere pagando magari solo il tributo senza sanzioni se si rinuncia all’appello ecc. È sempre bene tenersi aggiornati: nel 2023, ad esempio, molte controversie pendenti hanno potuto essere chiuse con il pagamento del 90% o 100% del solo imponibile (a seconda dei gradi di giudizio). Al luglio 2025, non v’è una definizione aperta, ma il Legislatore spesso ne introduce.
4) Gestione delle somme in pendenza di giudizio (riscossione frazionata)
Una domanda frequente: “Devo pagare qualcosa subito, anche se faccio ricorso?”. Risposta: sì, in parte, a meno che non si ottenga la sospensione. Il sistema della riscossione frazionata prevede:
- Dopo la notifica dell’avviso (divenuto esecutivo decorsi 60 gg), se il contribuente impugna, l’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) può richiedere intanto una percentuale dell’imposta contestata. Per le liti soggette alla vecchia norma, era 1/3 dopo primo grado e un ulteriore 2/3 dopo il secondo, oltre alle sole sanzioni in misura ridotta fino al secondo grado. Con la riforma 2022, come si diceva, la sentenza di primo grado è esecutiva al 100%, il che lascia intendere che già dopo la notifica del ricorso la riscossione provvisoria sia salita al 50% (questo perché L.130/2022 ha sostituito l’art.68 D.Lgs.546/92). In mancanza di chiarimenti ufficiali qui, prudenzialmente uno scenario è: presentato ricorso, l’AdE-Riscossione potrebbe emettere cartella per il 50% delle imposte accertate (senza sanzioni per ora); dopo l’eventuale sentenza di primo grado sfavorevole, potrebbe riscuotere anche il restante 50% più sanzioni intere.
- Se si ottiene la sospensione giudiziale, invece, nulla è dovuto finché la sospensione dura (solitamente fino alla sentenza di primo grado).
- In caso di sentenza di primo grado favorevole al contribuente, questi ha diritto all’eventuale sblocco/rimborso di somme già versate in eccedenza (es. se aveva pagato il 1/3 e vince completamente, ha rimborso di quel terzo in più).
- Per evitare effetti rovinosi, è stata prevista la possibilità di chiedere sospensione in appello della sentenza di primo grado (come visto). La Cassazione può raramente sospendere l’esecutività della sentenza d’appello, ma succede di rado.
In pratica, il contribuente che fa ricorso deve mettere in conto di dover forse pagare una frazione durante il giudizio. Se non paga spontaneamente, può ricevere una cartella esattoriale già pochi mesi dopo la proposizione del ricorso, per la parte dovuta. È importante dunque informarsi e, se necessario, valutare piani di rateizzazione con Agenzia Riscossione per gli importi provvisori (la rateazione fino a 72 rate è di solito concedibile su richiesta per somme oltre €120, se il contribuente prova temporanea difficoltà).
Lato sanzioni: fino al giudizio di primo grado non vengono riscosse; dopo, sì, ma se la sentenza è di conferma integrale, le sanzioni vanno pagate per intero (senza più riduzione). Anche qui la riflessione è: se la sanzione è molto alta, talvolta conviene l’adesione per bloccarla a 1/3, piuttosto che rischiare di doverla pagare al 100%.
Domande frequenti (FAQ) su accertamento integrativo
Di seguito, una serie di domande comuni in tema di avviso di accertamento integrativo, con risposte dal punto di vista pratico e giuridico:
- D: L’Agenzia delle Entrate può emettere più avvisi di accertamento per lo stesso anno d’imposta?
R: In linea generale no, vige il principio di unicità dell’accertamento: per ciascun anno il Fisco dovrebbe emettere un solo avviso che “esaurisca” le contestazioni. L’accertamento integrativo è però l’eccezione: consente un secondo avviso (o anche terzo, teoricamente) solo se emergono nuovi elementi non conosciuti prima. Quindi può succedere di ricevere più atti sul medesimo anno, ma solo entro i limiti e condizioni di legge. Inoltre, se il primo atto era un accertamento parziale, è possibile un secondo accertamento senza necessità di nuovi elementi sui restanti aspetti. In sintesi: salvo casi particolari (nuovi elementi o primo atto parziale), non è ammesso il “doppio accertamento” sullo stesso periodo. - D: Cosa si intende esattamente per “nuovi elementi”?
R: Sono fatti, dati o informazioni fiscali che non erano noti all’ufficio al momento del primo accertamento, e che forniscono materia imponibile aggiuntiva da tassare. Devono essere sopravvenuti temporalmente (scoperti dopo) e significativi oggettivamente (incidono sul tributo). Esempi: un conto bancario estero scoperto successivamente, un contratto non esibito prima, la vendita di un immobile emersa dopo via Catasto, ecc. Non sono “nuovi elementi” le semplici rielaborazioni di dati già acquisiti, né le valutazioni giuridiche diverse su fatti noti. Cassazione ha detto che anche elementi noti ad un altro ufficio ma non comunicati a quello accertatore sono “nuovi” per quest’ultimo. - D: Se i “nuovi elementi” in realtà erano già conosciuti dall’ufficio, cosa succede?
R: In tal caso l’accertamento integrativo è illegittimo. La legge richiede espressamente la sopravvenienza, e giurisprudenza e dottrina concordano che l’assenza di reale novità rende nullo l’atto. Starà al contribuente dimostrare che l’ufficio li aveva già: ad esempio, allegando che quei documenti erano nel PVC originario o che rispondevano a un questionario precedente. Se il giudice accerta che non c’era nulla di nuovo, annullerà l’avviso integrativo per violazione dell’art.43 DPR 600/73. - D: Devo pagare subito le somme dell’accertamento integrativo?
R: Non immediatamente tutto. Entro 60 giorni dalla notifica, puoi decidere di pagare con sanzioni ridotte (acquiescenza) oppure presentare ricorso o adesione. Se fai ricorso, di solito l’Agente della Riscossione dopo i 60 giorni chiederà un pagamento provvisorio (storicamente 1/3 dell’imposta). Con le nuove norme potrebbe chiedere il 50% dopo il ricorso. Le sanzioni non vengono riscosse finché non c’è sentenza. Se chiedi sospensione giudiziale e viene accordata, nel frattempo non paghi nulla. In sintesi: hai un minimo respiro per valutare, ma preparati a dover versare una parte se la questione si protrae. - D: Quanto tempo ho per impugnare l’avviso integrativo?
R: 60 giorni dalla data di notifica, escluse eventuali sospensioni. Puoi ottenere +90 giorni extra se presenti istanza di adesione entro i primi 60. Inoltre, se i 60 giorni cadono tra 1 e 31 agosto, è sospeso il conto per quei 31 giorni (riprende a settembre). Attenzione a calcolare bene: es., notifica 10 luglio → scadenza normale 8 settembre, ma sosp. feriale sposta a 9 ottobre. - D: Posso fare ricorso da solo o serve un avvocato?
R: Se l’importo contestato (al netto di interessi e sanzioni) supera €3.000, devi farti assistere da un difensore tecnico abilitato. Sotto 3.000 puoi anche fare da solo, ma è sconsigliabile se non hai esperienza in materia. Dato che l’integrativo di solito riguarda cifre rilevanti (nuovi redditi ecc.), verosimilmente ti servirà un avvocato tributarista o un commercialista esperto di contenzioso. - D: Quali sono le difese più efficaci in giudizio contro un integrativo?
R: Le difese di solito si concentrano su: (1) Vizi procedurali/formali (mancanza nuovi elementi, difetto motivazione, tardività, omesso contraddittorio – come dettagliato sopra); (2) Merito (contestare la ricostruzione fiscale dell’ufficio sui nuovi elementi: ad es. dimostrare che certe somme non erano reddito, che un costo negato invece era deducibile, ecc.). Una difesa efficace spesso combina entrambi: si eccepisce che l’atto non doveva proprio essere emesso (vizio formale) e che comunque le pretese sono infondate (merito). Ad esempio: “l’ufficio ha violato l’obbligo di nuovi elementi perché i fatti erano noti, e per giunta quei movimenti bancari erano trasferimenti infragruppo non imponibili”. In caso di integrativo successivo a adesione, un’ottima difesa è dire che l’ufficio sta di fatto vanificando l’accordo preso, senza possedere nulla di nuovo (giudici sono sensibili a questa argomentazione, perché l’adesione dovrebbe chiudere la partita salvo eccezioni di legge). - D: Se ho definito il primo accertamento con adesione o l’ho pagato, possono ancora farmi un integrativo?
R: Sì, ma solo in situazioni particolari. Se hai definito con adesione un accertamento ordinario, possono farti un integrativo solo se emergono nuovi elementi molto rilevanti (evasione >50% di quella definita e >€77.000). Se invece hai definito un accertamento parziale, la legge consente ulteriori accertamenti sullo stesso anno anche senza nuovi elementi specifici. In pratica, aderire a un parziale non ti mette al riparo da altri avvisi su altri aspetti. Se hai semplicemente pagato (acquiescenza) il primo avviso, la situazione è simile all’adesione ordinaria: l’ufficio può farti integrativo se trova nuovi elementi. Se invece hai aderito a una definizione agevolata (tipo un condono tombale annuale, quando esistevano), in genere quell’anno è coperto completamente e non è accertabile oltre – ma dipende dalla norma del condono. - D: L’accertamento integrativo annulla e sostituisce il primo accertamento?
R: No. L’integrativo è un atto aggiuntivo, l’avviso originario resta valido. Infatti, l’integrativo “integra o modifica in aumento” senza annullare il precedente. I due importi si sommano (salvo che l’ufficio volontariamente sgravasse parte del primo, ma sarebbe un caso di autotutela bonaria raro). Se invece l’ufficio intendeva correggere un errore del primo, avrebbe dovuto annullare quello e rifarlo (cosa che dal 2024 non può più fare se peggiora la situazione). Quindi attenzione: se hai un contenzioso in corso sul primo avviso e arriva un integrativo, ti trovi con due atti distinti, ciascuno con i propri termini di impugnazione. Anche il primo non si “riapre” e devi proseguire a impugnarlo se lo ritieni errato. - D: In materia di tributi locali (IMU, TARI, ecc.), esiste l’accertamento integrativo?
R: I tributi locali hanno regole proprie, ma per analogia si applica un principio simile. Ad esempio, la legge sull’IMU (L. 296/2006) prevede che il Comune notifica un avviso di accertamento esecutivo, e può rettificarlo/integrarlo se scopre nuovi elementi entro i termini (che per IMU sono 5 anni, come per le imposte statali). Non c’è una disciplina dettagliata come l’art.43, ma in via di prassi si ammette un secondo avviso se, poniamo, l’Agenzia Entrate comunica al Comune una rendita catastale aumentata successivamente: il Comune può integrare la richiesta IMU su quell’immobile. Di certo, anche per i tributi locali vale il divieto di doppia imposizione: il secondo atto non può recuperare cose che il Comune conosceva già. Quindi, pur senza una norma esplicita uguale, la logica dei “nuovi elementi” viene rispettata anche a livello locale. Il nostro focus però resta sul Fisco statale, dove la figura dell’avviso integrativo è normata. - D: Ho ricevuto un invito al contraddittorio, ma poi comunque l’accertamento integrativo è arrivato: è normale?
R: Sì, l’obbligo di contraddittorio significa che l’ufficio deve sentirti, ma non necessariamente accogliere le tue osservazioni. Se dopo l’invito (dove magari hai presentato memorie) l’ufficio ha ritenuto comunque di emettere l’atto, può farlo, purché nella motivazione del provvedimento dia conto delle tue difese e del perché non le ha ritenute sufficienti. Verifica nell’avviso integrativo se c’è un paragrafo del tipo “Osservazioni del contribuente e valutazione dell’Ufficio”: dev’esserci. Se manca totalmente, potresti eccepire che il contraddittorio è stato fittizio. Se invece c’è, bisogna contestare nel merito le argomentazioni (es: l’ufficio dice “non abbiamo accolto perché la documentazione fornita non prova…”, e tu in ricorso ribatti che invece prova eccome, etc.). Il contraddittorio obbligatorio mira a migliorare la qualità degli atti, non garantisce che l’atto non esca. - D: In caso di accertamento integrativo, posso chiedere la rottamazione delle cartelle o aderire a qualche “pace fiscale”?
R: La rottamazione delle cartelle (come quella prevista dalla L. 197/2022 per cartelle 2000-2017, o proroghe) riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione. Se l’accertamento integrativo diventa cartella (dopo 60 giorni), allora rientra in quei carichi e puoi rottamare (se ricade nelle annate ammesse dalla norma). Ma in genere conviene agire prima, come spiegato. Le “Paci fiscali” o definizioni agevolate cambiano di volta in volta: nel 2023 c’era la definizione agevolata delle liti pendenti (pagavi percentuali del valore in causa a seconda del grado di giudizio). Se in futuro ve ne fossero altre (es. condono su avvisi in corso), potrai valutare. Ma non c’è nulla di strutturale al momento. L’accertamento con adesione rimane la “pace fiscale” ordinaria prevista dall’ordinamento.
Abbiamo così affrontato i dubbi più comuni. In definitiva, l’accertamento integrativo è una seconda chiamata del Fisco, possibile solo in circostanze precise. Il contribuente deve sapere che ha diritti solidi per contestarne l’emissione arbitraria – e grazie alle ultime riforme ha anche nuovi strumenti (contraddittorio generalizzato, autotutela obbligatoria) per far valere la propria posizione.
Conclusioni e consigli finali
Affrontare un avviso di accertamento integrativo può sembrare doppiamente frustrante – non solo si subisce un controllo fiscale, ma addirittura reiterato. Tuttavia, come abbiamo visto, l’ordinamento italiano offre al contribuente una serie di tutele sostanziali e procedurali. Il messaggio chiave è: non scoraggiarsi e non subire passivamente. Occorre invece:
- Verificare subito la legittimità dell’atto (nuovi elementi effettivi? motivazione chiara? rispetto termini?).
- Far valere i propri diritti: dal contraddittorio preventivo (se non è stato rispettato) fino al ricorso in giudizio, il contribuente ha voce in capitolo.
- Utilizzare gli strumenti deflattivi a proprio vantaggio: l’adesione può ridurre il danno, l’autotutela può eliminare errori palesi senza litigare, la conciliazione può chiudere in tempi brevi.
- Documentare ogni cosa: la difesa tecnica in questi casi richiede riscontri documentali (perizie, estratti conto, documenti contrattuali). Più prove si portano a sostegno della propria versione, più chance di successo.
- Tenere d’occhio le novità normative: tra 2023 e 2025 ci sono stati cambiamenti epocali (fine della mediazione tributaria, contraddittorio obbligatorio, riforma della giustizia tributaria, norme sull’autotutela) che mutano il quadro rispetto al passato. Un avvocato aggiornato saprà coglierne i vantaggi per il contribuente.
- Mantenere un atteggiamento collaborativo ma fermo: collaborativo nelle fasi di dialogo con il Fisco (mostrarsi disponibili a spiegare e, se del caso, a regolarizzare), ma fermo nel far valere i propri diritti quando l’Amministrazione eccede (non esitare a impugnare atti ingiusti o infondati).
Dal punto di vista del “debitore” (il contribuente accertato), difendersi da un accertamento integrativo richiede un mix di tempestività, competenza e strategia. Non è una situazione banale, spesso implica questioni complesse. Per questo, salvo casi di piccola entità, è sempre opportuno farsi assistere da professionisti esperti in diritto tributario. Ma conoscendo le linee guida tracciate in questa guida, il contribuente sarà in grado di affrontare con maggiore consapevolezza il procedimento, dialogare in maniera efficace con il proprio consulente e partecipare attivamente alla propria difesa.
Ricordiamo sempre che, in uno Stato di diritto, anche il Fisco è tenuto a rispettare le regole: un accertamento integrativo non può diventare uno strumento arbitrario per “tormentare” il contribuente, ma è lecito solo come rimedio eccezionale a reali scoperte postume. Le commissioni tributarie (oggi corti di giustizia), in molte pronunce, hanno ribadito questi concetti, annullando gli atti emessi in violazione. Pertanto, il contribuente informato e ben difeso ha ottime probabilità di vedere riconosciute le proprie ragioni.
Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate al 2025)
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 43: Termine per l’accertamento delle imposte dirette. Comma 3 (ora 4) – disciplina l’accertamento integrativo (“fino alla scadenza del termine l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, che devono essere indicati a pena di nullità…”).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57: Termine per gli accertamenti IVA. Analogo all’art. 43 DPR 600/73, consente accertamenti integrativi in caso di nuovi elementi (anche qui con obbligo di indicazione a pena di nullità).
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2 c.4: Effetti dell’accertamento con adesione. Elenca i casi in cui un’adesione non preclude ulteriori accertamenti sullo stesso periodo: lett. a) sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi comportanti maggiore imposta >50% e > €77.468; lett. b) accertamento parziale definito; lett. c) redditi societari o di partecipazione connessi.
- Statuto del Contribuente (L. 212/2000):
– art. 6, co. 3-bis: Contraddittorio preventivo obbligatorio per gli avvisi di accertamento emessi dal 2024 (introdotto da D.Lgs. 218/2023).
– art. 7-bis: Nullità degli atti per violazione del contraddittorio o altre norme sul procedimento (anch’esso introdotto nel 2023).
– art. 10-quater: Autotutela obbligatoria – elenca i casi di palese illegittimità in cui l’ufficio deve annullare l’atto in autotutela (errore persona, calcolo, doppia imposizione, ecc.). Introdotto da D.Lgs. 219/2023.
– art. 10-quinquies: Autotutela facoltativa – disciplina l’annullamento d’ufficio in altri casi, esercitabile discrezionalmente (sempre in bonam partem). Introdotto da D.Lgs. 219/2023. - Cass., Sez. V, ord. 16 aprile 2024, n. 10226: Legittimo l’accertamento integrativo emesso pochi giorni dopo il primo, se basato su dati nuovi non previamente conosciuti dall’ufficio (nella specie, dati emersi da indagini GdF non ancora in possesso del settore accertatore al momento del primo avviso). Conferma che per “nuovi elementi” si intendono anche quelli noti all’amministrazione in senso lato ma non all’ufficio specifico.
- Cass., Sez. V, sent. 3 giugno 2024, n. 15436: (massimata su FiscoOggi) In tema di accertamento, il mancato esercizio di un potere in precedenti attività istruttorie non pregiudica ulteriori determinazioni per annualità anteriori oggetto di giudizio, la cui validità non è condizionata dall’emersione di nuovi elementi – questi sono richiesti solo nel diverso caso di integrazione mediante nuovo avviso. In sostanza, la Cassazione chiarisce che se l’Ufficio non aveva accertato tutto il possibile in passato su quell’anno (ma non aveva emanato un atto definitivo), può farlo ora senza bisogno di elementi nuovi, perché non si tratta di un integrativo ma di un autonomo accertamento su una frazione di imponibile non precedentemente oggetto di atto definitivo.
- Cass., Sez. V, ord. 12 gennaio 2025, n. 788: In caso di accertamento parziale definito con adesione, l’ulteriore azione accertatrice entro i termini è consentita senza bisogno di nuovi elementi (art.2 c.4 lett. b D.Lgs.218/97). Le varie ipotesi di accertamento successivo previste dalla legge (lett. a, b, c) sono alternative tra loro e non cumulative. Nel caso concreto, l’Agenzia ha avuto ragione in Cassazione: la CTR aveva sbagliato ad applicare la regola dei “nuovi elementi” (lettera a) ad un caso di adesione su parziale (lettera b).
- Cass., Sez. V, ord. 21 luglio 2023, n. 10817: (commentata su Ecnews) Conferma la legittimità di un integrativo emesso dopo un accordo di adesione sulle stesse annualità, qualora dopo l’adesione emergano fatti nuovi inevitabilmente portanti a un nuovo atto. Ribadisce che l’adesione non è un “ombrello” assoluto se intervengono nuove scoperte.
- Cass., Sez. Unite, sent. 16 maggio 2018, n. 12213: (principio generale) L’emissione di un avviso integrativo è nulla se l’Ufficio era già in possesso degli elementi alla data del primo avviso, atteso che l’art.43 DPR 600 consente modifiche solo per sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. (Sentenza spesso citata in materia di unicità dell’accertamento).
- Prassi Agenzia Entrate – Circolare 21/E del 07/11/2024: Istruzioni sull’autotutela dopo D.Lgs.219/2023. Chiarisce i casi di annullamento obbligatorio e come l’ufficio deve gestire le istanze di autotutela, nonché introduce la possibilità di impugnare il rifiuto di autotutela nei casi obbligatori (novità: D.Lgs. 220/2023 ha modificato art.19 D.Lgs.546/92 includendo tale ipotesi).
Avviso di accertamento integrativo? Fatti Difendere da Studio Monardo
Hai già ricevuto un accertamento e ora te ne arriva un altro “integrativo”?
L’Agenzia delle Entrate sostiene di aver trovato nuovi elementi che giustificano ulteriori imposte, interessi e sanzioni?
L’avviso di accertamento integrativo può essere emesso solo in presenza di fatti nuovi e rilevanti, ma spesso viene utilizzato in modo improprio o oltre i limiti di legge. Con la giusta difesa, può essere annullato o ridimensionato.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza il nuovo avviso e verifica se ci sono effettivamente elementi nuovi e legittimi
- 📌 Controlla il rispetto dei termini di decadenza, i limiti all’integrazione e la fondatezza delle pretese
- ✍️ Redige memorie difensive, impugna l’atto e avvia il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
- ⚖️ Ti rappresenta nel ricorso tributario per ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento integrativo
- 🔁 Ti assiste nella gestione complessiva della posizione fiscale già oggetto del primo accertamento
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e impugnazione di atti successivi e integrativi
- ✔️ Consulente per la difesa di contribuenti colpiti da accertamenti ripetuti o cumulativi
- ✔️ Consulente legale per imprese, professionisti e privati soggetti a controlli fiscali complessi
Conclusione
Un avviso integrativo non può essere emesso liberamente: deve rispettare regole precise.
Con l’assistenza di un professionista puoi bloccare le pretese illegittime, difenderti con forza e tutelare i tuoi diritti fiscali.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti integrativi comincia da qui.