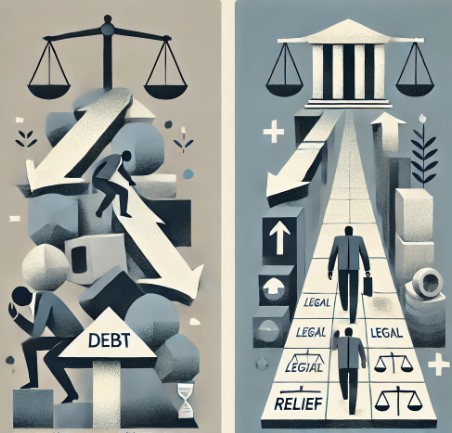Hai accumulato troppi debiti e non riesci più a far fronte ai pagamenti? Sei una persona fisica – lavoratore, pensionato, ex imprenditore o disoccupato – e ti stai chiedendo se esiste una via legale per uscire dal sovraindebitamento senza perdere tutto?
La legge italiana offre uno strumento potente e accessibile anche ai non fallibili: la procedura di sovraindebitamento. Serve a bloccare pignoramenti, ridurre i debiti e ripartire da zero, in modo trasparente e tutelato.
Cos’è il sovraindebitamento?
– È la situazione in cui una persona non è più in grado di pagare i propri debiti con regolarità
– Può riguardare debiti fiscali, bancari, personali, rate di prestiti, carte revolving, affitti arretrati
– Si verifica anche per cause impreviste: malattia, separazioni, perdita di lavoro, calo del reddito
– Non conta l’importo: conta l’incapacità oggettiva di far fronte agli impegni finanziari
Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento?
– Persone fisiche non soggette a fallimento (lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati)
– Ex imprenditori che hanno cessato l’attività o che operavano in forma individuale non fallibile
– Consumatori con debiti da finanziamenti, spese quotidiane, bollette
– Debitori che non hanno agito con dolo o colpa grave nella gestione delle finanze
Quali sono le soluzioni previste dalla legge?
– Piano del consumatore: riservato a chi ha solo debiti personali, senza necessità di accordo con i creditori
– Concordato minore: per lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, con una proposta ai creditori
– Liquidazione controllata: estinzione dei debiti tramite cessione volontaria di parte del patrimonio
– Esdebitazione del debitore incapiente: se non hai beni o redditi, puoi ottenere la cancellazione totale del debito residuo
Cosa succede quando attivi la procedura?
– Si bloccano immediatamente pignoramenti, cartelle, azioni esecutive
– I creditori non possono più agire in modo autonomo
– Si presenta un piano al Tribunale tramite un gestore della crisi
– Il Giudice omologa il piano e lo rende vincolante per tutti
– Una volta concluso il piano, i debiti residui vengono cancellati
Cosa puoi ottenere con la procedura di sovraindebitamento?
– Riduzione dei debiti fino al 70–80%
– Pagamento solo parziale e in base alle tue reali possibilità
– Blocco delle procedure esecutive
– Salvataggio della prima casa in molti casi
– Uscita definitiva dai debiti e nuova possibilità di vita serena
Il sovraindebitamento non è una colpa, ma una condizione da cui è possibile uscire legalmente. La legge è dalla parte di chi dimostra buona fede e volontà di rimettersi in regola.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in procedure di sovraindebitamento e tutela del debitore ti spiega cosa sapere se sei una persona fisica sovraindebitata, quali strumenti usare e come difendere il tuo futuro.
Hai debiti che non riesci più a sostenere? Hai paura di pignoramenti o vuoi proteggere la tua famiglia? Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti diremo qual è la soluzione più adatta alla tua situazione e come ripartire da zero in modo legale e sostenibile.
Introduzione al Sovraindebitamento
Il sovraindebitamento indica la situazione in cui una persona (o un ente non fallibile) non è più in grado di far fronte ai propri debiti con il patrimonio o il reddito disponibile. In altre parole, le obbligazioni assunte superano stabilmente la capacità di rimborso del debitore, esponendolo a procedure esecutive e a un rischio concreto di insolvenza civile. Questo concetto è stato introdotto nell’ordinamento italiano per offrire un “secondo inizio” a debitori civili, piccoli imprenditori e professionisti non soggetti alle ordinarie procedure fallimentari.
La prima normativa organica sul sovraindebitamento risale alla Legge 3/2012, nota anche come “legge salva suicidi”, con cui per la prima volta si è riconosciuta una via d’uscita ai debitori civili soffocati dai debiti. L’intento di fondo è favorire la reintegrazione economica e sociale del debitore meritevole, bilanciando la tutela dei creditori con l’opportunità di cancellare i debiti non pagabili. Il principio del “favor debitoris” è infatti il cardine di questa disciplina, che privilegia soluzioni negoziali o liquidatorie atte a evitare conseguenze esclusivamente punitive per chi si trova in gravi difficoltà economiche. In quest’ottica, le norme sul sovraindebitamento incoraggiano un approccio di supporto anziché sanzionatorio verso il debitore onesto in crisi.
Va chiarito che il sovraindebitamento riguarda debitori non assoggettabili alle tradizionali procedure concorsuali (fallimento/liquidazione giudiziale o concordato preventivo). Si tratta tipicamente di persone fisiche (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori individuali) e di enti minori (società di dimensioni ridotte, imprenditori agricoli, associazioni senza scopo di lucro, startup innovative nei limiti di legge, ecc.). Questi soggetti, definiti “non fallibili”, in passato restavano privi di tutele collettive in caso di insolvenza, potendo subire solo esecuzioni individuali frammentarie. La normativa sul sovraindebitamento colma questo vuoto, predisponendo procedure concorsuali semplificate e ritagliate su misura per le crisi da debiti di privati e piccole imprese.
Esempio pratico: Un padre di famiglia, lavoratore dipendente, ha accumulato debiti con banche, finanziarie e arretrati fiscali per oltre €100.000, a causa di perdita del lavoro e spese mediche improvvise. Non essendo un imprenditore “fallibile”, egli rientra tra i soggetti sovraindebitati. La legge gli offre strumenti per proporre un piano di rientro sostenibile o liquidare i pochi beni di cui dispone, ottenendo la cancellazione del debito residuo (esdebitazione) e potendo così ricominciare con una “fedina finanziaria pulita”.
Evoluzione normativa: dalla Legge 3/2012 al Codice della Crisi (aggiornato 2025)
Negli ultimi anni la disciplina del sovraindebitamento è stata oggetto di profonde riforme. Di seguito ripercorriamo le tappe normative principali e le novità introdotte fino a luglio 2025:
- Legge 3/2012 (“salva suicidi”) – Ha introdotto tre procedure dedicate ai debitori civili e non fallibili: (1) l’accordo di composizione dei debiti (accordo con i creditori), (2) il piano del consumatore e (3) la liquidazione del patrimonio. Questa legge ha rappresentato il primo riconoscimento del sovraindebitamento nel nostro ordinamento, con finalità di prevenzione dell’usura e dell’estorsione e per offrire un rimedio ai casi di insolvenza “civile”.
- Decreto Crescita bis 179/2012 (conv. L.221/2012) – Ha esteso l’ambito di applicazione delle procedure, ad esempio ammettendo anche le start-up innovative: queste ultime, per un periodo iniziale, non potevano essere dichiarate fallite, ma solo sottoposte alle procedure da sovraindebitamento.
- Interventi minori 2015-2019 – Nel corso degli anni la L.3/2012 è stata ritoccata su punti specifici (es. semplificando l’esdebitazione del debitore fallito dopo la chiusura del fallimento, coordinando la norma col Codice del Consumo in tema di merito creditizio, ecc.) in vista di una riforma organica già in cantiere.
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – D.Lgs. 14/2019 – Questa riforma epocale ha riordinato l’intera materia concorsuale, abrogando la Legge 3/2012 e trasponendone gli istituti nel nuovo Codice. Il CCII ha rinominato e in parte rimodellato le procedure di sovraindebitamento, confermando l’impianto di base ma inserendolo in un sistema unitario insieme alle procedure maggiori (concordato preventivo, liquidazione giudiziale). L’entrata in vigore del Codice, originariamente prevista nel 2020, è stata più volte rinviata – anche causa pandemia – e le norme sul sovraindebitamento sono diventate operative definitivamente dal 15 luglio 2022. Da tale data, le domande di composizione delle crisi da sovraindebitamento vanno proposte secondo gli articoli del CCII e non più ex L.3/2012.
- Decreto “Ristori” 137/2020, conv. in L.176/2020 – Anticipando l’attuazione di parti del futuro Codice, questa legge ha innovato la L.3/2012 introducendo alcuni miglioramenti immediati a favore dei debitori. In particolare: ha ampliato la definizione di consumatore includendovi il socio illimitatamente responsabile per debiti estranei all’attività sociale; ha permesso ai soci illimitatamente responsabili di accedere alle procedure per i debiti personali e di chiedere la liquidazione del patrimonio personale separatamente; soprattutto, ha introdotto l’“esdebitazione del debitore incapiente” (nuovo art. 14-quaterdecies L.3/2012), cioè la possibilità per una persona fisica totalmente priva di beni e reddito di ottenere la cancellazione di tutti i debiti senza pagare nulla, mettendo però a disposizione degli eventuali creditori le utilità sopravvenienti nei 4 anni successivi. Questa importante novità – che vedremo in dettaglio più avanti – è ora trasfusa nell’art. 283 CCII.
- Decreti Correttivi al CCII (2020-2024) – Dopo la pubblicazione del Codice, diversi provvedimenti ne hanno corretto e integrato il testo. Un primo D.Lgs. 147/2020 ha armonizzato il CCII alla luce delle modifiche transitorie introdotte dalla L.176/2020, recependone molte (es. esdebitazione incapienti). Successivamente, il D.L. 118/2021 (conv. L.147/2021) ha rinviato al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del CCII e introdotto una procedura nuova (la composizione negoziata della crisi), che tuttavia esula dal sovraindebitamento delle persone fisiche. In attuazione della direttiva UE 2019/1023 sull’insolvenza, è stato emanato il D.Lgs. 83/2022 che ha apportato ulteriori modifiche al Codice (specie sulla ristrutturazione dei debiti e sulle interdizioni post-procedura). Infine, di particolare rilievo, il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto “Correttivo Ter”, in vigore dal 28 settembre 2024) ha affinato una serie di disposizioni dopo i primi due anni di applicazione del CCII. In tema di sovraindebitamento, il Correttivo Ter ha: chiarito definitivamente la definizione di consumatore (art. 2 lett. e CCII) e la gestione dei debiti misti personali/professionali; semplificato l’accesso per le famiglie sovraindebitate; modificato l’art. 74 CCII sul concordato minore; e coordinato il trattamento dei crediti fiscali e contributivi nelle varie procedure. Tali interventi mirano a “oliere i meccanismi” procedurali emersi nella pratica e a rendere le norme più efficienti ed eque, sempre nel solco del favor debitoris ma contemperando le ragioni del Fisco e degli altri creditori pubblici.
Normativa vigente (luglio 2025): la disciplina del sovraindebitamento è attualmente contenuta principalmente negli artt. 65-83 CCII (che regolano il piano di ristrutturazione del consumatore e il concordato minore) e negli artt. 268-277 CCII (che regolano la liquidazione controllata), oltre agli artt. 278-283 CCII in tema di esdebitazione. A queste si aggiungono norme generali, come l’art. 2 CCII (definizioni, inclusa quella di sovraindebitamento alla lett. c e di consumatore alla lett. e) e l’art. 69 CCII (requisiti di meritevolezza e cause ostative). È bene sottolineare che gli istituti attuali ricalcano quelli della L.3/2012 ma con importanti miglioramenti per il debitore. Ad esempio, oggi è possibile presentare procedure familiari congiunte, la liquidazione ha durata massima ridotta a 3 anni, l’esdebitazione finale opera in modo automatico (d’ufficio) senza dover presentare un’ulteriore istanza, ed è stata introdotta la possibilità di esdebitazione anche per chi non ha nulla da offrire (“debitore incapiente”). D’altro canto, il legislatore ha previsto alcune limitazioni per evitare abusi, come il divieto di ottenere un nuovo “fresh start” a distanza ravvicinata (bisogna attendere almeno 5 anni da una precedente esdebitazione) e l’esclusione dei debitori colpevoli di frode o malafede (sanzionati col diniego dei benefici).
Le procedure di sovraindebitamento: panoramica generale
Le procedure oggi disponibili per regolare il sovraindebitamento delle persone fisiche (e degli altri soggetti non fallibili) sono essenzialmente tre, due a carattere negoziale/concordatario e una di tipo liquidatorio:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (spesso abbreviato semplicemente “piano del consumatore”), riservato alle persone fisiche consumatrici, ossia ai debitori non fallibili che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Si tratta di un piano proposto dal debitore al tribunale per pagare – integralmente o parzialmente – i propri debiti, con omologazione giudiziale senza voto dei creditori. È dunque una procedura “unilaterale” del consumatore, subordinata però a stringenti requisiti di accesso (onestà, assenza di colpa grave) verificati dal giudice.
- Concordato minore, destinato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore (es. piccoli imprenditori commerciali sotto soglia, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative non fallibili, enti non profit, ecc.). È sostanzialmente un “mini-concordato preventivo”: il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, eventualmente con suddivisione in classi, che per essere omologato deve ottenere l’approvazione dei creditori (con maggioranze previste dalla legge) e il vaglio del tribunale. È uno strumento pensato per consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale nonostante la crisi – tanto che la norma incoraggia la continuità, consentendo concordati liquidatori solo in casi particolari e con apporti esterni. In mancanza di consenso dei creditori, il tribunale può comunque omologare forzosamente il concordato (cram-down) se ritiene la proposta vantaggiosa e rispettosa delle priorità di legge, inclusa la soddisfazione minima dei crediti pubblici (come vedremo).
- Liquidazione controllata del sovraindebitato, procedura di carattere liquidatorio analoga al fallimento (ora liquidazione giudiziale) ma riservata ai debitori civili. Qui il patrimonio del debitore viene acquisito e liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale, per ripartire il ricavato ai creditori. La grande differenza rispetto al fallimento tradizionale sta negli effetti finali: nella liquidazione controllata il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti che non sono stati soddisfatti con il ricavato. La procedura ha inoltre durata limitata (per le persone fisiche al massimo 3 anni) e può essere attivata anche su istanza dei creditori (eventualità finora rara, ma prevista dalla legge). La liquidazione controllata rappresenta spesso l’ultima risorsa per il debitore sovraindebitato che non abbia i requisiti o la possibilità di proporre un piano/concordato: pur comportando la perdita dei beni, essa garantisce comunque una via d’uscita dai debiti residui, purché il debitore collabori lealmente.
Accanto a queste tre procedure principali, il Codice prevede anche due fattispecie speciali da menzionare:
- L’esdebitazione del debitore incapiente (detta anche “esdebitazione senza utilità”), introdotta di recente, che consente al debitore persona fisica privo di qualsiasi patrimonio o reddito di ottenere la cancellazione di tutti i debiti in essere senza dover pagare nulla ai creditori. È una misura straordinaria, concessa una tantum a debitori meritevoli ma sfortunati, che vedremo dettagliatamente più avanti.
- Le procedure familiari unitarie, anch’esse una novità del CCII: se più membri di una stessa famiglia risultano tutti sovraindebitati a causa di eventi comuni, essi possono presentare un’unica procedura congiunta (ad esempio, un unico piano del consumatore familiare) evitando costi e istruttorie separate. I requisiti sono la convivenza e la comunanza dell’origine dell’indebitamento. Questa possibilità aiuta nuclei familiari che abbiano contratto debiti insieme (ad es. marito e moglie coobbligati su mutui/finanziamenti) a uscire dalla crisi in modo coordinato. Ad esempio, due coniugi indebitati per il medesimo evento (es. fallimento dell’attività familiare) possono proporre un solo piano comune, con evidenti vantaggi di economia processuale.
Di seguito analizzeremo nei dettagli ciascuna procedura (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione incapiente), evidenziandone i presupposti, il funzionamento, i vantaggi per il debitore e gli eventuali limiti o condizioni ostative. In fondo alla guida, alcune Domande & Risposte chiariranno i dubbi più frequenti, e saranno presentate tabelle riepilogative e simulazioni pratiche per sintetizzare i punti chiave.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Chi può accedere e quando conviene
Il Piano del consumatore (ora formalmente “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” ex artt. 65-73 CCII) è riservato esclusivamente ai debitori “consumatori”, cioè alle persone fisiche che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale. In sostanza, rientrano in questa categoria i privati cittadini (dipendenti, pensionati, casalinghe, studenti, disoccupati) e anche ex imprenditori o professionisti limitamente ai debiti personali da questi assunti fuori dall’attività lavorativa. La definizione di consumatore nel CCII (art. 2, co.1 lett. e) è stata ulteriormente precisata dal correttivo 2024, esplicitando che conta la natura dei debiti contratti: se il soggetto ha anche debiti professionali, solo quelli di natura personale possono rientrare nel piano. Ad esempio, un avvocato con debiti per contributi previdenziali e forniture dello studio non potrà qualificarli come “debiti da consumatore”; se però ha anche un mutuo casa o prestiti personali, quei debiti estranei all’attività potranno essere oggetto di un piano del consumatore, mentre la parte professionale andrebbe trattata in altra sede (concordato minore).
Importante: Inserire anche un solo debito di natura imprenditoriale/professionale in un piano del consumatore rende l’intera procedura inammissibile. La Corte di Cassazione ha ribadito che il piano è riservato a chi ha solo debiti “consumeristici”, escludendo i piani “misti”: se tra i debiti ve ne fosse anche uno soltanto derivante da attività d’impresa (ad es. un debito da garante di una società), il ricorso dev’essere rigettato. In tal caso, il debitore dovrà ripiegare su una liquidazione controllata o su un concordato minore, oppure proporre un piano del consumatore escludendo quel debito non consumeristico (col rischio però di non esdebitare tale specifica posizione). La separazione tra le due categorie è dunque netta: chi esercita attività economiche e ha debiti relative ad esse non può “mascherarli” in un piano del consumatore.
Accedono al piano del consumatore tutti i debitori civili in stato di sovraindebitamento che soddisfino i requisiti di meritevolezza (assenza di comportamenti fraudolenti o gravemente colposi) e che non ricadano in cause di esclusione previste dalla legge. Tali cause ostative, comuni un po’ a tutte le procedure, includono: aver già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti (o più di due volte in totale nella vita), aver determinato la propria insolvenza con dolo o colpa grave, oppure aver presentato documentazione incompleta o non veritiera. Sul requisito soggettivo fondamentale – la meritevolezza – torneremo tra poco. Anticipiamo però che la “buona fede” del consumatore rappresenta il fulcro su cui il giudice basa la valutazione di ammissibilità e soprattutto la decisione se omologare o meno il piano proposto.
Il piano del consumatore è la soluzione preferibile quando il debitore persona fisica dispone di un reddito regolare o beni liquidabili in parte, tali da poter offrire ai creditori un pagamento (anche parziale) nel tempo, senza tuttavia poter soddisfare l’intero debito. A differenza della liquidazione, il piano non comporta la spossessione totale dei beni: il debitore di regola conserva la proprietà dei suoi asset (tranne quelli eventualmente destinati ai pagamenti) e si impegna a corrispondere somme periodiche secondo le proprie possibilità. È quindi indicato per chi, ad esempio, ha una fonte di reddito e può permettersi rate sostenibili per qualche anno, oppure possiede un immobile che preferisce non venga venduto all’asta ma offrendo ai creditori un valore equivalente (es. attraverso un finanziamento garantito). Al contrario, se il debitore non ha alcuna capacità di pagamento, il piano sarebbe irrealistico e si opterà per la liquidazione controllata o addirittura per l’esdebitazione “incapiente”.
Come funziona: predisposizione e contenuto del piano
La procedura si avvia con un ricorso al tribunale competente (del luogo di residenza del debitore) in cui il consumatore, assistito da un avvocato e coadiuvato da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), propone un piano dettagliato di ristrutturazione dei debiti. Nel ricorso devono essere elencati tutti i creditori con i rispettivi crediti, indicati i beni e redditi del debitore, e deve essere allegata la relazione particolareggiata dell’OCC che attesta la completezza e veridicità dei dati e valuta la fattibilità del piano. Questa figura (OCC o gestore della crisi) ha un ruolo cruciale: oltre a aiutare a redigere il piano, verifica che il debitore abbia dichiarato tutto l’attivo e passivo e che la proposta sia sostenibile e non arrechi indebiti pregiudizi ai creditori.
Il contenuto del piano del consumatore è molto flessibile: può prevedere qualsiasi forma di soddisfacimento dei crediti, purché venga rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione (privilegi, ipoteche e pegni vanno trattati prioritariamente sui beni gravati). In pratica, il consumatore propone di pagare entro un certo termine quanto effettivamente può in base alle sue effettive possibilità economiche, e chiede che al termine della procedura gli sia cancellato il debito residuo non pagato (esdebitazione). Ad esempio, potrebbe offrire il pagamento di una rata mensile di €300 per 5 anni da stipendio, più la liquidazione volontaria di un’automobile e di alcuni risparmi, impegnandosi così a soddisfare – poniamo – il 40% dell’ammontare dovuto, con stralcio del restante 60%. Non esistono soglie fisse di pagamento minimo ai creditori chirografari, ma il piano deve assicurare loro una utilità almeno pari a quella ricavabile in una eventuale liquidazione controllata. Se la proposta offre troppo poco rispetto all’alternativa liquidatoria, il tribunale potrebbe infatti giudicarla inammissibile o non omologabile per mancanza di convenienza. Ad esempio, la Cassazione ha confermato che è legittimo negare l’omologa di un piano che garantisca ai creditori chirografari solo una % “irrisoria” di soddisfacimento, inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni disponibili.
Durata del piano: la legge non fissa una durata massima esplicita, ma generalmente i piani si estendono su più anni. In base alla prassi e ai precedenti piani omologati, è comune una durata fino a 5 anni, estensibile a 7-10 anni in casi particolari (soprattutto se vi sono crediti ipotecari da rimborsare in parte). L’importante è che l’arco temporale sia ragionevole e che il debitore possa realisticamente rispettare gli impegni per tutto il periodo previsto.
Una volta depositato, il ricorso viene comunicato ai creditori, i quali possono presentare osservazioni o opposizioni. Tuttavia – ed è qui la peculiarità del piano del consumatore – non è richiesto alcun voto o accordo da parte loro. I creditori dunque non “approvano” il piano: possono contestarne la fattibilità o la convenienza, ma la decisione finale spetta al Giudice. Il tribunale, infatti, valuta autonomamente: (a) la fattibilità economica del piano (verificando che le somme promesse siano attendibili, col supporto della relazione OCC); (b) la meritevolezza del debitore (assenza di frode o colpa grave nell’indebitamento, come da art. 69 CCII); (c) la convenienza del piano rispetto alla liquidazione (specialmente per i creditori non privilegiati). Se questi requisiti sono soddisfatti, il piano viene omologato con decreto del tribunale e diventa vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti.
Vale la pena evidenziare una disposizione introdotta per sanzionare il comportamento di eventuali creditori “imprudenti”: l’art. 69 CCII prevede che il creditore che ha colpevolmente contribuito al sovraindebitamento, ad esempio concedendo credito senza valutare adeguatamente il merito creditizio del debitore (in violazione dell’art. 124-bis TUB), non può proporre opposizione o reclamo in sede di omologa contestando la convenienza del piano. Si tratta di una “punizione” per banche/finanziarie che abbiano prestato denaro a chi era già noto come insolvente: tali creditori negligenti vedono compressi i loro poteri di contestazione. Questo meccanismo incentiva gli intermediari finanziari ad una sana concessione del credito e al contempo tutela il consumatore sovraindebitato meritevole, impedendo che l’omologazione del suo piano venga bloccata da chi gli ha prestato soldi con leggerezza. In sede di giudizio di omologa, il tribunale verifica d’ufficio se ricorrono queste circostanze: qualora un creditore eccepisca, ad esempio, la “colpa grave” del debitore per aver aumentato i debiti, il giudice terrà conto di eventuali omissioni di verifica del merito creditizio da parte di quello stesso finanziatore, valutando meno severamente la posizione del debitore. In altre parole, se la banca non ha fatto il proprio dovere di controllo, la “colpa” del consumatore che si è ulteriormente indebitato viene declassata da grave a lieve: non impedirà dunque l’accesso alla procedura.
Una volta omologato, il piano del consumatore produce effetti protettivi analoghi a quelli di un concordato: i creditori sono vincolati a quanto stabilito dal piano e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali per tutta la sua durata. Eventuali pignoramenti già in essere vengono sospesi o cadono, essendo ricompresi nella soluzione concorsuale. Inoltre, debiti come la cessione del quinto dello stipendio vengono ricondotti nel piano e la relativa trattenuta sul salario viene bloccata, in modo che il debitore possa disporre di reddito per ottemperare al piano. Durante l’esecuzione, il debitore dovrà rispettare le scadenze di pagamento indicate; spesso viene nominato un gestore (lo stesso OCC) per controllare l’adempimento e distribuire le somme ai creditori secondo il piano.
Esdebitazione e conclusione del piano
Se il debitore esegue regolarmente il piano del consumatore fino al termine, egli ha diritto alla completa esdebitazione dei debiti residui non pagati. Ciò significa che, con decreto finale, il tribunale dichiara inesigibili verso il debitore tutte le passività ancora pendenti (incluse quelle verso il Fisco per la parte falcidiata). Il consumatore viene dunque liberato definitivamente dal peso dei debiti pregressi e può ripartire da zero. Si noti che l’esdebitazione non estingue in senso tecnico le obbligazioni, ma le rende non più azionabili nei confronti di quel debitore. Restano impregiudicati i diritti verso eventuali coobbligati o garanti: ad esempio, se un parente ha prestato garanzia per un debito del consumatore, il creditore potrà ancora rivalersi sul garante per la parte non pagata. Allo stesso modo, se il debitore principale viene esdebitato, chi gli aveva fatto da fideiussore non è liberato (salvo poi rivalersi eventualmente sul debitore in base agli accordi fra loro).
Nel corso dell’esecuzione del piano, se il debitore viene meno ai propri obblighi in modo significativo (ad esempio omettendo pagamenti rilevanti non giustificati), il tribunale – su segnalazione dell’OCC o su istanza di un creditore – può disporre la revoca dell’omologazione. In tal caso, il piano viene meno e i crediti riacquistano piena efficacia (dedotti però i pagamenti eventualmente già ricevuti in conto piano). Il Codice prevede tuttavia che, per evitare di lasciare il debitore e i creditori “a mani vuote” dopo un piano fallito, il tribunale possa aprire d’ufficio una liquidazione controllata dei beni residui del debitore. Ciò offre una via di uscita: anziché tornare alle esecuzioni individuali, si passa a liquidare in modo concorsuale quel che resta del patrimonio, consentendo al debitore (se meritevole) di conseguire comunque l’esdebitazione al termine della liquidazione. Questo meccanismo di conversione evita abusi (debitori che avviano piani irrealistici solo per guadagnare tempo) ma nello stesso tempo protegge il favor debitoris: se il piano salta per motivi non fraudolenti, il debitore può comunque aspirare alla cancellazione dei debiti tramite la successiva liquidazione.
Un aspetto importante, specie per il debito fiscale, è che nel piano del consumatore i crediti erariali e contributivi possono essere inclusi e trattati alla pari degli altri crediti. Il giudice valuterà la congruità dell’eventuale pagamento parziale di tali debiti, tenendo presente che il Fisco non partecipa a un voto ma è comunque vincolato dall’omologazione. La normativa (art. 65 CCII e segg.) richiede che il piano offra ai crediti privilegiati (inclusi quelli tributari privilegiati) un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione. In pratica, l’Erario dev’essere soddisfatto almeno nella misura in cui lo sarebbe escutendo i beni su cui vanta privilegio o garanzia. Ad esempio, se c’è un’ipoteca di Equitalia su un immobile, il piano dovrà prevedere che al credito ipotecario fiscale sia destinato almeno l’equivalente del valore di realizzo dell’immobile (o comunque una percentuale congrua) per poter essere confermato. Su questo la Cassazione ha chiarito che il tribunale, nel giudicare l’ammissibilità di un piano/accordo, deve comparare quanto offerto al creditore ipotecario con quanto ricaverebbe in caso di liquidazione dei beni, tenendo conto anche di eventuali diritti di escussione residui che il creditore perderebbe con l’omologa. In sintesi, non si può imporre al creditore privilegiato un sacrificio superiore a quello che la procedura liquidatoria comporterebbe. Se il piano rispetta tale condizione e gli altri requisiti, verrà omologato e anche il Fisco ne sarà vincolato (eventuali crediti falcidiati saranno poi esdebitati al termine).
Vantaggi principali del piano del consumatore: consente al debitore di evitare la spoliazione totale del patrimonio (spesso la casa di abitazione può essere salvata evitando la vendita forzata), di rateizzare il debito in base alla propria capacità reddituale, e di ottenere la liberazione dai debiti residui senza il voto dei creditori. Svantaggi: richiede che il debitore sia in buona fede e offra comunque qualcosa ai creditori (non è ottenibile se non si può pagare nulla); inoltre la procedura può risultare lunga e impegnativa, con l’onere di rispettare il piano per diversi anni sotto vigilanza del OCC/giudice.
Esempio pratico 1 (Piano sostenibile): Maria, insegnante con stipendio di €1.500, ha €80.000 di debiti (prestiti e carte di credito). Non possiede casa ma solo un’auto. Con un piano del consumatore propone di pagare €500 al mese per 5 anni (per un totale di €30.000) distribuendo il pagamento proporzionalmente ai creditori chirografari, più la liquidazione volontaria dell’auto (stimata €5.000). In tal modo i creditori ricevono circa il 40% ciascuno. L’OCC attesta che Maria potrà sostenere la rata conservando il minimo vitale per sé. Il tribunale omologa il piano considerando Maria meritevole (i debiti derivano da cure mediche familiari) e ritenendo congruo offrire 35.000€ rispetto a una liquidazione in cui, senza stipendio, i creditori avrebbero preso forse 5.000€. Maria esegue i pagamenti per 5 anni e ottiene l’esdebitazione del residuo (€45.000 circa) alla fine.
Esempio pratico 2 (Mancata meritevolezza): Luigi ha accumulato €50.000 di debiti di gioco con varie finanziarie, mentendo sul proprio reddito per ottenere nuovi prestiti da usare al gioco d’azzardo. Prova a presentare un piano del consumatore offrendo di pagare solo €5.000 in totale. L’OCC però segnala che Luigi ha tenuto un comportamento gravemente irresponsabile (colpa grave) ed ha aggravato volutamente la sua esposizione. Il tribunale, valutate le circostanze, nega l’omologa per difetto di meritevolezza: i creditori restano liberi di agire esecutivamente. Luigi potrà tutt’al più accedere alla liquidazione controllata (che i creditori possono chiedere d’ufficio), ma è probabile che anche l’esdebitazione finale gli venga negata per indegnità (essendo l’indebitamento causato da sua malafede).
Concordato Minore
Ambito soggettivo: chi vi ricorre?
Il concordato minore è la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento destinata al debitore non consumatore sovraindebitato. In pratica vi rientrano tutti quei soggetti non fallibili che non sono persone fisiche “consumatrici”. Si tratta principalmente di:
- Piccoli imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità (art. 2, co.1 lett. d CCII – c.d. “imprese minori”). Ad esempio un commerciante individuale con debiti sotto 500.000 € e meno di 10 dipendenti, che non potrebbe essere dichiarato fallito, può accedere al concordato minore in caso di insolvenza. Lo stesso vale per società di persone o SRL di piccole dimensioni non fallibili (come start-up innovative nei primi anni).
- Imprenditori agricoli, tradizionalmente esclusi dal fallimento: anch’essi rientrano a pieno titolo tra i soggetti sovraindebitati e possono usare il concordato minore (o la liquidazione controllata) per risolvere la propria crisi.
- Professionisti e lavoratori autonomi con debiti riferiti alla loro attività (es. avvocati, medici, artigiani con partita IVA). Pur non essendo “imprenditori commerciali”, questi soggetti generano debiti professionali (col fisco, con fornitori, dipendenti dello studio, ecc.) e non sono consumatori per tali debiti. Pertanto, in caso di sovraindebitamento, devono far ricorso al concordato minore per ristrutturare sia i debiti professionali sia quelli personali eventualmente connessi. Come visto, se i debiti personali prevalgono nettamente su quelli d’attività, alcuni giudici hanno ammesso anche un piano del consumatore “ibrido”, ma la linea prudente è di utilizzare il concordato minore per l’intero ammontare quando c’è un’attività economica in essere.
- Enti non commerciali e associazioni prive di scopo di lucro (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, fondazioni non imprenditoriali, condomini, ecc.). Questi soggetti, non esercitando attività d’impresa in via principale, non sono fallibili e sono equiparati ai debitori civili. In caso di sovraindebitamento (ad es. un’ASD con debiti verso fornitori e fisco), potranno proporre un concordato minore oppure subire una liquidazione controllata, evitando magari la liquidazione coatta amministrativa (prevista solo in alcuni casi speciali di enti).
In generale, il concordato minore copre “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale”. Rientrano persino società estinte (imprese cancellate dal Registro Imprese da meno di 5 anni), per i debiti rimasti in capo ai soci: il codice consente infatti che i soci illimitatamente responsabili o la stessa società cancellata possano accedere alle procedure minori per sistemare i residui debiti sociali. Il correttivo 2024 ha ampliato questa possibilità, chiarendo il trattamento delle imprese cessate e dei soci, equiparandoli ai debitori non fallibili a tutti gli effetti.
Importante: un consumatore puro non può scegliere di fare un concordato minore semplicemente per evitare le regole più stringenti del piano del consumatore. Se una persona fisica ha solo debiti personali, dovrà usare il piano; se invece ha una commistione di debiti personali e d’impresa, dovrà valutare quale componente è prevalente e agire di conseguenza. In giurisprudenza si è ammesso, ad esempio, che un socio illimitatamente responsabile con debiti misti presenti un concordato minore per i debiti d’impresa e, parallelamente o in successione, un piano del consumatore per i debiti personali. Tuttavia occorre cautela per evitare conflitti: oggi la norma prevede espressamente procedure familiari congiunte, ma non disciplina in dettaglio il doppio binario persona fisica/impresa. L’indirizzo prevalente è che, in caso di debiti misti, si debba utilizzare il concordato minore per tutti i debiti se il soggetto non è qualificabile come consumatore (cioè se ha un’attività economica in essere). La possibilità di spezzare i debiti in due procedure differenti va valutata caso per caso, con coordinamento tra tribunali se necessario.
Finalità e tipologie di concordato minore
La filosofia del concordato minore è di consentire al debitore in crisi di continuare l’attività quando possibile, evitando la liquidazione del patrimonio e il dissolvimento dell’impresa. Per questo, la legge configura il concordato minore in via ordinaria come un concordato in continuità (ossia con prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale durante e dopo la procedura). Si prevede comunque la possibilità di presentare un concordato minore liquidatorio, ma solo in casi eccezionali: il debitore può proporlo solo se apporta risorse esterne tali da incrementare in modo apprezzabile l’attivo a vantaggio dei creditori. In altre parole, se un piccolo imprenditore vuole semplicemente liquidare tutto, dovrebbe preferibilmente avviarsi alla liquidazione controllata; se invece vuole usare la forma del concordato liquidatorio (magari per gestire meglio la vendita o perché ci sono complessi contrattuali da cedere), la legge richiede che egli metta sul piatto qualcosa in più (ad es. capitali di terzi, nuovo denaro o beni non già compresi nel patrimonio) così da giustificare la scelta concordataria. Questo per evitare concordati liquidatori “puramente dilatori” e poco vantaggiosi rispetto a una liquidazione standard.
Nella pratica, molti concordati minori presentati sinora sono stati in continuità: ad esempio, artigiani o commercianti che ristrutturano i debiti e proseguono l’attività, oppure professionisti che dilazionano il pagamento dei debiti fiscali mentre continuano a lavorare. Ciò consente di preservare il valore dell’impresa e le fonti di reddito (che peraltro servono poi a pagare i creditori).
Iter procedurale e ruolo dei creditori
Il concordato minore si avvia anch’esso con un ricorso al tribunale, contenente il piano concordatario proposto e la documentazione analoga a quella del piano del consumatore (elenco creditori, inventario dei beni, atti degli ultimi anni, bilanci se esistenti, relazione dell’OCC sull’origine della crisi e sulla fattibilità del piano). Anche qui è obbligatorio l’ausilio di un OCC/gestore che asseveri il piano e l’attendibilità dei dati. Non è raro, trattandosi spesso di attività d’impresa, che il piano preveda un’analisi di sostenibilità sul modello di un piccolo piano industriale.
Una differenza chiave rispetto al piano del consumatore sta nella partecipazione dei creditori: nel concordato minore i creditori devono approvare la proposta perché questa possa diventare efficace. La legge prevede che, una volta aperta la procedura, venga indetta un’udienza (o una votazione scritto/telematica) in cui i creditori esprimono il loro voto. Il quorum richiesto per l’approvazione è la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In altre parole, servono sì-voti che rappresentino più del 50% dell’ammontare complessivo dei crediti aventi diritto a voto. Se il piano prevede la suddivisione dei creditori in classi (ad esempio separando i privilegiati dai chirografari, o distinguendo tra tipologie di creditori), occorre anche che sia raggiunta la maggioranza in ciascuna classe o comunque vengano rispettati i criteri di cram-down previsti (ad esempio almeno il 50% in ogni classe e il 60% del totale). In questo il concordato minore ricalca le regole base del concordato preventivo: il tribunale omologa solo se c’è un sufficiente consenso tra i creditori. Dissenting creditors: se uno o più creditori votano contro, ma il quorum è comunque raggiunto, essi sono comunque vincolati dall’eventuale omologa (salvo il diritto di proporre opposizione per contestare la convenienza, analogo a quello del concordato preventivo).
Da notare che anche nel concordato minore è possibile la partecipazione di crediti pubblici (Erario, enti previdenziali). Il CCII, novellato dai correttivi, ha uniformato il trattamento dei crediti fiscali e contributivi in tutte le procedure. In particolare, per il concordato minore l’art. 74 co.4 CCII richiama espressamente la disciplina della transazione fiscale prevista per il concordato preventivo (art. 88 CCII). Ciò significa che il debitore può proporre il pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari, ma l’omologa richiederà il rispetto di condizioni specifiche: ad esempio, il voto favorevole dell’Erario se la proposta prevede un trattamento deteriore rispetto a certe soglie. In caso di voto contrario del Fisco, il tribunale potrebbe omologare lo stesso solo se viene assicurato il soddisfacimento minimo stabilito dalla legge (le famose percentuali di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 63 CCII, fissate – dopo varie modifiche – su livelli piuttosto elevati). Per fare un esempio concreto: se l’Erario ha un credito privilegiato, il concordato potrà cram-dowarlo solo offrendo almeno il 30% di tale credito (soglia ipotetica, qui giusto illustrativa), altrimenti servirà l’adesione esplicita dell’Agenzia delle Entrate. Su questi dettagli tecnici il Codice è intervenuto più volte; basti sapere che oggi anche nei concordati minori i crediti fiscali sono “forzabili” con l’omologa giudiziale, ma a condizione di aver rispettato requisiti stringenti di soddisfazione minima e confronto con l’alternativa liquidatoria.
Tornando all’iter: dopo il voto, il tribunale tiene conto dell’esito e procede all’omologazione. Oltre a verificare la regolarità del voto e l’assenza di opposizioni fondate, il giudice compie un controllo di legalità e fattibilità del piano. Verifica quindi che siano rispettate le regole sui privilegi, che il piano sia eseguibile e non fraudolento, e valuta eventuali contestazioni sulla convenienza sollevate dai creditori dissenzienti. Se tutto è in regola e se necessario applica il cram-down sulle classi dissenzienti (purché abbiano trattamento non inferiore alla liquidazione), il tribunale emette decreto di omologazione. Da quel momento il piano diventa obbligatorio per tutte le parti.
Effetti del concordato minore omologato: similmente al concordato preventivo, il debitore è tenuto ad attuare il piano sotto la vigilanza di un liquidatore o commissario nominato (spesso lo stesso OCC). I creditori perdono titolo per agire individualmente e devono attendere le distribuzioni previste in piano. Se il piano contempla la prosecuzione dell’attività, il debitore potrà mantenere la gestione sotto supervisione; se prevede cessioni di beni, si procederà alle vendite secondo quanto concordato. Al termine dell’esecuzione, se il debitore è una persona fisica, egli può chiedere l’esdebitazione per i debiti rimasti non pagati (ovviamente purché abbia rispettato le condizioni di meritevolezza e non vi siano cause ostative). Se invece il debitore era, ad esempio, una società, non si pone il tema dell’esdebitazione personale (la società cancellata è estinta, e per i soci illimitati si valuterà a parte). È importante notare che il concordato minore, diversamente dall’accordo ex L.3/2012, prevede espressamente l’accesso all’esdebitazione finale per la persona fisica, equiparandolo al concordato preventivo in continuità.
Analogamente a quanto visto per il piano del consumatore, anche nel concordato minore l’art. 77 CCII richiama le cause di inammissibilità legate a comportamenti scorretti del debitore. Dunque non può accedere chi ha commesso frodi, chi ha già avuto un’esdebitazione recente (<=5 anni) o più di due in totale, chi ha presentato documenti falsi, ecc. Inoltre, pur non essendo formalmente richiesta la “meritevolezza” come requisito soggettivo (termine usato per i consumatori), di fatto anche nel concordato minore il debitore deve dimostrare correttezza e trasparenza: se emergono atti in frode o malafede, il tribunale può rifiutare l’omologa per indegnità. Perfino dopo l’omologa, se si scoprono irregolarità gravi, il concordato può essere revocato su istanza dei creditori (art. 78 CCII, simile all’art. 72 CCII per il piano). Ad esempio, un imprenditore che durante il concordato ha nascosto beni ai creditori rischierà la revoca dell’omologa e potrà solo subire la liquidazione controllata senza beneficio di esdebitazione.
Un’importante novità introdotta nel CCII è che in caso di mancata omologazione del concordato minore – ad esempio perché i creditori non lo approvano o perché il giudice lo rigetta per indegnità – il tribunale, su richiesta del debitore, può aprire d’ufficio la procedura di liquidazione controllata. Questo meccanismo evita al debitore di tornare allo “scoperto” in balia dei creditori. Se il piano concordatario fallisce, si passa immediatamente alla liquidazione dei beni da parte del tribunale, consentendo poi al debitore persona fisica di chiedere l’esdebitazione al termine di quella procedura. In sostanza, il sistema cerca di non vanificare completamente i tentativi di soluzione concordataria: il debitore ha una sorta di rete di sicurezza, purché abbia agito in buona fede.
Esempio pratico: Un piccolo imprenditore edile (impresa individuale), con debiti totali per €300.000 (fornitori, banche e debiti fiscali), è insolvente ma vorrebbe evitare la cessazione dell’attività. Presenta un concordato minore in continuità offrendo: pagamento integrale dei debiti previdenziali e di una parte dell’IVA grazie a un finanziatore terzo (apporto esterno), pagamento del 40% ai chirografari in 5 anni, e impegno a onorare regolarmente i debiti futuri. I creditori votano: l’85% in valore dei crediti approva. Il tribunale omologa il piano. L’imprenditore continua la sua attività e paga nei 5 anni le percentuali promesse. Alla fine, i debiti residui (60% chirografari non pagati) vengono dichiarati inesigibili verso di lui (esdebitazione) e l’impresa risanata prosegue la sua vita. I creditori fiscali, avendo ottenuto almeno quanto avrebbero ricavato liquidando i beni (ad esempio era stata ipotecata una proprietà poi salvata col nuovo finanziamento), sono stati vincolati dalla transazione fiscale approvata implicitamente.
Confronto piano vs concordato: Per chiarire, riportiamo una sintesi comparativa:
| Caratteristica | Piano del consumatore | Concordato minore |
|---|---|---|
| Destinatari | Persona fisica consumatore (debiti personali non professionali). | Debitore non consumatore sovraindebitato (piccolo imprenditore, professionista, ente non fallibile). |
| Iniziativa | Solo il debitore può proporlo (legittimazione attiva esclusiva del consumatore). | Di regola il debitore (anche qui iniziativa volontaria); creditori possono chiedere liquidazione, non direttamente il concordato. |
| Approvazione dei creditori | Non richiesta: nessun voto, decide tutto il giudice. Creditori possono solo fare osservazioni/opposizioni. | Richiesta: serve voto favorevole di >50% dei crediti (in ogni classe, se previste). Il tribunale omologa se c’è la maggioranza e il piano è conforme alla legge (possibile cram-down su dissenzienti). |
| Contenuto del piano | Pagamenti parziali o dilazionati secondo le effettive possibilità; durata flessibile (spesso 4-5 anni, fino a 10 max). Nessuna cessione integrale del patrimonio, il debitore paga in misura sostenibile. | Pagamenti parziali/dilazionati ai creditori. Può prevedere continuità aziendale (preferibile) o liquidazione con apporto esterno. Possibile suddivisione in classi e trattamenti differenziati. |
| Ruolo dell’OCC | Centrale: redige la relazione attestando veridicità dati e fattibilità del piano. | Parimenti essenziale: relazione OCC obbligatoria su cause dell’indebitamento, completezza dati e attuabilità del piano. |
| Requisito soggettivo chiave | Meritevolezza del debitore: no dolo o colpa grave nell’indebitarsi (art. 69 CCII). Valutazione discrezionale del giudice in sede di omologa. | Onestà e trasparenza del debitore: analoghe cause ostative (frodi, uso abusivo del credito, false informazioni) precludono l’accesso. Non si parla di “meritevolezza” espressamente, ma il debitore indegno non viene ammesso/omologato. |
| Effetti durante la procedura | Sospensione delle azioni esecutive (previa richiesta di misure protettive). Il debitore mantiene la disponibilità dei beni (salvo quanto destinato ai pagamenti). | Sospensione delle azioni esecutive simile (protezione ex art. 54 CCII). In continuità il debitore resta in gestione sotto vigilanza; se liquidatorio volontario, cede i beni secondo piano. |
| Esito finale tipico | Omologazione del piano dal giudice. Esecuzione (pagamento rate e altre azioni previste). Esdebitazione dei debiti residui al completamento (se debitore adempiente e meritevole). | Omologa del concordato se approvato da creditori. Esecuzione del piano sotto controllo. Esdebitazione per il debitore persona fisica a fine procedura (se condizioni rispettate). Nessuna esdebitazione per entità diverse dalla persona fisica (società, enti). |
| Mancato successo | Se non omologato o revocato, possibilità di conversione in liquidazione controllata su istanza del debitore. | Parimenti, in caso di diniego/rigetto, il tribunale può aprire d’ufficio la liquidazione controllata (salvaguardando l’opportunità di esdebitazione). |
| Vantaggi per debitore | Niente vendita forzata complessiva dei beni; tutela del patrimonio minimo vitale; niente voto creditori (iter più rapido) se meritevole. | Possibilità di continuare l’attività; negoziazione con creditori; flessibilità (es. classi, continuità); evitare stigma del fallimento. |
| Svantaggi/limiti | Necessaria onestà e qualche capacità di pagamento; durata pluriannuale d’impegno; omologazione incerta se soddisfazione creditori troppo esigua. | Necessario consenso dei creditori (rischio di esito negativo se mancano voti); iter più complesso; richiede eventuale liquidazione di attivo o sacrifici per soddisfare soglie fiscali. |
Come si vede, piano del consumatore e concordato minore presentano analogie ma rispondono a platee differenti e hanno meccanismi di approvazione diversi. Dal punto di vista del debitore persona fisica, la scelta dipende essenzialmente dalla natura dei debiti: se sono tutti personali/di consumo, la strada è il piano; se coinvolgono un’attività economica, bisognerà interagire coi creditori tramite il concordato. In entrambi i casi, l’obiettivo finale è pagare ciò che si può e farsi liberare dal resto, evitando la ben più gravosa liquidazione forzata del patrimonio (che esaminiamo ora).
Liquidazione Controllata del sovraindebitato
Natura e presupposti
La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura concorsuale che porta alla liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore sovraindebitato, analoga al fallimento ma calibrata sui soggetti non fallibili. Corrisponde di fatto alla vecchia “liquidazione del patrimonio” della L.3/2012, con alcuni ritocchi importanti: durata massima ridotta, maggiori garanzie procedurali e, soprattutto, esdebitazione “automatica” del debitore onesto a fine procedura. L’idea di fondo è che, se un debitore sommerso dai debiti non può offrire un piano sostenibile, allora si ricorre alla vendita ordinata di tutti i suoi beni per soddisfare i creditori il più possibile, liberandolo poi dai debiti residui in modo da dargli la possibilità di ripartire.
Chi può essere soggetto a liquidazione controllata? Tutti i debitori in condizione di sovraindebitamento non assoggettabili a liquidazione giudiziale (fallimento). In pratica: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up non fallibili, enti non commerciali, ex imprenditori cessati da non più di 5 anni, ecc.. La definizione è ampia: l’art. 268 CCII parla di “soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale”. Restano esclusi solo gli enti pubblici (lo stesso art. 268 lo specifica) e ovviamente le imprese di dimensioni rilevanti, che sarebbero fallibili e per le quali la strada è la liquidazione giudiziale ordinaria. Dunque, in caso di dubbi sulla fallibilità, il tribunale verificherà prima se il soggetto supera o meno le soglie di legge; se non le supera, potrà essere ammesso alla liquidazione controllata.
La liquidazione controllata può essere attivata in due modi:
- Su ricorso dello stesso debitore, che può chiedere l’apertura della procedura dichiarando la propria insolvenza (o semplicemente la situazione di sovraindebitamento irreversibile). Questa è l’ipotesi più frequente nella pratica fino ad oggi.
- Su istanza di uno o più creditori o di un pubblico ministero (quest’ultimo raramente, forse in casi di rilevante interesse pubblico). Questa era una novità già prevista dalla L.3/2012 ma poco utilizzata; il CCII la conferma ed anzi la rafforza, prevedendo un meccanismo di salvaguardia: se i creditori chiedono la liquidazione, il tribunale deve prima verificare se il debitore ha presentato (o intende presentare) un piano del consumatore o un concordato minore. Correttivo 2024: l’art. 271 CCII è stato modificato per stabilire che, in caso di istanza dei creditori, il tribunale deve concedere al debitore un termine (fino a 90 giorni, prorogabile di altri 30) per proporre una soluzione alternativa. Se il debitore nel frattempo deposita un ricorso per piano o concordato minore, la domanda di liquidazione dei creditori viene dichiarata improcedibile (superata dalla procedura di regolazione alternativa). Se invece il debitore non sfrutta questa chance o la sua domanda concordataria viene respinta, allora si procede con la liquidazione su istanza creditori. Questo meccanismo tutela il debitore: gli viene data un’ultima opportunità di evitare la liquidazione forzata, presentando un piano di ristrutturazione entro termini perentori.
In sintesi, la priorità è sempre data a strumenti diversi dalla liquidazione: solo quando non vi sono alternative percorribili si opta per liquidare i beni. Ciò è coerente col principio, ormai sancito, che anche per i debitori insolventi occorre verificare prima la possibilità di risanamento o di accordo, e ricorrere alla liquidazione giudiziaria (o controllata) solo come extrema ratio.
Apertura della procedura: competenza al tribunale, forma con sentenza (analoga alla sentenza dichiarativa di fallimento). La sentenza di apertura nomina un giudice delegato e un liquidatore (spesso viene confermato l’OCC che ha seguito la fase iniziale, se la richiesta veniva dal debitore). Inoltre ordina al debitore di consegnare/rilasciare i beni compresi nel patrimonio liquidabile e fissa i termini per le domande dei creditori (insinuazione al passivo). Con la sentenza scatta automaticamente lo spossessamento: il debitore perde la disponibilità e l’amministrazione dei propri beni, che passano in gestione al liquidatore. Gli atti dispositivi compiuti dal debitore dopo l’apertura sono inefficaci rispetto ai creditori (quindi eventuali pagamenti fatti o ricevuti devono essere restituiti).
Da notare che lo spossessamento non priva il debitore della titolarità giuridica dei beni: egli ne resta proprietario finché non vengano venduti a terzi dal liquidatore. Quindi, se la liquidazione si chiudesse lasciando alcuni beni invenduti, questi rimarrebbero al debitore liberamente. Ciò evita, ad esempio, che beni invendibili vadano persi: semplicemente tornano al debitore alla fine.
La liquidazione controllata abbraccia tutti i beni del debitore esistenti al momento dell’apertura, nonché quelli che dovessero sopravvenire durante la procedura (salvo alcune eccezioni come i redditi da lavoro necessari al sostentamento, i beni impignorabili ex lege, ecc., che rimangono fuori dal concorso). Se durante la procedura il debitore acquisisce nuovi beni (eredità, vincite, ecc.), essi confluiscono nella massa attiva a beneficio dei creditori, al netto però delle passività connesse al loro acquisto/conservazione. Questa regola fa sì che, ad esempio, se il debitore eredita un immobile durante la liquidazione, tale immobile entra nell’attivo ma prima dovranno essere pagate le spese (prededucibili) per eventualmente amministrarlo o liquidarlo.
La procedura prevede poi le fasi tipiche: accertamento del passivo (i creditori presentano domanda entro 90 giorni dall’apertura, termine prorogabile di 30, come da art. 277 CCII aggiornato), formazione dello stato passivo da parte del GD, possibilità di opposizioni; quindi la liquidazione dei beni a cura del liquidatore (vendite all’asta o trattative private autorizzate) e infine la ripartizione del ricavato ai creditori secondo l’ordine dei privilegi. Il tutto soggiace al principio della par condicio creditorum: i chirografari ricevono proporzionalmente quel che resta dopo aver soddisfatto i crediti pre-deducibili e privilegiati.
Una novità: durata massima. Il CCII ha stabilito, incorporando il dettato della direttiva UE, che la procedura di liquidazione controllata deve concludersi entro 3 anni dall’apertura. In precedenza si parlava di 4 anni nella L.3/2012 modificata, ma ora il tetto è 3 anni per uniformità con la durata massima delle procedure di esdebitazione degli imprenditori in Europa. Decorsi 3 anni, se anche la liquidazione non è materialmente terminata, il debitore persona fisica può comunque chiedere la chiusura e l’esdebitazione (salvo proroghe per ragioni eccezionali). Ciò evita che liquidazioni di modesta entità si protraggano indefinitamente.
Esdebitazione “di diritto” nella liquidazione controllata
Uno dei punti di forza della liquidazione controllata attuale è che, a differenza del passato, il debitore persona fisica non deve più presentare una specifica istanza per ottenere l’esdebitazione. L’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione opera di diritto a seguito del decreto di chiusura della procedura o anche antecedentemente, decorsi 3 anni dall’apertura. In pratica, se la liquidazione dura più di tre anni, il debitore meritevole potrebbe essere esdebitato già allo scoccare del terzo anno, anche prima che siano ultimate tutte le ripartizioni, così da non ritardare il suo fresh start. Di solito comunque la liquidazione si chiuderà formalmente entro i 3 anni con un decreto del giudice delegato che accerta la fine delle operazioni e dichiara la procedura chiusa; contestualmente o con decreto separato, il tribunale dispone l’esdebitazione del debitore. Il debitore non deve fare domanda, ma può ovviamente opporsi se per assurdo preferisse non ottenere il beneficio. I creditori hanno facoltà di proporre reclamo entro 30 giorni avverso il decreto di esdebitazione se ritengono che i requisiti non fossero soddisfatti (ad es. scoprono che il debitore aveva nascosto qualcosa).
Condizioni per l’esdebitazione automatica: La normativa elenca una serie di condizioni in presenza delle quali l’esdebitazione non viene concessa. Tali cause, in larga parte, rispecchiano quelle già note per la L.3/2012 e l’esdebitazione post-fallimentare, integrate con le previsioni della direttiva UE. In particolare, NON beneficia della esdebitazione il debitore che:
- Ha cagionato la situazione di sovraindebitamento con dolo o colpa grave, o ha agito in malafede o frode verso i creditori. Ad esempio, chi ha dissipato il proprio patrimonio con operazioni dolose a danno dei creditori, o chi ha contratto debiti con l’intenzione di non pagarli, può vedersi negare il beneficio.
- Ha violato i doveri procedurali di cooperazione: se durante la liquidazione ha ostacolato o rallentato le operazioni, non ha consegnato documenti, ha reso difficile la ricostruzione del patrimonio (magari tenendo contabilità falsa), ecc..
- Ha beneficiato di un’altra esdebitazione nei 5 anni precedenti. Questa regola impedisce utilizzi troppo frequenti: se il debitore era già stato esdebitato, ad esempio, 3 anni prima, non potrà ripetersi subito. Dovrà attendere almeno 5 anni dalla precedente.
- Ha già beneficiato di esdebitazioni per due volte in totale nella sua vita. Qui il legislatore pone un limite quantitativo: un terzo fresh start non è concesso nemmeno dopo molti anni.
- È stato condannato per reati gravi in ambito fallimentare o economico, come bancarotta fraudolenta, reati societari, ecc., salvo che sia intervenuta riabilitazione. In presenza di procedimenti penali pendenti per tali reati, il tribunale sospende la decisione sull’esdebitazione finché il processo penale non si conclude.
- Ha già soddisfatto parzialmente i creditori fuori dalla procedura. (Questa invece non è più una condizione: diversamente dal passato, non è necessario che i creditori abbiano ricevuto almeno una parte dei loro crediti perché il debitore ottenga l’esdebitazione. Anche se il realizzo è stato zero – situazione di “no asset” – il debitore meritevole può essere esdebitato comunque.)
In aggiunta, l’art. 282 esclude che possano essere cancellati alcuni tipi di debiti specifici, anche in caso di esdebitazione concessa. Restano sempre esclusi dall’esdebitazione (cioè non vengono cancellati e rimangono dovuti):
- Gli obblighi di mantenimento e alimentari dovuti per legge (es. assegni di mantenimento al coniuge o ai figli).
- I debiti da risarcimento danni per fatti illeciti extracontrattuali (tipicamente, i danni da responsabilità civile verso terzi derivanti da reato o torto).
- Le sanzioni penali o amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (multe, ammende, contravvenzioni amministrative).
Queste categorie restano dunque escluse: ad esempio, un debito per risarcimento danni verso una vittima di lesioni personali non sarà spazzato via; idem l’obbligo di pagare gli alimenti all’ex coniuge arretrati o le multe stradali non pagate. Il razionale è che sono debiti che attengono a responsabilità personali o doveri inderogabili che l’ordinamento tutela in modo speciale.
Se non ricorre nessuna delle cause ostative e non vi sono queste categorie particolari, il debitore esce libero da tutti gli altri debiti al termine della liquidazione controllata. Ciò comprende, ad esempio, i debiti bancari, finanziari, fiscali (sì, anche i debiti fiscali residui vengono esdebitati, a meno che si tratti di sanzioni amministrative pecuniarie di natura punitiva). Il provvedimento di esdebitazione rende i crediti “inesigibili” nei confronti di quel debitore, mentre eventuali coobbligati rimangono responsabili: se Tizio viene esdebitato dal suo debito verso la banca, il garante Caio ne risponde comunque per intero, perché l’obbligazione in sé non è estinta.
Esdebitazione e società/enti: la legge consente la liquidazione controllata anche di società non fallibili o enti. In tal caso, l’esdebitazione opera per la società (che però spesso cessa di esistere) ma richiede che anche i soci illimitatamente responsabili e gli amministratori soddisfino i requisiti di meritevolezza (nei tre anni precedenti). Se tutto ok, l’esdebitazione della società si estende ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Invece non copre i debiti personali dei soci. Ciò incentiva i soci a non compiere atti distrattivi durante la liquidazione, perché altrimenti potrebbero perdere il beneficio. In sostanza, il fresh start è pensato per le persone fisiche, ma indirettamente può giovare anche a chi stava dietro una piccola società personale.
Conclusione della liquidazione: Una volta venduti i beni e distribuito il possibile, la procedura viene chiusa e – come illustrato – segue l’eventuale esdebitazione. Il debitore torna in possesso di qualsiasi bene eventualmente rimasto invenduto e cessa l’effetto spossessamento. Se, caso raro, emergessero attivi dopo la chiusura (ad es. un giudizio pendente dà esito positivo), potrà forse riaprirsi la procedura (la legge prevede ipotesi di riapertura se si scoprono attivi occulti entro certi termini). Altrimenti, il capitolo dei debiti pregressi è chiuso definitivamente.
Vantaggi dal punto di vista del debitore: la liquidazione controllata, pur comportando la perdita dei beni, cancella tutti i debiti (tranne eccezioni di legge) ed è relativamente rapida (3 anni). Il debitore non rimane per decenni perseguitato dai creditori per il residuo non pagato. Inoltre, durante la procedura è protetto dalle azioni esecutive individuali e può contare su un liquidatore professionale che gestisce la vendita con criterio, evitando dispersioni e pignoramenti disordinati. In pratica, è una sorta di “fallimento personale” ma con esito favorevole: dopo, il debitore onesto è pulito e può ripartire, senza lo stigma permanente del debito.
Svantaggi: evidentemente, il sacrificio patrimoniale. Tutti i beni non necessari al sostentamento minimo vengono liquidati; il debitore perde il controllo del suo patrimonio e vede magari venduti anche beni a cui teneva (la casa di abitazione, se non rientra nei limiti impignorabilità, può essere liquidata). Inoltre, se il debitore non collabora lealmente, rischia di finire la procedura senza esdebitazione e quindi pure spogliato dei beni e ancora gravato dai debiti. Quindi la condotta corretta è essenziale.
Esempio pratico: Fabio, piccolo imprenditore edile, ha debiti per €500.000 ma l’attività è ferma e non riesce a proporre un concordato credibile. Ha però una casa (prima casa) e un capannone; la banca ha ipoteca su entrambi. Fabio avvia una liquidazione controllata. Il liquidatore vende il capannone e l’auto aziendale, ricavando €200.000 con cui soddisfa integralmente la banca ipotecaria e in parte i fornitori. La casa, essendo prima casa non di lusso, in certi tribunali può essere protetta dall’esecuzione in base a normative emergenziali, ma poniamo che venga venduta anche quella ricavando €150.000 che vanno per lo più alla banca (residuo) e al fisco. Dopo 3 anni la procedura si chiude. Fabio, che ha cooperato pienamente, ottiene l’esdebitazione dei circa €100.000 di debiti rimasti (multe e parte di debiti chirografari). Egli non ha più proprietà immobiliari, ma può ricominciare senza pendenze. I creditori insoddisfatti non potranno più chiedergli nulla in futuro.
Esdebitazione del debitore incapiente (“esdebitazione a zero”)
Una delle innovazioni più significative introdotte in questo settore è la possibilità di esdebitazione immediata per il debitore incapiente, ossia per quella persona fisica totalmente priva di beni e di capacità di pagamento. Prevista inizialmente dall’art. 14-quaterdecies L.3/2012 (introdotto dalla L.176/2020) e ora disciplinata dall’art. 283 CCII, questa procedura speciale consente, in via eccezionale, di cancellare tutti i debiti anche senza alcuna contropartita per i creditori, quando si verificano determinate condizioni.
Requisiti e condizioni
Per accedere all’esdebitazione dell’incapiente, il debitore deve essere una persona fisica sovraindebitata non soggetta a liquidazione giudiziale (quindi rientrante nell’ambito del sovraindebitamento). Inoltre deve trovarsi in una condizione di assoluta incapienza, ovvero:
- Privo di beni liquidabili – Non deve possedere un patrimonio significativo da poter mettere a disposizione dei creditori. Se ha anche pochi beni di valore trascurabile, di solito si richiede che tentarne la liquidazione sarebbe antieconomico (ad es. qualche mobile usato, o un’auto di scarso valore, ecc.). In genere l’OCC attesta che non c’è attivo utile.
- Nessuna capacità di pagamento – Il debitore non deve disporre di redditi, stipendi o altre utilità con cui potrebbe soddisfare i creditori nemmeno parzialmente. In pratica, è la figura del “nullatenente”: niente proprietà immobiliari, nessun reddito pignorabile, nessun fondo o investimento, niente di niente.
- Meritevolezza particolare – Oltre ai soliti requisiti di onestà (assenza di frodi, ecc.), qui si richiede che il debitore non abbia fatto ricorso abusivo al credito e che la sua incapienza non derivi da comportamento volontario. Ad esempio, se si è deliberatamente impoverito per non pagare i creditori, non sarà ammesso. Serve quindi che la situazione di nullatenenza sia frutto di circostanze sfortunate e che il debitore abbia mantenuto un atteggiamento corretto.
- Una tantum – L’esdebitazione senza utilità può essere concessa una sola volta nella vita (analogamente alle limitazioni viste prima). Il debitore incapiente che ne usufruisca non potrà più chiedere esdebitazioni di altre procedure per sempre, salvo ovviamente casi eccezionali.
La procedura si avvia su istanza del debitore al tribunale. Di solito è prevista l’assistenza di un OCC che prepari una relazione dettagliata sulla posizione del debitore, certificando la totale incapienza e l’assenza di atti in frode (ad esempio deve confermare che il debitore non ha donato beni recentemente per risultare nullatenente). Va notificata ai creditori l’istanza, in modo che possano eventualmente opporsi se ritengono che il debitore in realtà avesse qualcosa.
Il tribunale, verificati i requisiti, emette decreto di esdebitazione dell’incapiente: con esso cancella tutti i debiti del debitore alla data della domanda. È un provvedimento straordinario perché, a differenza delle altre procedure, qui i creditori non ottengono nulla (0%) immediatamente. Proprio per questo, la legge introduce una clausola di salvaguardia per i creditori: per i 4 anni successivi, se sopravvengono utilità rilevanti nel patrimonio del debitore, egli ha l’obbligo di darne comunicazione e di destinarle in parte ai creditori soddisfatti. In pratica, l’esdebitazione è concessa subito ma con condizione risolutiva parziale: se entro quattro anni il debitore “baciato dalla fortuna” riceve ad esempio una cospicua eredità, una vincita, o comunque torna in possesso di somme importanti (non frutto del suo lavoro ordinario, che invece può tenere), i creditori potranno pretendere il pagamento fino a concorrenza di quelle nuove utilità. Non c’è però un ritorno allo status di indebitato generale: solo le sopravvenienze rilevanti vengono condivise. Dopo il quadriennio di “osservazione”, qualsiasi bene arrivi al debitore sarà definitivamente suo senza obblighi verso i vecchi creditori.
Effetti del decreto: i debiti del debitore incapiente sono inesigibili come in ogni esdebitazione. I creditori non possono più agire esecutivamente per il passato. Eventuali garanzie reali concesse da terzi restano valide (se c’era un fideiussore, come sempre, rimane obbligato). Se il debitore dovesse nei 4 anni omettere di segnalare una sopravvenienza o di consegnarne la parte dovuta, rischia la revoca dell’esdebitazione e a quel punto i debiti originari risorgerebbero.
La ratio: questa procedura risponde all’esigenza di giustizia sostanziale per i casi di povertà assoluta. Serve a evitare che persone completamente indigenti restino tecnicamente indebitate a vita per somme che mai potranno pagare, magari venendo escluse dall’economia legale (per paura di guadagni pignorabili ecc.). Si tratta di dare davvero un nuovo inizio a chi non ha nulla, pur sapendo che i creditori non recupereranno niente (ma se la persona è nullatenente, realisticamente non avrebbero recuperato comunque nulla neanche pignorando). L’ordinamento comunitario spinge per soluzioni di questo tipo in un’ottica di inclusione finanziaria e seconda chance.
Esempio pratico: Sara, 30 anni, ex lavoratrice precaria, ha debiti per €20.000 tra bollette, piccole rate e un finanziamento, ma è disoccupata, vive in affitto e non ha beni intestati né risparmi. Ogni tanto lavora in nero per mantenersi. È chiaramente insolvente ma non ha nulla da liquidare: anche volendo, nessun creditore otterrebbe utilità (non possiede auto, non ha reddito ufficiale). Sara può rivolgersi a un OCC e presentare istanza di esdebitazione da incapiente. Il tribunale verifica che Sara non ha atti in frode (es. non risulta che avesse un’auto e l’abbia venduta da poco per pochi soldi, ecc.), che non ha patrimonio e che non ha colpe gravi (i debiti li aveva fatti quando lavorava, poi ha perso il lavoro). Quindi cancella tutti i suoi €20.000 di debiti. Da quel momento Sara può ripartire: se in futuro troverà un lavoro regolare, quel reddito sarà suo (impignorabile nei limiti di legge, come per tutti), e se vorrà potrà anche accendere nuovi piccoli crediti (con cautela). Se, poniamo, entro 2 anni da questa esdebitazione Sara dovesse vincere alla lotteria €10.000, dovrebbe comunicarlo e quella somma verrebbe in buona parte destinata ai vecchi creditori (riaprendo in sostanza la partita creditoria fino a concorrenza). Ma se nulla cambia nella sua situazione, dopo 4 anni anche quell’obbligo cessa e Sara è definitivamente libera.
Limiti e cautele: l’esdebitazione incapiente non è pensata per situazioni border-line. Ad esempio, se il debitore possiede comunque anche un piccolo immobile o un’auto di medio valore, probabilmente il tribunale gli chiederà di tentare la liquidazione controllata (dove quell’attivo andrà ai creditori) anziché concedergli l’esdebitazione gratuita. Solo i casi davvero disperati e senza risorse sono destinatari appropriati. Inoltre, se emergesse che il debitore ha mentito – ad es. aveva dei beni nascosti – oltre a revocare il beneficio, potrebbe incorrere in responsabilità penale per falso.
Dal 2021, i primi esempi di applicazione di questa norma hanno iniziato a vedersi. Ad esempio, il Tribunale di Foggia nel 2021 ha emesso uno dei primi decreti di esdebitazione incapiente ex art. 283 CCII, fornendo un’illustrazione puntuale dei presupposti. Anche altri tribunali (es. Trib. Alessandria, provv. 2024) hanno seguito, omologando queste procedure quando ne ricorrevano i presupposti. Segno che lo strumento è entrato nella prassi e rappresenta un’importante rete di ultima istanza per i debitori civili in condizioni di indigenza.
Domande Frequenti (FAQ)
D: Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
R: Possono accedere alle procedure (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) tutti i debitori non fallibili in situazione di sovraindebitamento. In particolare: le persone fisiche consumatrici (solo piano o liquidazione, non il concordato); le persone fisiche imprenditori minori o professionisti (concordato minore o liquidazione); le imprese agricole; le start-up innovative (se escluse da fallimento nei primi anni, possono usare concordato minore o liquidazione); gli enti non commerciali (associazioni, fondazioni non imprenditoriali, condomini: concordato minore o liquidazione). Sono invece esclusi i soggetti assoggettabili a liquidazione giudiziale (fallimento) – es. società commerciali medio-grandi, imprenditori sopra soglia – i quali devono ricorrere alle procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, ecc.). Inoltre, non può accedere chi abbia già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti o più di due volte in totale, né chi abbia causato il proprio sovraindebitamento con frode o malafede (questi fattori costituiscono cause di inammissibilità).
D: Che differenza c’è tra il piano del consumatore e il concordato minore?
R: Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche con soli debiti personali “di consumo” e viene omologato dal tribunale senza il voto dei creditori. Richiede però un rigoroso giudizio di meritevolezza: il giudice verifica che il debitore non abbia colpe gravi nell’aver contratto i debiti. Il concordato minore, invece, è per debitori non consumatori (piccole imprese, professionisti, ecc.) e necessita del consenso dei creditori (maggioranza del credito) per essere approvato. Qui il debitore tipicamente mira a continuare l’attività (concordato in continuità) e i creditori hanno voce in capitolo. In entrambi i casi, se tutto va a buon fine, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti al termine della procedura. Riassumendo: piano = procedura unilaterale del consumatore, giudice arbitro; concordato = procedura negoziale, serve accordo con creditori e omologa giudiziale. Entrambe richiedono la relazione di un OCC e la supervisione del tribunale.
D: I debiti fiscali e contributivi (verso Agenzia Entrate, INPS, ecc.) possono essere inclusi? E le multe?
R: Sì, le procedure di sovraindebitamento includono tutti i debiti del debitore, anche quelli fiscali e previdenziali. Nel piano del consumatore e nel concordato minore è possibile proporre la rinegoziazione dei termini di pagamento o il pagamento parziale di imposte e contributi mediante la cosiddetta transazione fiscale (art. 63 CCII). Tuttavia, l’omologazione richiede il rispetto di certe condizioni: in generale, bisogna offrire al Fisco almeno quanto otterrebbe in una liquidazione del patrimonio e, in alcuni casi, raggiungere soglie di soddisfazione minima (per i crediti privilegiati erariali) a meno che l’ente non dia il consenso. Ad esempio, non si può prevedere di pagare l’IVA allo 0% senza assenso dell’Erario, perché l’IVA è un credito privilegiato per cui spesso si richiede almeno una percentuale minima. Le multe e sanzioni amministrative pecuniarie possono anch’esse essere inserite nei piani e ridotte; va però detto che anche se incluse e non pagate integralmente, le sanzioni pecuniarie non vengono esdebitate (restano escluse per legge). Quindi, ad esempio, se ho multe stradali, posso includerle nel piano e magari proporre di pagarle in parte, ma la parte non pagata alla fine resterà comunque dovuta (il che rende poco utile ridurle: conviene pagarle al 100% se possibile, perché tanto non spariscono).
D: Quali debiti non si cancellano nemmeno con l’esdebitazione?
R: Come accennato, alcuni debiti non sono mai esdebitabili (art. 278 co.7 CCII). Si tratta di: obblighi di mantenimento e alimentari (es. assegni familiari dovuti per legge); debiti per risarcimento da fatti illeciti extracontrattuali (danni civili verso terzi, tipicamente da reato); sanzioni pecuniarie penali o amministrative (multe, ammende). Questi debiti restano a carico del debitore anche dopo una procedura conclusa con esdebitazione: il creditore potrà riprenderne o continuarne l’esecuzione. Ad esempio, se un debitore aveva €10.000 di danni da incidente stradale cagionato, quella è una obbligazione di risarcimento da fatto illecito – non verrà cancellata. Importante: i debiti fiscali non rientrano tra gli esclusi, quindi sono esdebitabili (salvo la parte di sanzioni). Dunque, se dopo la liquidazione rimangono €50.000 di imposte non pagate, con l’esdebitazione questi crediti erariali non potranno più essere riscossi nei confronti del debitore. Attenzione però: se il debito fiscale deriva da violazioni penali (es. frode fiscale) e ciò comporta una multa penale, quella multa in quanto pena pecuniaria non si estingue.
D: Ho già fatto una procedura di sovraindebitamento qualche anno fa e ottenuto l’esdebitazione. Posso farne un’altra?
R: La legge impone un intervallo di almeno 5 anni tra un’esdebitazione e l’altra. Quindi, se hai ottenuto un’esdebitazione (sia dopo liquidazione sia a seguito di piano/concordato) devi attendere 5 anni dalla data in cui è diventata efficace per poter accedere di nuovo a una procedura da sovraindebitamento. Inoltre, non si possono ottenere più di due esdebitazioni in totale nell’arco della vita. Dunque massimo due “reset” dei debiti. Questo per evitare abusi seriali. Se una persona, ad esempio, è stata esdebitata nel 2018 e poi di nuovo nel 2025 (dopo i 5 anni), non potrà chiedere una terza esdebitazione in futuro.
D: Se non ho alcun bene né reddito (sono nullatenente), c’è un modo di liberarmi dai debiti?
R: Sì, ed è proprio la procedura di esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Se un debitore persona fisica non possiede beni liquidabili e non ha capacità di offrire alcuna utilità ai creditori, può chiedere al tribunale di essere esdebitato “a zero”, cioè senza pagare nulla ai creditori. Ovviamente deve dimostrare di essere meritevole e che la sua situazione è davvero di indigenza assoluta non provocata da lui. Se il tribunale accoglie, tutti i debiti vengono cancellati immediatamente. Nei 4 anni successivi, se il debitore dovesse ottenere nuove risorse (es. vincite, eredità), dovrà renderle disponibili ai creditori fino a concorrenza, ma trascorso quel periodo sarà libero definitivamente. Questa procedura, detta anche “esdebitazione a zero”, è concessa solo una volta nella vita del debitore. È pensata come extrema ratio per chi è intrappolato in debiti che non potrà mai pagare neanche parzialmente (si pensi a disoccupati, persone in povertà estrema). Ad esempio, diversi tribunali hanno già omologato esdebitazioni di incapienti, liberando completamente dal debito soggetti nullatenenti con storie di vita difficili.
D: Cosa succede ai miei beni e al mio stipendio mentre ho in corso una procedura?
R: Durante un piano del consumatore o concordato minore, il debitore rimane in possesso dei suoi beni (salvo diversa previsione del piano). Tuttavia, già dal momento del deposito del ricorso può chiedere al tribunale delle misure protettive che sospendono le azioni esecutive dei creditori e impediscono nuovi pignoramenti (art. 54 CCII). In genere il giudice emette un provvedimento che vieta ai creditori di iniziare o proseguire esecuzioni individuali sul patrimonio del debitore fino all’omologazione. Ciò significa che, ad esempio, se avevi lo stipendio pignorato, il pignoramento verrà sospeso durante la procedura (spesso i provvedimenti di sospensione vengono inviati al datore di lavoro). Analogamente, un’asta immobiliare verrebbe sospesa. Se poi la procedura viene omologata, gli atti esecutivi cessano definitivamente perché i creditori saranno soddisfatti secondo il piano. Nel piano del consumatore, tu mantieni l’amministrazione dei tuoi beni: quindi continui a percepire lo stipendio, ma devi destinarne la parte concordata al piano, e puoi continuare a usare i tuoi beni (salvo vendere quelli previsti dal piano). Nel concordato minore in continuità, vale lo stesso: il debitore rimane in gestione ma sotto controllo. In un eventuale concordato minore liquidatorio, invece, il piano potrebbe prevedere la cessione di tutti i beni a un liquidatore nominato, ma è una scelta volontaria del debitore in quel contesto. Durante la liquidazione controllata, invece, con la sentenza di apertura perdi la disponibilità dei beni (che passano al liquidatore) e non puoi più disporne. Eventuali beni essenziali per vivere (vestiti, mobili strettamente necessari, un piccolo importo di stipendio per le spese correnti) ti sono comunque lasciati secondo la legge. Il tuo stipendio, ad esempio, viene decurtato solo per la parte pignorabile (come avviene nei pignoramenti: di regola un quinto massimo, salvo il GD stabilisca diversamente). Comunque, dalla data di apertura della liquidazione non puoi pagare tu direttamente i creditori: sarà il liquidatore a farlo una volta raccolto l’attivo. Se durante la liquidazione guadagni qualcosa in più (es. straordinari), quella parte eccedente potrebbe essere acquisita alla massa (entro i limiti di pignorabilità). In ogni caso, nessun nuovo creditore può iniziare pignoramenti una volta aperta la liquidazione: tutti devono passare per la procedura concorsuale.
D: Quanto costa avviare una procedura di sovraindebitamento?
R: Ci sono dei costi, sebbene contenuti rispetto alle procedure concorsuali maggiori. Bisogna considerare: le spese di procedura e il compenso del Gestore della crisi/OCC, nonché l’eventuale compenso del liquidatore (se c’è liquidazione) e dell’avvocato che assiste il debitore. In genere: l’iscrizione a ruolo della procedura ha un costo di qualche centinaio di euro (marca da bollo, contributo unificato di solito €98). L’OCC spesso chiede un fondo spese iniziale (qualche centinaio di euro per predisporre la relazione) e poi viene compensato a fine procedura in base a tariffari ministeriali, di solito con una percentuale sui risultati (pagamenti effettuati ai creditori). Alcuni tribunali prevedono che i compensi dell’OCC e del liquidatore siano pagati come prededuzione all’interno della procedura, attingendo dall’attivo ricavato prima di pagare i creditori (il che significa che il debitore non deve anticiparli per intero, ma riducono ciò che va ai creditori). Se il debitore è completamente nullatenente, l’OCC può chiedere l’attivazione di un fondo statale (c’è un fondo di solidarietà per coprire in parte le spese degli OCC nei casi di particolare indigenza, previsto dal DM 202/2014). In sintesi, all’inizio il debitore deve spesso sostenere un piccolo costo (qualche centinaio di euro) per attivare la procedura e per la relazione OCC. L’avvocato, se il debitore non ha reddito, può essere chiesto di gratuito patrocinio (diversi tribunali ammettono il patrocinio a spese dello Stato per le procedure di sovraindebitamento, dato che sono equiparate a cause civili non voluttuarie). In caso contrario, l’onorario dell’avvocato dipende dal professionista ma molti applicano tariffe calmierate per queste procedure. Nel complesso, i costi non sono proibitivi: la ratio della legge è di dare una chance anche a chi è in difficoltà, quindi gli oneri sono contenuti e comunque proporzionati alla massa attiva (se c’è). Ad esempio, per un piano in cui il debitore paga €20.000 in 4 anni, l’OCC potrebbe avere diritto a qualche migliaio di euro a fine procedura, già conteggiati nel piano; l’avvocato magari chiede 1.500€ dilazionati; il contributo unificato è €98.
D: Se avevo già una causa o un decreto ingiuntivo in corso con un creditore, posso ancora fare il sovraindebitamento?
R: Sì. La pendenza di giudizi o di decreti ingiuntivi non impedisce di attivare una procedura di sovraindebitamento. Anzi, spesso il debitore ricorre a queste procedure proprio quando iniziano ad accumularsi cause e precetti. Una volta presentata la domanda di nomina OCC o di apertura procedura, il tribunale competente per l’esdebitazione solitamente informa gli altri giudici esecutivi. Se c’è un decreto ingiuntivo non ancora definitivo, la procedura di sovraindebitamento non lo sospende in automatico, ma il debitore può chiedere una moratoria: tuttavia, generalmente il creditore otterrà comunque il decreto (che accerta il credito) e poi si inserirà nel passivo concorsuale. La Cassazione ha chiarito che la pendenza della nomina OCC non costituisce motivo per sospendere un giudizio di cognizione sul credito: l’accertamento di un credito infatti non è incompatibile con la procedura concorsuale, anzi serve a definire il passivo. Quindi, ad esempio, se Tizio ha fatto causa a Caio per un credito, e Caio nel frattempo presenta piano del consumatore, la causa per stabilire se Caio deve quei soldi a Tizio può proseguire fino a sentenza (poi Tizio sarà trattato come creditore concorsuale nel piano). Invece, per le esecuzioni forzate, come detto, la presentazione dell’istanza sospende i pignoramenti in corso (previa pronuncia del giudice concorsuale). Se per assurdo il giudice dell’esecuzione non fosse stato informato e vendesse un bene durante il sovraindebitamento, il ricavato sarebbe comunque da rimettere nella procedura concorsuale.
D: Cosa significa esattamente “fresh start” per il debitore?
R: “Fresh start” vuol dire che, una volta ottenuta l’esdebitazione, il debitore può ricominciare da capo senza l’ombra dei debiti passati. In concreto: i creditori pregressi non possono più pretender nulla da lui (quei debiti sono come “cancellati” verso la sua persona); il debitore torna solvibile e affidabile sul mercato, potenzialmente può anche ottenere nuovo credito (se la sua situazione reddituale lo consente) perché non ha più posizioni insolute. Naturalmente, l’esdebitazione è annotata nei registri: ad esempio, nella Centrale Rischi o nei SIC privati può risultare per qualche tempo che Tizio ha fatto una procedura di sovraindebitamento. Ma non è un’infamia: è un percorso legale di risanamento. Non esistono “liste nere” pubbliche dei sovraindebitati esdebitati (diverso dal fallito civile, che prima rimaneva con stigma): oggi l’esdebitato è reinserito a pieno titolo. Alcuni effetti residuali: se i debiti comprendevano sanzioni penali, quelle restano (come detto) e vanno comunque pagate o scontate; se il debitore era protestato, dovrà fare la riabilitazione dei protesti; se aveva ipoteche giudiziali sui beni e quei beni sono rimasti invenduti, le ipoteche decadono? Su questo tecnicamente l’esdebitazione rende il debito inesigibile, quindi un’ipoteca a garanzia di un credito esdebitato perde efficacia (non può essere azionata), sebbene possa servire una formalità per cancellarla. In sintesi, il “fresh start” significa cancellazione legale dei debiti e riabilitazione economica. Come ha sottolineato anche la giurisprudenza recente e la stessa Corte di Giustizia UE, l’obiettivo delle normative moderne è di offrire al debitore sovraindebitato onesto la possibilità di tornare attivo economicamente, senza restare schiacciato a vita dai debiti passati.
D: I miei garanti o coobbligati beneficiano anche loro dell’esdebitazione?
R: No, l’esdebitazione opera solo in favore del debitore che l’ha ottenuta. I coobbligati (fideiussori, condebitori in solido, terzi garanti) restano obbligati per intero. Ad esempio, se i tuoi genitori hanno garantito un tuo prestito, e tu vieni esdebitato da quel prestito, la banca potrà comunque rivalersi sui tuoi genitori garanti per l’intero importo originario (detratto quanto eventualmente incassato nella procedura concorsuale). Questo principio è espressamente confermato dall’art. 282 co.3 CCII. Dunque attenzione: la tua esdebitazione personale non libera eventuali altri debitori. Stessa cosa per gli obbligati di regresso: se un coobbligato paga, potrà sempre agire in regresso contro di te nei limiti di quanto ha pagato prima dell’esdebitazione (in realtà, se ha pagato dopo la tua esdebitazione il suo regresso non potrà essere soddisfatto da te, perché tu sei esdebitato; ma se ha pagato prima, il suo credito di regresso era concorsuale e se non è stato soddisfatto, rimane esdebitato anche quello). Un po’ tecnica come questione, ma in sintesi: i tuoi debiti verso terzi garantiti non risorgono come debiti verso i garanti. Quei garanti semplicemente non beneficiano della cancellazione e devono pagare al posto tuo, se il creditore lo richiede.
D: E se dopo l’esdebitazione commetto nuovi errori e mi indebito di nuovo?
R: La legge non ti protegge per i debiti successivi. L’esdebitazione riguarda quelli anteriori alla procedura. Se dopo aver avuto un fresh start contrai nuovi debiti e finisci ancora insolvente, come visto potrai chiedere un’altra procedura solo trascorsi almeno 5 anni (e comunque non più di due volte nella vita). Quindi cerca di evitare di tornare nel ciclo! Uno scopo delle procedure è anche quello di promuovere una cultura finanziaria responsabile: infatti si parla di misure per educare il debitore ed evitare il sovraindebitamento recidivo. Ad esempio, la Direttiva UE 2019/1023 incoraggia gli Stati a prendere misure affinché le persone esdebitate non ricadano facilmente in nuove insolvenze. In Italia non c’è un divieto a fare debiti dopo l’esdebitazione, ma ovviamente il sistema creditizio saprà che hai avuto un’insolvenza pregressa e potrebbe essere più cauto nel prestarti soldi in futuro (almeno per qualche anno). Quindi, dopo un’esdebitazione, conviene fare tesoro dell’esperienza e gestire con prudenza le proprie finanze, per non trovarsi di nuovo nei guai senza più la rete di salvataggio.
D: Un creditore mi ha notificato un atto di precetto senza l’avviso sulla possibilità di ricorrere al sovraindebitamento. Posso far annullare il precetto?
R: Dal 2021, l’art. 480 c.p.c. richiede che nell’atto di precetto sia inserito l’avvertimento al debitore circa la possibilità di rivolgersi a un OCC per tentare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancanza di tale avviso non comporta la nullità del precetto. Si tratta di una irregolarità formale che non incide sul diritto sostanziale del creditore di intimare il pagamento. Quindi non è possibile ottenere l’annullamento del precetto solo per quell’omissione. Resta il fatto che, anche se il creditore non te lo ha scritto, tu hai comunque il diritto di attivare una procedura di sovraindebitamento: la mancata indicazione non pregiudica la tua possibilità di fare domanda al tribunale. In pratica l’avviso è un promemoria che la legge impone per informare i debitori di questa opportunità, ma se manca non invalida l’atto. Quindi, se hai ricevuto un precetto “incompleto”, non perdi i tuoi diritti: puoi contattare un OCC e iniziare la procedura, chiedendo magari la sospensione dell’esecuzione in corso.
D: I piccoli imprenditori o professionisti possono scegliere tra concordato minore e piano del consumatore?
R: In linea di massima no: se sei un imprenditore o professionista con debiti collegati alla tua attività, non rientri nella definizione di consumatore e dunque non puoi accedere al piano del consumatore per quei debiti. Devi usare il concordato minore. La scelta tra le procedure non è libera, ma determinata dalla qualifica del debitore e dalla natura dei debiti. Caso peculiare: se un imprenditore individuale ha anche molti debiti personali del tutto scollegati dall’attività, c’è stato chi ha provato a “spezzare” le due cose (piano per i debiti personali, concordato per quelli d’impresa). La legge non disciplina espressamente questa biforcazione, ma qualche tribunale l’ha ammessa in casi eccezionali, coordinando le procedure. Resta però rischioso per possibili conflitti. La regola generale è: se svolgi attività d’impresa o professionale, sei considerato debitore non consumatore, e quindi fai concordato minore per l’insieme dei tuoi debiti (tutti i debiti, anche personali, possono essere inclusi in concordato minore). Invece, se hai cessato l’attività e i tuoi debiti residui sono ormai personali (ad esempio debiti fiscali personali o cose così), potresti qualificarti come consumatore per quei debiti estranei e tentare un piano su quelli; però attento, se i debiti d’impresa sono ancora rilevanti, il giudice potrebbe non trovarti “puro” consumatore. In pratica, la linea di demarcazione la fa la natura dei debiti: debiti per esigenze personali → piano; debiti legati ad attività economica → concordato.
D: Durante la procedura posso continuare la mia attività lavorativa/imprenditoriale?
R: Sì. La legge mira proprio a consentire la continuazione dell’attività ove possibile, specie nel concordato minore. Se sei un imprenditore o professionista in concordato minore in continuità, continui a esercitare sotto la tua responsabilità, magari con qualche restrizione (il tribunale può richiedere che non aggravi la posizione debitoria, ecc.). Avrai l’obbligo di seguire il piano, quindi ad esempio non potrai pagare vecchi debiti al di fuori del piano, ma puoi contrarre debiti nuovi se funzionali all’attività corrente (purché li paghi regolarmente, altrimenti rischi di decadere dai benefici). Nel piano del consumatore, se hai un lavoro da dipendente lo mantieni e anzi usi parte dello stipendio per pagare le rate; se sei un autonomo, continui a lavorare normalmente. Nella liquidazione controllata, se avevi un’impresa, di fatto quell’impresa viene liquidata a meno che un esercizio provvisorio sia autorizzato (il CCII prevede l’esercizio provvisorio solo nella liquidazione giudiziale, per la liquidazione controllata di solito no, ma se c’è un’attività che conviene portare avanti per vendere meglio i beni, il liquidatore potrebbe temporaneamente gestirla). In generale, niente ti vieta di continuare a produrre reddito durante la procedura – anzi, è auspicabile perché con quel reddito puoi alimentare i pagamenti. Solo, il reddito in più potrebbe essere in parte destinato ai creditori (come detto, nella liquidazione il liquidatore prenderà la parte pignorabile). Una volta esdebitato, potrai esercitare attività normalmente: attenzione, per i fallimenti c’era l’interdizione all’impresa, ma nel sovraindebitamento non c’è alcuna interdizione. Quindi anche se hai fatto liquidazione controllata, non sei soggetto a divieti di aprire nuove attività o essere amministratore di società (salvo il caso di reati commessi, ma quella è altra materia). Questo è un notevole vantaggio per i piccoli imprenditori: l’esdebitazione li rimette in gioco subito.
Conclusioni
Il sovraindebitamento delle persone fisiche rappresenta una “patologia” finanziaria purtroppo diffusa, ma oggi l’ordinamento offre strumenti avanzati per gestirla in modo ordinato e umano. Dal punto di vista del debitore, conoscere queste procedure significa poter trasformare una situazione disperata in un percorso verso la riabilitazione economica. Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, aggiornato alle ultime riforme del 2024-2025, enfatizza il favor debitoris e punta a facilitare l’accesso alle soluzioni per i debitori meritevoli.
Abbiamo visto che esistono diverse opzioni – dal piano del consumatore per chi può pagare almeno in parte, al concordato minore per i piccoli operatori economici, alla liquidazione controllata con esdebitazione finale, fino all’esdebitazione “senza attivo” per i casi più gravi – e che ciascuna ha i suoi requisiti e benefici. In tutte, comunque, il punto di vista del debitore è radicalmente cambiato rispetto al passato: da soggetto passivo condannato al debito eterno, egli diventa protagonista di un percorso di risanamento, responsabile ma assistito dalla legge nel trovare una via d’uscita sostenibile. Chiaramente, il sistema tutela anche i creditori: richiede trasparenza, lealtà e sacrificio massimo delle risorse disponibili. Ma oltre a questo, non si può chiedere al debitore l’impossibile; anzi, conviene a tutti che egli torni produttivo e libero da vincoli insaldabili.
Per gli avvocati e professionisti del settore, seguire queste evoluzioni normative e giurisprudenziali è fondamentale per assistere efficacemente i debitori (così come, sul fronte opposto, i creditori nel far valere i propri diritti nelle procedure). Come abbiamo citato, la giurisprudenza recente – dalle decisioni della Cassazione alle pronunce dei tribunali di merito – sta delineando in modo sempre più chiaro i confini dell’accesso, i criteri di meritevolezza e le tutele procedurali. Ad esempio, la Cassazione ha definito limiti alla falcidiabilità dei creditori ipotecari nei piani, i giudici di merito stanno applicando con equilibrio il concetto di merito creditizio dei finanziatori negligenti, e la Corte di Giustizia UE ha di recente confermato che escludere i debitori disonesti dall’esdebitazione è compatibile con la direttiva insolvenze, mentre ha messo in dubbio eccessive esclusioni di categorie di debiti dal beneficio. Tutto ciò confluisce in un quadro normativo complesso ma organico, che avvocati e operatori devono conoscere per usare al meglio queste procedure.
Dal punto di vista del debitore, dunque, “cosa sapere” sul sovraindebitamento si può riassumere così: non tutto è perduto quando i debiti superano le possibilità, esistono vie legali per uscirne; occorre però agire per tempo, con onestà e affidandosi a professionisti esperti (OCC e legali), per imboccare la procedura giusta e seguire le regole. Il cammino richiede impegno e qualche rinuncia, ma al traguardo c’è la cancellazione dei debiti e la riconquista della dignità finanziaria. Sapere di avere questo diritto – quello al fresh start – è già un primo passo importante per chiunque si trovi schiacciato dai debiti.
Nota: La presente guida ha un taglio divulgativo ma basato sulla normativa italiana vigente a luglio 2025 e sui più autorevoli orientamenti giurisprudenziali. Ogni caso concreto può presentare peculiarità: si raccomanda dunque, in situazioni reali di sovraindebitamento, di rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi o a un legale specializzato, che possano valutare i requisiti specifici e assistere nel percorso più idoneo.
Fonti e Riferimenti Normativi/Giurisprudenziali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14) – artt. 2, 65-83, 268-283, e successive modifiche D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
- Legge 27 gennaio 2012, n.3 (Disciplina originaria del sovraindebitamento, abrogata dal CCII).
- Legge 18 dicembre 2020, n.176 (conversione D.L. 137/2020 “Ristori”) – ha modificato la L.3/2012 introducendo esdebitazione incapiente, ampliando nozione di consumatore, ecc..
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n.136 (“Correttivo Ter” al CCII) – v. Relazione illustrativa e commenti su sovraindebitamento (definizione di consumatore confermata e migliorata, procedure familiari, trattamento crediti fiscali).
- Cassazione Civile, sez. I, 26 luglio 2022 n.23343 – Omissione dell’avviso ex art.480 co.2 c.p.c. nel precetto non causa nullità dell’atto.
- Cassazione Civile, sez. I, 14 febbraio 2023 n.4613 – Sovraindebitamento: in sede di omologa dell’accordo ex L.3/2012, va garantito al creditore ipotecario dissenziente un trattamento non inferiore al ricavabile da liquidazione (comparazione da estendersi ai diritti realizzabili su beni alienati).
- Cassazione Civile, sez. I, 27 luglio 2023 n.22699 – Nozione di consumatore abilitato al piano: confermata definizione restrittiva (debiti contratti per esigenze personali, estranee ad attività di impresa; basta un debito di natura imprenditoriale per escludere accesso come consumatore).
- Tribunale di Rimini, 7 gennaio 2025 (decr.) – In concordato minore, i crediti erariali privilegiati e chirografari vanno soddisfatti “in misura non deteriore” rispetto agli altri di pari rango (applicazione art.74 co.4 CCII).
- Corte di Giustizia UE, sent. 8 maggio 2024 (causa C-20/23) – Art.23 par.4 direttiva insolvenze 2019/1023: limiti alle esclusioni di intere categorie di debiti dall’esdebitazione (questione pregiudiziale su debiti tributari).
- Corte di Giustizia UE, sent. 10 aprile 2025 (causa C-723/23) – Confermata compatibilità con diritto UE di norme nazionali che negano l’accesso all’esdebitazione a debitori che abbiano agito in modo disonesto o in malafede (interpretazione art.23 direttiva EU 2019/1023).
- Tribunale di Foggia, 2021 – Decreto di esdebitazione del debitore incapiente ex art.283 CCII: primo caso applicativo. V. anche Tribunale di Milano, Tribunale di Alessandria 2024 (decreti analoghi) per prassi su incapienti.
- Linee guida e prassi: Protocollo Tribunale di Milano 2021 (procedure sovraindebitamento); Linee guida Tribunale di Spoleto 2022 sulla liquidazione controllata; approfondimenti vari in dottrina.
Sovraindebitamento delle persone fisiche? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai accumulato troppi debiti e non riesci più a pagare rate, mutui, bollette o cartelle esattoriali?
Ti senti schiacciato da prestiti, finanziarie e richieste continue da parte dei creditori?
Se sei una persona fisica non fallibile (privato, pensionato, lavoratore dipendente, autonomo o ex imprenditore), la legge ti tutela. Puoi accedere a una procedura di sovraindebitamento per rinegoziare i debiti o ottenerne la cancellazione.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la tua situazione debitoria complessiva: banche, Fisco, INPS, finanziarie, fornitori
- 📌 Verifica i requisiti di accesso alla procedura di sovraindebitamento prevista dal Codice della Crisi
- ✍️ Redige il piano del consumatore, la ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata
- ⚖️ Ti assiste davanti all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e al Tribunale
- 🔁 Ti guida fino all’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti non più pagabili
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto del sovraindebitamento e tutela delle persone fisiche
- ✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
- ✔️ Specializzato nella difesa di privati, famiglie, pensionati, lavoratori e partite IVA in difficoltà economica
Conclusione
Il sovraindebitamento non è una colpa, ma una condizione che può capitare a chiunque.
Con la giusta assistenza puoi bloccare i creditori, salvare il tuo patrimonio e ripartire da zero, liberandoti dai debiti.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua rinascita economica comincia da qui.