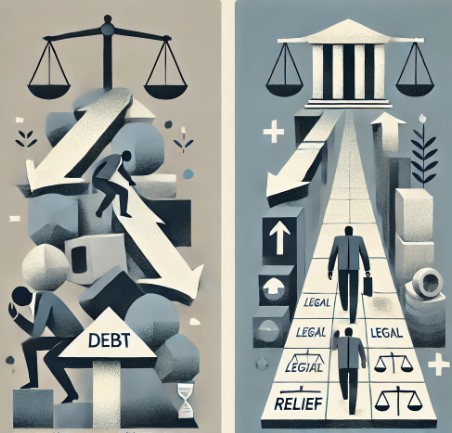Hai troppi debiti e stai valutando la procedura di sovraindebitamento, ma nel frattempo hai ricevuto (o potresti ricevere) beni in eredità? Ti stai chiedendo cosa succede a quei beni, se vanno persi, se possono essere esclusi o se esistono modi per proteggerli?
La procedura di sovraindebitamento ti permette di ristrutturare o estinguere i debiti non sostenibili, ma richiede trasparenza totale sul tuo patrimonio, inclusi i beni ereditati. Tuttavia, la legge offre anche tutele precise, soprattutto se agisci in tempo.
Cosa succede se ricevi beni in eredità prima della procedura?
– I beni entrano a far parte della massa attiva e devono essere dichiarati
– Rientrano nel calcolo della tua capacità patrimoniale e reddituale
– Possono essere destinati, in tutto o in parte, alla soddisfazione dei creditori
– Se hai già accettato l’eredità, non puoi più escludere quei beni dal patrimonio
E se l’eredità arriva dopo l’inizio della procedura?
– Se la ricevi prima dell’omologa del piano, devi comunicarlo e il giudice valuterà l’impatto sul piano di pagamento
– Se arriva dopo l’omologazione, può restare fuori, ma dipende dai termini dell’accordo e dalle clausole previste
– L’eredità può costituire una “sopravvenienza” rilevante e portare a una modifica del piano approvato
Cosa puoi fare per tutelarti prima di accettare l’eredità?
– Valuta sempre l’accettazione con beneficio d’inventario, per separare i debiti dell’eredità da quelli personali
– Se l’eredità è solo passività, puoi rinunciarvi
– Se sei ancora in fase istruttoria della procedura, valuta attentamente con l’avvocato l’opportunità di accettare o rinunciare
– Attento ai termini: l’accettazione tacita può avvenire anche con atti di gestione
L’eredità influisce sempre sulla procedura?
– Non necessariamente. Dipende dal valore, dal momento in cui viene ricevuta e dal tipo di piano presentato
– In alcuni casi, puoi proporre un piano che include la liquidazione volontaria del bene ereditato, per ottenere l’omologa
– In altri, se la procedura è già omologata, puoi destinare parte dei beni a pagamento volontario extra piano
Come si comportano i creditori in questi casi?
– Se l’eredità è rilevante, possono chiedere la modifica del piano o opporsi all’omologazione
– In fase di trattativa, la presenza di un bene ereditato può aiutare ad ottenere uno stralcio maggiore, se usato strategicamente
– L’importante è non nascondere l’informazione, per evitare la revoca della procedura e conseguenze penali
Cosa rischi se non dichiari i beni ereditati?
– La revoca dell’omologa e la decadenza dai benefici ottenuti
– L’impossibilità di accedere nuovamente alla procedura per diversi anni
– L’obbligo di pagare tutti i debiti, con interessi e sanzioni
– Possibili denunce per falso in procedura o frode ai creditori
Ricevere beni in eredità non è sempre un ostacolo alla procedura, ma va gestito con attenzione. Un errore o una dimenticanza può compromettere tutto il percorso di uscita dal debito.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in procedure di sovraindebitamento e tutela del patrimonio familiare ti spiega cosa succede se ricevi beni in eredità mentre sei sovraindebitato, come comportarti e quali strategie adottare per proteggere i tuoi diritti.
Hai ricevuto o stai per ricevere un’eredità e sei in difficoltà con i debiti? Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Valuteremo la tua situazione e ti diremo se puoi accedere alla procedura, come gestire i beni ricevuti e come difendere il tuo patrimonio.
Introduzione
La procedura di sovraindebitamento rappresenta uno strumento legale che consente ai debitori “non fallibili” (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, ecc.) di gestire e risolvere una situazione di crisi debitoria attraverso piani di ristrutturazione o liquidazione dei propri beni. In Italia, questo istituto è stato introdotto con la Legge 3/2012 (cosiddetta “legge sul sovraindebitamento”) e, a partire dal 15 luglio 2022, è confluito nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato). Si tratta di procedure concorsuali “minori” pensate per offrire al debitore sovraindebitato una via d’uscita tramite la ristrutturazione dei debiti o, in casi estremi, la liberazione dai debiti residui (esdebitazione), bilanciando al contempo gli interessi dei creditori.
Un aspetto delicato e spesso fonte di domande è l’interazione tra la procedura di sovraindebitamento e i beni ricevuti in eredità. Cosa accade se un debitore sovraindebitato ottiene un’eredità? Può rinunciarvi per evitare che venga aggredita dai creditori? I creditori possono reclamare quei beni ereditari? E se invece è il debitore sovraindebitato a lasciare debiti agli eredi, come si inserisce la procedura concorsuale in caso di decesso? Questa guida – aggiornata a luglio 2025 – affronta dettagliatamente queste domande dal punto di vista del debitore, fornendo riferimenti normativi italiani aggiornati, sentenze recenti e linee guida operative. Il taglio sarà giuridico ma divulgativo, adatto sia ai professionisti legali (avvocati, OCC) sia ai privati e imprenditori coinvolti, con approfondimenti di livello avanzato.
Struttureremo l’analisi descrivendo tutte le tipologie di procedure di sovraindebitamento attualmente previste (piano del consumatore/ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente), distinguendo le principali categorie di debitori ammissibili. Successivamente, esamineremo il rapporto tra sovraindebitamento e beni ereditari, includendo sia i beni che il debitore riceve in eredità, sia gli effetti della morte del debitore sulla procedura. Saranno fornite tabelle riepilogative per facilitare la comprensione delle caratteristiche delle procedure e delle possibili scelte riguardo all’eredità. Inoltre, una sezione di Domande e Risposte affronterà in forma chiara i quesiti più frequenti (FAQ). Esempi pratici e simulazioni – rigorosamente riferiti al contesto italiano – aiuteranno a contestualizzare le regole. Le fonti utilizzate (normative e giurisprudenziali) sono elencate in fondo alla guida nella sezione Fonti, per consentire al lettore ulteriori approfondimenti.
Quadro normativo e soggetti ammessi alle procedure
Il concetto di sovraindebitamento è definito dalla legge come lo stato di crisi o insolvenza in cui può trovarsi un debitore non assoggettabile alle ordinarie procedure fallimentari (ora “liquidazione giudiziale”). In altre parole, rientrano nell’ambito del sovraindebitamento “tutti i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi. Storicamente, le procedure previste dalla Legge 3/2012 erano riservate ai soggetti “non fallibili”, cioè coloro che per natura o dimensioni non potevano essere dichiarati falliti secondo la Legge Fallimentare del 1942. Oggi, sotto il Codice della Crisi (CCII), queste procedure conservano la stessa platea di destinatari, includendo:
- Consumatori: persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali. Il consumatore è titolare esclusivamente di obbligazioni di natura civile/consumistici (es. famiglie indebitate per mutui, finanziamenti al consumo, bollette, ecc.). Recenti modifiche normative hanno chiarito che anche il socio di una società di persone (snc, sas, sapa) può essere considerato “consumatore” limitatamente ai debiti assunti per fini estranei all’attività imprenditoriale. Dunque, ad esempio, un socio illimitatamente responsabile potrà accedere a una procedura di sovraindebitamento per i propri debiti personali non legati alla società, senza che la sola possibilità di estensione del fallimento della società a lui (ex art. 256 CCII) costituisca più un divieto automatico.
- Imprenditori minori: imprenditori individuali (commerciali) di piccole dimensioni, sotto le soglie di fallibilità previste dalla legge (oggi generalmente ricomprese nella categoria dei debitori non soggetti a liquidazione giudiziale). Sono tipicamente piccoli commercianti o artigiani che non superano determinati parametri di attivo, ricavi e debiti. Rientrano anche gli imprenditori agricoli, i quali per legge non sono soggetti a fallimento, e dunque possono utilizzare le procedure da sovraindebitamento indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda agricola.
- Lavoratori autonomi e professionisti: ad esempio, liberi professionisti (avvocati, medici, commercialisti, ecc.), artisti, start-up innovative individuali, e in generale soggetti che pur avendo debiti legati a un’attività economica non sono soggetti a fallimento (i professionisti e gli enti non commerciali non potevano fallire neppure sotto la vecchia legge fallimentare). Il CCII include espressamente i professionisti e le ditte individuali tra i debitori sovraindebitati che possono accedere alle procedure di composizione della crisi.
- Soci illimitatamente responsabili di società: come accennato, un socio di società di persone (es. SNC) potrebbe trovarsi con debiti personali o anche essere esposto per i debiti sociali. Se la società non è assoggettabile a liquidazione giudiziale (ad esempio perché agricola o di piccole dimensioni), i soci possono essere considerati debitori sovraindebitati. In particolare, il nuovo art. 2 lett. e) CCII (come modificato dal correttivo 2024) permette al socio illimitatamente responsabile di accedere a una procedura da sovraindebitamento per i debiti estranei all’attività d’impresa.
- Enti non commerciali e altri soggetti non fallibili: rientrano anche categorie come associazioni, fondazioni o altri enti che non esercitano attività d’impresa commerciale in via principale, e che quindi non possono essere dichiarati falliti. Questi, qualora si trovino insolventi, possono utilizzare le procedure di sovraindebitamento (ad esempio, un’associazione culturale indebitata).
Come si vede, la platea è ampia: il legislatore ha voluto includere chiunque resti fuori dal fallimento (oggi liquidazione giudiziale) per ragioni soggettive o quantitative. Ciò detto, occorre distinguere le varie procedure offerte a tali debitori, perché il Codice della Crisi prevede soluzioni diverse a seconda della natura del debitore e del tipo di accordo o liquidazione prospettato. In particolare, il CCII ha ridefinito in modo netto due sottocategorie di composizione della crisi da sovraindebitamento: da un lato la ristrutturazione dei debiti del consumatore (riservata esclusivamente ai consumatori), dall’altro il concordato minore (accessibile ai debitori non consumatori). Oltre a queste procedure “di accordo”, esiste la procedura liquidatoria, ora denominata liquidazione controllata del sovraindebitato, analoga alla vecchia “liquidazione del patrimonio” di cui alla L.3/2012. Infine, novità di grande rilievo introdotta dal Codice è l’esdebitazione del debitore incapiente, una procedura speciale che consente – in presenza di stringenti condizioni – di cancellare i debiti residui a chi non ha alcuna risorsa da mettere a disposizione dei creditori.
Riassumendo, il ventaglio di procedure a disposizione del debitore sovraindebitato comprende:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (già noto come “piano del consumatore” nella L.3/2012);
- Concordato minore (successore dell’accordo di composizione dei debiti, per soggetti diversi dal consumatore);
- Liquidazione controllata del patrimonio (successore della “liquidazione del patrimonio” L.3/2012, equiparabile a una liquidazione concorsuale);
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (procedura introdotta dal CCII per il debitore persona fisica privo di beni e redditi).
Le prime due sono procedure di composizione concordataria della crisi (con un piano di pagamento, con o senza voto dei creditori a seconda dei casi), le ultime due sono procedure di carattere liquidatorio (in cui il patrimonio del debitore è messo a disposizione dei creditori, sia integralmente come nella liquidazione, sia virtualmente inesistente come nel caso dell’incapiente). Nei paragrafi seguenti analizziamo singolarmente queste procedure, focalizzandoci su come i beni ereditati dal debitore vengono trattati in ciascuna di esse e quali strategie può adottare il debitore stesso.
Tipologie di procedure da sovraindebitamento e trattamento dei beni ereditari
In questa sezione passiamo in rassegna le diverse procedure di sovraindebitamento oggi vigenti, evidenziandone le caratteristiche chiave (soggetti ammessi, requisiti, funzionamento) e concentrandoci sul destino dei beni eventualmente ricevuti in eredità dal debitore nell’ambito di ciascuna procedura. È importante sottolineare che, quale che sia la procedura intrapresa, il principio generale della responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 c.c. continua a valere: il debitore “risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. In sede concorsuale, ciò si traduce nella regola per cui, entro certi limiti temporali, anche i beni sopravvenuti durante la procedura (come ad esempio un’eredità ricevuta in corso di procedura) devono essere destinati al soddisfacimento dei creditori. Il modo in cui questo avviene varia però a seconda del tipo di procedura, come vedremo di seguito.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il piano del consumatore – oggi denominato “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” nel Codice della Crisi (artt. 67-73 CCII) – è una procedura riservata esclusivamente al debitore persona fisica consumatore, cioè colui che ha debiti di natura per lo più civile e non professionale. È una procedura monocratica e giudiziale, nel senso che non richiede l’accordo dei creditori attraverso un voto, bensì viene valutata ed eventualmente omologata direttamente dal Tribunale (previo parere dell’Organismo di Composizione della Crisi – OCC). In altre parole, a differenza dei concordati o accordi, i creditori non votano sul piano del consumatore; essi possono tuttavia proporre opposizioni in sede di omologazione, ma la decisione finale spetta al giudice, il quale verifica la fattibilità e la convenienza del piano e – soprattutto – la meritevolezza del debitore.
Requisiti di accesso: il consumatore deve trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio tra i debiti e il patrimonio/reddito disponibile per soddisfarli, tale da renderlo incapace di adempiere alle obbligazioni. È richiesta la assenza di condotte fraudolente o gravemente colpose nell’indebitamento. La legge richiede che il debitore abbia agito con diligenza e buona fede: in particolare l’art. 69 CCII (così come l’ex art. 12 L.3/2012) prevede che non devono emergere atti in frode ai creditori né una causazione dolosa o gravemente colposa del proprio indebitamento. Questa valutazione è affidata al Tribunale, che si avvale della relazione redatta dall’OCC (la quale deve indicare le cause dell’indebitamento, la storia finanziaria del debitore e il suo comportamento). Da notare che la riforma ha attenuato il precedente rigore: in passato bastava anche colpa lieve per negare l’accesso, oggi la soglia è dolo o colpa grave. Dunque, ad esempio, un consumatore che abbia accumulato debiti per spese voluttuarie o gioco d’azzardo patologico potrebbe vedersi negare il piano se tale condotta è considerata gravemente colposa, a meno che non dimostri un ravvedimento e percorsi di recupero (es. nel caso della ludopatia).
Funzionamento del piano: il debitore, con l’ausilio dell’OCC, predispone un piano di rientro dei debiti proponendo il pagamento, anche parziale e dilazionato, di quanto dovuto ai creditori. Il piano può prevedere qualsiasi forma di ristrutturazione del debito, inclusi stralci (pagamenti parziali del dovuto), dilazioni (rateizzazioni su più anni), eventuali garanzie offerte da terzi, cessione di parte dei redditi futuri, etc. Può anche contemplare la liquidazione di taluni beni del debitore, ma l’obiettivo è consentire al consumatore di conservare quanto più possibile uno standard di vita dignitoso e magari preservare beni essenziali (come l’abitazione principale) compatibilmente con il soddisfacimento parziale dei crediti. Il tribunale omologa il piano se ritiene che il debitore sia meritevole e che il piano assicuri ai creditori un pagamento non inferiore a quello che otterrebbero in una liquidazione controllata dei beni (principio della convenienza). Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti) e, se il debitore esegue fedelmente quanto previsto, egli ottiene la esdebitazione (cancellazione dei debiti residui non pagati nel piano).
Novità introdotte (aggiornamento 2024): il Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024) ha apportato alcune modifiche per rendere più efficace e flessibile il piano del consumatore. In particolare:
- È stata ampliata la nozione di consumatore, come già detto, in modo da includere anche i debitori persone fisiche che abbiano eventualmente ruoli di soci d’impresa, purché i debiti oggetto del piano siano estranei all’attività imprenditoriale.
- È stata introdotta espressamente la possibilità per membri della stessa famiglia convivente di presentare un piano familiare unitario, cioè un unico progetto di ristrutturazione che coinvolge più co-debitori legati da vincoli familiari. Ciò consente, ad esempio, a moglie e marito entrambi indebitati di proporre insieme un piano congiunto, semplificando la procedura.
- È stata reintrodotta e ampliata la moratoria per i crediti muniti di privilegio o ipoteca. Mentre la L.3/2012 già permetteva una moratoria fino a 1 anno dall’omologazione per iniziare a pagare i creditori privilegiati, ora l’art. 67, comma 4 CCII consente una moratoria fino a 2 anni. Questo consente al debitore di sospendere fino a due anni il pagamento delle rate ad esempio di mutui ipotecari, per potersi riorganizzare finanziariamente, fermo restando che gli interessi maturati nel frattempo sui crediti privilegiati vanno comunque soddisfatti. La ragione è bilanciare l’esigenza di rendere il piano più sostenibile per il debitore con la tutela dei creditori privilegiati, i quali non votano nel piano del consumatore e quindi non possono opporsi se non con osservazioni al giudice.
- Viene esplicitata la possibilità (art. 67, comma 5 CCII) di mantenere in essere il mutuo sulla prima casa: se il debitore è in regola con i pagamenti, può continuare a pagare alle scadenze originarie le rate del mutuo ipotecario sulla sua abitazione, escludendole dalla ristrutturazione. Se invece è in temporaneo arretrato, il giudice può autorizzare il pagamento delle rate scadute per ripristinare la regolarità. In tal modo, il piano può prevedere di non liquidare la casa di abitazione, consentendo al debitore di conservarla, pagando il mutuo come originariamente previsto (questa è una novità importante che tutela il bene-casa evitando che la procedura imponga necessariamente la vendita).
- Proceduralmente, è stato chiarito (art. 67, comma 6 CCII) che tutta la procedura di omologazione del piano si svolge davanti ad un giudice monocratico (e non in composizione collegiale), il che dovrebbe snellire e velocizzare l’esame delle richieste.
- È stata eliminata la possibilità di presentare una domanda “in bianco” o prenotativa (ovvero senza allegare subito il piano dettagliato) per il piano del consumatore: il Correttivo 2024 ha infatti precluso che il debitore consumatore depositi un ricorso incompleto ex art. 44 CCII al solo scopo di ottenere misure protettive, rinviando la presentazione del piano. Ora occorre presentare direttamente un piano completo, così da evitare abusi e ritardi.
Beni ricevuti in eredità nel piano del consumatore: veniamo ora al tema centrale: come vengono trattati i beni ereditari all’interno di un piano del consumatore. Possiamo distinguere vari momenti:
- Eredità già aperta (o prevista) prima della presentazione del piano: se al momento in cui il consumatore predispone il piano sa di aver diritto a un’eredità (ad esempio perché un familiare è già deceduto e si sta definendo la successione, o perché è destinatario di un testamento), egli ha l’obbligo di dichiarare e includere nel piano anche quei beni o diritti ereditari. La completezza e trasparenza del patrimonio è essenziale per la buona fede del debitore. Un tentativo di occultare un’eredità a cui si è chiamati configurerebbe senz’altro un atto in frode ai creditori, impedendo l’omologazione. Pertanto, il debitore consumatore dovrà decidere se accettare l’eredità ed inserirne il valore tra le risorse disponibili per il piano, oppure se rinunciarvi. La rinuncia all’eredità, tuttavia, non è una scelta priva di conseguenze: se effettuata “con danno dei creditori”, questi potranno impugnarla ai sensi dell’art. 524 c.c. (vedremo tra poco i dettagli). In sede di piano del consumatore, la presenza di un’eredità potenzialmente disponibile può incidere sulla valutazione di fattibilità e convenienza fatta dal giudice: ad esempio, se il debitore ha la possibilità concreta di incamerare un bene ereditario di valore tale da soddisfare interamente i creditori, difficilmente un piano che proponga un pagamento parziale potrà dirsi conveniente o comprensibile. In tal caso probabilmente il giudice si aspetterà che il debitore utilizzi l’eredità per pagare i debiti integralmente (o quantomeno offra ai creditori l’equivalente valore). In sintesi, se il debitore prevede di ricevere beni in eredità, dovrà tenerne conto nel piano, pena il rigetto per mancanza di buona fede.
- Eredità ricevuta durante l’esecuzione del piano: può accadere che, dopo l’omologazione, mentre il piano è in corso di esecuzione (che spesso dura alcuni anni), il debitore consumatore riceva un’eredità inattesa – ad esempio viene a mancare un parente e gli lascia dei beni. In questa situazione, cosa succede dipende in parte dalle clausole del piano e in parte dal comportamento del debitore. Normativamente, nel piano del consumatore non vi è una regola specifica che imponga di destinare ai creditori i beni sopravvenuti dopo l’omologazione (a differenza della liquidazione controllata, come vedremo). Il piano infatti è un accordo/ordine del giudice che cristallizza quanto il debitore deve pagare. Se, poniamo, il piano prevedeva che Tizio paghi 30.000 € in 5 anni a fronte di 100.000 € di debiti, l’obbligo di Tizio verso i creditori concorsuali resta quello, anche se nel frattempo Tizio eredita, ad esempio, 50.000 €. I creditori non possono automaticamente pretendere di più rispetto a quanto omologato. Tuttavia, occorre considerare alcuni punti cruciali: (a) se l’eredità sopravviene prima che il piano sia omologato in via definitiva (ad esempio durante la pendenza del giudizio di omologazione), il debitore è tenuto a segnalarlo e probabilmente l’OCC o il giudice chiederanno di modificare il piano per tener conto di questa nuova utilità; (b) se l’eredità sopravviene dopo l’omologazione, il piano potrebbe contenere una clausola di impegno del debitore a destinare ai creditori anche parte di eventuali utilità sopravvenute. Alcuni piani, per ottenere il favore del giudice, prevedono volontariamente che, in caso di significativi miglioramenti della situazione economica del debitore durante l’esecuzione (eredità, vincite, ecc.), una percentuale venga versata ai creditori. Non è obbligatorio per legge, ma potrebbe essere inserito come indice di buona fede; (c) se non c’è alcuna clausola e il debitore, pur avendo ereditato, continua ad adempiere regolarmente al piano, in linea di principio conserverà l’eredità per sé una volta pagate le somme dovute dal piano. Non viola la legge così facendo, perché il piano omologato lo autorizza a pagare solo quanto stabilito. D’altro canto, se la eredità è cospicua (ad esempio sufficiente a pagare tutti i debiti per intero), potrebbe essere interesse dello stesso debitore valutare un adempimento anticipato e integrale del piano: molti tribunali, in caso di adempimento integrale immediato, dichiarano cessata la procedura per esecuzione anticipata e il debitore si libera subito. Nulla vieta infatti al debitore di soddisfare i creditori meglio di quanto previsto. Quindi, se Tizio eredita 50.000 € e gli restano 20.000 € di pagamenti da fare secondo il piano, potrebbe decidere di saldarli in un’unica soluzione e concludere la procedura prima del termine, tenendo per sé il residuo dell’eredità. In mancanza, comunque, nessuna sanzione è prevista purché egli rispetti il piano.
Va però lanciato un monito: se emergesse che il debitore era a conoscenza dell’eredità in arrivo sin dall’inizio e ha dolosamente taciuto l’informazione per farsi omologare un piano più favorevole (pagando meno di quanto poteva), ciò configurerebbe un abuso. In tal caso, i creditori potrebbero chiedere la revoca dell’omologazione per comportamento scorretto. Ad esempio, se Caio ottiene l’omologazione di un piano sostenendo di non avere risorse, ma omette di riferire che è erede in una successione in corso, e poi subito dopo l’omologazione accetta l’eredità, i creditori potrebbero eccepire la malafede. La giurisprudenza ha evidenziato che il debitore nel piano del consumatore è tenuto a una rappresentazione completa e corretta della propria situazione patrimoniale, pena il venir meno del requisito di meritevolezza. Dunque, trasparenza e lealtà sono fondamentali. In sintesi, un’eredità sopravvenuta durante l’esecuzione di un piano già omologato rimane tecnicamente del debitore, ma costui dovrebbe valutare attentamente le implicazioni legali ed etiche di come gestirla, e soprattutto non deve aver taciuto informazioni rilevanti al momento dell’omologa.
Concordato minore
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è la procedura destinata ai debitori sovraindebitati non consumatori. Si rivolge quindi, tipicamente, a piccoli imprenditori, professionisti, ditte individuali con debiti anche di natura commerciale, start-up innovative individuali, imprenditori agricoli con debiti verso fornitori, ecc. Si chiama “minore” per distinguerlo dal concordato preventivo delle imprese soggette a fallimento (liquidazione giudiziale): in pratica, è un accordo concorsuale simile al concordato preventivo ma su scala ridotta e adattato ai soggetti non fallibili. Non possono accedere al concordato minore i consumatori puri (per loro c’è il piano del consumatore), e restano esclusi anche gli imprenditori sopra soglia (che devono eventualmente fare un concordato preventivo o fallimento). La rigidità attuale del sistema è tale per cui la scelta è binaria: o il debitore è consumatore e va col piano ex art.67, o non lo è (perché i debiti attengono ad un’attività) e allora deve ricorrere al concordato minore ex art.74. Ciò ha creato qualche incertezza per situazioni miste (ad esempio un ex imprenditore con debiti in parte personali e in parte d’impresa): la legge delega aveva lasciato dei “buchi” che solo in parte le modifiche correttive hanno colmato. In generale, un imprenditore individuale cessato da oltre un anno potrebbe trovarsi in difficoltà ad accedere al concordato minore per come le norme erano scritte, ma il correttivo 2024 è intervenuto in materia come si dirà a proposito della liquidazione controllata.
Accesso e requisiti: per il concordato minore valgono requisiti simili a quelli del piano del consumatore quanto allo stato di sovraindebitamento e all’assenza di atti in frode. Anche qui serve la relazione particolareggiata dell’OCC. Una differenza è che nel concordato minore i creditori vengono coinvolti: benché il CCII non parli più di “voto” espresso in adunanza come nella L.3/2012 (accordo di composizione), i creditori hanno diritto di esprimere dissenso e l’omologazione richiede che non vi sia il voto contrario di una certa maggioranza di crediti. In particolare, l’art. 78 CCII prevede che il tribunale omologa il concordato minore se non risulta il dissenso dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Dunque il meccanismo è: i creditori possono essere consultati sul piano proposto e, se più del 50% (in valore) si oppongono, l’omologa non può avvenire (salvo il tribunale possa bypassare l’opposizione irragionevole se ritiene la proposta comunque più vantaggiosa per i creditori, analogamente a quanto avveniva per l’accordo nella L.3/2012, ma su questo rinviamo ai dettagli applicativi). Il debitore, dal canto suo, deve essere meritevole: l’art. 75 CCII richiama anch’esso la verifica di assenza di frode e di dolo o colpa grave nell’indebitamento (quindi stessi standard di affidabilità richiesti al consumatore). Inoltre, esistono alcune cause di inammissibilità specifiche: ad esempio il correttivo 2024 ha stabilito che non si può accedere al concordato minore se il debitore ha già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti. È stata invece rimossa la precedente causa ostativa che vietava l’accesso a chi avesse già utilizzato una qualunque procedura di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti (anche senza esdebitazione): ora conta solo l’eventuale esdebitazione già avuta, non il fatto di aver tentato un piano prima. Ciò rende il sistema un po’ più permissivo per chi ad esempio aveva fatto un piano poi decaduto: prima sarebbe stato bloccato 5 anni, ora può ritentare subito se non ha beneficiato di esdebitazione.
Funzionamento: il concordato minore può avere contenuto sia liquidatorio che in continuità. Può cioè prevedere che il debitore metta a disposizione tutti i suoi beni per soddisfare i creditori (concordato liquidatorio), oppure che prosegua in qualche attività producendo reddito con cui pagare in futuro i creditori (concordato in continuità minore). Può anche essere misto. In ogni caso, viene presentato un piano concordatario accompagnato da una proposta. Ad esempio, un piccolo imprenditore agricolo potrebbe proporre ai creditori di pagare il 40% dei debiti nell’arco di 4 anni, utilizzando i proventi futuri dell’azienda, e magari dismettendo qualche bene non essenziale. I creditori privilegiati non soddisfatti integralmente devono esprimere adesione alla falcidia proposta (o comunque si seguono regole analoghe al concordato preventivo sulla necessità di soddisfare almeno il valore di liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione). Se i creditori non si oppongono in maggioranza e le opposizioni presentate (se minori) vengono rigettate, il tribunale omologa il concordato minore. Da quel momento il debitore dovrà attenersi al piano e, a esecuzione completata, ottiene l’esdebitazione per la parte di debiti rimasta eventualmente insoddisfatta.
Eredità nel concordato minore: similmente al caso del piano del consumatore, dobbiamo distinguere:
- Se l’eredità è già nella disponibilità o conoscenza del debitore al momento della proposta di concordato, egli dovrà indicarla. Qui, anzi, i creditori stessi potrebbero venire a saperlo e opporsi se non vedono l’eredità inclusa a beneficio della massa. Ad esempio, se un professionista sovraindebitato è chiamato all’eredità di un genitore, è prevedibile che i creditori pretenderanno che accetti l’eredità e ne destini il ricavato (in tutto o in parte) al concordato. Nasce quindi la scelta cruciale per il debitore: accettare l’eredità o rinunciarvi? In un concordato, la rinuncia avrebbe come effetto che quei beni ereditari non entrano nel patrimonio concordatario, ma ciò è suscettibile di essere visto come un atto in frode o quantomeno come comportamento non collaborativo. Inoltre, i creditori potrebbero attivarsi ex art. 524 c.c. per rendere inefficace la rinuncia. Quindi, è altamente consigliabile che il debitore accetti con beneficio d’inventario l’eredità (per valutare asset e passività del de cuius) e la inserisca nel piano. Accettare con beneficio d’inventario, attenzione, non protegge i beni ereditati dai creditori personali del debitore: il beneficio serve solo a separare il patrimonio ereditario per pagare i debiti del defunto, ma una volta soddisfatti quelli, l’eventuale attivo residuo entra a far parte a tutti gli effetti del patrimonio dell’erede e può essere aggredito dai suoi creditori. Dunque, ai fini del concordato minore, accettare con beneficio o puramente non fa differenza per i creditori del debitore: in entrambi i casi, i beni entrano nel piano. Rinunciare, come detto, non impedirebbe comunque ai creditori di far valere le loro ragioni su quei beni tramite l’azione in giudizio prevista.
- Se l’eredità sopravviene dopo l’omologazione del concordato minore e durante la sua esecuzione, vale un discorso analogo a quello fatto per il piano del consumatore: non vi è una norma specifica che pretenda la distribuzione ai creditori delle sopravvenienze post-omologa in un concordato minore. Tuttavia, nel concordato c’è l’ulteriore elemento della vigilanza del commissario/liquidatore (figura nominata dal giudice) il quale potrebbe richiedere di modificare il piano se l’apporto dell’eredità consente un pagamento più celere o integrale. I creditori, se vengono a conoscenza della sopravvenienza, possono anch’essi chiedere un’iniziativa. I margini di modifica post-omologa sono però ristretti: in genere il concordato omologato deve essere eseguito come stabilito, e l’ordinamento non prevede una “riapertura” della procedura per nuove risorse (a differenza di procedure fallimentari dove c’è istituto di riapertura per sopravvenienze, qui no). Dunque, se ad esempio un imprenditore in concordato minore paga regolarmente le percentuali dovute e nel frattempo eredita un immobile, quell’immobile di per sé non entra automaticamente nel concordato. Tuttavia, se il debitore non adempie o accumula ritardi, sicuramente i creditori e il tribunale terranno conto della sopravvenuta disponibilità e potrebbero revocare il concordato in caso di inadempimento, aprendo magari una liquidazione dove quel bene verrà preso. Quindi il consiglio pratico è: se ereditate durante un concordato minore, utilizzate quella risorsa per migliorare l’adempimento del concordato stesso, ad esempio saldando prima o pagando una maggiore percentuale ai chirografari mediante un accordo modificativo, in modo da prevenire conflitti.
Novità normative 2024 sul concordato minore: oltre alle cause di inammissibilità già menzionate (divieto per chi ha già avuto esdebitazione in 5 anni), una modifica interessante riguarda la definizione di “risorse esterne” nel piano. Spesso i piani di concordato minore prevedono l’apporto di risorse da terzi (es. un familiare che mette una somma per aiutare a pagare i creditori). L’art. 74, c.2 CCII parlava di aumento della soddisfazione dei creditori grazie a risorse esterne, concetto poco chiaro; il correttivo ha specificato che si deve guardare all’incremento dell’attivo disponibile grazie ai contributi esterni, piuttosto che a nebulosi concetti di soddisfazione. Ciò facilita la verifica da parte del tribunale: concretamente, un finanziamento di un terzo che aumenta l’attivo del 10% è una risorsa esterna conteggiabile.
Inoltre, vi è un principio di “preferenza per le soluzioni concordate”: se un creditore presenta istanza per aprire una liquidazione controllata, ma il debitore nel frattempo presenta un proprio piano o concordato, il giudice deve esaminare prima la proposta di concordato minore e solo se questa fallisce aprire la liquidazione. Questo incoraggia i debitori a presentare piani, poiché la domanda del creditore non li travolge automaticamente.
Liquidazione controllata del sovraindebitato
La liquidazione controllata (Capo IX, art. 268 e seguenti CCII) è la procedura concorsuale di tipo liquidatorio applicabile ai debitori sovraindebitati. Corrisponde concettualmente al fallimento (ora chiamato liquidazione giudiziale) per i soggetti non fallibili. In pratica, consiste nel mettere a disposizione di tutti i creditori l’intero patrimonio del debitore, sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal tribunale, al fine di liquidarlo (convertire in denaro) e distribuire il ricavato tra i creditori secondo le regole della parità di trattamento (graduazione dei privilegi, ecc.). Al termine, il debitore persona fisica onesto ha diritto alla liberazione dai debiti residui (esdebitazione).
Chi vi accede: qualunque debitore sovraindebitato può chiedere la propria liquidazione controllata. La grande novità introdotta dal Codice della Crisi è che anche i creditori possono prendere l’iniziativa di chiedere la liquidazione controllata del loro debitore, cosa che sotto la Legge 3/2012 non era possibile. Dunque, se un debitore non prende alcuna iniziativa e i creditori ritengono che esista patrimonio da aggredire, possono rivolgersi al tribunale per far aprire la liquidazione (è una sorta di “fallimento coatto del non fallibile”). Ciò ovviamente può avere riflessi sull’eredità: se un debitore indebitato non agisce e nel frattempo eredita dei beni, i creditori possono anticiparlo chiedendo al giudice di aprire una liquidazione per far cadere dentro quei beni ereditati. Vale però il principio visto sopra: se il debitore deposita, magari in extremis, un piano del consumatore o concordato minore, questo ha priorità e la liquidazione controllata su istanza dei creditori verrà sospesa in attesa dell’esito del piano.
Avvio e condizioni: per aprire una liquidazione controllata occorre il semplice stato di insolvenza o sovraindebitamento. Non ci sono requisiti di meritevolezza in questa fase (la meritevolezza influirà semmai sulla successiva esdebitazione). Tuttavia, il correttivo 2024 ha introdotto un filtro importante per evitare liquidazioni “inutli”: l’art. 268 CCII adesso stabilisce che la domanda di liquidazione presentata dal debitore è improcedibile se l’OCC non attesta la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori. Ciò significa che se il debitore non possiede beni né redditi e non ci sono prospettive di recuperare nulla (nemmeno tramite cause di revocatoria o simili), non si deve aprire la procedura, per non gravare l’erario di costi inutili. In tal caso, il debitore privo di attivo potrà semmai percorrere la via dell’esdebitazione “incapiente” diretta (vedi prossimo paragrafo). Questo filtro è volto a evitare le liquidazioni “zero asset”, in cui non c’è nulla da liquidare: ora è richiesto che l’OCC dichiari che almeno qualche bene o valore recuperabile c’è. A livello temporale, la liquidazione può essere richiesta dal debitore anche se ha cessato un’eventuale attività da oltre un anno (mentre inizialmente pareva vi fosse un termine decadenziale di 1 anno in analogia alla liquidazione giudiziale): il D.Lgs. 136/2024 ha chiarito inserendo un comma 1-bis all’art. 33 CCII che il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’eventuale impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione anche oltre il termine di un anno. Ciò risolve l’equivoco che pareva escludere dal concordato minore l’imprenditore cessato (che però rimaneva pur sempre sovraindebitato come consumatore). In sintesi, oggi la liquidazione controllata resta sempre possibile per la persona fisica sovraindebitata, anche molto tempo dopo aver chiuso la sua impresa, perché comunque come consumatore potrebbe aver contratto altri debiti.
Effetti della liquidazione: con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, si produce un effetto pari al pignoramento generale di tutti i beni del debitore: i beni attuali del debitore formano il patrimonio liquidatorio e non possono più essere aggrediti individualmente dai singoli creditori (scatta il divieto di azioni esecutive individuali). Inoltre – elemento cruciale – anche i beni futuri che perverranno al debitore in un certo periodo rientrano nella procedura. Sotto la vecchia legge 3/2012, l’art. 14-undecies L.3/2012 stabiliva che i beni sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione andavano ricompresi nell’attivo da liquidare. Ora, il Codice ha ridotto questo periodo a 3 anni dall’apertura della liquidazione, collegandolo però all’istituto dell’esdebitazione automatica (art. 282 CCII). In pratica: la liquidazione controllata dura al massimo 3 anni (salvo eventuali proroghe di pochi mesi per completare atti in corso) – trascorsi 3 anni dall’apertura, il debitore persona fisica ha diritto all’esdebitazione di diritto. Durante questi tre anni, tutti i beni ed i redditi che eccedono le necessità di mantenimento e che sopravvengono al debitore devono essere acquisiti dal liquidatore e destinati a pagare i creditori. Questo principio è stato oggetto anche di recente conferma da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 6/2024): il giudice delle leggi ha ritenuto non fondata la questione di legittimità che lamentava l’assenza, nel CCII, di un limite temporale preciso come il vecchio quadriennio, affermando che il sistema vigente – letto alla luce dell’art. 282 CCII – implica comunque un orizzonte triennale massimo entro cui i beni futuri possono essere catturati dal liquidatore. In altri termini, secondo la Corte Costituzionale, il combinato disposto degli artt. 142 e 282 CCII fa sì che entro tre anni si determini un equo bilanciamento tra il diritto del debitore a tornare libero dai debiti e quello dei creditori di soddisfarsi anche su utilità sopravvenute. Quindi, se pure il CCII non ripete testualmente la frase “i beni sopravvenuti nei 4 anni… formano oggetto della liquidazione”, la sua struttura fa sì che fino all’eventuale esdebitazione (massimo tre anni) i beni futuri possano essere acquisiti. E infatti prassi e dottrina applicano l’art. 142, comma 2 CCII (che prevede l’acquisizione dei beni futuri dell’imprenditore fallito fino alla chiusura) anche alla liquidazione controllata.
Beni ereditati durante la liquidazione controllata: alla luce di quanto sopra, se il debitore riceve un’eredità dopo l’apertura della liquidazione controllata entro il triennio, tale eredità rientra interamente tra i beni da liquidare. Il debitore ha il dovere di informare il liquidatore di ogni sopravvenienza attiva. In particolare, un’eredità è un caso tipico: supponiamo che nel secondo anno di liquidazione il debitore erediti un immobile o una somma di denaro; ebbene, quei beni diventano parte dell’attivo concorsuale e il liquidatore dovrà procedere a liquidarli (vendere l’immobile, o raccogliere la somma) per distribuirne il ricavato ai creditori. Questo accade automaticamente, in virtù dell’effetto di pignoramento generale e delle norme concorsuali.
Un interrogativo: può il debitore tentare di sottrarre l’eredità ai creditori rinunciandovi durante la liquidazione? Ipotizziamo che il debitore, sapendo di essere in procedura, formalmente rinunci all’eredità sperando che così non entri nel suo patrimonio e quindi sfugga ai creditori. Questa mossa è destinata a fallire: intanto, l’art. 270 CCII prevede espressamente che se il debitore compie atti in frode (come la rinuncia a un credito o a un diritto) durante la procedura, l’esdebitazione finale gli può essere negata. Inoltre – e soprattutto – i creditori hanno strumenti per neutralizzare la rinuncia all’eredità. Ai sensi dell’art. 524 c.c., come più volte richiamato, i creditori del rinunciante possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in sua vece. Questa azione compete ai creditori singolarmente o al liquidatore quale rappresentante della massa creditoria. Nella prassi, i liquidatori nelle procedure di liquidazione hanno già fatto ricorso a questo strumento quando il sovraindebitato ha cercato di rinunciare a eredità di valore. Ad esempio, in un caso recente del 2024, il Tribunale di Venezia ha affrontato proprio una situazione simile: un debitore esecutato non aveva accettato un’eredità (lasciando decorrere i termini dopo una actio interrogatoria del creditore), di fatto perdendo il diritto di accettare; il creditore procedente ha quindi azionato l’art. 524 c.c. e il Tribunale ha dichiarato inefficace la rinuncia e autorizzato il creditore ad accettare l’eredità in luogo del debitore. In quella sentenza (Trib. Venezia 16 ottobre 2024, n. 3607) si ribadisce che l’azione ex art. 524 c.c. è esperibile anche quando il chiamato all’eredità ha perso il diritto per decorso del termine ex art. 481 c.c., equiparandosi tale situazione a una rinuncia in senso proprio. È sufficiente, quale presupposto, che la rinuncia (o mancata accettazione) rechi danno ai creditori, ossia che vi siano ragioni fondate per ritenere insufficiente il patrimonio del debitore a soddisfare i crediti. Nel caso di specie, è stato onere del debitore (peraltro contumace) provare il contrario, cosa non avvenuta. Questa pronuncia conferma quindi che rinunciare all’eredità “non salva” il patrimonio ereditario dalle pretese dei creditori: l’eredità verrà considerata come se accettata, limitatamente a quanto serve per pagarli. Per il debitore ciò comporta il duplice svantaggio di non liberarsi comunque dei debiti (perché i creditori si soddisfano sui beni ereditari) e di perdere definitivamente l’eredità (egli non torna ad esserne erede nemmeno per l’eventuale eccedenza): infatti l’art. 524 c.c. prevede che i creditori possono accettare l’eredità al solo scopo di soddisfarsi, e l’eventuale residuo (relictum) resta devoluto secondo le regole ordinarie della successione (al chiamato successivo). Il debitore che ha rinunciato, quindi, non riacquista la qualità di erede neppure per la parte eccedente i debiti: la sua scelta di rinuncia viene rispettata per quanto attiene alla quota eccedente il soddisfacimento dei creditori. Questo aspetto è fondamentale: se ad esempio l’eredità vale 100 e i debiti personali del rinunciante sono 50, i creditori prenderanno 50 e il restante 50 non tornerà al debitore rinunciante ma andrà eventualmente ad altri chiamati (o agli eredi di riserva, o allo Stato se non vi sono altri eredi). Dunque, per un debitore sovraindebitato rinunciare a un’eredità è quasi sempre una mossa autolesionista, perché:
- se l’eredità aveva valore inferiore ai debiti, i creditori la prenderanno comunque e resteranno insoddisfatti per la parte eccedente, lasciando il debitore ancora esposto (salvo esdebitazione concorsuale se la procedura si conclude);
- se l’eredità aveva valore superiore ai debiti, con la rinuncia il debitore perde l’opportunità di coprire interamente i debiti e di trattenere l’eventuale surplus (che invece andrà ad altri).
In conclusione, all’interno della liquidazione controllata il consiglio per il debitore è di accettare l’eredità (magari con beneficio d’inventario se opportuno) e collaborare col liquidatore affinché i beni ereditari siano liquidati a vantaggio dei creditori. Questo perché tanto la rinuncia non gli gioverebbe (verrebbe vanificata), mentre l’accettazione potrebbe quantomeno consentire una gestione più ordinata e magari un miglior realizzo di quei beni. Si noti inoltre che la liquidazione controllata non priva il debitore della possibilità, in fase di chiusura, di chiedere di mantenere alcuni beni se di valore trascurabile o se i creditori sono stati soddisfatti: ad esempio, se alla fine della liquidazione restano beni ereditari non venduti e i creditori sono già stati soddisfatti oltre una certa soglia, potrebbe anche darsi che il liquidatore restituisca il residuo (ipotesi remota ma teoricamente possibile). Ma se il debitore rinuncia fin dall’inizio, si preclude ogni chance.
E se l’eredità arriva dopo la chiusura della liquidazione controllata? Come detto, trascorsi 3 anni, la procedura si chiude normalmente (con decreto di esdebitazione di diritto, salvo eccezioni). A quel punto il debitore è libero dai debiti concorsuali residui. Se egli, ad esempio al quarto anno dalla apertura, riceve un’eredità, questa non potrà più essere toccata per i debiti ex concorso, in quanto la procedura è terminata e i debiti sono stati cancellati. In sostanza, dopo la chiusura, i creditori concorsuali non hanno più titolo ad agire (se l’esdebitazione è stata concessa), e l’eredità resterà interamente al debitore come nuovo patrimonio “pulito”. Questo scenario rappresenta un rischio calcolato che la legge accetta: se un debitore ha avuto la fortuna di incassare una somma cospicua dopo la sua esdebitazione, nessuno potrà più chiedergliela per i vecchi debiti (diverso è il discorso per l’esdebitazione incapiente, in cui vige la regola dei 4 anni, come vedremo). Ciò può sembrare iniquo verso i creditori, ma rientra nella filosofia del fresh start: la legge preferisce dare al debitore una possibilità di rifarsi una vita, anche a costo che ottenga un beneficio in caso di colpi di fortuna postumi. Del resto, se l’eredità era prevedibile e prossima, difficilmente la procedura sarebbe stata chiusa prima di acquisirla; se invece era del tutto aleatoria (es. eredità da un parente lontano inaspettata), pazienza per i creditori, che hanno comunque beneficiato di 3 anni di eventuali sopravvenienze.
Morte del debitore durante la liquidazione controllata: un ultimo aspetto connesso alle eredità nella liquidazione riguarda cosa accade se è il debitore a decedere mentre la procedura è in corso. In tal caso si apre la successione del debitore stesso: i suoi eredi dovranno decidere se accettare o meno l’eredità (che comprende l’eventuale attivo residuo e i debiti non soddisfatti). Ebbene, l’art. 35 CCII (“Morte del debitore”) stabilisce che, se il debitore muore dopo l’apertura della liquidazione (controllata o giudiziale), questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario. Se gli eredi non hanno accettato (eredità giacente) prosegue nei confronti del curatore dell’eredità giacente. Ciò significa che la procedura non si estingue per la morte: i beni del debitore defunto verranno liquidati nella stessa procedura concorsuale già aperta, e gli eredi – se hanno accettato l’eredità – partecipano come “successori” del debitore ma con la tutela del beneficio d’inventario (non risponderanno oltre il valore dell’attivo ereditario). La norma recepisce un principio già affermato analogicamente dalla giurisprudenza sotto la vecchia legge fallimentare e la L.3/2012: la morte del debitore non rende inutile la procedura, perché permane l’interesse a liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori, interesse che possono avere anche gli stessi eredi (ad esempio per liberarsi dai debiti col vincolo del patrimonio ereditario). Dunque, dal punto di vista degli eredi del debitore sovraindebitato, può convenire proseguire la procedura: se questa si conclude con un’esdebitazione, gli eredi non saranno tenuti a pagare oltre quanto ricavato dall’attivo ereditario, e i debiti residui saranno estinti (liberando anche loro dalla responsabilità ereditaria residua). In pratica, l’erede beneficiato d’inventario potrà ottenere tramite la procedura concorsuale lo stesso effetto di non dover pagare di tasca propria gli eventuali debiti eccedenti. Nel caso di concordato minore o piano del consumatore, il CCII inizialmente non prevedeva espressamente la continuazione in caso di morte, lasciando un vuoto normativo. La giurisprudenza, tuttavia, ha in alcuni casi permesso la prosecuzione: ad esempio, il Tribunale di Vicenza (decr. 12 marzo 2024) ha stabilito che, se il debitore muore durante un concordato minore, si può assegnare agli eredi un termine per subentrare e proseguire la procedura. Questo orientamento è coerente con quanto previsto per la liquidazione e con l’interesse degli eredi a definire in modo definitivo la posizione debitoria del defunto. Pertanto, l’eredità in questi casi consiste essenzialmente nell’attivo (se c’è) che verrà ripartito secondo il piano, mentre il beneficio per gli eredi è che i debiti residui, se la procedura arriva a compimento, non li perseguiteranno oltre.
Esdebitazione del debitore incapiente
L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) è una procedura del tutto peculiare, introdotta per la prima volta con il Codice della Crisi, che consente al debitore persona fisica meritevole, privo di qualunque capacità di pagare, di ottenere la cancellazione dei debiti senza alcuna liquidazione preventiva. Si tratta di un “fresh start” a costo zero per chi è completamente incapiente (da non confondere con l’esdebitazione successiva alla liquidazione, che invece presuppone di aver messo a disposizione i beni). In altre parole, se un soggetto non fallibile si trova senza beni pignorabili né redditi aggredibili, può chiedere direttamente al tribunale di essere liberato dai debiti, a patto di soddisfare alcune condizioni stringenti.
Requisiti soggettivi: possono accedere a questa procedura solo i debitori persone fisiche (sono escluse le persone giuridiche) che siano qualificabili come sovraindebitati ai sensi dell’art. 2 CCII, quindi che rientrino nelle categorie viste (consumatore, piccolo imprenditore, professionista, ecc.). In pratica, l’istituto è riservato a consumatori o piccoli imprenditori/professionisti insolventi, perché le società e gli enti collettivi hanno altri strumenti o comunque non possono “sparire” i debiti senza liquidazione. Inoltre, la legge prevede che tale esdebitazione a costo zero possa essere concessa una sola volta nella vita al debitore, per evitare abusi (è un “colpo di spugna” unico e irripetibile se non in casi eccezionali).
Requisiti oggettivi: la condizione cardine è l’incapienza: il debitore “non deve essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”. Ciò significa niente patrimonio liquidabile, niente reddito disponibile oltre la mera sopravvivenza, e nessuna prospettiva concreta di miglioramento a breve. In più, il debitore deve essere meritevole: l’art. 283, comma 7 CCII richiede l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. È la stessa formula delle altre procedure (art. 69 CCII per il piano del consumatore) – con la differenza che qui non c’è stata alcuna procedura concorsuale in cui i creditori hanno potuto opporsi o votare, per cui il controllo sulla meritevolezza è ancor più delicato: il giudice approfondirà con l’aiuto dell’OCC se il debitore ha fatto il possibile per evitare il sovraindebitamento, se non ha assunto obbligazioni con leggerezza o fraudolenza, e se non ha nascosto beni (l’OCC redige una relazione simile a quella ex art. 68 CCII). Ad esempio, se un soggetto ha dilapidato beni in atti gratuiti poco prima di chiedere l’esdebitazione incapiente, la meritevolezza difetterà certamente (ci sarebbero atti in frode).
Procedura: il debitore deposita un ricorso al tribunale, allegando l’elenco di tutti i suoi debiti, e dichiarando di non avere alcun modo di pagarli neanche in minima parte. Viene nominato un OCC che redige una relazione attestante la veridicità delle dichiarazioni (in particolare che il debitore non possiede immobili, mobili di valore, crediti esigibili, ecc., e che il suo reddito è appena sufficiente per vivere). Se all’esito dell’istruttoria il tribunale ritiene soddisfatti i requisiti, emette un decreto che concede l’esdebitazione dell’incapiente, cioè dichiara inesigibili tutti i debiti del debitore verso i creditori concorsuali (sono esclusi ovviamente debiti come alimenti, risarcimenti da illecito e altri non falcidiabili). Da quel momento il debitore rinasce libero dai debiti pregressi senza aver pagato nulla. È un risultato notevole, giustificato dal fatto che, diversamente, quel debitore sarebbe comunque rimasto a vita in balia dei creditori senza poter reagire.
Tuttavia, c’è un’importante condizione risolutiva: il beneficio non è totalmente incondizionato, ma “fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto laddove sopravvengano utilità rilevanti”. Questa clausola, prevista dall’art. 283 comma 1 CCII, significa che nei quattro anni successivi alla pronuncia dell’esdebitazione l’incapiente, se dovesse ricevere beni o entrate significative, è tenuto a pagare comunque i suoi vecchi creditori, fino a concorrenza del loro credito e comunque almeno nei limiti delle utilità sopravvenute. In particolare, la norma specifica che l’obbligo permane se sopraggiungono utilità che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% del totale dei crediti. Quindi c’è una soglia di rilevanza: se il debitore ottiene entro 4 anni dei beni tali da poter pagare almeno un decimo di quanto doveva, allora l’esdebitazione condizionata viene meno pro quota. In pratica, l’esdebitazione dell’incapiente è provvisoria per 4 anni: se in questo periodo il debitore resta nullatenente, allora diventa definitiva e i creditori non potranno più nulla; ma se ad esempio dopo 2 anni il debitore ottiene una eredità o vince alla lotteria, egli dovrà utilizzarla per pagare i creditori fino a copertura dei debiti (o quantomeno fino all’importo ereditato se i debiti sono maggiori). La legge esclude che siano considerate “utilità” eventuali finanziamenti ricevuti dal debitore, così ad esempio se qualcuno gli presta dei soldi non scatta l’obbligo, evitando che il debitore si indebiti di nuovo solo per pagare i vecchi creditori. Sono invece chiaramente utilità rilevanti i beni ricevuti a titolo gratuito, i crediti, le vincite, gli immobili ereditati, ecc.. Il debitore in esdebitazione incapiente è tenuto a presentare al Tribunale un rendiconto su eventuali utilità sopravvenute e, se del caso, a pagare i creditori con esse. Se non lo fa spontaneamente, i creditori, venuti a conoscenza dell’acquisizione, potranno agire esecutivamente.
Esempio pratico: Mario, nullatenente con 100.000 € di debiti, ottiene nel 2025 l’esdebitazione dell’incapiente. Nel 2026, però, suo zio muore e gli lascia in eredità 50.000 €. Questa somma rappresenta il 50% dei debiti originari di Mario, dunque ben sopra la soglia del 10%. Mario dovrà informare il Tribunale e impiegare quei 50.000 € per pagare i suoi ex creditori (in misura proporzionale ai loro crediti). Se non lo facesse, l’esdebitazione gli potrebbe essere revocata o comunque i creditori potrebbero aggredire quei soldi poiché l’inesigibilità dei debiti era condizionata. Invece, se l’eredità fosse stata di importo modesto – poniamo 5.000 €, cioè il 5% del debito – Mario non sarebbe tenuto a riaprire i conti con i creditori, perché la soglia del 10% non è superata. In quel caso potrebbe trattenere la piccola somma senza decadere dal beneficio, in quanto considerata non significativa per i creditori.
Trascorsi 4 anni dal decreto di esdebitazione senza che siano sopravvenute utilità apprezzabili, Mario potrà considerarsi definitivamente libero: i debiti anteriori resteranno inesigibili per sempre. In caso invece di sopravvenienza rilevante entro il quadriennio e conseguente pagamento parziale, si può ritenere (in mancanza di chiarimenti normativi) che i debiti restino inesigibili per la parte eccedente quanto pagato.
Morte del debitore incapiente dopo l’esdebitazione: se il debitore decede dopo aver ottenuto l’esdebitazione incapiente, i creditori – per la parte ancora non eventualmente soddisfatta – potrebbero agire verso i suoi eredi se si verifica la condizione delle utilità sopravvenute. Ma essendo l’esdebitazione già pronunciata, in linea di massima i debiti sarebbero estinti. Questo per dire che l’esdebitazione incapiente, una volta concessa, cancella i debiti come qualsiasi esdebitazione; la condizione quadriennale è un onere a carico del debitore beneficiato, la cui morte renderebbe difficoltoso per i creditori far valere tale condizione. Probabilmente, in tal scenario, se l’erede accetta l’eredità del debitore incapiente entro i 4 anni, e nell’eredità ci sono sostanze nuove (un paradosso: l’incapiente deceduto che lascia un patrimonio), i creditori potrebbero tentare di sostenere che quelle sostanze sopravvenute vanno usate per pagarli (in quanto utilità sopravvenute entro 4 anni). Ma è una casistica limite, raramente affrontata.
Sintesi: l’esdebitazione dell’incapiente è un istituto di carattere sociale, pensato per evitare che persone e famiglie totalmente schiacciate dai debiti restino escluse per sempre dalla vita economica. Si concede loro una “ripartenza” ma con la clausola anti-furbi di restare sotto osservazione per 4 anni. I beni ricevuti in eredità rappresentano proprio la tipica “utilità sopravvenuta” da tenere in considerazione: se il debitore incapiente viene a ereditare beni di un certo valore in quel periodo, la legge impone che essi siano destinati, almeno in parte, ai creditori originari. In definitiva, per un debitore che stia pensando di chiedere l’esdebitazione incapiente, è bene valutare se vi siano prospettive concrete di acquisire beni nei prossimi anni (es. sta per aprirsi una successione a suo favore): se tali prospettive esistono, forse è più opportuno percorrere una normale liquidazione o un piano, in modo da gestire quei beni in maniera trasparente; se invece davvero non c’è nulla all’orizzonte, l’esdebitazione incapiente può essere la soluzione più rapida.
Di seguito, presentiamo una tabella riepilogativa delle principali caratteristiche delle procedure descritte, per una visione d’insieme:
| Procedura | Destinatari (Debitori ammessi) | Approvazione | Durata | Esito sui debiti |
|---|---|---|---|---|
| Piano del consumatore (ristrutt. debiti) | Persona fisica consumatore (debiti civili, non professionali). | Omologazione giudiziale, senza voto creditori (salvo opposizioni). Richiede meritevolezza. | Piano di solito 4–5 anni (flessibile). Misure protettive attive durante la procedura. | Esdebitazione a fine piano se eseguito: i debiti residui cancellati. (Eventuali beni sopravvenuti durante il piano non obbligatoriamente inclusi, ma buona fede impone trasparenza). |
| Concordato minore (accordo) | Debitori non consumatori: piccoli imprenditori, professionisti, start-up indiv., imprend. agricoli, etc. (no società fallibili). | Consenso creditori richiesto: omologa se non v’è dissenso della maggioranza in valore. Giudice verifica convenienza e meritevolezza. | Durata variabile secondo il piano (può prevedere liquidazione di beni e/o pagamenti periodici). | Esdebitazione a fine esecuzione: debiti residui estinti. Beni sopravvenuti post-omologa non inclusi di diritto, ma possibili adattamenti (no riapertura procedura salvo inadempimento). |
| Liquidazione controllata | Qualsiasi debitore sovraindebitato non fallibile (consumatore o meno). Avviabile anche dai creditori. Improcedibile se nessun attivo ricavabile. | Sentenza del tribunale apre la liquidazione. Creditori concorrenti secondo la legge (insinuazioni). Nessun voto richiesto, procedura d’ufficio. | Max 3 anni dall’apertura per persona fisica (per legge, esdebitazione “di diritto” decorsi 3 anni). Può chiudersi prima se attivo liquidato. | Alla chiusura, debiti concorsuali residui cancellati (previa verifica meritevolezza). Beni sopravvenuti entro 3 anni dall’apertura sono acquisiti all’attivo e liquidati (eredità, stipendi ecc. inclusi). Dopo chiusura/esdebitazione, nuove acquisizioni restano al debitore. |
| Esdebitazione incapiente | Persona fisica sovraindebitata meritevole senza alcun attivo liquidabile né capacità di pagamento. (Una sola volta nella vita). | Decreto del tribunale su ricorso del debitore, sentiti OCC e creditori (eventuali opposizioni). Niente voto: valutazione giudiziale equitativa. | Procedimento relativamente breve (pochi mesi). Dopo il decreto, c’è un periodo di 4 anni di “sorveglianza” per sopravvenienze. | I debiti sono dichiarati inesigibili verso il debitore. Se entro 4 anni il debitore ottiene utilità ≥10% debiti, obbligo di pagarle ai creditori fino concorrenza crediti. Trascorsi 4 anni senza novità, la liberazione diventa definitiva. (In caso di sopravvenienze parziali, debiti estinti salvo per parte pagata). |
Accettazione o rinuncia dell’eredità: cosa deve sapere il debitore indebitato
Approfondiamo ora in termini generali il dilemma che un debitore sovraindebitato può trovarsi di fronte quando diventa chiamato a un’eredità: meglio accettare o rinunciare? E con quali modalità? Questo è un tema cruciale, poiché – come abbiamo visto – le scelte in materia successoria possono avere un impatto significativo sulla procedura concorsuale e sulla posizione dei creditori. Di seguito analizziamo le tre opzioni principali (accettazione pura e semplice, accettazione con beneficio d’inventario, rinuncia) e le relative conseguenze legali per un debitore con molti debiti personali.
- Accettazione pura e semplice: il chiamato all’eredità che non compie alcuna dichiarazione entro il tempo previsto (10 anni massimo, ma il termine può essere sollecitato dai creditori con l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c.) si considera tacitamente erede se compie atti di disposizione dei beni ereditari. Con l’accettazione (espressa o tacita) pura e semplice, l’intero patrimonio del defunto si confonde con quello dell’erede. Da quel momento, i creditori personali dell’erede possono rivalersi anche sui beni ereditati al pari degli altri beni dell’erede, senza distinzione. Quindi se Tizio, indebitato, accetta l’eredità di suo padre, i suoi creditori potranno pignorare i beni ereditari come qualunque altro bene di Tizio. Nella prospettiva del sovraindebitamento, accettare l’eredità significa che quei beni entrano nella procedura (se è in corso o se verrà aperta) e saranno considerati tra le risorse per pagare i creditori. Vantaggi: l’erede, accettando, potrà utilizzare l’eventuale attivo ereditario per soddisfare i propri creditori; se il valore dell’eredità supera i debiti, dopo averli pagati gli rimarrà il surplus. Inoltre, accettando egli evita che subentri un altro chiamato al posto suo: mantiene quindi la chance di beneficiare di quanto residua dopo i creditori. Svantaggi: accettando pura e semplice, l’erede risponde anche degli eventuali debiti del defunto senza limitazioni (questo attiene però ai creditori del defunto, non ai suoi). Nel nostro contesto, il problema principale è che i beni ereditati diventano aggredibili ipso iure. Tuttavia, nel quadro di una procedura da sovraindebitamento questo è ineludibile comunque – e come visto, è preferibile gestire quei beni attivamente anziché tentare di sottrarli con una rinuncia inefficace. In sintesi, se l’eredità è attiva (beni di valore) conviene quasi sempre accettare: permetterà di onorare parte dei debiti e magari uscirne prima.
- Accettazione con beneficio d’inventario: è uno strumento previsto dagli artt. 484 ss. c.c. che consente all’erede di accettare l’eredità mantenendo separati i patrimoni del defunto e proprio. L’effetto principale è che l’erede risponderà dei debiti del defunto solo nei limiti dell’attivo ereditario: i suoi beni personali restano al riparo da azioni dei creditori del defunto. Dal punto di vista dei creditori personali dell’erede (ovvero i creditori antecedenti all’eredità), il beneficio d’inventario non impedisce loro di aggredire i beni ereditari entrati in possesso dell’erede. Infatti, una volta pagati i debiti del defunto, l’eventuale residuo attivo entra a far parte del patrimonio personale dell’erede (sebbene con alcune cautele procedurali, come l’obbligo di rendiconto). Durante la fase in cui l’eredità è separata, vi è uno stato di limitata disponibilità: i creditori dell’erede possono far pignorare i beni ereditari solo dopo che siano stati soddisfatti i creditori del defunto e sempre che vi sia un saldo attivo. Tuttavia, nella pratica concorsuale, se l’erede è in procedura di liquidazione, i creditori dell’erede (riuniti) e quelli del defunto (che saranno soddisfatti col beneficio) agiscono in parallelo, ma i secondi hanno prelazione sul patrimonio ereditario. In sostanza, per l’erede indebitato accettare con beneficio serve a non peggiorare la sua situazione aggiungendovi i debiti eventualmente lasciati dal de cuius (ad esempio cartelle fiscali del defunto, mutui, etc. non ricadranno sul suo patrimonio personale oltre l’attivo ereditario). Ma non serve a evitare che i suoi creditori mettano le mani sui beni ereditati. Per fare un esempio: Caia, fortemente indebitata, accetta con beneficio l’eredità di suo padre che consiste in una casa del valore di €100.000, su cui c’è un mutuo residuo (debito del defunto) di €20.000. Col beneficio, Caia pagherà prima i €20.000 di mutuo attingendo magari dalla vendita o da altri soldi dell’eredità; i restanti €80.000 restano attivi ereditari. A quel punto Caia, per conservare il beneficio, dovrebbe liquidare il residuo e incassarlo formalmente come erede. Ma i suoi creditori personali potranno aggredire quell’attivo residuo (o chiedere di partecipare alla liquidazione) appena i creditori del defunto sono soddisfatti. In pratica, il beneficio d’inventario può complicare un po’ la procedura, ma non cambia l’esito: i creditori personali di Caia otterranno comunque la casa (o il suo ricavato) per soddisfarsi, attraverso la procedura concorsuale di Caia. Quindi, il beneficio ha senso se l’eredità ha passività (per non doverle sobbarcare personalmente), ma non è un mezzo per proteggere l’eredità dai propri creditori. Dal punto di vista della procedura di sovraindebitamento, l’eredità accettata con beneficio entra comunque nell’attivo disponibile del debitore (al netto dei debiti ereditari da pagare).
- Rinuncia all’eredità: la rinuncia formalizzata con atto pubblico (presso un notaio o in tribunale) comporta che il chiamato non diviene erede e l’eredità viene devoluta ad altri (eventuali chiamati successivi, rappresentanti, oppure allo Stato in assenza di successibili). Come abbiamo lungamente analizzato, la rinuncia “a mani vuote” non impedisce ai creditori del rinunciante di intervenire. Essi dispongono di due strumenti: il già citato art. 481 c.c. (actio interrogatoria), per evitare inerzie volute a tempo indeterminato, e soprattutto l’art. 524 c.c. (impugnazione della rinuncia). Quest’ultimo consente di dichiarare la rinuncia inefficace verso i creditori e autorizzare questi ultimi ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, esclusivamente per soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. La legge non richiede neppure la prova della fraus creditorum (cioè che la rinuncia sia stata fatta apposta per frodarli); basta che la rinuncia abbia arrecato pregiudizio ai creditori, nel senso che senza quell’eredità i creditori trovano un patrimonio del debitore insufficiente. È quindi un rimedio molto potente, più agevole dell’azione revocatoria ordinaria (che peraltro è esclusa in caso di rinuncia, trattandosi di atto personalissimo). Il creditore agisce in via iure proprio, non surrogatoria: significa che non “costringe” il debitore ad accettare (il debitore resta della sua idea di rinuncia), ma bypassa il debitore e accetta lui per la quota necessaria a recuperare il suo credito. Ciò come visto ha il risultato che l’erede rinunciante perde completamente l’eredità: non l’ha accettata lui, e i creditori prendono quel che serve, il resto va ad altri chiamati.
In termini pratici: la rinuncia conviene al debitore solo in scenari molto limitati, ad esempio se: (a) l’eredità è gravata di debiti superiori all’attivo (caso in cui comunque egli farebbe bene a rinunciare per non ereditare passività netta); (b) i creditori personali del debitore sono modesti o distratti, e l’attivo ereditario è di modico valore, tale che forse nessuno si attiverà (c’è però sempre il rischio di curatore dell’eredità giacente o creditori eventuali del de cuius che subentrano); (c) il debitore vuole favorire altri chiamati: rinunciando, fa sì che l’eredità vada ai figli, ad esempio, se i creditori non intervengono. Ma contare sull’inazione dei creditori è un azzardo. Spesso i creditori (specie se istituzionali, banche, fisco) vigilano e, se scorgono una rinuncia a un’attività rilevante, agiscono. Come evidenziato dalla sentenza Trib. Venezia 3607/2024, anche non accettare e far scadere i termini viene considerato alla stregua di una rinuncia impugnabile. La rinuncia non evita neanche le lungaggini: il creditore procedente deve comunque instaurare un giudizio (come ha fatto Allianz nel caso citato) per ottenere la pronuncia di inefficacia, ma se ne vale la pena lo farà.
In sostanza, un debitore pieno di debiti che rinuncia a un bene ereditario compie un atto inefficace e dannoso: se quell’attivo poteva salvarlo parzialmente, egli se ne priva, i creditori cercheranno di prenderlo e lui comunque rimane indebitato per l’eventuale eccedenza. Perfino nell’ambito della procedura di sovraindebitamento, come visto, atti di rinuncia configurano frode e possono far perdere i benefici (esdebitazione negata).
Ricapitolando in breve, dal punto di vista di un debitore sovraindebitato chiamato a un’eredità:
- Se l’eredità ha valore netto positivo, conviene accettare (di regola con beneficio d’inventario per prudenza, specie se non si è certi dell’assenza di debiti del de cuius). Questo farà entrare i beni nel suo patrimonio, ma permetterà di usarli per pagare i creditori. Eventuali eccedenze dopo il pagamento resteranno a lui.
- Accettare con beneficio d’inventario è consigliabile se il de cuius aveva debiti suoi, perché limita la responsabilità di doverli pagare oltre il valore ereditario. Non impedisce però ai creditori personali dell’erede di aggredire i beni ereditari. Quindi è una scelta opportuna per gestire i rapporti tra patrimonio del defunto e creditori del defunto, ma non fornisce un “scudo” verso i propri creditori.
- Rinunciare all’eredità è sconsigliato se nell’eredità ci sono beni di valore a cui i creditori potrebbero essere interessati. I creditori hanno un forte strumento per annullare la rinuncia e ottenere quei beni. Rinunciare ha senso solo se l’eredità è addirittura passiva (più debiti che crediti) o di valore talmente modesto da non giustificare azioni (ma attenzione che i creditori potrebbero agire lo stesso per principio, specie enti pubblici). Rinunciare non elimina i debiti personali del debitore e, anzi, gli fa perdere un’occasione di ridurli.
Possiamo schematizzare le opzioni con la seguente tabella:
| Opzione del chiamato all’eredità | Effetti sul patrimonio del debitore (erede) | Conseguenze per i creditori personali del debitore |
|---|---|---|
| Accettazione pura e semplice | I beni ereditari entrano nel patrimonio del debitore. L’erede diventa titolare di tutti i rapporti attivi e passivi del defunto (continuità dei beni e debiti). | I creditori del debitore possono aggredire liberamente i beni ereditati (divenuti suoi). Il debitore risponde anche degli eventuali debiti del defunto con tutto il proprio patrimonio (rischio di aggravio se il defunto aveva passività). |
| Accettazione con beneficio d’inventario | L’attivo ereditario resta separato fino alla liquidazione. L’erede paga i debiti ereditari solo con l’attivo ereditario, preservando il proprio patrimonio personale. Dopo la liquidazione, l’eventuale saldo attivo entra nel patrimonio dell’erede (ora “ripulito” dai debiti del defunto). | Fintanto che l’eredità è separata, i creditori personali dell’erede possono soddisfarsi sui beni ereditari solo dopo i creditori del defunto. In una procedura concorsuale, tuttavia, il liquidatore considererà quell’attivo (al netto dei debiti ereditari) destinato anche ai creditori personali. In definitiva, il residuo attivo finisce comunque a disposizione dei creditori dell’erede (anche se il beneficio li obbliga ad attendere la definizione delle passività ereditarie). Non offre protezione ai beni ereditari rispetto ai creditori dell’erede, oltre la fase di liquidazione dei debiti ereditari. |
| Rinuncia all’eredità | Il chiamato non entra mai in possesso dei beni ereditari, che passano ai successivi aventi diritto (altri eredi o Stato). Il suo patrimonio resta invariato (non aumenta né dei beni né dei debiti del defunto). | Se la rinuncia priva i creditori di una fonte di soddisfacimento, essi possono impugnarla ex art. 524 c.c. e farsi autorizzare dal tribunale ad accettare l’eredità in luogo del debitore rinunciante. In tal caso i creditori potranno pignorare i beni ereditari fino a copertura dei loro crediti, ignorando la rinuncia (inefficace verso di loro). Il debitore rinunciante non diviene erede e non beneficia comunque dei beni (nemmeno di eventuali eccedenze). Se i creditori non agiscono (caso raro per valori significativi), essi perdono quell’opportunità ma i debiti del debitore restano dovuti: la rinuncia non li estingue e anzi il debitore ha perso un potenziale attivo con cui pagarli. |
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito, proponiamo una serie di domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni sul rapporto tra sovraindebitamento ed eredità, riepilogando in forma sintetica quanto esposto in dettaglio nella guida.
D: I debiti di una persona deceduta si trasmettono agli eredi?
R: Sì, per legge gli eredi subentrano sia nei beni che nei debiti del defunto (principio della continuità patrimoniale), fatta eccezione per debiti di natura personale che si estinguono con la morte (es. sanzioni amministrative e penali). Tuttavia, un erede può limitare la propria responsabilità accettando l’eredità con beneficio d’inventario: così facendo, i debiti del defunto saranno pagati solo coi beni ereditari, senza intaccare il patrimonio personale dell’erede. Se invece l’erede rinuncia all’eredità, non subentra né nei beni né nei debiti del defunto (quindi non è tenuto a pagarli), ma perde anche ogni diritto su eventuali attivi ereditari. La scelta va ponderata: se i debiti del defunto superano i beni, la rinuncia è spesso la soluzione prudente; se i beni superano i debiti, l’erede può accettare (meglio se con beneficio per cautela). Nel contesto di una procedura di sovraindebitamento, accettare con beneficio garantisce che i debiti del defunto non aggravino la crisi del debitore erede, mentre i creditori del debitore-erede potranno comunque rivalersi sui beni ereditari residui.
D: Se un debitore sovraindebitato riceve un’eredità durante la procedura, deve darla ai creditori?
R: Dipende dalla procedura. In liquidazione controllata, sì: tutti i beni sopravvenuti entro 3 anni dall’apertura della procedura vanno acquisiti e destinati ai creditori. Ciò include gli stipendi, le vincite e ovviamente i beni ricevuti in eredità in quel periodo. La Corte Costituzionale ha confermato che tale regola è legittima ed anzi espressione del principio generale che il debitore risponde con i beni presenti e futuri. Quindi, se Tizio è in liquidazione controllata e durante la procedura eredita ad esempio un immobile, il liquidatore lo aggiungerà all’attivo e probabilmente lo venderà per pagare i creditori. Invece, nel piano del consumatore o nel concordato minore, i beni sopravvenuti dopo l’omologazione tecnicamente non sono automaticamente inclusi, perché il piano/concordato definisce già quanto il debitore deve pagare. Tuttavia, il debitore deve aver agito in buona fede: se sapeva dell’eredità in arrivo doveva dichiararla sin dall’inizio. Se l’eredità è davvero inaspettata e arriva dopo l’omologa, nessuna norma lo obbliga a modificar il piano per includerla, ma eticamente e strategicamente potrebbe convenire impiegarla per pagare i debiti prima o in maggior misura. In breve: in liquidazione i beni ereditati vanno sempre ai creditori (se la procedura è aperta); in un piano/concordato no, salvo che fossero noti prima, ma il debitore deve comunque agire con correttezza e informare l’OCC.
D: Posso tenere nascosta un’eredità in arrivo per farmi omologare il piano e poi prenderla dopo?
R: Assolutamente no. Questo sarebbe un comportamento fraudolento che compromette la meritevolezza e può portare alla revoca dell’omologazione o alla mancata esdebitazione. Il debitore, sia nel piano del consumatore sia nel concordato minore, ha l’obbligo di rappresentare in modo completo e veritiero la propria situazione patrimoniale. Se emerge che ha occultato deliberatamente l’esistenza di un patrimonio (ad esempio un’eredità attesa) per ottenere condizioni più favorevoli, il giudice può rifiutare l’omologa o, se già concessa, i creditori potrebbero impugnarla. La convenienza del piano viene valutata anche in base a ciò che il debitore può dare: un’eredità significativa muterebbe gli equilibri. Inoltre, l’OCC redige una relazione con l’elenco completo dei beni del debitore: occultare volontariamente un bene è anche reato (falsa attestazione) oltre che causa di inammissibilità. In sintesi, la trasparenza è d’obbligo: meglio includere l’eredità nel piano e semmai negoziare di conservarne parte (ad esempio proponendo di liquidarla in percentuale) che celarla rischiando di perdere tutti i benefici della procedura.
D: Un debitore indebitato può rinunciare all’eredità per non farla prendere ai creditori?
R: Può provarci, ma i creditori hanno mezzi efficaci per vanificare la rinuncia. Come spiegato, i creditori del rinunciante possono rivolgersi al tribunale e ottenere di accettare loro l’eredità al posto del debitore (azione ex art. 524 c.c.). Non serve dimostrare la frode, basta che la rinuncia rechi pregiudizio (ossia che se avesse accettato ci sarebbero beni per pagarli). Una volta autorizzati, essi prenderanno dall’asse ereditario quanto basta a soddisfare i propri crediti. Il debitore rinunciante, in tal caso, resta tagliato fuori dall’eredità: la sua volontà di non essere erede viene rispettata, quindi non avrà alcun diritto su quei beni, nemmeno su quanto eventualmente in eccesso rispetto ai debiti pagati. In pratica, rinunciare non impedisce ai creditori di raggiungere i beni, e comporta solo che il debitore ci rimette l’eredità senza magari neanche ridurre i propri debiti (se erano superiori). Pertanto, rinunciare a un’eredità è di solito una mossa controproducente per un debitore insolvente. L’unico scenario in cui ha senso è se l’eredità è nettamente passiva (cioè solo debiti): in tal caso, rinunciando evita di farsi carico dei debiti del defunto. Ma se l’eredità ha un attivo, grande o piccolo, i creditori saranno legittimati a inseguirla. Perfino se nessun creditore agisse immediatamente, la rinuncia potrebbe essere considerata un atto in frode nella procedura concorsuale, con rischio di perdita dell’esdebitazione. Dunque il consiglio generale è: meglio accettare l’eredità (eventualmente con beneficio d’inventario) e gestirla nell’ambito della soluzione concordataria o liquidatoria, piuttosto che rinunciare sperando inutilmente di “salvarla” dai creditori.
D: Che succede se durante la liquidazione controllata muore il debitore? I suoi eredi ereditano anche i debiti?
R: Se un debitore muore pendente la procedura di liquidazione controllata (o anche giudiziale), la legge prevede che la procedura continui con la partecipazione degli eredi. L’art. 35 CCII stabilisce infatti la prosecuzione nei confronti degli eredi (anche se hanno accettato con beneficio) o del curatore dell’eredità giacente. In pratica, i beni del debitore defunto restano vincolati per pagare i suoi creditori sotto il controllo del liquidatore originario, senza formare oggetto di nuova successione libera. Gli eredi, qualora accettino l’eredità (spesso lo faranno con beneficio d’inventario), non dovranno gestire personalmente i crediti e debiti: sarà la procedura a farlo. Se l’attivo ereditario (cioè i beni del debitore defunto) basta a pagare tutti i creditori concorsuali, gli eredi potranno ottenere l’eventuale avanzo; se non basta, al termine della liquidazione verrà concessa l’esdebitazione che libera il de cuius dai debiti residui e, di riflesso, libera gli eredi dall’obbligo di pagarli (perché il debito è inesigibile). Questo è un grande vantaggio: pensiamo a un figlio che accetta con beneficio l’eredità del padre sovraindebitato; lasciando proseguire la liquidazione, potrà chiedere (anche in qualità di erede interessato) l’esdebitazione finale, ottenendo che i debiti eccedenti l’attivo vengano cancellati. Così quell’erede non dovrà più preoccuparsene in futuro. Se invece la procedura non potesse proseguire e l’erede avesse accettato, si troverebbe debitore per i debiti paterni eccedenti, sia pure nei limiti del patrimonio ereditario per via del beneficio. Insomma, conviene agli eredi far continuare la procedura concorsuale: i creditori verranno soddisfatti sul patrimonio ereditario, e ciò che resta dei debiti sarà estinto senza intaccare il loro patrimonio personale (specie se hanno beneficiato). Nota: nel caso di piano del consumatore o concordato minore, la normativa espressa non c’era (salvo la modifica del 2022 per la liquidazione), ma la giurisprudenza propende anch’essa per la prosecuzione su istanza degli eredi, oppure la conversione in liquidazione. Ad esempio, un tribunale ha concesso agli eredi di un debitore in concordato minore di subentrare e proseguire la procedura, ritenendo applicabili in via analogica gli stessi principi. Pertanto, se un debitore muore con un piano in corso, gli eredi faranno bene a contattare l’OCC e valutare di proseguirlo o convertirlo in liquidazione controllata per chiuderla formalmente e beneficiare della liberazione dai debiti residui.
D: Che differenza c’è tra l’avere un’eredità in un piano del consumatore e averla in liquidazione?
R: La differenza sta principalmente nel fatto che nel piano del consumatore il debitore può cercare di conservare parte del beneficio dell’eredità, mentre in liquidazione no. Se nel piano del consumatore il debitore include l’eredità, egli può proporre di usarla parzialmente per pagare i creditori, forse trattenendo qualche bene se ciò non pregiudica la fattibilità (esempio: “utilizzo i contanti ereditati per pagare i creditori, ma chiedo di poter tenere l’immobile di famiglia”). La fattibilità di tale proposta dipende dai numeri e dal giudizio di convenienza del tribunale. In liquidazione, invece, tutti i beni ereditati devono essere liquidati (salvo siano di valore trascurabile) e il debitore non ha voce in capitolo: perde la disponibilità di quei beni e riceverà solo l’eventuale residuo dopo pagamento di tutti i debiti (residuo che raramente esiste). Inoltre, nel piano i creditori non votano, ma il giudice omologa se ritiene corretto il piano: il debitore potrebbe convincere il giudice che vendere un’eredità (es. la casa di famiglia) è troppo penalizzante e offrire un’alternativa (es. versare l’equivalente in rate). In liquidazione non c’è questa discrezionalità: la casa ereditata sarà venduta, punto. Quindi, dal punto di vista del debitore, gestire l’eredità in un piano concordato offre maggiore flessibilità (e speranza di conservarne qualcosa), mentre in una liquidazione concorsuale vi è certezza che l’eredità verrà utilizzata integralmente per i creditori. Va detto però che un giudice del piano non approverà mai che il debitore tenga l’intera eredità e paghi zero ai creditori: se c’è un valore ereditario, una parte significativa dev’essere destinata ai creditori anche nel piano, altrimenti non sarebbe conveniente. Il vantaggio del piano è che, se l’eredità non copre tutto, il debitore può ottenere la cancellazione del debito residuo senza necessariamente liquidare ogni bene (magari offrendo rate future), mentre la liquidazione liquida tutto subito e poi estingue il debito residuo. In altre parole, il piano è più concordato e modulabile, la liquidazione è più rigida e automatica.
D: Dopo aver ottenuto l’esdebitazione come incapiente, eredito dei soldi: devo darli ai vecchi creditori?
R: Sì, se l’eredità arriva entro 4 anni dal provvedimento di esdebitazione e l’importo è significativo (pari almeno al 10% di quanto era dovuto). In tal caso, la legge prevede espressamente che l’esdebitazione è condizionata: il debitore ha ancora “l’obbligo di pagamento del debito” entro 4 anni in caso di sopravvenienze utili. Ciò significa che dovrà utilizzare i beni ereditati (o altre utilità sopraggiunte) per soddisfare, fino dove possibile, i creditori che aveva prima. Esempio: Debitore scaricato dai debiti nel 2023, eredita €30.000 nel 2025, aveva €50.000 di debiti cancellati – deve riaprire i conti e pagare i creditori almeno fino a €30.000 (in proporzione, ciascuno riceverà circa il 60% del suo credito originario). Se invece l’eredità è modesta, sotto la soglia del 10%, la legge la ignora e il debitore può tenerla. Trascorsi 4 anni dall’esdebitazione, qualunque cosa il debitore ottenga è definitivamente sua, i creditori non potranno più nulla. In sintesi: per 4 anni dopo un’esdebitazione “a zero” il debitore è in una sorta di probation: se ha un colpo di fortuna, ne devono beneficiare anche i suoi vecchi creditori (fino a concorrenza dei crediti).
D: Quante volte posso fare una procedura di sovraindebitamento o ottenere un’esdebitazione?
R: La legge pone dei limiti per evitare abusi:
- L’esdebitazione ordinaria (quella che si ottiene al termine di una liquidazione controllata o di un concordato/piano eseguito) può, in teoria, essere concessa più volte, ma con almeno 5 anni di intervallo. Il CCII all’art. 278 comma 2 prevede che l’esdebitazione non è concessa se il debitore ne ha già beneficiato nei 5 anni precedenti (norma analoga all’art. 142 l.fall. per il fallito). Quindi due esdebitazioni ordinarie consecutive <5 anni non sono ammesse. Inoltre, per il concordato minore è stato introdotto (correttivo 2024) che non è ammissibile proprio la proposta se il debitore ha ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti (il che impedisce di chiedere un nuovo concordato se si è già avuta cancellazione debiti da poco). Per il piano del consumatore vale in pratica lo stesso criterio, anche se il CCII lo sottintende nel richiedere la buona fede: ripetere procedure a breve potrebbe essere letto come mala fede.
- L’esdebitazione dell’incapiente è concessa una tantum: la legge dice esplicitamente “solo per una volta”. Quindi un debitore non può chiedere di cancellare i debiti a zero più di una volta nella vita. Se lo fa e poi si sovraindebita di nuovo, dovrà utilizzare le altre procedure (piano, concordato, ecc.) ma non potrà ottenere un secondo “colpo di spugna” gratuito.
- Quanto alle procedure di sovraindebitamento in sé (senza considerare l’esdebitazione finale), in passato la L.3/2012 vietava di accedere a una nuova procedura se se ne era già fruito nei 5 anni precedenti. Oggi, come visto, il correttivo 2020 ha eliminato il divieto generale e ha lasciato solo quello legato all’esdebitazione ottenuta. Quindi, per esempio, se nel 2023 un debitore propone un piano del consumatore ma non riesce a portarlo a termine (viene revocato o risolto), non deve aspettare 5 anni: può anche subito nel 2024 presentare magari una liquidazione o un concordato minore, purché ovviamente la situazione lo giustifichi e non abbia avuto un’esdebitazione nel mezzo.
In sintesi: ripetere le procedure è possibile ma non se si è già avuta la cancellazione dei debiti di recente. L’ordinamento intende dare un’opportunità seria di rilancio, non diverse in rapida successione.
D: In conclusione, cosa dovrebbe fare un debitore pieno di debiti che riceve un’eredità?
R: Ogni caso è specifico, ma in linea generale: se l’eredità ricevuta è consistente, il debitore dovrebbe valutarla come un’opportunità per risolvere la sua situazione debitoria. Se la somma ereditata consente di pagare tutti i debiti, potrebbe farlo e chiudere le pendenze (magari anche tramite accordi transattivi a saldo e stralcio con i creditori). Se l’eredità non basta a pagare tutto, il debitore può avvalersi delle procedure di sovraindebitamento per regolare i conti in modo definitivo: ad esempio, proponendo un piano del consumatore in cui mette a disposizione l’intera eredità (o gran parte) ottenendo in cambio l’esdebitazione sul restante. In questo modo i creditori ricevono subito qualcosa (forse più di quanto avrebbero ottenuto altrimenti) e accettano la cancellazione del residuo. Ciò consente al debitore di ripartire pulito. Ciò che non deve fare, come spiegato, è tentare di giocare d’astuzia rinunciando o nascondendo l’eredità: questa strada porta quasi sempre a problemi legali (impugnative dei creditori, rigetto delle procedure, possibili denunce per sottrazione di beni ai creditori). Se il patrimonio ereditato ha valore sentimentale (es. casa di famiglia) e il debitore vuole cercare di salvarlo, l’unica via è negoziarla all’interno di un concordato/piano, offrendo ai creditori un valore equivalente magari grazie a terzi o a pagamenti dilazionati. Bisogna convincere il tribunale che non vendere quell’immobile non penalizza i creditori. Non c’è garanzia di successo, ma almeno è un tentativo lecito (in alcuni casi i giudici hanno omologato piani dove il debitore manteneva l’abitazione offrendo ai creditori pagamenti alternativi). Invece, se il bene ereditato viene semplicemente occultato o omesso, appena i creditori lo scoprono faranno valere i loro diritti. In conclusione: massima trasparenza e utilizzo proattivo dell’eredità per risolvere la crisi debitoria. Questo è nell’interesse del debitore (che così riduce la propria esposizione e può arrivare a cancellare i debiti residui legalmente) e anche dei creditori (che vedono soddisfatte le loro ragioni in misura ragionevole senza lunghe esecuzioni).
Conclusioni
La gestione dei beni ereditari in situazioni di sovraindebitamento richiede un delicato equilibrio tra la tutela dei creditori e la possibilità di dare al debitore una via d’uscita sostenibile. La normativa italiana, aggiornata al 2025 con il Codice della Crisi e i suoi correttivi, offre un ventaglio di strumenti per affrontare la crisi debitoria – dal piano del consumatore al concordato minore, dalla liquidazione controllata all’esdebitazione dell’incapiente – ciascuno con regole specifiche sul destino del patrimonio del debitore.
Da quanto esposto, emergono alcune linee guida generali dal punto di vista del debitore sovraindebitato:
- Onestà e collaborazione sono fondamentali: il debitore deve dichiarare e utilizzare ogni risorsa disponibile, incluse le eredità, nel migliore interesse della procedura. Tentare di sottrarre beni agli obblighi (ad esempio rinunciando a un’eredità per non pagarci i creditori) è non solo eticamente scorretto ma giuridicamente inefficace, perché l’ordinamento predispone meccanismi per impedirlo. Al contrario, la legge “premia” il debitore onesto: ad esempio concedendo l’esdebitazione al termine della procedura, o addirittura immediatamente per l’incapiente meritevole, a patto che egli non abbia nascosto nulla.
- Protezione dell’unico bene di famiglia: se il debitore eredita, ad esempio, la casa dei genitori e quella è anche la sua abitazione, la procedura di sovraindebitamento (in particolare il piano del consumatore) offre margini per salvaguardarla, prevedendo la continuazione del mutuo e una moratoria sui pagamenti. Il debitore può proporre di conservare l’immobile pagando i creditori in altra forma (rate, altre risorse). Non c’è garanzia di riuscita, ma almeno in sede di piano del consumatore il giudice può valutare soluzioni più flessibili e umane, tenuto conto che i creditori chirografari non votano ma neppure subiscono un sacrificio eccessivo (devono ricevere almeno quanto avrebbero da una liquidazione). Nella liquidazione, invece, non v’è spazio per ragioni personali: i beni (anche la casa) andranno venduti. Pertanto, un debitore che tenga a un bene ereditario specifico potrebbe preferire tentare la carta di un accordo/piano anziché finire in liquidazione forzata dai creditori.
- Timing e scelta della procedura: l’arrivo di un’eredità può cambiare la strategia. Ad esempio, un debitore che inizialmente pensava all’esdebitazione incapiente (perché non aveva nulla) se scopre di essere prossimo erede di un bene, dovrà riconsiderare: quell’istituto non gli permetterà di “liberarsi” e tenere il bene, poiché comunque se l’eredità arriva entro 4 anni dovrà usarla per i creditori. Forse in tal caso è meglio attendere l’eredità e proporre un piano con essa. Viceversa, un debitore che non si aspettava nulla e ottiene l’esdebitazione incapiente dovrebbe vivere in modo morigerato per 4 anni, sapendo che se ha un colpo di fortuna dovrà condividerlo con chi aveva credito da lui, il che è giusto. Dopo quel periodo, sarà davvero ripartito da zero. In generale, se c’è un evento successorio noto all’orizzonte (es. un genitore molto anziano con patrimonio), il debitore e i suoi consulenti devono tenerne conto nella pianificazione della crisi. Anche presentare una procedura troppo presto, per poi ritrovarsi un’eredità in corso d’opera, può creare complicazioni; a volte può convenire attendere e includere tutto in un’unica soluzione concorsuale.
In definitiva, la legislazione sul sovraindebitamento ha tracciato un percorso di responsabilizzazione reciproca: il debitore è chiamato a mettere sul piatto tutti i suoi beni presenti e futuri (fino a un certo limite temporale) perché solo così può aspirare a liberarsi del peso dei debiti; i creditori, dal canto loro, devono accettare un soddisfacimento non integrale ma in tempi ragionevoli, sapendo che oltre quel limite il debitore potrà tornare a una vita normale e qualunque risorsa acquisisca in seguito non sarà più reclamabile. L’eredità rientra in questo schema: se ricevuta nel periodo critico (durante la procedura o entro i termini di condizionalità), va sostanzialmente destinata ai creditori; se perviene successivamente, appartiene ormai al debitore libero.
Dal punto di vista pratico, il debitore sovraindebitato dovrebbe consultare tempestivamente un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o un legale esperto per valutare la propria situazione, specialmente in presenza di vicende ereditarie. La normativa è complessa ma flessibile: come abbiamo visto, esistono soluzioni ad hoc per i vari casi, e la giurisprudenza recente (Cassazione, tribunali, Corte Costituzionale) ha chiarito molti dubbi, fornendo basi solide su cui fondare le strategie (dalla prosecuzione post mortem delle procedure, alla tutela dei creditori in caso di rinunce, all’ambito delle esdebitazioni).
In conclusione, “cosa sapere” per un debitore riguarda soprattutto la consapevolezza che un’eredità può – e deve – diventare parte della soluzione alla crisi di debiti, non un escamotage per aggirarla. Utilizzata correttamente, può accelerare la procedura e migliorare le prospettive di soddisfare i creditori e di ottenere l’esdebitazione. Cercare invece di isolarla dal contesto debitorio è in contrasto con i principi di legge e destinato a fallire. L’ordinamento, aggiornato alle sfide odierne, fornisce gli strumenti per bilanciare equamente le posizioni: spetta al debitore farne buon uso, preferibilmente con l’ausilio di professionisti, per voltare pagina e raggiungere quel “fresh start” che è l’obiettivo ultimo delle procedure di sovraindebitamento.
Fonti
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), in particolare artt. 2, 33, 35, 67-73, 74-83, 268-283 CCII.
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Composizione delle crisi da sovraindebitamento) – normativa previgente di riferimento.
- Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. “Correttivo ter” al CCII) – Modifiche alle procedure da sovraindebitamento (nuova definizione di consumatore, limiti temporali, ecc.).
- Corte Costituzionale, sentenza n. 6/2024 – legittimità costituzionale art. 142, co.2 CCII (durata della liquidazione controllata e acquisizione beni futuri).
- Tribunale di Venezia, sentenza n. 3607/2024 (16 ottobre 2024) – Impugnazione da parte dei creditori della mancata accettazione dell’eredità (azione ex art. 524 c.c.): autorizzata l’accettazione in luogo del debitore rinunciante.
- Tribunale di Vicenza, decreto 12/03/2024 – Concordato minore e morte del debitore: ammessa prosecuzione con subentro degli eredi (termine per decidere se continuare).
Procedura di sovraindebitamento e beni ricevuti in eredità? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai avviato o stai valutando una procedura di sovraindebitamento, ma hai ricevuto un’eredità?
Temi che i beni ereditati possano compromettere l’omologazione del piano o l’accesso alla procedura?
Quando si riceve un’eredità durante o prima di una procedura di sovraindebitamento, è fondamentale gestire correttamente il patrimonio per non rischiare l’inammissibilità o la revoca del beneficio dell’esdebitazione.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la tua situazione patrimoniale e i beni ereditati (immobili, conti, quote, crediti)
- 📌 Verifica l’impatto dell’eredità sulla procedura già avviata o in fase di preparazione
- ✍️ Ti assiste nella valutazione tra accettazione, rinuncia o accettazione con beneficio d’inventario
- ⚖️ Redige piani aggiornati, modifica istanze già depositate e tratta con l’OCC e i creditori
- 🔁 Ti guida verso soluzioni che tutelano il diritto all’esdebitazione, senza compromettere la tua ripartenza
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto della crisi e procedure di sovraindebitamento
- ✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
- ✔️ Specializzato in casi complessi con eredità, donazioni o successioni in corso
Conclusione
Ricevere un’eredità non significa automaticamente perdere l’accesso al sovraindebitamento, ma serve una gestione attenta e tempestiva.
Con il giusto supporto legale puoi difendere il tuo diritto all’esdebitazione e pianificare il futuro in modo consapevole.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua ripartenza comincia da qui, anche con un’eredità in corso.