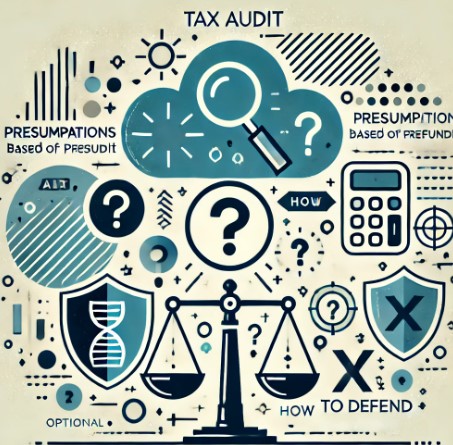Hai ricevuto un accertamento fiscale basato solo su presunzioni e ti stai chiedendo se sia legittimo? Ti contestano ricavi non dichiarati, spese non coerenti o flussi bancari sospetti, senza alcuna prova concreta?
Il Fisco può fondare un accertamento su presunzioni, ma solo se sono gravi, precise e concordanti. Se invece si tratta di semplici ipotesi o valutazioni arbitrarie, puoi contestare tutto e far valere i tuoi diritti.
Cosa si intende per accertamento fondato su presunzioni?
È un accertamento fiscale basato su elementi indiretti, dai quali l’Agenzia delle Entrate deduce che il contribuente abbia dichiarato meno del dovuto. Le presunzioni possono riguardare spese, comportamenti, conti correnti, beni posseduti, dati bancari, incroci tra fatture e acquisti.
Quando il Fisco può usare le presunzioni?
– Quando mancano documenti contabili affidabili
– Quando la contabilità è ritenuta inattendibile o incompleta
– Quando emergono dati bancari non giustificati
– Quando ci sono scostamenti rilevanti dai parametri ISA o dalle medie di settore
– Quando ci sono incongruenze tra tenore di vita e redditi dichiarati
Quando un accertamento basato su presunzioni è illegittimo?
– Se le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti
– Se si fondano su semplici congetture o stime arbitrarie
– Se non è stato rispettato il contraddittorio con il contribuente
– Se la contabilità è regolare ma ignorata dal Fisco
– Se le spese o i versamenti contestati sono giustificati con prove concrete
Come puoi difenderti da un accertamento presuntivo?
Analizza nel dettaglio le presunzioni usate dall’Agenzia e chiedi l’accesso agli atti. Ricostruisci in modo puntuale la tua posizione fiscale e patrimoniale. Giustifica spese, flussi bancari, versamenti e acquisti con prove documentali (contratti, donazioni, prestiti, risparmi pregressi). Dimostra la correttezza della contabilità o la natura non imponibile delle somme. Partecipa attivamente al contraddittorio e presenta una memoria difensiva. Se l’accertamento è infondato, puoi presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace?
– L’annullamento dell’accertamento se privo dei requisiti di legge
– La riduzione di imposte e sanzioni
– Il riconoscimento della legittimità della tua contabilità
– La tutela del tuo reddito, del tuo patrimonio e della tua attività
– La chiusura della vicenda con una definizione agevolata
Le presunzioni non bastano per farti pagare di più: devono essere fondate su fatti concreti e lasciarti la possibilità di difenderti. Se agisci subito, puoi evitare danni economici e personali molto seri.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati tributaristi esperti in accertamenti presuntivi e difesa del contribuente ti spiega quando l’Agenzia può usare le presunzioni, quali limiti deve rispettare e cosa fare per contestare un accertamento basato su ipotesi.
Hai ricevuto un accertamento fondato su semplici presunzioni?
Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo le presunzioni utilizzate, i tuoi documenti e le contestazioni ricevute, e ti diremo se puoi annullare l’accertamento, ridurre le sanzioni o difendere la tua posizione senza compromessi.
Introduzione
Gli accertamenti fiscali basati su presunzioni rappresentano uno strumento potente in mano all’Amministrazione finanziaria per combattere l’evasione, ma possono risultare particolarmente insidiosi per i contribuenti. In termini semplici, una presunzione tributaria consente al Fisco di dedurre l’esistenza di materia imponibile (redditi, ricavi non dichiarati, basi imponibili IVA non contabilizzate, ecc.) a partire da indizi o fatti noti, in mancanza di prove dirette. Da un lato, ciò facilita l’accertamento – l’ufficio può fondare la pretesa fiscale su elementi indiretti invece che su prove documentali certe –; dall’altro, carica il contribuente di un onere pesante: dovrà confutare l’assunto presuntivo dimostrando il contrario (ad esempio tramite documenti, testimonianze ora ammissibili per iscritto, o altre prove contrarie).
In questa guida approfondiremo tutti gli aspetti di un accertamento fiscale fondato su presunzioni – tipologie di presunzioni legali e semplici previste dal sistema tributario italiano, normative di riferimento, orientamenti giurisprudenziali più aggiornati (fino al 2025), nonché strategie difensive sia in sede amministrativa che nel processo tributario. Il taglio è avanzato ma con un linguaggio chiaro e divulgativo, adatto a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) ma anche a imprenditori e privati cittadini che vogliano capire come difendersi da pretese fiscali basate su presunzioni. La prospettiva adottata è quella del contribuente (debitore d’imposta), evidenziando diritti, garanzie e strumenti di tutela a sua disposizione.
Ma andiamo ora per punti.
Che cosa si intende per accertamento fondato su presunzioni
Un accertamento fiscale fondato su presunzioni è un atto impositivo (tipicamente un avviso di accertamento) con cui l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza determinano un maggior reddito imponibile o una maggiore imposta dovuta basandosi non su prove dirette, bensì su presunzioni o indizi. In sostanza, l’ente impositore inferisce l’esistenza di ricavi non dichiarati, di operazioni imponibili non contabilizzate o di altri elementi fiscali nascosti a partire da fatti noti o comportamenti del contribuente. Tali fatti fungono da “tracce”: per esempio, ingenti versamenti bancari non giustificati fanno presumere incassi in nero; uno stile di vita molto al di sopra del reddito dichiarato fa presumere redditi non dichiarati; la presenza di attività finanziarie all’estero non dichiarate fa presumere che i fondi derivino da evasione, e così via.
Giuridicamente, la presunzione è uno strumento probatorio regolato dal codice civile e da leggi speciali. Si distingue tra:
- Presunzioni legali, stabilite direttamente dalla legge, le quali attribuiscono a determinati fatti noti un significato vincolante ai fini fiscali (es.: l’art. 32 DPR 600/1973 presume che certi movimenti bancari siano reddito imponibile). Le presunzioni legali possono essere relative (iuris tantum) – ammettono prova contraria da parte del contribuente – oppure, in rari casi, assolute (iuris et de iure) – non ammettono alcuna prova contraria.
- Presunzioni semplici, che non sono previste da una norma specifica ma sono il frutto di un ragionamento induttivo del giudice (o dell’ufficio) basato su fatti e indizi concreti. La legge (art. 2729 c.c.) ne consente l’uso solo se gli indizi su cui si basano sono gravi, precisi e concordanti. In sostanza, il giudice può ritenere provato un fatto sconosciuto (es.: esistenza di vendite “in nero”) partendo da uno o più fatti noti, purché questi convergano univocamente verso quella conclusione.
Nel contesto tributario, le presunzioni vengono spesso utilizzate in fase di accertamento quando i dati dichiarati dal contribuente appaiono inattendibili, incompleti o incoerenti rispetto alla realtà. Anziché limitarsi a quanto emerge dalle scritture contabili o dalle dichiarazioni fiscali, l’Ufficio finanziario può fondare la rettifica su elementi indiretti. Ciò avviene tipicamente in uno dei seguenti scenari:
- Contabilità irregolare o inattendibile: se dal controllo contabile emergono omissioni, falsità o inesattezze, l’ufficio può presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati o l’inesistenza di costi dichiarati, purché supportato da indizi solidi (es.: incongruenze nelle rimanenze, margini irrealistici, fatture false, ecc.).
- Mancata presentazione della dichiarazione: se il contribuente non ha nemmeno dichiarato i redditi, il Fisco può procedere a una ricostruzione “a tavolino” del reddito imponibile anche in via induttiva pura, utilizzando qualsiasi dato disponibile e anche presunzioni molto semplificate (come percentuali forfettarie, parametri di settore, ecc.).
- Disallineamento tra reddito dichiarato e manifestazioni di ricchezza: quando uno stile di vita, investimenti o spese effettuate non trovano copertura nel reddito ufficiale, si attiva l’accertamento sintetico (cd. redditometro). Ad esempio, l’acquisto di beni di lusso, il mantenimento di determinati beni (auto di grossa cilindrata, imbarcazioni, proprietà immobiliari costose) o elevati movimenti finanziari possono far scattare una presunzione di maggiore capacità contributiva ai sensi dell’art. 38 DPR 600/1973.
- Indagini finanziarie sui conti correnti: l’Agenzia delle Entrate può ottenere i dati dei conti bancari e postali del contribuente (previa autorizzazione interna) e presumere che ogni accredito non giustificato sul conto sia un ricavo non dichiarato e che ogni prelievo non giustificato costituisca spesa in nero (dunque indirettamente finanziata con ricavi in nero). Questa è una presunzione legale relativa molto incisiva: sposta sul contribuente l’onere di dimostrare la diversa provenienza o finalità di ciascun movimento bancario.
Questi esempi illustrano il concetto: l’Ufficio parte da tracce o anomalie (fatti noti) per risalire, tramite una presunzione, a maggiori imposte dovute (fatto ignoto da provare). La chiave per difendersi è capire quale tipo di presunzione viene utilizzata contro di noi e quali contromisure probatorie possiamo attivare per smontarla. Nei paragrafi seguenti analizzeremo dettagliatamente le varie tipologie di presunzioni tributarie e come esse incidono sul riparto dell’onere della prova, per poi passare alle strategie difensive.
Tipologie di presunzioni tributarie
In ambito fiscale italiano possiamo distinguere tre tipologie principali di presunzioni utilizzate negli accertamenti:
- Presunzioni legali (relative o assolute) – previste espressamente da una norma di legge tributaria. Conferiscono al fatto noto indicato dalla legge un valore di prova ex lege, spesso invertendo l’onere della prova a carico del contribuente. Possono essere relative (iuris tantum), se ammettono prova contraria, oppure assolute (iuris et de iure) se la legge esclude qualunque possibilità di prova contraria da parte del contribuente. Nel processo tributario, una presunzione legale dispensa l’ente impositore dal dover dimostrare il fatto presunto: esso si dà per provato in virtù della legge stessa, salvo che il contribuente lo dimostri falso (quando la presunzione è relativa). Esempio: l’art. 32 DPR 600/1973 stabilisce per legge che i versamenti bancari ingiustificati si presumono redditi tassabili (presunzione relativa); spetterà al contribuente provare, per ciascun versamento, che si tratta ad esempio di trasferimenti da altri propri conti, di somme già tassate o di entrate non imponibili. Se una presunzione legale è assoluta, invece, nessuna prova può essere ammessa per sovvertirla – ma queste sono ipotesi molto rare nel diritto tributario (ad es. in passato: la presunzione che determinate scritture “nero su bianco” come i brogliacci extra-contabili di un imprenditore rappresentassero ipso facto ricavi occulti, vicina a un’iuris et de iure). In generale comunque, quasi tutte le presunzioni legali tributarie sono relative (iuris tantum) e mirano semplicemente a spostare il peso probatorio sul contribuente.
- Presunzioni semplici – non previste da una norma specifica, ma costruite caso per caso dal Fisco (e poi valutate dal giudice) sulla base di indizi e circostanze fattuali. La loro ammissibilità è subordinata per legge al rispetto del criterio della gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.). Ciò significa che gli elementi indiziari utilizzati debbono avere un peso significativo (gravità), essere ben definiti e non ambigui (precisione), e non contraddirsi a vicenda ma convergere verso la medesima conclusione (concordanza). Solo se queste condizioni sono soddisfatte, una presunzione semplice può ritenersi valida e dunque idonea a fondare un accertamento. Diversamente dalla presunzione legale, quella semplice non inverte automaticamente l’onere della prova a carico del contribuente: in giudizio resta sempre onere dell’Amministrazione provare adeguatamente i fatti su cui si basa la presunzione e convincere il giudice della loro gravità/precisione. In pratica però, quando il giudice tributario ritiene fondata una certa presunzione semplice (cioè ritiene che gli indizi addotti dal Fisco soddisfino i requisiti di legge), di conseguenza spetterà al contribuente attivarsi per fornire elementi specifici di segno contrario, al fine di scardinare quella conclusione presuntiva. Esempio: se dall’analisi dei consumi di energia elettrica di un negozio l’ufficio presume maggiori ricavi non dichiarati (indizio: consumi incompatibili con il fatturato), il giudice valuterà se tale indizio è grave, preciso e concordante; se lo è, considererà provato il maggior ricavo salvo che il contribuente presenti prove convincenti del contrario (es. dimostrando che l’alto consumo è dovuto ad attività diverse non produttive di reddito).
- Presunzioni “supersemplici” (o presunzioni ultra-semplificate) – è un termine dottrinale per indicare quelle presunzioni ancora più deboli delle presunzioni semplici classiche, che la legge talvolta consente in situazioni eccezionali, dispensando addirittura l’Amministrazione dal dover fornire indizi gravi e precisi. Si verificano soprattutto in caso di omessa dichiarazione o di totale inattendibilità delle scritture: in tali frangenti, la legge permette al Fisco di prescindere completamente dai dati contabili e di procedere a una determinazione arbitraria del reddito, anche basata su dati extracontabili o mere percentuali medie, senza necessità di prove robuste. Ad esempio, l’art. 39, comma 2, DPR 600/1973 prevede che se il contribuente non presenta la dichiarazione o tiene libri inattendibili, l’ufficio determina il reddito d’impresa sulla base dei dati comunque raccolti, potendo anche avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità e precisione. In parole povere, in situazioni di default dichiarativo o contabile, il Fisco può procedere con metodi induttivi puri (es: applicare parametri standard di redditività, oppure ricostruire il volume d’affari in base ad elementi secondari) senza dover prima produrre forti indizi specifici. Chiaramente, anche in questo caso il contribuente mantiene il diritto di difendersi, ma parte da una posizione più difficoltosa: dovrà cercare di dimostrare, a posteriori, che la ricostruzione presuntiva operata dal Fisco è eccessiva o infondata nonostante la mancanza di dati ufficiali.
Tabella riepilogativa – Differenze tra presunzioni legali, semplici e supersemplici
| Tipologia di presunzione | Definizione e caratteri | Effetti sul processo probatorio |
|---|---|---|
| Legale (iuris tantum) | Prevista direttamente da una norma di legge tributaria. Di regola è relativa (iuris tantum): ammette prova contraria del contribuente. Raramente può essere assoluta (iuris et de iure), se la legge esclude espressamente ogni prova contraria. Esempio: art. 32 DPR 600/73 presume che versamenti bancari non giustificati siano ricavi tassabili. | Inverte (sposta) l’onere della prova a carico del contribuente. L’Amministrazione finanziaria dà per esistente il fatto presunto (maggior reddito, ecc.) senza ulteriori dimostrazioni, e sarà il contribuente a dover fornire prova contraria analitica per vincere la presunzione. Se la presunzione è assoluta, il contribuente non può fornire alcuna prova contraria. |
| Semplice | Non fissata dalla legge, ma frutto di un ragionamento inferenziale basato su indizi di fatto (art. 2729 c.c.). È ammessa solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti. Richiede una valutazione complessiva e rigorosa degli elementi indiziari disponibili. Esempio: accertamento da studi di settore/ISA: il reddito ricostruito in base a medie di settore è una presunzione semplice di maggior reddito. | Non esonera pienamente il Fisco dal suo onere probatorio: le presunzioni semplici sono strumenti attraverso cui l’ente impositore cerca di assolvere tale onere. In giudizio, l’Amministrazione deve persuadere il giudice che gli indizi sono fondati (GPC); se ci riesce, il fatto ignoto è considerato provato salvo prova contraria del contribuente. Il contribuente quindi dovrà confutare specificamente la presunzione con proprie prove (documenti, perizie, testimoni, ecc.), mostrando ad es. che i calcoli presuntivi non si applicano al suo caso concreto. |
| “Supersemplice” (o ultra-semplificata) | Presunzione induttiva attenuata: non richiede gli usuali requisiti di gravità/precisione degli indizi. Introdotta da norme fiscali speciali per situazioni di evasione conclamata o assenza di dichiarazione. L’art. 39 comma 2 DPR 600/1973, ad esempio, consente in caso di omessa dichiarazione di determinare il reddito “a tavolino” prescindendo dalle scritture e usando anche presunzioni prive di gravità/precisione. | L’Ufficio può determinare d’autorità la base imponibile senza dover supportare la pretesa con elementi indiziari solidi. In giudizio, il contribuente potrà sempre contestare il quantum dell’accertamento, ma la legge non richiede all’Ufficio di esibire la normale dote indiziaria iniziale. In pratica il contribuente dovrà scalzare una ricostruzione fondata su medie o parametri, spesso attraverso elementi esterni (es. dimostrando che nell’anno in questione vi erano cause eccezionali per il basso reddito). L’onere probatorio per il contribuente rimane difficile, data la carenza di dati contabili a suo favore. |
Come si evince dalla tabella, la differenza chiave risiede nel fondamento normativo della presunzione e nel conseguente riparto dell’onere della prova:
- Se la presunzione è legale, il fatto presunto è ritenuto ipso iure vero fino a prova contraria: il contribuente parte in svantaggio, dovendo smentire attivamente la tesi del Fisco.
- Se è semplice, il Fisco deve comunque presentare in giudizio elementi convincenti a sostegno della presunzione; solo dopo che tali elementi abbiano convinto il giudice, il contribuente è chiamato a fornire una controprova. In altre parole, le presunzioni semplici non esentano l’Ufficio dal suo onere iniziale, ma costituiscono il mezzo attraverso cui esso cerca di soddisfarlo.
- Se è supersemplice, l’Ufficio può agire con maggiore libertà (e arbitrarietà) nella quantificazione del reddito, confidando nell’anomalia macroscopica della situazione (es.: nessuna dichiarazione presentata). In giudizio, il ruolo del giudice sarà valutare se l’accertamento, ancorché “libero”, abbia mantenuto un criterio di ragionevolezza e se il contribuente offra elementi per ritenere che la pretesa sia eccessiva o infondata.
Nei prossimi paragrafi vedremo concretamente come queste categorie di presunzioni si applicano nelle diverse procedure di accertamento previste dal nostro ordinamento (articoli 38, 39 DPR 600/1973, accertamenti bancari, ecc.) e quali strategie difensive risultano più efficaci in ciascun caso.
Norme e metodi di accertamento basati su presunzioni
L’ordinamento tributario (segnatamente il DPR 600/1973 per le imposte dirette e il DPR 633/1972 per l’IVA) prevede vari metodi di accertamento in cui le presunzioni giocano un ruolo più o meno rilevante. Di seguito esaminiamo i principali:
3.1 Accertamento analitico-induttivo (art. 39, comma 1, DPR 600/1973)
L’accertamento analitico-induttivo è la modalità con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) dichiarato dal contribuente quando la contabilità presenta delle irregolarità. In termini normativi, l’art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973 dispone che, se dall’ispezione della contabilità e dalle altre verifiche svolte risultano incompletezze, falsità o inesattezze nei dati dichiarati, “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”. Questa è la classica ipotesi dell’accertamento analitico-induttivo (detto anche “accertamento extracontabile”): l’ufficio parte dai dati contabili forniti dal contribuente ma, riscontrandovi anomalie, li integra o corregge in via induttiva sulla base di indizi coerenti.
Esempio tipico: un controllo fiscale rileva che un’azienda ha registrato una quantità di materie prime incompatibile con i prodotti finiti venduti, oppure emergono fatture per operazioni inesistenti (false fatturazioni) che gonfiano i costi. In tal caso, l’ufficio può presumere che esistano ricavi aggiuntivi non dichiarati (nel primo esempio, produzione extra non contabilizzata) oppure che vi siano costi fittizi da riprendere a tassazione (nel secondo esempio, le fatture false). Queste conclusioni derivano “per presunzione” da fatti-indizio accertati (discrepanze tra input e output, documenti falsi, ecc.), e la legge impone che tali indizi abbiano caratteristiche di gravità, precisione e concordanza.
Dal punto di vista probatorio, l’art. 39 c.1 lett. d) configura dunque una presunzione legale relativa a favore del Fisco: la norma stessa autorizza l’uso di presunzioni semplici G.P.C., dando loro dignità di prova idonea per fondare l’atto impositivo. Ciò significa che in giudizio il contribuente non può limitarsi a contestare che l’Ufficio abbia usato “solo” presunzioni: la legge glielo consente espressamente. L’unica via difensiva è attaccare la qualità e coerenza degli indizi: ad esempio, dimostrare che le irregolarità contestate sono marginali o isolate (quindi non “gravi”), oppure offrire una spiegazione alternativa che spezzi la concordanza degli indizi. Se anche un solo elemento viene messo in dubbio, viene meno il trittico GPC necessario alla presunzione e l’accertamento perde fondamento.
Orientamenti giurisprudenziali: la Cassazione ha costantemente confermato la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo in presenza di scritture inattendibili. Ad esempio, con la sent. n. 14885/2018 ha ribadito che “ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/73, l’Ufficio può fondare la rettifica su presunzioni semplici rispondenti ai requisiti di legge, senza che sia necessaria la prova diretta dell’occultamento di ricavi”. Tuttavia, la Suprema Corte ha anche precisato che non ogni irregolarità contabile legittima di per sé un accertamento induttivo: se le irregolarità sono lievi o isolate, non tali da inficiare l’attendibilità globale della contabilità, l’uso di presunzioni potrebbe risultare arbitrario (Cass. n. 757/2020, n. 2861/2021). In pratica: serve comunque una seria difformità o un insieme di anomalie, altrimenti l’accertamento va annullato per carenza di presupposti.
Difesa del contribuente nell’analitico-induttivo: occorre dunque puntare a dimostrare che le presunzioni dell’ufficio non sono supportate da indizi sufficientemente solidi. Strategie possibili:
- Fornire spiegazioni documentate delle irregolarità riscontrate (es.: la differenza nelle materie prime è dovuta a cali peso fisiologici o errori non dolosi, non a produzione in nero; le fatture contestate non erano soggettivamente false ma riferite a fornitori reali, provando magari con documenti aggiuntivi).
- Evidenziare se l’ufficio ha omesso di considerare elementi a favore del contribuente: es. ha ricostruito i ricavi con un mark-up standard ma ignorando che l’impresa ha avuto merce invenduta rimasta in magazzino o perdite per obsolescenza.
- Verificare il rispetto del contraddittorio: se l’accertamento analitico-induttivo si basa su studi di settore o ISA (vedi infra), era obbligatorio attivare il contraddittorio endoprocedimentale; la mancata instaurazione del dialogo preventivo con il contribuente può rendere nullo l’atto (sul punto, v. Cass. SS.UU. n. 18184/2013 per gli studi di settore). Anche al di fuori di tali casi, segnalare un difetto di contraddittorio può essere una linea difensiva, benché la giurisprudenza non riconosca ancora un obbligo generalizzato (vedi par. 5.1).
- Far leva su errori di motivazione: l’avviso di accertamento deve indicare chiaramente gli elementi presuntivi e le ragioni per cui li si ritiene probanti. Con le nuove norme dello Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000 come modificato dal D.Lgs. 219/2023), la motivazione dev’essere ancora più dettagliata, con esplicita indicazione di “presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche” su cui si fonda la decisione. Se l’atto è generico (es. afferma “contabilità inattendibile” senza spiegare perché) o richiama altri documenti senza allegarli, ciò può costituire motivo di annullamento.
3.2 Accertamento induttivo “puro” (art. 39, comma 2, DPR 600/1973)
L’accertamento induttivo puro è previsto dall’art. 39, comma 2, DPR 600/1973 ed è la forma più ampia e discrezionale di accertamento, riservata a situazioni in cui il contribuente ha gravemente violato i propri obblighi dichiarativi o contabili. La norma recita che, “in deroga” alle regole ordinarie, l’Ufficio può determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, nelle seguenti ipotesi:
- Omessa dichiarazione del reddito d’impresa (lett. a);
- Mancata presentazione del bilancio e conto economico, se dovuti (lett. b);
- Mancanza o indisponibilità delle scritture contabili obbligatorie (ad es. contribuente che non ha tenuto i registri, oppure li ha sottratti a verifica – lett. c);
- Contabilità assolutamente inattendibile perché viziata da infedeltà gravi, numerose e ripetute, tali da vanificare l’intero impianto contabile (lett. d).
In tali casi estremi, si autorizza il Fisco a un accertamento eminentemente forfettario/induttivo: l’output dell’accertamento può essere una semplice stima del reddito basata su elementi secondari. Ad esempio, se un imprenditore non ha dichiarato nulla e non esibisce contabilità, l’Agenzia potrebbe desumere il reddito imponibile dai dati bancari, oppure applicando un tasso di ricarico medio del settore alle poche informazioni disponibili sulle vendite, o ancora utilizzando i cosiddetti “parametri” (coefficienti presuntivi per attività simili). Si parla non a caso di presunzioni “supersemplici” in questo contesto: la legge consente di prescindere dal rigoroso criterio GPC e di usare anche presunzioni molto semplificate.
Implicazioni probatorie: l’accertamento induttivo puro è sostenuto da una forte presunzione legale a favore dell’Ufficio. In giudizio, infatti, al contribuente non basterà criticare la fragilità della ricostruzione presuntiva (che magari è effettivamente basata su medie e non su dati specifici): dovrà piuttosto concentrarsi sul contestare la sussistenza delle condizioni che legittimavano l’accertamento induttivo puro. Vale a dire, dovrà dimostrare che non ricorrevano i presupposti della lett. a), b), c) o d). Ad esempio, se l’Ufficio ha proceduto induttivamente affermando che la contabilità era inattendibile (lett. d), il contribuente può cercare di dimostrare che in realtà le violazioni contestate non erano così gravi e diffuse da giustificare l’abbandono totale delle scritture. Se invece l’accertamento è motivato dall’omessa dichiarazione (lett. a), sarà oggettivamente difficile contestare quel fatto (l’omissione dichiarativa risulta dagli atti); in tal caso la difesa dovrà concentrarsi sul merito della quantificazione, pur sapendo che la legge non richiede all’Ufficio di provare analiticamente ogni componente.
Difesa del contribuente nell’induttivo puro: le strategie possibili includono:
- Dimostrare la non applicabilità del metodo induttivo puro: ad esempio provare che alcune scritture contabili in realtà esistevano e sono state messe a disposizione (contraddicendo la lettera c), o che le irregolarità contestate sono limitate e non tali da azzerare l’attendibilità dell’insieme (contraddicendo la lettera d). Se si riesce a declassare la situazione a un caso da accertamento analitico-induttivo e non puro, l’atto potrebbe essere annullato perché l’Ufficio ha ecceduto.
- Contestare la ragionevolezza della ricostruzione presuntiva: sebbene la legge dia mano libera, la giurisprudenza richiede comunque che l’accertamento induttivo abbia un minimo di coerenza. Ad esempio, Cass. n. 20897/2019 ha annullato un accertamento induttivo che determinava un reddito d’impresa sproporzionato rispetto a qualsiasi parametro logico, affermando che “anche l’accertamento induttivo dev’essere ancorato a criteri di ragionevolezza e non può tradursi in arbitrio impositivo”. Il contribuente può presentare perizie di parte o studi economici per dimostrare che il reddito attribuito è impossibile (es.: perché supererebbe il 100% dei ricavi stimati, o perché l’attività per sua natura non poteva generare quei margini).
- Evidenziare errori procedurali: se l’accertamento deriva da una verifica, va controllato il rispetto delle garanzie (es.: se c’è stato accesso in loco, rispetto del verbale di chiusura e del termine di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso, come da art. 12, c.7 L. 212/2000). Qualunque vizio formale può essere fatto valere per annullare l’atto, dato che nel merito la difesa è ardua.
In definitiva, l’accertamento induttivo puro è molto insidioso perché parte da un’implicita sfiducia verso il contribuente (che non ha dichiarato o ha tenuto registri inaffidabili). La miglior difesa è prevenirlo: presentare comunque le dichiarazioni, anche tardive, e tenere traccia di qualsiasi elemento che possa in seguito servire a giustificare il proprio reddito reale (es.: se un contribuente non ha fatturato perché l’attività era ferma, conservare evidenze di questa inattività – comunicazioni, costi fissi sostenuti a vuoto, ecc.). Nel malaugurato caso in cui ci si trovi sotto accertamento induttivo puro, occorre raccogliere ex post quante più prove possibili che contrastino la presunzione (ad es. contratti che dimostrano che parte del patrimonio non proveniva da redditi ma da donazioni, eredità, vincite, indennizzi, ecc., non soggetti a tassazione).
3.3 Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (art. 38 DPR 600/1973 e “redditometro”)
L’accertamento sintetico è lo strumento con cui il Fisco determina il reddito complessivo di una persona fisica sulla base delle spese sostenute, investimenti e segnali di capacità contributiva, in luogo delle fonti di reddito dichiarate. È disciplinato dall’art. 38 DPR 600/1973 (commi 4-7) e rappresenta un caso particolare di presunzione semplice, spesso noto come “redditometro”.
In sintesi, il meccanismo è il seguente: se un contribuente persona fisica ha sostenuto nell’anno spese per consumi, investimenti patrimoniali, o manifestato un tenore di vita incompatibile con il reddito dichiarato, l’ufficio può presumere che il reddito effettivo sia più alto e rettificare di conseguenza. La norma prevede alcune soglie: ad esempio (attuale disciplina), l’accertamento sintetico è possibile solo se il reddito “accertabile” supera di almeno il 20% il reddito dichiarato (soglia riferita a due anni consecutivi). Inoltre, prima di emettere l’avviso basato su redditometro, l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire spiegazioni (il contraddittorio è obbligatorio) circa la differenza riscontrata. Solo se le spiegazioni non risultano convincenti, si procede all’accertamento (art. 38 co.7 DPR 600).
Evoluzione: il “redditometro” è stato per anni applicato tramite specifici decreti ministeriali che individuavano le spese-indice (abitazione, autovetture, viaggi, ecc.) e attribuivano un reddito presunto in base ad esse. Tale strumento ha subìto vicende alterne: il DM 2015 attualmente in vigore ha subito sospensioni e revisioni, e un “nuovo redditometro” predisposto nel 2018 è stato bloccato per timori legati alla privacy e all’affidabilità. Nel 2023-2024 si era ipotizzato un nuovo decreto redditometro, ma un Atto di indirizzo del MEF del 23/5/2024 ne ha ulteriormente sospeso l’entrata in vigore, privilegiando piuttosto metodi sintetici mirati e correttivi (es. focalizzati su incongruenze macroscopiche, anziché su medie nazionali standard). Al luglio 2025, dunque, l’accertamento sintetico rimane previsto dalla legge ma viene utilizzato con cautela e solo in presenza di scostamenti significativi non giustificati.
Presunzione e prova contraria: la Corte di Cassazione ha chiarito che l’accertamento sintetico costituisce una presunzione semplice di capacità contributiva: non dispensa l’ufficio dal provare i fatti indice (ossia le spese sostenute o gli incrementi patrimoniali) e dal rispettare la procedura (invito al contraddittorio). Una volta che l’ufficio abbia dimostrato, ad es., che il contribuente ha comprato casa, auto, barca e pagato scuole costose ai figli dichiarando solo 20.000€ di reddito, la presunzione di un reddito superiore è logica e grave. A quel punto, spetta al contribuente l’onere di fornire prova contraria per giustificare la compatibilità di quelle spese con i redditi dichiarati. La legge stessa prevede (art. 38 co.6) che il contribuente possa dimostrare, ad esempio, che le spese sono state sostenute con redditi diversi da quelli del periodo d’imposta (es. utilizzando risparmi accumulati negli anni precedenti, eredità, donazioni ricevute, redditi esenti o soggetti a tassazione separata).
In giudizio, dunque, la difesa consisterà nel dimostrare la provenienza non tassabile o già tassata delle somme utilizzate per le spese. Oppure nel contestare i calcoli del Fisco, ad esempio dimostrando che alcune voci di spesa attribuitegli in realtà non lo riguardano o sono state sovrastimate. La giurisprudenza ha affermato che se il contribuente fornisce una spiegazione credibile e documentata delle fonti finanziarie utilizzate, l’accertamento sintetico va annullato (Cass. n. 719/2018).
Esempi di difesa nel redditometro:
- Presentare documentazione bancaria che provi che un dato acquisto (es. casa) è stato pagato con denaro proveniente dalla vendita di un altro immobile o con un mutuo (non con redditi non dichiarati).
- Dimostrare che il mantenimento di certi beni (es. barca) è stato in realtà a carico di terzi o che il bene era in comunione con altri soggetti che ne hanno sostenuto i costi.
- Contestare eventuali errori nell’identificazione delle spese: talvolta le spese vengono stimate con algoritmi e possono non rispecchiare la realtà (es. il redditometro potrebbe presumere una spesa forfettaria per generi alimentari in base al nucleo familiare, ma se il contribuente prova di aver vissuto all’estero per metà anno, quella spesa presunta non è applicabile).
Nota sulle garanzie procedurali: come detto, l’invito al contraddittorio preventivo è obbligatorio. La mancata attivazione di questo confronto determina la nullità dell’accertamento sintetico (Cass. SS.UU. n. 24823/2015 ha statuito l’obbligatorietà del contraddittorio per il redditometro, trattandosi di tributo non armonizzato ma per cui la legge interna già prevedeva espressamente tale fase). Inoltre, dal 2020 è stato previsto (DL 34/2019) che gli indici di capacità contributiva e i criteri del redditometro debbano essere individuati con decreto ministeriale sentiti anche i rappresentanti dei consumatori, a garanzia di maggiore equità – riforma però ancora in divenire al 2025.
In conclusione, l’accertamento sintetico è un tipico esempio di battaglia probatoria: il Fisco porta indizi di spesa, il contribuente deve contrapporre prove sulla copertura di quelle spese. Se rimane un ragionevole dubbio sulla fondatezza della pretesa (ossia se le prove del contribuente sono sufficienti a spiegare le spese), il giudice tributario deve annullare l’accertamento per difetto di prova. In caso contrario, la presunzione vince.
3.4 Presunzioni da indagini finanziarie e conti bancari (art. 32 DPR 600/1973)
Una delle presunzioni legali più incisive in ambito tributario è quella legata alle indagini finanziarie sui conti correnti. L’art. 32 del DPR 600/1973 (richiamato anche dall’art. 51 DPR 633/1972 per l’IVA) prevede che l’Amministrazione, quando rileva movimentazioni bancarie non giustificate, possa presumerle componenti di reddito imponibile. In particolare, per i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, la regola stabilisce che:
- Tutti i versamenti (accrediti) riscontrati sui conti sono considerati ricavi o compensi non dichiarati, a meno che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che sono di natura non imponibile.
- Tutti i prelevamenti (addebiti) dal conto, se di ammontare non giustificato da spese documentate, si considerano impiegati per acquisti in nero e, quindi, corrispondono a ricavi non contabilizzati (in sostanza: si presume che quei soldi prelevati “in contanti” siano serviti a pagare costi occulti relativi ad affari non dichiarati, generando ricavi occulti).
Questa presunzione originariamente si applicava indistintamente a chiunque, ma interventi normativi e giurisprudenziali l’hanno calibrata: ad esempio, oggi per i privati non imprenditori la presunzione sui prelevamenti non opera (in quanto un privato può prelevare contante per fini personali estranei a fatti imponibili; Cass. SS.UU. n. 228/2014 e modifiche normative l’hanno recepito). Per imprenditori e professionisti, invece, vige tuttora sia per versamenti che per prelievi.
Dal punto di vista probatorio, siamo in presenza di una presunzione legale relativa di origine legislativa. Ciò comporta:
- L’Amministrazione finanziaria non è tenuta a provare nulla di più che l’esistenza dei movimenti sul conto e la mancata giustificazione da parte del contribuente. Non occorre alcun requisito di gravità/precisione degli indizi, in quanto è la legge stessa a qualificare quei movimenti come indizi sufficienti.
- Il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria analitica: deve dimostrare, per ciascun versamento, che si trattava ad esempio di trasferimenti dal suo conto personale a quello aziendale (dunque non un ricavo esterno), o rimborsi, o somme esenti (es. un prestito ricevuto, documentato da contratto); per ciascun prelievo, deve indicare il beneficiario o lo scopo (es. prelievo usato per pagare l’affitto personale, quindi non legato all’attività). La Cassazione ha sottolineato che questa presunzione è sì “grave” ma non insuperabile: “al contribuente basta indicare il beneficiario dei prelievi o fornire altri elementi di prova contraria” per vincerla. Naturalmente “basta indicare” va inteso in senso sostanziale: occorre produrre elementi credibili a supporto di quanto si afferma, meglio se documentali (ricevute, copia assegni, ecc.).
Giurisprudenza recente sulle indagini bancarie: la Suprema Corte continua a considerare ferrea tale presunzione. Ad esempio, con ordinanza n. 18596/2024, ha ribadito testualmente: “in virtù della presunzione stabilita dall’art. 32 DPR 600/1973 – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questi non dimostra che ne ha tenuto conto in dichiarazione o che sono estranei alla produzione del reddito. Il contribuente ha l’onere di superare la presunzione legale dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna movimentazione, e il giudice di merito deve verificare rigorosamente l’efficacia delle prove fornite”. Questo passaggio conferma anche l’obbligo del giudice di valutare puntualmente ogni singola operazione contestata e la relativa giustificazione: non è ammesso rigettare in blocco le spiegazioni del contribuente senza esaminarle analiticamente.
Un aspetto interessante riguarda il cosiddetto “divieto di doppia presunzione”: in diritto probatorio si suole dire che una presunzione semplice non può basarsi a sua volta su un’altra presunzione. Ebbene, la Cassazione (ord. n. 5529/2025) ha chiarito che questo principio non è violato nel caso delle indagini bancarie: l’ufficio parte da un fatto certo (movimenti su un conto) e su di esso innesta la presunzione legale; non sta basandosi su una presunzione ulteriore. Quindi è legittimo utilizzare i dati bancari anche come indizi di altre presunzioni, purché almeno il primo livello sia un fatto noto. In altre parole, non c’è doppia presunzione se l’input è un fatto oggettivo (es. versamento su conto), da cui si deduce un ricavo non dichiarato, e magari da questo si deduce un’ulteriore conseguenza (es. IVA evasa correlata a quel ricavo): la seconda è una conseguenza diretta del fatto presunto (ricavo) più che una nuova presunzione slegata.
Difendersi da un accertamento bancario: il contribuente che riceve un avviso basato su movimenti bancari ha come prima reazione quella di raccogliere tutte le pezze giustificative di quei movimenti. È consigliabile, già in sede amministrativa (nel contraddittorio con l’ufficio o in risposta a questionari), fornire l’elenco dei movimenti contestati con accanto la relativa spiegazione e documenti di supporto. Ad esempio:
- Versamento X euro sul conto il 10/06: provenienza = restituzione finanziamento da parte di Tizio (allegare copia bonifico con causale).
- Prelievo Y euro dal conto il 20/07: destinazione = pagamento fattura affitto locale commerciale (allegare copia fattura e quietanza se pagata in contanti con quel prelievo).
- Versamento in contanti Z euro il 05/09: provenienza = denaro prelevato dal proprio conto personale e versato su quello cointestato con la moglie (allegare estratto conto personale con prelievo coincidente e magari dichiarazione della moglie).
È fondamentale essere analitici e precisi: generalizzazioni del tipo “sono tutti prestiti da amici” senza nominativi o prove non bastano. La difesa deve fornire al giudice elementi tracciabili e verificabili.
Va notato che oggi, grazie alla riforma del 2022, sono ammesse anche testimonianze scritte nel processo tributario (vedi par. 5.4). Questo può aiutare, ad esempio, a provare prestiti tra privati: ci si può far rilasciare dichiarazioni giurate da chi ha effettivamente dato/riavuto i soldi, da utilizzare come prova a supporto.
Limiti alla utilizzabilità dei dati bancari: un argomento difensivo spesso tentato era l’eccezione di illegittima acquisizione dei dati (es. contestare che l’autorizzazione interna alle indagini bancarie non fosse allegata all’atto, o che i dati provenissero da indagini penali e quindi non utilizzabili in ambito fiscale). Su questo la Cassazione – con riferimento anche alla novella dell’art. 7 Statuto – ha chiarito che la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie non rende nullo l’atto impositivo, in quanto tale autorizzazione non attiene alla “motivazione” sostanziale dell’atto. L’illegittimità dell’atto sussiste solo se mancava proprio l’autorizzazione a monte (quindi se l’ufficio ha acquisito i dati senza avere il via libera dal direttore competente) e se ciò ha arrecato un concreto pregiudizio al contribuente.
Per quanto concerne invece dati acquisiti da procedimenti penali o da autorità estere con limitazioni d’uso, la Cass. n. 8452/2025 ha affermato un principio netto: in mancanza di una specifica previsione normativa, l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini fiscali non ne comporta l’inutilizzabilità. Solo se l’utilizzo di quei dati ledesse un diritto fondamentale di rango costituzionale sarebbe ipotizzabile escluderli; altrimenti, nel dubbio, il Fisco può usarli. In pratica, le cosiddette prove “illegittimamente acquisite” (ad es. documenti bancari trasmessi oltre i limiti di una rogatoria) possono essere impiegate nell’accertamento tributario, perché nel diritto tributario non vige un generale “frutto dell’albero avvelenato” come nel penale.
Quindi, su questo fronte, la difesa del contribuente è indebolita: non si può sperare di far cadere la pretesa solo perché il Fisco ha ottenuto i dati in modo formalmente non corretto, salvo casi rarissimi (es. palese violazione del diritto alla riservatezza sancito costituzionalmente, ma situazioni limite).
3.5 Altre presunzioni legali in materia fiscale
Oltre alle macro-aree sopra trattate, esistono numerose presunzioni legali specifiche nel sistema tributario italiano. Elenchiamo le principali, perché il contribuente potrebbe doversi difendere anche da queste:
- Presunzione di distribuzione utili occulti nelle società di capitali a ristretta base – Questa è una presunzione giurisprudenziale consolidata: in una società di capitali con pochi soci (es. 2-3 soci), se il Fisco accerta utili extracontabili non dichiarati dalla società, presume che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle quote. Di conseguenza, oltre a tassare la società per i maggiori utili, notifica accertamenti IRPEF ai singoli soci come se avessero percepito dividendi non dichiarati. Si tratta formalmente di una presunzione semplice (non sta in una legge, ma in una massima giurisprudenziale), che però la Cassazione per anni ha trattato come se fosse legale invertendo l’onere della prova a carico del socio (il quale dovrebbe provare di non aver ricevuto nulla – la classica probatio diabolica). Una recente sentenza della Cassazione (n. 26473/2024) ha confermato la validità di tale presunzione, affermando che il socio, per vincerla, deve provare con chiarezza la propria estraneità alla gestione sociale e alla distribuzione degli utili. Nel caso specifico un socio di minoranza sosteneva di non aver mai ricevuto utili occulti; la Corte ha ritenuto insufficienti le sue prove (solo estratti bancari e autodichiarazioni) e ha confermato l’accertamento. Difesa: un socio può difendersi evidenziando di non aver ruolo gestionale (es. socio puramente di capitale), che gli utili extracontabili sono rimasti nell’azienda (reinvestiti o distratti magari dall’amministratore), insomma cercando di rompere l’automatismo. Con la riforma dell’onere probatorio del 2022, in teoria, simili presunzioni “automatiche” dovrebbero essere valutate caso per caso: l’Ufficio dovrà provare concretamente che in quel caso gli utili sono usciti dalle casse sociali verso i soci. Ma trattandosi di presunzione molto radicata, la prudenza impone di raccogliere prove forti (delibere di accantonamento utili, depositi bancari rimasti sul conto societario, ecc.).
- Società “non operative” (o di comodo) – La legge stabilisce parametri in base ai quali una società che dichiara ricavi o redditi molto bassi rispetto al valore delle proprie attività è considerata “non operativa” e viene assoggettata ad un regime presuntivo: il reddito minimo viene determinato applicando percentuali ai beni posseduti (immobili, partecipazioni, crediti) a prescindere dal bilancio. Questa è una presunzione legale relativa: la società può dimostrare di non aver raggiunto quei ricavi per cause oggettive (chiedendo un’interpello disapplicativo preventivo o provando in contenzioso le circostanze). Se non lo fa, verrà tassata su un reddito minimo presunto (e anche l’IVA avrà limiti di detraibilità). Difesa: predisporre accurata documentazione sulle cause che hanno reso non operativa la società (es. immobile invenduto per crollo mercato immobiliare, partecipazione non fruttifera perché l’altra società è in perdita, ecc.). La normativa di riferimento è l’art. 30 della L. 724/1994, più volte modificato.
- Presunzioni IVA su beni non giustificati – Il DPR 10/11/1997 n. 441 contiene presunzioni iuris tantum in materia di IVA: in particolare, l’art. 1 presuppone che i beni acquistati e presenti in magazzino senza fattura siano stati acquistati in evasione IVA (presunzione di acquisto irregolare), mentre l’art. 2 presume che i beni mancanti dal magazzino (che risultavano dalle scritture ma non si trovano) siano stati ceduti senza fattura quindi in evasione IVA. Il contribuente può vincere tali presunzioni dimostrando, ad esempio, che i beni mancanti sono stati distrutti o rubati (con denuncia) o che i beni trovati senza documento in realtà sono di terzi in conto deposito, ecc. Difesa: fondamentale avere inventari attendibili e giustificativi per le differenze inventariali. Se l’azienda è soggetta a furti, deperimenti, etc., documentare questi eventi.
- Redditometro immobiliare (valore normale) – In ambito di registro o imposte immobiliari, si è a lungo applicata la presunzione che se in un atto di compravendita immobiliare il prezzo dichiarato era inferiore al valore normale o catastale, si potesse rettificare il valore. Questa presunzione legale è stata superata dalle nuove regole (prezzo-valore per gli immobili abitativi) e da orientamenti a tutela della libertà contrattuale (Cass. SS.UU. n. 18184/2013 in tema di valore normale). Oggi l’Amministrazione non può più presumere un maggior corrispettivo solo perché l’immobile ha un valore OMI superiore, deve portare altri elementi (es. prove di pagamenti extra).
- Presunzione di reddito per investimenti esteri non dichiarati (quadro RW) – Abbiamo visto con il caso di Cass. 8452/2025: la norma (art. 12 DL 78/2009) prevede che i patrimoni detenuti in paradisi fiscali non dichiarati comportino la presunzione di un reddito imponibile pari al 5% annuo del valore occultato (oltre a sanzioni e raddoppio termini). Questa è una presunzione legale relativa ma molto forte. Il contribuente può evitare la tassazione solo provando che quei capitali erano già tassati o di provenienza lecita e non produttiva di reddito (ad es. mero possesso di contanti non investiti). Difesa: assai complessa, spesso conviene aderire a eventuali procedure di voluntary disclosure. In giudizio, se i documenti sono stati ottenuti via rogatoria, non vale la tesi dell’inutilizzabilità (v. sopra Cass. 8452/2025): occorre piuttosto negoziare sul quantum (il 5% presunto potrebbe essere eccessivo se i fondi non generavano redditi, ma su questo la norma è rigida).
- Presunzione di onerosità dei finanziamenti soci – Se un socio presta denaro alla sua società, per prassi il Fisco presume che tale prestito sia fruttifero (con interessi) salvo prova contraria, così da tassare per trasparenza un interesse figurativo. Non è una vera norma di legge generale, ma in alcuni casi l’Agenzia ha rettificato l’IRPEF del socio calcolando interessi attivi su finanziamenti infruttiferi perché “nessuno presta soldi gratis”. Questa presunzione è però stata spesso respinta dai giudici se mancava una base normativa. Difesa: evidenziare che il finanziamento era infruttifero come da accordi, magari formalizzandolo in scrittura privata.
Come si vede, il panorama è vasto. Ogni presunzione ha la sua controprova specifica da offrire. Un consiglio generale: conoscere la norma di riferimento è cruciale, perché lì spesso è indicato esplicitamente come superare la presunzione (es: “salvo prova contraria che…”) e la giurisprudenza fornisce indicazioni sulle prove ritenute valide nei vari casi.
Onere della prova e ruolo del giudice nel contenzioso tributario
Dopo aver individuato la natura delle presunzioni utilizzate dall’Ufficio, il nodo cruciale diventa come si ripartisce l’onere della prova nel successivo contenzioso e quale sia il ruolo attivo del giudice nel valutare le presunzioni. La materia ha visto un’importante novità normativa con la riforma del processo tributario del 2022 (L. 130/2022), che ha introdotto nel D.Lgs. 546/1992 l’art. 7, comma 5-bis, ridefinendo in parte le regole sul chi deve provare cosa nel processo. Analizziamo la situazione distinguendo presunzioni legali e semplici.
4.1 Presunzioni legali: inversione dell’onere a carico del contribuente
Se l’accertamento fiscale è fondato su una presunzione legale relativa, la regola generale è che il fatto presunto si considera provato per legge, salvo che il contribuente fornisca la prova contraria. In altri termini, l’onere della prova è invertito: l’Amministrazione, grazie alla norma, può limitarsi a dimostrare i fatti-base previsti dalla legge (es. l’esistenza di versamenti non giustificati su un conto) e poi sta al contribuente dimostrare che da quei fatti non discende ciò che la legge presume (es. che quei versamenti non erano reddito ma trasferimenti interni).
Nel processo, dunque, il contribuente assume sostanzialmente il ruolo di “attore” che deve smontare la pretesa fiscale. Il giudice tributario, dal canto suo, deve verificare se il contribuente ha assolto a questo onere e, in mancanza, dare per valida la presunzione.
Un esempio classico è dato dalle indagini bancarie: il giudice verificherà se il contribuente ha fornito per ciascun movimento bancario contestato una giustificazione idonea e documentata. Se ci sono movimentazioni rimaste senza spiegazione o con spiegazione ritenuta non credibile, la presunzione prevarrà e quelle somme saranno considerate ricavi non dichiarati. Analogamente, per la presunzione di utili ai soci: il giudice verificherà se il socio è riuscito a dimostrare la sua non partecipazione agli utili occulti; in caso contrario, darà per buona la presunzione di distribuzione.
Va sottolineato che anche in presenza di presunzione legale, il giudice tributario deve comunque esercitare un controllo: ad esempio, se la legge presume redditi da movimenti bancari “non giustificati”, il giudice deve accertare prima se quei movimenti siano effettivamente privi di giustificazione oppure se il contribuente ne abbia fornita una. Non può semplicemente accogliere l’atto fiscale senza valutare le prove contrarie offerte. Un errore del giudice di merito, spesso censurato in Cassazione, è dichiarare che “il contribuente non ha fornito prova contraria” in modo apodittico, senza analizzare voce per voce. La Cassazione insiste su una verifica rigorosa e puntuale dell’efficacia dimostrativa delle prove contrarie fornite dal contribuente, “dandone conto in motivazione”. Se il giudice di merito non fa questo (motivazione carente), la sentenza è viziata.
In sintesi: con presunzioni legali, il contribuente è “in salita” e deve provare attivamente il proprio assunto; il giudice funge da arbitro che vede se quella prova è convincente abbastanza da superare la presunzione. Se sì, la pretesa cade; se no, la pretesa viene confermata.
4.2 Presunzioni semplici: obbligo per il Fisco di provare gravità, precisione e concordanza
Discorso diverso per le presunzioni semplici (non supportate da specifica norma). Qui l’onere iniziale della prova resta sull’ente impositore: è il Fisco che, in giudizio, deve dimostrare la fondatezza degli elementi presuntivi addotti, in particolare provarne i caratteri di gravità, precisione e concordanza. In pratica l’Amministrazione finanziaria deve convincere il giudice che, dati quei fatti noti, è logico e altamente probabile desumere il fatto ignoto (maggior reddito) così come prospettato nell’atto.
Questo principio è stato codificato proprio dalla nuova norma del 2022: l’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92 afferma che “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova emersi…”.. Ciò ha valenza generale, ma un impatto particolare nelle cause basate su presunzioni semplici: finalmente viene chiarito che non basta all’ufficio richiamare l’accertamento e dire “è il contribuente che deve giustificarsi”. Se l’atto è fondato essenzialmente su presunzioni semplici, “spetta sempre all’Amministrazione finanziaria dimostrare nel processo che le circostanze di fatto allegate provano puntualmente la pretesa”. Dunque l’onere probatorio dell’ente non si esaurisce con l’emissione dell’atto, ma prosegue in giudizio: il Fisco deve portare documenti, testimoni (se del caso), argomentazioni per corroborare gli indizi raccolti. Il giudice, da parte sua, è tenuto a verificare accuratamente la sussistenza dei requisiti di legge per quelle presunzioni. Se ritiene che la prova fornita dall’ente sia mancante, contraddittoria o insufficiente, deve annullare l’atto.
Ad esempio, se l’accertamento si basa su studi di settore (presunzione semplice), in giudizio l’Ufficio dovrà dimostrare che la divergenza tra i ricavi dichiarati e quelli presunti dallo studio è significativa e non spiegabile con le peculiarità dell’azienda, magari producendo il verbale di contraddittorio col contribuente dove non sono emerse giustificazioni accettabili, ecc. Se semplicemente si limitasse a dire “lo studio di settore dice così, il contribuente non ha provato il contrario”, rischierebbe la soccombenza perché ha invertito indebitamente l’onere. Infatti, la giurisprudenza post-riforma evidenzia: “le presunzioni semplici sono strumenti per l’assolvimento dell’onere della prova da parte del Fisco, non esoneri da tale onere”.
Solo dopo che l’Amministrazione abbia fatto ciò, qualora il giudice ritenga dimostrata la validità della presunzione (indizi gravi, precisi, concordanti), allora entra in gioco il contribuente con le sue controprove. Ma attenzione: qualora l’Ufficio fallisca nel fornire una prova presuntiva convincente, non si arriva nemmeno a quel punto – l’atto va annullato direttamente. Questo è un sensibile rafforzamento delle garanzie del contribuente rispetto al passato, perché in precedenza spesso i giudici (e la stessa Cassazione, a dire il vero) tendevano a dire: “c’è uno scostamento dallo studio di settore, tocca al contribuente giustificarlo”. Ora la tendenza si inverte: tocca all’Ufficio provare che lo scostamento è indice di evasione, solo se ci riesce toccherà al contribuente replicare.
4.3 La riforma del processo tributario 2022 e il nuovo art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992
È opportuno approfondire gli effetti della L. 130/2022 sulla materia probatoria. Questa legge, in vigore dal 16.9.2022, ha introdotto il comma 5-bis all’art. 7 del D.Lgs. 546/92 (Codice del processo tributario) con l’obiettivo di chiarire e uniformare i criteri sull’onere della prova. La formulazione (in sintesi) è: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova emersi nel contraddittorio tra le parti. Restano ferme le disposizioni di legge che pongono a carico del contribuente specifici oneri probatori”.
Questa norma ha portata innovativa ma anche dei limiti:
- Conferma esplicitamente che è il Fisco a dover provare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa tributaria (il che è in linea col principio generale dell’art. 2697 c.c.).
- Specifica che il giudice deve decidere in base alle prove emerse nel processo, quindi non può più dare per scontato nulla: deve valutare attivamente le prove offerte da entrambe le parti e, se quelle del Fisco sono mancanti o contraddittorie, deve annullare l’atto. Quindi introdurre il 5-bis equivale a dettare una regola di giudizio: in caso di incertezza o lacuna probatoria a carico di chi doveva provare (Amministrazione), la decisione va a favore del contribuente (annullamento dell’atto). Questo concetto prima non era scritto in alcuna norma, ora c’è.
- Tuttavia, la stessa norma 5-bis fa salvo quanto diversamente previsto da leggi sostanziali (“restano ferme le disposizioni di legge che…”). Ciò significa che non tutte le presunzioni legali vengono intaccate. In particolare, le presunzioni legali relative restano efficaci nel porre sul contribuente l’onere della prova contraria. Infatti, la relazione illustrativa alla legge di riforma chiariva che l’intento non era di alterare le presunzioni legali esistenti, ma solo di ribadire i principi generali. Lo stesso comma 5-bis è stato letto dalla Cassazione (ord. 2667/2025) come “norma di natura processuale nell’individuare una regola di giudizio, ma non deroga ai criteri generali di riparto dell’onere probatorio ove già stabiliti dal legislatore sostanziale”. Tradotto: se c’è una presunzione legale che sposta l’onere sul contribuente, continua a farlo; il giudice però dovrà comunque verificare se il contribuente quell’onere l’ha assolto oppure no.
- Un altro aspetto è la tempistica di applicazione: la Cassazione (ord. 2667/2025 cit.) ha affermato che la nuova norma sull’onere probatorio ha natura sostanziale nella parte in cui innovativamente onera l’ente della prova delle contestazioni di costi ed elementi passivi, dunque non si applica retroattivamente ai giudizi in corso se l’atto è antecedente (principio di irretroattività delle norme sostanziali). In concreto, ci sarà un periodo di transizione in cui gli atti pre-riforma potrebbero essere giudicati con i vecchi criteri. Ma per gli accertamenti notificati dal 2023 in avanti, il 5-bis vale a pieno.
In sintesi, oggi abbiamo un quadro più definito:
- Accertamenti basati su presunzioni semplici: l’Ufficio deve fornire in giudizio prova puntuale dei fatti e della logicità della presunzione; se non ci riesce, il giudice annulla. (Esempi: studi di settore, redditometro, presunzione di utili ai soci – quest’ultima, come visto, in fase di ripensamento proprio grazie al 5-bis).
- Accertamenti basati su presunzioni legali: resta a carico del contribuente la prova contraria (esempi: movimenti bancari, presunzione cessioni IVA, etc.), ma il giudice deve scrupolosamente valutare ogni prova offerta dal contribuente su ciascun elemento.
Per completare il quadro, va ricordato che il giudice tributario ha un potere di valutazione libera delle prove (principio del libero convincimento). Nell’ambito delle presunzioni semplici, ciò significa che non c’è un numero prefissato di indizi necessario: conta la qualità. Un solo indizio molto forte può bastare (Cass. n. 27071/2016: “anche un solo elemento, se dotato dei caratteri di gravità e precisione, può sorreggere la presunzione”), mentre tanti piccoli indizi contraddittori non convinceranno. Il giudice può anche utilizzare presunzioni di secondo grado (le cosiddette presunzioni di presunzioni) solo se la prima è legale; se sono entrambe semplici, non può dedurre un fatto ignoto da un altro fatto ignoto. Ma come abbiamo visto, questo è più teoria che pratica, perché quasi sempre c’è almeno un fatto certo di partenza.
Concludendo questa sezione, la chiave per il contribuente è: obbligare l’Amministrazione a fare il proprio dovere probatorio (non lasciarsi intimidire dalla presunzione) e parallelamente non sprecare l’opportunità di presentare tutte le prove contrarie possibili, visto che ora il giudice deve prenderle in considerazione nel merito. La riforma del 2022 mira a un processo tributario più equo, in cui vince chi porta i migliori argomenti e prove, non chi semplicemente si rifugia dietro automatismi presuntivi.
Come difendersi: strategie e strumenti di tutela del contribuente
Affrontare un accertamento fondato su presunzioni richiede un mix di conoscenza tecnica (norme e sentenze rilevanti) e di capacità strategica nel far valere i propri diritti sia in sede amministrativa che giudiziale. In questa parte della guida esaminiamo le principali strategie difensive e gli strumenti di tutela di cui dispone il contribuente, passo dopo passo dall’arrivo dell’avviso di accertamento alla (eventuale) causa tributaria.
5.1 Fase pre-contenziosa: difesa durante la verifica e l’accertamento
La difesa del contribuente inizia prima che l’accertamento diventi definitivo: molte possibilità si giocano già nella fase di verifica o di interlocuzione con l’ufficio, prima della notifica formale dell’avviso.
- Collaborare durante la verifica fiscale: se la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate effettuano un controllo (accesso, ispezione o verifica), il contribuente ha interesse a fornire spiegazioni e documenti agli organi accertatori. Ad esempio, se in sede di verifica emergono movimenti bancari anomali, è utile spiegare subito la loro natura, magari facendoli inserire nel processo verbale di constatazione (PVC). Le osservazioni messe a verbale dal contribuente possono indurre l’ufficio a ridimensionare o archiviare la pretesa. Inoltre, dopo la chiusura delle operazioni di verifica in loco, il contribuente (per Statuto del Contribuente, art. 12 c.7 L. 212/2000) ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste prima che l’ufficio emetta l’atto: è importantissimo sfruttare questo termine per inviare una memoria difensiva con tutte le prove e argomenti a proprio favore. L’ufficio è tenuto a valutarla.
- Contraddittorio endoprocedimentale: in alcune tipologie di accertamento il contraddittorio preventivo è obbligatorio. Abbiamo visto il caso del redditometro (art. 38 DPR 600) e degli studi di settore/ISA: in queste ipotesi l’ufficio deve convocare il contribuente, illustrargli le risultanze e ascoltare le sue giustificazioni. Se ciò non avviene, l’accertamento è annullabile. Pertanto, il contribuente deve: 1) presentarsi a tale convocazione con tutta la documentazione utile e magari assistito dal proprio professionista; 2) dopo la discussione, consegnare una memoria scritta che riepiloghi le proprie difese (così rimane traccia formale). Se l’ufficio ignora totalmente le argomentazioni fornite, ciò potrà essere eccepito poi in ricorso per difetto di motivazione. Se invece il contraddittorio non viene proprio attivato dove doveva, l’atto è viziato ab origine.
- Rispondere ai questionari/inviti: spesso l’Agenzia invia al contribuente questionari (ex art. 32 DPR 600) chiedendo chiarimenti o documenti su determinate operazioni. Anche se non c’è ancora un’accertamento formalizzato, non ignorare questi inviti! Il contribuente deve rispondere entro 60 giorni presentando i dati richiesti. La mancata risposta, oltre a esporre a sanzione, fa scattare una disposizione che preclude al contribuente di poi produrre in giudizio i documenti non esibiti prima (art. 32 ultimo comma). Quindi, se arrivano richieste di esibire, ad esempio, i contratti relativi a operazioni bancarie, bisogna fornirli subito: non poterli più usare in contenzioso sarebbe un autogol fatale. Inoltre, rispondere può convincere l’ufficio a non procedere con l’accertamento se le spiegazioni sono soddisfacenti.
- Istanza di autotutela: prima che scadano i termini per il ricorso, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’ufficio, evidenziando gli errori o elementi nuovi emersi e chiedendo l’annullamento (totale o parziale) dell’atto. L’autotutela è discrezionale per l’Amministrazione (non obbligatoria), ma vale la pena tentare soprattutto se ci sono evidenti errori di fatto (es. il Fisco ha conteggiato due volte la stessa somma, oppure ha applicato una presunzione fuori dai casi di legge, ecc.). Talvolta, in presenza di fumus di fondatezza del ricorso, l’ufficio preferisce annullare in autotutela piuttosto che perdere in giudizio. Va però chiarito che l’autotutela non sospende i termini di ricorso: va fatta tempestivamente e comunque si consiglia di predisporre il ricorso parallelo per sicurezza, qualora l’ufficio tardi a rispondere.
In generale, in questa fase il contribuente deve costruire il più possibile un “fascicolo difensivo”: raccogliere documenti, testimonianze (es. dichiarazioni scritte di soggetti terzi, che poi potranno essere formalizzate in testimonianze nel processo), perizie tecniche se necessario, normativa e prassi a supporto. Tutto questo materiale servirà sia per convincere l’ufficio (in adesione o autotutela) sia, se inevitabile, in giudizio.
Un accenno sul contraddittorio “generalizzato”: la questione se l’Amministrazione abbia l’obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente in ogni caso prima di emettere un accertamento (quindi anche oltre i casi specifici) è dibattuta. La Cassazione fino al 2023 ha oscillato: alcune pronunce (es. Cass. n. 701/2020, n. 21800/2020) negavano un obbligo generalizzato per i tributi non armonizzati (Irpef, Ires), mentre per l’IVA – tributo armonizzato UE – la Corte di Giustizia UE lo richiede solo se dall’assenza di contraddittorio può derivare pregiudizio al diritto di difesa. Nel 2023 però vi sono segnali di apertura: Cass. n. 16574/2023 ha affermato un principio favorevole al contribuente, sostenendo che l’Amministrazione dovrebbe sempre attivare il contraddittorio se dall’atto possono emergere nuovi elementi su cui il contribuente non si è mai espresso. In attesa di un consolidamento, il consiglio pratico è: chiedere sempre un confronto all’ufficio se si ritiene di avere spiegazioni risolutive, anche quando la legge non lo prevede espressamente. Farlo per iscritto (ad es. “Istanza di audizione ex art. 5 L. 212/2000” o similari). Se l’ufficio rifiuta e poi emette un atto debole, si potrà lamentare che, avendo negato il confronto, ha agito in violazione dei principi di collaborazione e buona fede (artt. 5 e 10 Statuto). Non è una nullità automatica, ma può influenzare il giudizio di merito.
5.2 Accertamento con adesione e altri istituti deflativi
Quando l’avviso di accertamento è stato notificato (o sta per esserlo, se preannunciato con invito), il contribuente può valutare l’opportunità di ricorrere a strumenti deflativi del contenzioso, cioè soluzioni che evitano la causa trovando un accordo col Fisco o beneficiando di riduzioni sanzionatorie. I principali sono:
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): è una procedura che consente al contribuente, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto (o anche prima su invito dell’ufficio), di presentare istanza di adesione e avviare un dialogo negoziale con l’Agenzia delle Entrate. Si tiene uno o più incontri dove il contribuente espone le proprie ragioni e l’ufficio può rivedere la pretesa. Se si trova un accordo, viene formalizzato un atto di adesione con la nuova imposta concordata e sanzioni ridotte a 1/3 del minimo. Questo strumento è utilissimo quando l’accertamento ha aspetti controversi: ad esempio, in caso di presunzioni, il contribuente può convincere l’ufficio a riconoscere alcune sue prove contrarie, riducendo così la base imponibile presunta. L’adesione evita il rischio e il costo del giudizio, ma implica il pagamento di quanto concordato (di solito in rate). Da notare che presentare l’istanza di adesione sospende il termine per fare ricorso per 90 giorni, dando più tempo per trattare.
- Acquiescenza agevolata: se il contribuente ritiene di non avere margini di difesa (magari perché la presunzione è difficilmente confutabile o i costi del contenzioso superano i benefici), può scegliere di prestare acquiescenza all’atto, cioè pagarlo senza litigare, beneficiando però della riduzione delle sanzioni ad 1/3 (sempre il D.Lgs. 218/97). L’acquiescenza va formalizzata entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento e richiede il pagamento (o prima rata) di imposta + interessi + sanzioni ridotte. Una volta fatto, l’atto non è più impugnabile. Questa scelta è da fare solo dopo aver valutato bene la situazione con un consulente: conviene in caso di accertamenti fondati su presunzioni ma in cui il contribuente non ha elementi concreti per contestare. Attenzione: l’adesione è preferibile all’acquiescenza quando c’è margine, perché nell’adesione spesso il Fisco accetta di limare la base imponibile, mentre l’acquiescenza si applica sul dovuto integralmente.
- Mediazione/reclamo tributario: fino al 2023 era previsto che per gli atti di valore fino a €50.000 si dovesse presentare un reclamo-mediazione prima di procedere in giudizio, cercando un accordo con l’ufficio. Tuttavia, da gennaio 2024 la mediazione tributaria obbligatoria è stata abrogata per i nuovi ricorsi. Ciò significa che oggi il contribuente può adire direttamente la giustizia tributaria senza questo passaggio intermedio. Rimane però la conciliazione giudiziale, di cui diremo dopo, che è una sorta di mediazione ma in corso di causa.
- Ravvedimento operoso: non è applicabile dopo la notifica di accertamento (va fatto prima). Lo citiamo solo per dire che, se il contribuente, in sede di contraddittorio anticipa un’adesione ammettendo per esempio dei ricavi non dichiarati, potrebbe ravvedersi su quelli prima della formalizzazione dell’atto per avere sanzioni ancora più ridotte. Ma è scenario raro in materia di presunzioni (di solito il contribuente non “confessa” anticipatamente, tenta invece di difendersi).
In conclusione, l’accertamento con adesione è la principale opzione deflativa per chi è oggetto di accertamento presuntivo. E va considerata seriamente perché spesso consente soluzioni di compromesso ragionevoli: ad esempio, in un accertamento bancario, l’ufficio potrebbe accettare alcune giustificazioni su base equitativa (senza ammetterlo in giudizio) e ridurre l’imponibile contestato del, poniamo, 30%, più sanzioni al minimo, chiudendo la vicenda. Ciò che invece in giudizio potrebbe essere incerto (alcuni giudici magari rigetterebbero tutte le giustificazioni, altri ne accoglierebbero alcune), in sede di adesione può diventare oggetto di trattativa pragmatica.
5.3 Il ricorso in Commissione/Tribunale tributario: tempi e modalità
Se non si è giunti a un accordo o se lo si ritiene ingiustificato, il contribuente deve passare al contenzioso tributario. Dal 2023, per effetto della riforma, le Commissioni Tributarie sono state ribattezzate Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (ma la sostanza del processo rimane simile). Ecco gli aspetti pratici principali:
- Termine per impugnare: 60 giorni dalla notifica dell’atto (accertamento). Attenzione: se si è presentata istanza di adesione, il termine è sospeso per 90 giorni e riprende poi a decorrere per la parte rimanente se l’adesione non si conclude. In caso di rigetto espresso dell’istanza di adesione prima dei 90 giorni, i 60 giorni ripartono dalla data del rigetto.
- Forma del ricorso: va redatto un atto scritto, contenente i motivi (argomentazioni giuridiche e di fatto) per cui si chiede l’annullamento/riforma dell’atto impugnato. Nel caso di accertamento presuntivo, i motivi di ricorso tipici saranno: violazione di legge (se l’ufficio ha male applicato le norme sulle presunzioni, es. applicando presunzione in difetto dei requisiti); eccesso di potere o difetto di motivazione (se la motivazione dell’atto è generica o non considera le prove contrarie presentate); infondato accertamento nel merito (contestazione analitica delle ricostruzioni presuntive e presentazione di controprove). È importante citare nelle motivazioni sia le norme (es. art. 39 DPR 600/73, art. 2729 c.c., Statuto contrib.) sia eventuale giurisprudenza di legittimità favorevole (sentenze di Cassazione) per sostenere le proprie tesi.
- Notifica del ricorso: oggi il processo tributario è telematico, quindi il ricorso si notifica via PEC all’ufficio che ha emesso l’atto (es. Direzione Provinciale delle Entrate) entro i 60 giorni. Poi, entro 30 giorni dalla notifica, va depositato (telematicamente) presso la segreteria della Corte Tributaria.
- Sospensione dell’atto: se l’accertamento comporta un importo da pagare e il contribuente ritiene vi sia un danno grave e irreparabile nell’eseguire (es. importo elevato che metterebbe in crisi l’azienda), può presentare un’istanza di sospensione al giudice, motivandola. Il giudice la valuta in tempi rapidi e, se accolta, l’esecuzione (es. iscrizione a ruolo delle somme) viene sospesa fino alla sentenza di primo grado. Nel caso di accertamenti presuntivi, se le ragioni del contribuente appaiono solide (ad esempio un evidente errore dell’ufficio nel calcolo presuntivo), la sospensione viene concessa; se invece è più incerto, si tende a chiedere al contribuente magari di pagare in parte (talvolta il giudice può sospendere parzialmente).
- Valore della controversia e spese: il valore è dato dall’imposta contestata (al netto di interessi e sanzioni). Se inferiore a €3.000, oggi il giudizio monocratico (giudice singolo) di primo grado prevede regole semplificate. Sopra, giudice collegiale. Le spese legali in primo grado sono di norma contenute (e se si vince, di solito il Fisco viene condannato a rifonderle, salvo compensazione in caso di soccombenza reciproca).
Da evidenziare: dal 2023 non c’è più l’obbligo di mediazione come detto, quindi il ricorso produce subito effetti senza attendere 90 giorni (eccetto sospensioni per adesione). Ciò snellisce il processo.
5.4 La difesa nel processo tributario: prove, testimonianze e tecniche difensive
In sede processuale, il contribuente deve mettere in atto una difesa strutturata. Ecco i punti chiave:
- Produzione documentale: bisogna depositare tutti i documenti utili a sostenere i motivi di ricorso. Ad esempio: estratti conto, contratti, perizie, corrispondenza commerciale, sentenze di Cassazione rilevanti (possono essere allegate per farle notare al giudice), normative, circolari dell’Agenzia se favorevoli (non vincolanti per il giudice ma persuasive). Importante: i documenti da cui si vuole far emergere fatti a favore vanno prodotti subito in primo grado. In appello la produzione di nuovi documenti è limitata (solo se non era possibile prima). Quindi non serbare “carte vincenti” per dopo: giocarle subito.
- Testimonianza scritta: la riforma 2022 ha introdotto la possibilità di chiedere al giudice tributario di ammettere una testimonianza per iscritto (art. 7 c.4-bis D.Lgs. 546/92). Non è libera come nel processo civile: serve che entrambe le parti siano d’accordo, oppure che il giudice la ritenga assolutamente necessaria e la ammetta d’ufficio. Se ammessa, il giudice formula i quesiti e il testimone risponde per iscritto con dichiarazione autenticata. Come sfruttarla? Nel nostro contesto, può essere utile per confermare ad es. la provenienza di somme: far testimoniare un soggetto che ha prestato soldi al contribuente, o un cliente che confermi di aver pagato un importo incluso in un versamento contestato, ecc. Bisogna chiedere l’ammissione nell’atto di ricorso o nella prima difesa. Data la novità, molti giudici sono prudenti nell’ammettere testi, ma provarci può fare la differenza in casi fondati su ricostruzioni presuntive.
- Consulenza tecnica di parte (CTP): non c’è CTU d’ufficio nel tributario di solito, ma le parti possono allegare consulenze tecniche di parte, ad es. una perizia contabile o econometrica che dimostri che il redditometro è sballato oppure che i calcoli dell’ufficio su percentuali di ricarico non tengono conto di X e Y. Un giudice potrebbe tenerne conto se ben fatta e non confutata dall’ufficio.
- Discussione in udienza: se il ricorso non è deciso solo sulle carte, c’è un’udienza pubblica in cui esporre oralmente le ragioni. È un momento cruciale per “fare sintesi” e sottolineare al giudice gli aspetti favorevoli. Nel caso di presunzioni complesse, vale la pena predisporre magari uno schema riassuntivo (anche grafico, tabelle) da illustrare. Ad esempio, per un caso bancario con decine di movimenti, portare una tabella che mostra come tutti i versamenti contestati sono spiegati, tranne magari uno residuo: farlo vedere chiaramente può convincere il giudice che la gran parte della pretesa è infondata.
- Attenzione ai formalismi: se ci sono vizi formali o di notifica dell’atto, vanno dedotti come motivi di ricorso, ma è bene non puntare tutto solo su quelli. Spesso la Commissione, se può, preferisce decidere nel merito (specialmente oggi che i giudici tributari sono professionalizzati). Meglio presentare anche le ragioni di merito, per sicurezza.
- Uso della giurisprudenza: citare precedenti di Cassazione è sempre utile. Ad esempio: “Cassazione sent. n. XXX/20.. ha stabilito che un unico elemento può sorreggere la presunzione solo se dotato di massima gravità, il che non ricorre nel caso di specie”, oppure “Cass. n. YYYY/20..: la mancata attivazione del contraddittorio in accertamenti fondati su presunzioni semplici comporta la nullità dell’atto”. I giudici tributari spesso apprezzano il riferimento a orientamenti consolidati, oppure, se c’è contrasto, scegliere la linea più favorevole e argomentare perché è preferibile (diritti del contribuente, ecc.).
- Chiamare in causa i terzi? Nel processo tributario non esiste una vera chiamata di terzo come nel civile; però se un terzo ha interesse (es. una società nei ricorsi dei soci per utili presunti), va valutato se fare ricorso separato e chiederne la riunione, oppure segnalare al giudice l’esistenza dell’altro giudizio. In genere, cause strettamente connesse (società e soci) vengono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo stesso collegio.
- Conciliazione giudiziale: durante il processo, fino all’udienza, è possibile pervenire a conciliazione (totale o parziale) con l’ente, con riduzione delle sanzioni (1/3). Dopo la riforma 2022, la conciliazione può essere proposta anche dal giudice stesso (conciliazione “guidata”). Può essere saggia se, alla luce di quanto emerso, si intravede un accordo vantaggioso. Anche in appello è possibile la conciliazione, con sanzioni ridotte a 1/2.
In generale, la difesa nel processo deve mantenere il focus: dimostrare che la presunzione del Fisco non regge. Questo si fa evidenziando: a) errori procedurali (che minano la legittimità dell’atto); b) carenze logiche o probatorie negli indizi dell’ufficio (che minano la gravità/precisione); c) presenza di prove contrarie forti (che spezzano la concordanza degli indizi o ribaltano la presunzione). Se questi tre aspetti vengono trasmessi efficacemente al giudice, le chance di vittoria sono alte.
5.5 Pronunce giurisprudenziali favorevoli al contribuente: come utilizzarle
La giurisprudenza – in particolare della Corte di Cassazione e, talvolta, delle Corti di merito – gioca un ruolo importante nel delineare i limiti delle presunzioni fiscali. Il contribuente può e deve fare leva sulle sentenze più recenti e rilevanti a proprio favore, sia per persuadere l’ufficio in sede di adesione sia soprattutto in giudizio. Ecco alcune pronunce chiave aggiornate al 2025 e come possono essere invocate:
- Cass. n. 18596/2024 – Tema: accertamenti bancari, onere di prova. Principio: conferma che la presunzione ex art. 32 è legale e che il contribuente deve provare analiticamente l’estraneità di ogni movimento, con obbligo del giudice di verificare ogni prova. Come usarla: se si è fornita prova per gran parte dei movimenti, citare questa sentenza per dire che il giudice di merito deve darne conto e se ciò non avviene è errore. Utile per chiedere attenzione analitica del giudice su ogni giustificazione.
- Cass. n. 26473/2024 – Tema: utili extracontabili ai soci (società a ristretta base). Principio: ribadita la presunzione di distribuzione ai soci; onere al socio di provare di non aver partecipato. Come usarla: se si difende un socio, conoscerne il contenuto è utile per distinguerla: ossia evidenziare cosa mancava in quel caso (magari il socio non aveva prove forti). Oppure, se si è l’ufficio, la si userà contro. Dal lato contribuente, sottolineare però che la riforma 2022 impone comunque la prova concreta caso per caso e citare dottrina (come l’articolo di Rivista Dir. Trib. 2025) che dice che l’automatismo è in crisi.
- Cass. n. 5529/2025 – Tema: doppia presunzione. Principio: ha escluso che il cosiddetto divieto di doppia presunzione impedisca di usare dati presuntivi su presunzioni legali, distinguendo tra presunzioni semplici concatenate e presunzioni legali. Come usarla: se l’ufficio ha fatto inferenze a catena, il contribuente potrebbe tentare di invocare il divieto di doppia presunzione; questa sentenza però ridimensiona la portata del divieto. Dal lato contribuente, meglio evitare di basare la difesa su cavilli teorici come la doppia presunzione, e puntare su altro. Dal lato ufficio, la si cita per dire “legittimo il ragionamento induttivo su dati bancari per risalire anche all’IVA evasa, non è doppia presunzione ma conseguenza logica”.
- Cass. n. 8452/2025 – Tema: utilizzabilità prove irrituali. Principio: elementi acquisiti irritualmente (ad es. da indagini penali o estere con limiti d’uso) sono utilizzabili in assenza di divieti espressi, salvo incidano su diritti fondamentali. Come usarla: lato contribuente, purtroppo sfavorevole, quindi se si voleva escludere prove acquisite impropriamente, questa sentenza va contro. Lato ufficio, è un assist: si cita per dire “anche se i documenti vengono da una perquisizione penale poi archiviata, li possiamo usare”. Il contribuente potrà replicare solo se davvero c’è in gioco un diritto forte (es. intercettazione illegale? Molto raro in ambito fiscale).
- Cass. n. 14885/2018; Cass. n. 757/2020 – Tema: accertamento analitico-induttivo vs. lievi irregolarità. Principio: se le irregolarità contabili non incidono gravemente sull’attendibilità globale, l’accertamento induttivo non è legittimo. Come usarla: se la contabilità ha pochi errori, citare queste a supporto dell’idea che l’ufficio non poteva buttare tutto alle ortiche.
- Cass. SS.UU. n. 18184/2013 – Tema: contraddittorio in tributi non armonizzati (studi settore) e nullità. Principio: ha sancito che la violazione dell’obbligo di contraddittorio previsto da legge interna comporta nullità dell’atto. Come usarla: se l’ufficio non ha fatto il contraddittorio in redditometro o studi di settore, è la base su cui chiedere nullità.
Nella seguente tabella, riepiloghiamo alcune sentenze recenti rilevanti e il principio affermato, utili come riferimento rapido:
| Sentenza (Corte Cass.) | Argomento | Principio di diritto |
|---|---|---|
| Cass. n. 18596/2024 | Indagini finanziarie – Presunzione art. 32 DPR 600/73 | Movimenti bancari non giustificati = redditi occulti (presunzione legale): il contribuente deve provare analiticamente per ciascun movimento l’estraneità a fatti imponibili; il giudice deve valutare con rigore ogni prova contraria offerta. |
| Cass. n. 26473/2024 | Utili extracontabili – Società a ristretta base | Valida la presunzione (giurisprudenziale) che gli utili non contabilizzati di società a pochi soci siano stati distribuiti ai soci: spetta al socio dimostrare con prove rigorose di non aver partecipato alla distribuzione (es. estraneità alla gestione). |
| Cass. n. 8452/2025 | Prove acquisite irritualmente | Nel processo tributario non esiste un generale principio di inutilizzabilità delle prove raccolte irritualmente (es. in violazione di norme procedurali), salvo incida su diritti fondamentali. Un documento ottenuto in modo irrituale è utilizzabile se nessuna legge ne vieta espressamente l’uso ai fini fiscali. |
| Cass. n. 5529/2025 | Doppia presunzione | Il “divieto di doppia presunzione” (presunzione basata su altra presunzione) si riferisce solo a concatenazioni di presunzioni semplici; non impedisce al Fisco di trarre conseguenze da una presunzione legale. Dunque le risultanze delle presunzioni legali (es. dati bancari) possono essere impiegate per ulteriori accertamenti senza violare tale divieto^. |
| Cass. n. 16574/2023 | Contraddittorio anticipato | Tende a riconoscere un obbligo generale di attivare il contraddittorio endoprocedimentale ogniqualvolta l’Ufficio intenda emettere un accertamento fondato su elementi rispetto ai quali il contribuente non sia stato sentito (anche per tributi non armonizzati). (Sentenza innovativa, da verificare consolidamento). |
| Cass. n. 20897/2019 | Ragionevolezza accertamento induttivo | Anche nell’accertamento induttivo puro, l’Amministrazione deve rispettare un criterio di ragionevolezza: ricostruzioni del reddito palesemente sproporzionate o illogiche sono illegittime. (In causa: annullato accertamento con reddito impossibile rispetto ai dati di mercato). |
| Cass. SS.UU. 228/2014 | Presunzione su prelevamenti privati | (Massima delle Sezioni Unite) La presunzione sui prelevamenti non giustificati si applica solo ai titolari di reddito d’impresa (oggi anche professionisti), non ai privati consumatori: per questi ultimi un prelievo bancario non giustificato non può presumersi spesa produttiva di reddito. (Norma adeguata dal DL 193/2016). |
^ Nota: la massima di Cass. 5529/2025 è stata ricostruita dal contenuto disponibile, essendo un’ordinanza non integralmente pubblicata. In generale, va intesa nel senso di ridimensionare l’eccezione della “doppia presunzione” quando l’Amministrazione muove da una presunzione legale.
Come si vede, alcune sentenze rafforzano le posizioni del Fisco, altre tutelano di più i contribuenti. Nella difesa di un caso concreto, sarà fondamentale individuare e citare quelle più pertinenti al proprio scenario. Ad esempio, per un accertamento bancario citeremo la 18596/2024 (sul rigore richiesto al giudice nel valutare le prove contrarie); per uno studio di settore insisteremo sul 5-bis art.7 D.Lgs.546 (onere in capo al Fisco) e su sentenze tipo Cass. 9765/2014 che dicevano che lo scostamento da studi di settore di per sé non basta se contribuente prova cause specifiche; per un caso di utili soci, evidenzieremo eventuali pronunce di merito recenti che con la nuova legge abbiano magari dato torto al Fisco, e così via.
In ogni modo, far vedere al giudice tributario che la nostra tesi è supportata da autorevoli precedenti aumenta la credibilità. E se pure la controparte (Agenzia) porterà sue sentenze, noi possiamo distinguere i casi di specie, spiegare perché il nostro caso è diverso o perché la giurisprudenza si è evoluta. Ad esempio, l’ufficio porta Cass. 26473/2024 (socio perde); noi ribattiamo che dopo quell’episodio è uscito un articolo su Rivista dir. trib. che evidenzia come con il nuovo art.7 comma 5-bis quelle presunzioni automatiche vadano riesaminate caso per caso.
L’aggiornamento giurisprudenziale al 2025 mostra un trend di maggiore equilibrio: il legislatore e i giudici stanno dando segnali che il contribuente non è più “colpevole fino a prova contraria” in ogni caso, ma che il Fisco deve fare la sua parte. Questo va sfruttato nel modo giusto.
Esempi pratici di accertamenti presuntivi e relative difese
Di seguito presentiamo alcuni casi pratici simulati che illustrano situazioni tipiche di accertamenti basati su presunzioni, con le possibili strategie difensive del contribuente.
Caso 1: Accertamento bancario basato su movimenti non giustificati
Scenario: Il sig. Rossi, imprenditore edile, riceve un avviso di accertamento per l’anno 2022 in cui l’Agenzia delle Entrate contesta ricavi non dichiarati per €200.000. La base dell’accertamento sono le indagini finanziarie: sui conti correnti aziendali e personali di Rossi sono stati trovati, nell’anno, versamenti in contanti e assegni per circa €150.000 non giustificati e prelevamenti per €100.000 ritenuti anomali rispetto alle spese dichiarate. L’Ufficio applica la presunzione legale (art. 32) considerando quei €250.000 complessivi come ricavi occulti. Dedotti alcuni costi forfettari, tassa €200.000 come maggior reddito d’impresa.
Difesa: Rossi, assistito dal suo avvocato tributarista, prepara innanzitutto un prospetto analitico di tutti i movimenti contestati (magari allegato già alla richiesta di adesione):
- Versamenti contanti per €20.000 il 10/03/2022: spiegazione: erano incassi di lavori di ristrutturazione già fatturati e contabilizzati regolarmente (Rossi dimostra che proprio il 9/3 aveva emesso fatture per €22.000 incassate in contanti – allega copie fatture e registro corrispettivi). -> Prova contraria: il denaro era già tassato (incasso di operazioni dichiarate).
- Versamento assegno €50.000 il 20/05/2022: spiegazione: trattasi di assegno circolare ricevuto dalla vendita della seconda casa di Rossi (che era in comunione con la moglie). Rossi allega il rogito di vendita dell’immobile datato 15/05/2022, in cui è previsto che €50.000 vengano pagati con a.c. n. XYZ intestato a Rossi. Quella vendita è già soggetta a imposta di registro, non genera reddito tassabile. -> Prova: l’origine è capitale personale non imponibile (plusvalenza esente perché erano passati >5 anni dall’acquisto).
- Versamenti vari sul cc personale tot €30.000 in piccoli importi: spiegazione: Rossi mostra che ogni primo del mese versava €3.000 prelevati dal conto dell’impresa per pagare le spese familiari; essendo trasferimento da conto aziendale (già tassato come prelievo), non sono nuovi ricavi. -> Prova: movimenti infragruppo/auto-trasferimenti (allega estratti di entrambi i conti mostrando prelievo dal conto azienda e versamento stesso giorno sul personale).
- Prelievi contanti tot €100.000 nell’anno: spiegazione: Rossi documenta che ha pagato in contanti alcuni fornitori (idraulico, piastrellista) per piccoli lavori subappaltati, presentando dichiarazioni liberatorie firmate da questi fornitori attestate di aver ricevuto quei pagamenti (alcuni sono irregolari perché superano €2.000 in contanti, ma ai fini fiscali prova che erano costi reali sostenuti). Inoltre €30.000 di prelievi sono serviti per spese personali (viaggi, mantenimento famiglia) – Rossi esibisce ricevute di un’agenzia viaggi per €10.000 e spese scolastiche per €5.000, pagate in contanti combacianti con alcuni prelievi. -> Prova: i prelievi avevano destinazioni note, parte per costi d’impresa (che l’ufficio potrebbe negare perché non fatturati, ma almeno li toglie dal novero dei ricavi occulti) e parte per spese personali (non generano ricavi).
Con questo dossier, Rossi si presenta all’adesione. L’ufficio, preso atto delle prove:
- Accetta che i €20.000 di incassi erano dichiarati – li toglie dalla pretesa.
- Accetta parzialmente la storia dell’immobile: richiede però prova che quell’assegno sia confluito nel patrimonio personale e non in azienda. Rossi sottolinea che era suo bene privato, quindi esente. L’ufficio concorda di eliminare €50.000 dalla base (quei versamenti non saranno considerati ricavi).
- Sui €30.000 di versamenti mensili, l’ufficio nota che i prelievi corrispondenti erano già considerati ricavi (essendo prelievi dal conto azienda). Capisce che includere anche i versamenti sarebbe doppia conteggiatura. Rimuove dunque quei €30.000 dalla sommatoria (erano già considerati come prelievi anomali semmai).
- Sui prelievi €100.000: l’ufficio è scettico sulle dichiarazioni dei fornitori in nero ma riconosce che almeno €30.000 erano spese familiari non attinenti all’impresa. Per policy, sui prelievi spesso tendono a insistere. Si concorda un abbattimento forfettario del 50% sui €100.000, considerando provato che metà non era per ricavi (in parte personali, in parte costi non fatturati).
Alla fine, dall’originario €250.000 di movimenti, l’accordo di adesione riduce a circa €100.000 la quota di ricavi non giustificati (essenzialmente i prelievi non coperti dalle prove). Su €100.000, Rossi paga le imposte dovute con sanzioni ridotte 1/3.
Esito: Rossi ha evitato il giudizio e ha ridotto l’imponibile contestato del 60%. Certo, ha dovuto comunque pagare su importi per cui non aveva pezze d’appoggio (i costi in nero), ma rispetto al rischio iniziale ha contenuto i danni.
Lezione: in un accertamento bancario, la difesa migliore è preventiva (tenere traccia di tutto) ma se non lo si è fatto, occorre mettere insieme ex post quanti più documenti e spiegazioni possibili. Ogni euro giustificato è un euro tolto dalla base presunta.
Se l’ufficio fosse stato inflessibile e non avesse aderito, Rossi avrebbe portato queste prove in Commissione tributaria. Con buone probabilità, come minimo, il giudice avrebbe tolto i €70.000 dimostrati (incassi già tassati, vendita casa, spese personali), e forse avrebbe anche riconosciuto i costi in nero come elementi per escludere la produzione di ricavi (questo dipende dai giudici, alcuni in presenza di prove di pagamento a terzi, ancorché irregolari, riducono l’IVA evasa ma non l’imponibile).
Caso 2: Accertamento sintetico redditometrico vs. reale tenore di vita
Scenario: La sig.ra Bianchi, dipendente con stipendio annuo di €25.000, riceve un accertamento sintetico per il triennio 2019-2021. L’Agenzia ha riscontrato che Bianchi possiede: un appartamento di proprietà dove vive (acquistato nel 2018 a €200.000), un’auto Mercedes acquistata nuova nel 2020 (€50.000), e che ha effettuato spese per viaggi all’estero ogni anno per circa €10.000 (risultano dai movimenti carta di credito). In base a questi elementi, l’ufficio presume un reddito reale di €60.000 annui, ben superiore ai €25.000 dichiarati. Dopo invito al contraddittorio (cui la contribuente però non ha partecipato), emette avvisi di accertamento aggiungendo ~€35.000 di imponibile annuo per ciascuno dei tre anni, più imposte IRPEF e addizionali relative.
Difesa: La sig.ra Bianchi presenta ricorso (non vuole pagare perché sostiene di aver potuto sostenere quelle spese attingendo a risparmi di famiglia e aiuti). Nella sua memoria difensiva spiega:
- L’appartamento è stato pagato in gran parte con il ricavato della vendita della casa dei genitori defunti: Bianchi produce copia della dichiarazione di successione del 2017 dove ereditava €150.000 e un altro immobile poi venduto. In più, un mutuo bancario di €50.000 copre il resto (allega contratto di mutuo e piano di ammortamento). Quindi per la casa, nessun reddito extra: ha usato capitale già esistente ed ereditato.
- L’auto Mercedes è stata acquistata dal marito di Bianchi (i due sono in separazione dei beni, e il marito è imprenditore con reddito alto). Bianchi allega copia del bonifico di pagamento dell’auto, effettuato dal conto del marito. L’auto è stata intestata a lei per ragioni assicurative, ma di fatto il bene è stato pagato e viene mantenuto dal consorte. Dunque il possesso dell’auto non riflette reddito proprio di Bianchi.
- I viaggi all’estero (€10.000/anno) sono stati regalati dal fratello di Bianchi, residente in Australia, che ogni anno invita lei e la famiglia a trovarlo e copre le spese aeree. Difatti, Bianchi allega lettere e e-mail del fratello dove questi le inviava biglietti aerei come regalo. E anche estratti conto dal suo (di lei) conto corrente che mostrano accrediti di €10.000/anno dal fratello (prove dei bonifici con causale “gift for travel”).
In più, Bianchi spiega che negli anni in esame ha attinto ai propri risparmi accumulati: allega estratto di un conto titoli da cui ha venduto azioni per €30.000 nel 2019 e €20.000 nel 2020, somme poi confluite sul suo conto per spese varie (queste vendite di investimenti non sono reddito tassabile, erano risparmi).
Con queste prove, Bianchi sostiene che tutte le spese evidenziate trovano copertura in fonti finanziarie non provenienti dal reddito imponibile del triennio:
- Eredità e mutuo -> casa.
- Soldi del marito -> auto.
- Doni del fratello -> viaggi.
- Vendita azioni -> ulteriore capacità di spesa.
L’ufficio, costituitosi in giudizio, insiste che comunque il tenore di vita è molto alto e che la contribuente non ha documentato al 100% ogni aspetto (es. chi paga bollette e mantenimento della casa? Bianchi risponde che col suo stipendio paga quelle spese ordinarie e su quelle nulla da eccepire).
Sentenza ipotetica: La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso di Bianchi. Nella motivazione scrive che l’Agenzia non ha adeguatamente considerato le prove presentate: in base all’art. 38 c.6 DPR 600, la contribuente ha dimostrato che le spese effettuate sono state finanziate con redditi di anni precedenti (risparmi, eredità) o con liberalità di terzi. Inoltre, evidenzia il giudice, l’Ufficio non ha fornito elementi ulteriori oltre alle spese “indice”: non risultano investimenti occulti, né incrementi patrimoniali ingiustificati (la casa è giustificata). Dunque manca quella gravità degli indizi necessaria per confermare la presunzione. In virtù del nuovo art. 7 c.5-bis D.Lgs. 546, essendo mancata la prova puntuale di un maggior reddito effettivo (le presunzioni dell’ufficio sono state tutte neutralizzate da spiegazioni), l’atto impositivo va annullato.
Lezione: In un accertamento sintetico, la vittoria del contribuente dipende dalla sua capacità di rendicontare le fonti di finanziamento delle sue spese. Anche regali, aiuti famigliari, utilizzo di risparmi: tutto va documentato. Le norme e la giurisprudenza lo consentono: se dimostri che hai speso denaro non derivante da nuovi redditi dell’anno, l’accertamento sintetico cade.
Caso 3: Presunta distribuzione di utili occulti ai soci di una piccola società
Scenario: La S.r.l. Alfa (4 soci, ristretta base) viene accertata per ricavi non contabilizzati di €500.000 nel 2021. L’Agenzia delle Entrate, oltre ad accertare IRES e IVA alla società, notifica ai 4 soci (persone fisiche) singoli avvisi IRPEF per “utili extrabilancio distribuiti” nel 2021, pro quota, per €125.000 ciascuno. Uno dei soci, minoritario al 20% e non amministratore (diciamo il sig. Verdi), impugna il suo avviso sostenendo di non aver mai percepito tali utili e di essere stato tenuto all’oscuro della gestione.
Difesa del socio Verdi: Nel ricorso, Verdi evidenzia:
- Lui era socio di capitale, senza deleghe amministrative, e durante il 2021 viveva all’estero per lavoro (allega documenti di residenza estera temporanea e contratto di lavoro estero). Dunque non partecipava alle decisioni operative.
- La società Alfa nel 2022 è fallita e dalle carte del fallimento risulta che i fondi extracontabili (se ve ne erano) sono stati utilizzati dall’amministratore per pagare maestranze in nero e tangenti (Verdi allega dichiarazioni rese dall’amministratore in sede di interrogatorio penale, raccolte nel frattempo, dove ammette di aver distratto somme per questi scopi).
- Verdi mostra che il suo conto corrente personale nel 2021 non ha ricevuto bonifici o versamenti anomali (movimentazione regolare e modesta, compatibile solo col suo stipendio estero). Nessun arricchimento tracciabile.
In base a ciò, Verdi chiede l’annullamento dell’accertamento IRPEF a suo nome, sostenendo che la presunzione di distribuzione di utili è stata smentita dai fatti: quei utili non sono andati a lui.
Possibile esito: Il giudice tributario, applicando il nuovo orientamento post-riforma, dà ragione a Verdi. Osserva che la presunzione di distribuzione di utili, pur ammessa dalla giurisprudenza, non è una presunzione legale ma solo semplice e non automatica. Pertanto, l’Ufficio avrebbe dovuto provare concretamente che nel caso specifico Verdi avesse percepito utili, cosa che non è avvenuta (nessuna traccia finanziaria, anzi evidenze contrarie). Cita magari l’art. 7 c.5-bis D.Lgs.546 per dire che l’onere probatorio spettava al Fisco, e questi non ha fornito alcuna prova specifica, affidandosi a un automatismo non sufficiente. Di conseguenza annulla l’atto verso Verdi. (Gli altri soci potrebbero avere sorte diversa se, ad esempio, l’amministratore socio al 60% incassava tutto lui: la presunzione verso di lui reggerebbe perché in quel caso le prove potrebbero dire che qualcuno ha preso quegli utili. Ma il minoritario estraneo può salvarsi).
Lezione: Per i soci, soprattutto minoritari, accusati di utili occulti, la difesa consiste nel dimostrare la mancata percezione: vita modesta, nessun accredito, nessun controllo gestionale. È utile anche mostrare dove quei utili siano finiti se non ai soci (es. l’amministratore se li è giocati o li ha reinvestiti altrove). Con la riforma, c’è spazio per convincere i giudici a non applicare più in modo rigido la presunzione, specie in presenza di soci non amministratori.
Questi esempi non coprono tutte le situazioni, ma riflettono problemi comuni. In ognuno notiamo che il punto decisivo è la prova: chi riesce a portare la prova più convincente vince la presunzione.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa significa in pratica “accertamento fondato su presunzioni”?
R: Significa che il Fisco determina maggiori imposte da pagare deducendo l’esistenza di redditi non dichiarati a partire da indizi o circostanze indirette, anziché basarsi su prove dirette. Ad esempio, se trova movimenti bancari non spiegati, presume che siano ricavi nascosti; se vede uno stile di vita lussuoso, presume redditi non dichiarati; se riscontra contabilità irregolare, presume che ci siano vendite in nero o costi fittizi, e così via. È quindi un accertamento “indiretto” che utilizza le presunzioni (strumenti logico-legali) per colmare la mancanza di prove certe di evasione.
D: Quali tipi di presunzioni usa il Fisco e come si differenziano?
R: In sintesi: le presunzioni legali sono previste da leggi tributarie (es. per legge un versamento bancario inspiegato è reddito) e di solito ribaltano l’onere della prova sul contribuente, seppur permettendo prova contraria (iuris tantum). Le presunzioni semplici non sono stabilite da leggi ma sono costruite dal Fisco su base indiziaria: valgono solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti. In questo caso, l’onere iniziale della prova resta al Fisco, che deve convincere il giudice della validità di tali indizi. Infine, si parla di presunzioni “supersemplici” quando la legge consente al Fisco di stimare arbitrariamente, anche senza indizi forti (tipicamente in caso di omessa dichiarazione o contabilità inesistente). La differenza sta quindi nel grado di forza attribuito all’indizio e a chi tocca l’onere di provare il contrario.
D: Se ricevo un accertamento basato su presunzioni, devo provare la mia innocenza?
R: Dipende dal tipo di presunzione. Se l’atto si basa su una presunzione legale (es. movimenti bancari), sì, in buona parte l’onere è tuo: dovrai fornire tu la prova contraria (documenti, giustificazioni) per ogni elemento contestato. Se invece l’accertamento si basa su presunzioni semplici (es. ricostruzioni induttive, studi di settore, redditometro), formalmente l’onere di provare che gli indizi sono validi è dell’ufficio. In pratica però, se l’ufficio porta elementi che convincono il giudice, tu dovrai contrastarli con controprove. Quindi, è prudente prepararsi sempre a “provare la tua innocenza” (o meglio, la correttezza della tua posizione fiscale) portando tutto il materiale difensivo possibile. La recente riforma del processo tributario (2022) ti tutela un po’ di più nelle presunzioni semplici, ma non significa che puoi restare passivo: conviene sempre ribattere punto per punto alle tesi del Fisco.
D: Possono farmi un accertamento solo in base ai versamenti sul mio conto corrente?
R: Sì, se non riesci a giustificarli. La legge permette di presumere che tutti i versamenti sul conto, se non giustificati, siano redditi in nero. È una delle presunzioni più comuni. Quindi se ti versano €50.000 sul conto e tu non dimostri che erano, ad esempio, un rimborso di prestito o un trasferimento da altro tuo conto o altra causale non reddituale, il Fisco li considererà come ricavi/compensi non dichiarati. Lo stesso per i prelievi dal conto per imprenditori/professionisti: se prelevi tanti contanti e non spieghi dove sono finiti, presumono che li hai usati per pagare spese “in nero” legate ad affari nascosti, quindi che avevi ricavi corrispondenti. In sintesi: sì, i movimenti bancari sono sufficienti a motivare un accertamento (sono presunzioni legali), e poi sta a te chiarirli.
D: Ho un’attività e la mia contabilità è a posto, possono comunque contestarmi ricavi non dichiarati?
R: Se la tua contabilità è formalmente regolare e non emergono incongruenze sostanziali, in teoria no, l’ufficio non può ignorarla. Però, se trovano elementi esterni che la contraddicono (es. clienti che dichiarano di aver pagato più di quanto fatturato, margini troppo bassi rispetto a medie, etc.), potrebbero fare un accertamento analitico-induttivo: controllano i conti e, trovando anche piccole irregolarità o incongruenze, usano quelle come appiglio per presunzioni di ricavi occulti. Detto ciò, la Cassazione ha spesso annullato accertamenti basati su un’unica anomalia lieve. Quindi se la tua contabilità è realmente solida e c’è solo qualche scostamento occasionale, hai buone chance di difesa. Diverso è se, pur con conti formalmente a posto, il Fisco trova prove esterne di evasione (es. un brogliaccio con doppia contabilità, o versamenti bancari anomali): allora userà quelle come presunzioni semplici per rettificare. In sintesi: una contabilità ordinata è la prima linea di difesa, ma non ti rende immune al 100% se affiorano indizi contrari.
D: I “redditometri” sono ancora in uso? Devo preoccuparmi se ho spese alte rispetto al mio reddito?
R: L’accertamento sintetico, o redditometro, esiste ancora nella legge (art. 38 DPR 600) ma dopo il 2015 è stato applicato pochissimo. Il “nuovo redditometro” elaborato nel 2018 è stato sospeso prima di partire, e ad oggi (2025) il MEF lo ha accantonato per ulteriori revisioni. Ciò non significa che il Fisco ignori del tutto chi ostenta ricchezza e dichiara poco: possono sempre farti un accertamento sintetico mirato, basato su alcune spese certe (es. acquisto di immobile, auto di lusso) e sulla differenza del 20% sui redditi dichiarati. Ma lo faranno solo in casi eclatanti e dopo averti ascoltato. Quindi, preoccupati fino a un certo punto: se tu hai fonti non tassabili (risparmi, eredità, donazioni) che finanziano il tuo tenore di vita, potrai spiegarlo e documentarlo in sede di contraddittorio e l’accertamento non dovrebbe partire. Se invece stai spendendo decisamente oltre il dichiarato e senza giustificazioni… allora sì, potresti essere un target per il redditometro, benché per ora sia usato col contagocce.
D: In un processo tributario posso portare testimoni?
R: Questa è una novità fresca: da fine 2022 è ammessa la testimonianza scritta in casi eccezionali. Cioè, non avrai il testimone che parla in udienza, ma se il giudice lo ritiene indispensabile (o entrambe le parti sono d’accordo), può far rispondere per iscritto a dei quesiti una persona informata dei fatti. È ancora tutto da rodare, ma sì, in teoria puoi avere testimonianze, ad esempio di un terzo che conferma la tua versione (es.: un cliente che attesta di averti pagato un tot e non di più, un parente che conferma di averti donato dei soldi usati per spese, ecc.). Devi però proporlo nel ricorso e sperare che il giudice concordi sulla necessità. Prima era vietato del tutto, ora c’è questa chance. Inoltre, puoi già allegare dichiarazioni sostitutive di atto notorio di terzi: non sono prove piene, ma se fatte bene e allegate, possono convincere il giudice a formalizzare la testimonianza. Quindi, sfrutta questa possibilità se hai testimoni chiave (ricordando che se mentono commettono reato di falso).
D: Cosa succede se il Fisco basa l’accertamento su documenti che ha ottenuto in modo illegale?
R: Dipende. In generale, nella giustizia tributaria non esiste un chiaro principio di inutilizzabilità come nel penale. La Cassazione ha detto che non c’è un divieto generale di usare prove irrituali in ambito tributario. Per esempio, se ottenessero info sul tuo conto all’estero tramite una fuga di notizie non ufficiale, potrebbero comunque usarle e sta a te contestare eventualmente la fonte, ma spesso il giudice le tiene buone se aiutano a raggiungere la verità fiscale. Solo se l’acquisizione ha violato un tuo diritto fondamentale (tipo domiciliarietà inviolabile, segretezza delle comunicazioni) forse potresti fare escludere la prova, magari coinvolgendo anche la Corte Costituzionale. Ma sono casi rari. Quindi, di regola, anche se pensi “hanno preso quei documenti senza autorizzazione!” ciò da solo non ti garantisce di annullare l’atto. Puoi usarlo come argomento (invalidità del procedimento), ma spesso i giudici lo superano. Fa eccezione la mancanza di autorizzazione per accedere ai conti: lì la legge la impone, ma anche in quel caso la Cassazione ha detto che se non ti ha pregiudicato, l’atto rimane valido. Insomma: contesta pure se vedi irregolarità nell’acquisizione prove (è sempre bene farlo perché non si sa mai), ma preparati soprattutto a difenderti nel merito.
D: Ho ricevuto un avviso basato su presunzioni; mi conviene fare ricorso o trattare col Fisco?
R: Dipende dalla situazione. Se hai buone prove e la pretesa è chiaramente errata o eccessiva, fare ricorso ha senso: oggi i giudici sono più attenti a non avallare presunzioni azzardate, quindi hai chance di vittoria e magari annullamento totale. Se invece la presunzione dell’ufficio è sfalsata ma un fondo di verità c’è (es. qualcosa non hai dichiarato davvero, anche se meno di quanto dicono), spesso conviene trattare: l’accertamento con adesione può ridurre notevolmente sanzioni e anche imponibili. In adesione puoi ottenere uno “sconto” che in sentenza magari non avresti, perché il giudice decide secondo legge (es. se per legge un elemento è reddito, lo deve confermare). L’ufficio in adesione invece può chiudere a metà strada per evitare la causa. Quindi valuta: se puoi dimostrare tutto -> ricorso; se la situazione è grigia -> prima prova un’adesione per spuntare il risultato migliore; se l’ufficio fa orecchie da mercante o offre poca riduzione, allora ricorso. Tieni conto anche dei costi/tempi: il ricorso dura anni e costa (anche se poi puoi recuperare le spese se vinci). L’adesione risolve in pochi mesi e con minori tensioni. Ogni caso è a sé, ma il buon consulente tributarista di solito tenta l’adesione e tiene pronto il ricorso come piano B.
D: In caso di presunzioni, quali sono le prove migliori che dovrei presentare?
R: Le prove documentali oggettive sono le migliori: estratti conto, contratti, fatture, quietanze, atti notarili, ecc. Qualsiasi documento ufficiale che dimostri la provenienza o la destinazione dei soldi contestati. Anche le perizie tecniche possono aiutare (per es. un perito che attesti che i margini del tuo settore sono più bassi di quelli usati dal Fisco). Le dichiarazioni di terzi (clienti, fornitori, parenti) sono utili, ma meglio se corroborate da documenti. Ora anche le testimonianze scritte sono possibili, come detto, quindi se hai qualcuno disposto a confermare per iscritto determinati fatti, raccogli quelle dichiarazioni (magari facendole autenticare da un notaio per dare più peso). Inoltre, non dimenticare la normativa e le circolari: ad esempio, se c’è una circolare dell’Agenzia che interpreta una presunzione a tuo favore, portala all’attenzione (i giudici le considerano). Infine, porta anche la logica: a volte uno schema o un calcolo aritmetico può essere la prova che la pretesa è assurda (mostra incongruenze, doppi conteggi, ecc.). Ricorda: il giudice tributario spesso non ha conoscenza approfondita della tua attività, guidalo tu a capire con elementi concreti.
D: Se perdo in primo grado, posso far valere le stesse ragioni in appello?
R: Sì, puoi appellarti (entro 60 giorni dalla sentenza) e riproporre le tue ragioni. Attenzione però: non puoi presentare nuove prove che avevi e non hai prodotto prima (a meno che siano emerse dopo, o non disponibili prima). Quindi è cruciale fare un primo grado completo. In appello, il giudice rivaluterà sia i fatti che il diritto (dal 2023 l’appello tributario non è più limitato ai motivi di gravame, è un “novum iudicium” quasi pieno). Potresti anche chiedere eventualmente una CTU (consulenza tecnica d’ufficio) in appello se ritieni serva un esperto neutrale – ora è un po’ più frequente di prima. Se perdi anche in appello, puoi ricorrere in Cassazione, ma lì si discute solo di diritto, non di fatti e prove. Quindi per le presunzioni, di solito la partita decisiva è tra primo e secondo grado. Vincere in primo è ottimo (spesso l’Agenzia accetta e non appella, specialmente su questioni fattuali), ma se perdi e sei convinto, l’appello ti dà un’altra chance.
D: Quanto tempo ho per preparare la difesa dopo aver ricevuto l’accertamento?
R: Dalla notifica hai 60 giorni per presentare ricorso (a meno che tu faccia prima istanza di adesione, che ti dà una pausa). Sono due mesi intensi: nel frattempo puoi chiedere accesso agli atti all’Agenzia per vedere il fascicolo istruttorio (utile per capire su cosa si basano). Usa questo tempo per raccogliere tutto. Se fai istanza di adesione entro 60 gg, il termine del ricorso si sospende per 90 gg dall’istanza: potenzialmente hai 60+90 = 150 giorni di tempo. Molti usano l’adesione anche per avere più tempo di costruire la pratica (oltre che per tentare l’accordo). Quindi, massimizza quel periodo: non ridurti all’ultimo giorno. Spesso giungono clienti dal professionista con l’accertamento scaduto o quasi: è un problema. Appena ricevi l’atto, contatta un esperto e inizia a lavorare alla difesa. Il tempo è poco e i dettagli tanti.
Conclusione: un accertamento fiscale basato su presunzioni non è una condanna definitiva, ma va affrontato con serietà e tempestività. Conoscere i propri diritti (contraddittorio, motivazione, onere della prova) e sfruttare le armi difensive (documenti, testimonianze, normative, giurisprudenza) consente spesso di ribaltare la situazione o quantomeno di attenuare molto la pretesa. La chiave è dimostrare con i fatti la realtà economica effettiva, smontando le costruzioni presuntive laddove esagerate o infondate. L’ordinamento offre strumenti di tutela: sta al contribuente (e ai suoi consulenti) attivarli al meglio.
Fonti
- DPR 29/09/1973 n. 600, art. 39, commi 1 lett. d) e 2 – Accertamento delle imposte sui redditi (metodi analitico-induttivo e induttivo).
- DPR 29/09/1973 n. 600, art. 38, commi 4-7 – Accertamento sintetico delle persone fisiche (redditometro).
- DPR 29/09/1973 n. 600, art. 32 – Poteri degli uffici (indagini finanziarie e presunzioni bancarie).
- Cassazione Civile, Sez. Trib., ord. n. 18596 del 30/06/2024 – Presunzione legale ex art.32 DPR 600: onere del contribuente e doveri del giudice.
- Cassazione Civile, Sez. Trib., sent. n. 26473 del 06/09/2024 – Distribuzione utili extracontabili in società a ristretta base: onere probatorio a carico del socio.
- Cassazione Civile, Sez. Trib., ord. n. 8452 del 31/03/2025 – Utilizzabilità di documenti acquisiti irritualmente ai fini dell’accertamento.
- Cassazione Civile, Sez. Trib., ord. n. 5529 del 02/03/2025 – Divieto di doppia presunzione e accertamenti tributari.
- D.Lgs. 31/08/2022 n. 130, art. 6 – Riforma processo tributario 2022 (ha introdotto art. 7, co.5-bis D.Lgs.546/92 sul nuovo onere probatorio).
- Cassazione SS.UU. n. 228/2014 – Presunzione prelevamenti non applicabile a privati non imprenditori.
- Cassazione SS.UU. n. 24823/2015 – Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nel redditometro.
- Cassazione Sez. Trib. n. 14885/2018; n. 757/2020 – Limiti all’accertamento induttivo in caso di irregolarità contabili non gravi.
- Cassazione Sez. Trib. n. 16574/2023 – Tendenza verso contraddittorio obbligatorio generalizzato.
- Cassazione Sez. Trib. n. 20897/2019 – Principio di ragionevolezza nell’accertamento induttivo puro.
- DECRETO del MEF 07/05/2024 (sospeso) – Nuovo redditometro 2024 e Atto di indirizzo 23/05/2024.
- Statuto del Contribuente (L. 212/2000) art. 7 – Chiarezza e motivazione degli atti (modificato da D.Lgs. 219/2023).
- D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 – Accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale (disciplina strumenti deflativi).
- Direttiva UE 2016/2258 (“Direttiva DAC5”) – Cooperazione amministrativa e utilizzo informazioni finanziarie, per questioni su prove estere (riferimento indiretto).
Accertamento fiscale fondato su presunzioni? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento basato su presunzioni dell’Agenzia delle Entrate?
Ti contestano ricavi o redditi non dichiarati solo perché considerati “incompatibili” con la tua situazione economica?
Gli accertamenti presuntivi sono tra i più insidiosi: si basano su dati indiretti, medie, consumi, spese e tenore di vita.
Ma la legge prevede che tu possa difenderti e ribaltare le presunzioni con prove concrete e documentate.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’avviso di accertamento e la base presuntiva utilizzata dal Fisco
- 📌 Verifica se le presunzioni sono infondate, arbitrarie o superabili
- ✍️ Redige memorie difensive per dimostrare la realtà dei tuoi redditi e delle tue spese
- ⚖️ Ti rappresenta nel contenzioso tributario e nelle fasi di contraddittorio con l’Agenzia
- 🧾 Ti assiste nella raccolta delle prove necessarie per smontare le ipotesi dell’Ufficio
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in accertamenti induttivi e presuntivi
- ✔️ Consulente per la difesa di contribuenti soggetti ad accertamenti su base indiretta
- ✔️ Consulente legale per lavoratori autonomi, imprenditori, professionisti e famiglie
Conclusione
Un accertamento fondato su presunzioni non è una prova definitiva.
Con una strategia legale mirata puoi difendere la tua posizione, ridurre l’imposizione e far valere i tuoi diritti.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa fiscale comincia da qui.