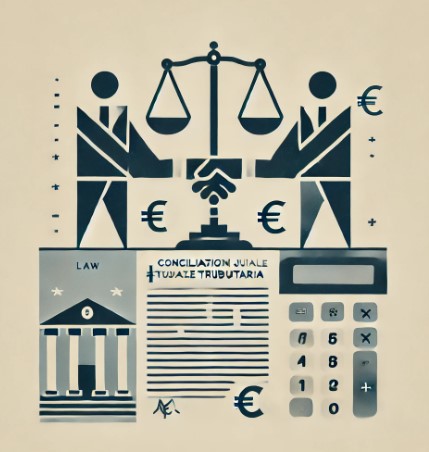Hai ricevuto un avviso di accertamento o sei già in contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e ti chiedi cos’è la conciliazione giudiziale tributaria? Vuoi sapere se è uno strumento utile per chiudere la lite fiscale senza andare fino in fondo?
La conciliazione giudiziale è uno strumento previsto nel processo tributario che consente al contribuente e all’Amministrazione finanziaria di definire la controversia in via bonaria, anche dopo aver presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
In cosa consiste la conciliazione giudiziale tributaria?
È un accordo tra contribuente e fisco che può avvenire:
– Durante il primo grado di giudizio (conciliazione “semplice”)
– Nel secondo grado (appello), in forma “fuori udienza” o in udienza pubblica
Attraverso la conciliazione si può ottenere:
– Una riduzione del tributo richiesto
– L’abbattimento delle sanzioni amministrative fino al 50% o meno
– La sospensione della riscossione coattiva
– La chiusura definitiva del contenzioso, con rinuncia alle spese legali reciproche
Quando conviene utilizzare la conciliazione giudiziale?
– Quando l’atto dell’Agenzia delle Entrate è contestabile ma con esiti incerti
– Quando si vuole evitare tempi lunghi e costi del processo
– Quando il contribuente vuole pagare solo una parte del dovuto e chiudere tutto subito
– Quando si vuole evitare il rischio di perdere in giudizio e pagare di più
Quali sono i vantaggi concreti per il contribuente?
– Riduzione dell’importo totale da pagare
– Possibilità di rateizzare il pagamento concordato
– Nessuna iscrizione a ruolo immediata
– Azione conciliativa senza passare per altre procedure amministrative
Come si attiva la conciliazione giudiziale?
– Presentando un’istanza di conciliazione alla Corte di Giustizia Tributaria
– Formulando una proposta scritta da parte del contribuente o del fisco
– Depositando l’accordo in udienza o fuori udienza, con omologazione da parte del giudice
Cosa succede se l’accordo viene raggiunto?
Il giudice prende atto della conciliazione, emette una sentenza che ne certifica l’efficacia, e la lite si chiude definitivamente. Le somme concordate vanno pagate nei tempi stabiliti, con possibilità di rateazione.
Attenzione: cosa succede se non rispetti i termini di pagamento?
In caso di mancato versamento anche di una sola rata, l’Agenzia delle Entrate può tornare a chiedere l’intero importo originario, più sanzioni e interessi. Serve quindi un piano chiaro e realistico.
La conciliazione giudiziale può essere un’ottima occasione per risolvere una lite fiscale in modo rapido e vantaggioso, ma solo se seguita da un avvocato esperto in contenzioso tributario.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati specializzati in difesa fiscale e contenzioso tributario – ti spiega come funziona la conciliazione giudiziale, quando conviene e quali errori evitare.
Hai già un ricorso in corso o stai per presentarlo?
Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso e ti diremo se è possibile chiudere la controversia con una conciliazione vantaggiosa per te.
Introduzione
La conciliazione giudiziale tributaria è uno strumento endoprocessuale con cui contribuente e Amministrazione finanziaria definiscono amichevolmente (in parte o totalmente) un contenzioso tributario già in corso. La norma di riferimento risiede nel D.Lgs. 546/1992 (Codice del processo tributario) e consente, in cambio dell’accettazione di una parte della pretesa (con relative somme versate), una riduzione delle sanzioni amministrative. Nella formulazione aggiornata, la conciliazione realizzata in primo grado comporta l’applicazione delle sanzioni al 40% del minimo di legge, in appello al 50%; dal 5 gennaio 2024, grazie al DLgs. 220/2023, è possibile conciliare anche in Cassazione (per ricorsi notificati da tale data) con sanzioni al 60%. In ogni caso, l’accordo è omologato dal giudice tributario che estingue il processo per «cessata materia del contendere».
Quadro normativo e principi
La disciplina della conciliazione giudiziale si trova agli artt. 48 e seguenti del D.Lgs. 546/1992 (successivamente aggiornati da varie leggi di bilancio e dal recente DLgs. 220/2023). In particolare:
- Art. 48 (conciliazione fuori udienza): le parti concordano un accordo scritto per definire total or parzialmente la lite, e lo depositano presso la Commissione tributaria prima dell’udienza. Se omologato dal giudice, l’accordo produce sentenza di estinzione.
- Art. 48-bis (conciliazione in udienza): ciascuna parte può chiedere in udienza la definizione (totale o parziale) fino a 10 giorni liberi prima della trattazione. Se le condizioni lo consentono, il giudice invita a conciliare e può rinviare l’udienza alla successiva seduta per perfezionare l’accordo. L’intesa si perfeziona con la redazione di un verbale in udienza, che diventa titolo per la riscossione delle somme concordate.
- Art. 48-bis.1 (proposta giudice): introdotto dalla riforma del 2023, permette al giudice di formulare d’ufficio una proposta conciliativa in udienza. La proposta può riguardare l’oggetto del giudizio, questioni di pronta soluzione e anche i precedenti giurisprudenziali, e – se una parte lo richiede – l’udienza può essere rinviata per valutare l’offerta. Questo istituto è valido solo in primo e secondo grado (non in Cassazione).
- Art. 48-ter (sanzioni): stabilisce le riduzioni sanzionatorie legate all’accordo. Se la conciliazione si perfeziona, le sanzioni si applicano al 40% del minimo in primo grado, al 50% in secondo grado. Il DLgs. 220/2023 ha modificato l’art. 48-ter per introdurre l’estensione alla Cassazione: a questo ultimo grado (per ricorsi notificati dal 5/1/2024) si applica il 60% del minimo. Dal medesimo decreto (comma 4-bis dell’art. 48) si prevede che «le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione», consentendo quindi l’accordo conciliativo anche in Cassazione.
In sintesi, la conciliazione giudiziale si colloca dopo che il giudizio tributario è iniziato (è quindi uno strumento “endoprocessuale”), e mira a chiudere la lite in tempi brevi, con benefici economici per il contribuente tramite la riduzione delle sanzioni.
Ambito di applicazione
La conciliazione giudiziale si applica a tutte le controversie tributarie sottoposte alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. Ciò significa che, indipendentemente dal tipo di tributo (imposte dirette, IVA, tributi locali, contributi, ecc.) o dal valore dell’atto contestato, se è stato notificato un ricorso in sede contenziosa le parti possono tentare l’accordo conciliativo. Essa vale sia per i giudizi in primo grado sia per quelli in appello, e – come detto – da gennaio 2024 anche per i ricorsi in Cassazione (nuova possibilità).
La proposta conciliativa può venire da entrambe le parti o dal giudice d’ufficio. Il contribuente, l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate (o degli enti locali) e l’agente della riscossione hanno tutti pari possibilità di proporre o accogliere l’accordo. La partecipazione di un soggetto terzo (ad esempio un comune creditore di tributi) è ammessa solo se già parte del giudizio. Importante: la conciliazione è sempre facoltativa per ciascuna parte, e non prevede sanzioni in caso di rifiuto; se la proposta non viene accettata, il giudizio prosegue normalmente.
Modalità di attivazione della conciliazione
La procedura concreta cambia a seconda che l’accordo si costruisca fuori udienza o in udienza:
- Fuori udienza (art. 48): Le parti redigono un accordo scritto congiunto, indicando le somme concordate (tributo, interessi e sanzioni ridotte) e il calendario di pagamento. Questo atto, sottoscritto dai legali o dalle parti in proprio, viene depositato in segreteria. Se la Commissione non ha ancora fissato la causa, il presidente decide con decreto. Se invece la causa era già fissata, il giudice, constatata la regolarità dell’accordo, lo omologa con sentenza di estinzione. A questo punto il giudizio si chiude (cessazione della materia del contendere). Si parla allora di sentenza di estinzione del giudizio. Il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo ai fini della riscossione delle somme pattuite.
- In udienza (art. 48-bis): Fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata, ogni parte può depositare una semplice istanza formale di conciliazione totale o parziale. Durante l’udienza, se le condizioni (controversia ammissibile alla definizione per legge) sono sussistenti, il presidente può invitare le parti a raggiungere un accordo. In tal caso può rinviare l’udienza successiva per formalizzare il verbale conciliativo. Quando le parti sottoscrivono il verbale in udienza, si perfeziona l’accordo, che diventa titolo per riscuotere le somme (come nel caso fuori udienza). Anche qui, il giudice estingue il processo con sentenza e registro della cessazione.
- Proposta del giudice (art. 48-bis.1): Introdotta nel 2023, permette al giudice di formulare una proposta di accordo già in udienza. Il contenuto può includere l’oggetto del giudizio, questioni semplici ma anche questioni connesse a precedenti giurisprudenziali. Se una parte chiede tempo per valutare, l’udienza può essere rinviata anche a tale scopo. Questo strumento è valido solo in Commissione tributaria (primo e secondo grado); in Cassazione è prevista solo la conciliazione “fuori udienza” (vedi oltre).
In tutti i casi, l’accordo conciliativo deve essere omologato dal giudice (con decreto o sentenza): il giudice verifica la legittimità formale e, se non rileva vizi, omologa l’intesa. Il giudice non entra nel merito delle somme concordate, a patto che siano rispettati i limiti di legge (es. versamento del tributo effettivamente dovuto).
Effetti dell’accordo e riduzione delle sanzioni
Il principale effetto dell’accordo conciliativo è l’estinzione del giudizio. La Commissione dichiara in sentenza o ordinanza che il processo tributario si chiude per «cessata materia del contendere». In pratica, la controversia viene chiusa definitivamente e non possono più essere emesse pronunce sul merito dei punti definiti dall’accordo.
Dal lato del debitore, il vantaggio è economico e consiste principalmente nella riduzione delle sanzioni. In base all’accordo, il contribuente paga l’intero tributo (eventualmente già parzialmente corrisposto) più una percentuale ridotta di sanzioni. Le sanzioni concorsuali si applicano nella misura agevolata stabilita dal legislatore: il 40% del minimo previsto in primo grado e il 50% in secondo grado. Ad esempio, se l’atto impugnato prevedeva sanzioni al 30% del tributo, con la conciliazione in primo grado si pagherà solo il 40% di quel 30% (cioè il 12% del tributo). Dal 5/1/2024, per i ricorsi in Cassazione l’aliquota è il 60% del minimo.
Un’ulteriore conseguenza molto favorevole è che gli interessi di mora cessano di decorrere sul credito impugnato dal momento in cui l’accordo è sottoscritto. Inoltre, se una somma di tributo era già stata versata (ad esempio con una dilazione antecedente), l’accordo può prevedere la compensazione con eventuali rimborsi o crediti maturati, congelando così eventuali riscossioni coattive già avviate. In pratica, con la conciliazione il contribuente ottiene tempi certi di definizione e contenimento delle spese aggiuntive rispetto al mero pagamento del tributo effettivamente dovuto.
Termini di versamento
Il pagamento delle somme concordate avviene secondo regole analoghe a quelle dell’accertamento con adesione. In particolare, entro 20 giorni dalla firma dell’accordo o dalla redazione del verbale conciliativo deve essere versato il primo importo. Se le parti richiedono rateizzazione, è ammessa la dilazione in un massimo di 8 rate trimestrali (periodo 3 mesi). Per debiti superiori a 50.000€, il legislatore permette fino a 16 rate trimestrali. I versamenti successivi sono dunque in scadenze fissate ogni tre mesi. Nel periodo di rateizzazione continuano a maturare interessi legali sulle rate non ancora versate. Se il contribuente salda tutte le rate nei tempi, l’accordo esaurisce ogni debito.
Se invece il contribuente salta una o più rate, l’accordo resta comunque valido (non si riapre il contenzioso originario), ma scatta la penalità di cui all’art. 15-ter del DPR 602/1973: una sanzione sostitutiva del 45% sul tributo residuo non versato. Anche in tal caso, però, è possibile applicare il ravvedimento operoso (d.lgs. 218/1997) per ridurre tale sanzione se il ritardo viene sanato tempestivamente.
Spese di lite
La regola generale è che le spese di lite non vengono liquidate con l’atto di estinzione per conciliazione: ciascuna parte sopporta le proprie spese. In pratica, l’accordo sancisce implicitamente una compensazione tra le spese già sostenute dalle parti. Tuttavia, le parti possono prevedere diversamente nel testo dell’accordo (ad esempio, prevedendo che l’Ufficio rimborsi le spese vive al contribuente), ma ciò è eccezionale.
Un aspetto particolare riguarda il rifiuto ingiustificato della conciliazione. Se una parte (di norma l’Ufficio finanziario) respinge la proposta conciliativa senza motivo e poi soccombe in giudizio (ossia la controparte ottiene un risultato migliore in sede di merito), allora le spese di lite a suo carico sono aumentate del 50%. Questa norma, inserita dal legislatore per evitare o punire comportamenti dilatori, si applica anche nel processo tributario (art. 15-ter del D.Lgs. 546/1992). In sostanza, conviene valutare seriamente le offerte conciliative anziché rifiutarle pregiudizialmente.
Conciliazione in Cassazione
La recente riforma del contenzioso tributario (DLgs. 220/2023) ha esteso la conciliazione ai giudizi di legittimità. Dal 5 gennaio 2024, per i ricorsi in Cassazione instaurati da quella data, è ammessa la conciliazione “fuori udienza”. Ciò si traduce nei seguenti punti:
- L’art. 48 del D.Lgs. 546/1992, comma 4-bis (introdotto dal DLgs 220/2023), stabilisce che le norme sulla conciliazione si applicano anche ai giudizi pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
- In Cassazione le parti devono presentare un accordo scritto per definire la lite, come avverrebbe per qualsiasi giudizio di Commissione. Non è previsto l’invito in udienza (non ha scopo conciliativo in Cassazione) e il giudice di legittimità non formula proposte conciliative (le norme dell’art. 48-bis e 48-bis.1, che riguardano la conciliazione in udienza, non si applicano al giudizio di Cassazione).
- L’art. 48-ter, comma 1, modificato dal DLgs. 220/2023, prevede per la Cassazione la sanzione ridotta pari al 60% del minimo di legge in caso di accordo. Tale percentuale si applica all’atto conciliativo perfezionato nel giudizio di legittimità. Ad esempio, se il tributo concordato è 100.000€ e la sanzione minima era 30.000€, con la conciliazione in Cassazione la sanzione sarà solo 18.000€ (60% di 30.000).
- Quando l’accordo è raggiunto, la Corte di Cassazione omologa l’intesa (con ordinanza o decreto) e dichiara estinto il ricorso. In pratica l’iter del giudizio di Cassazione si conclude senza svolgere la discussione sul merito, a beneficio della rapidità.
Questa novità consente al contribuente di ottenere una definizione anticipata anche a livello di Corte suprema, impedendo l’attesa di una pronuncia incerta. Tuttavia, va notato che la conciliazione in Cassazione dipende dalle questioni poste nel ricorso: se i motivi di gravame non consentono di ricomporre una lite globale (ad es. se riguardano solo aspetti formali), l’accordo potrebbe essere limitato. In ogni caso, il DLgs. 220/2023 ha fissato espressamente la fattibilità (art. 48 4-bis) e i benefici economici (art. 48-ter) della conciliazione anche in Cassazione.
Tabella riepilogativa
| Grado di giudizio | Sanzione applicata in conciliazione |
|---|---|
| Commissione tributaria (I grado) | 40% del minimo di legge |
| Commissione tributaria (II grado) | 50% del minimo di legge |
| Corte di Cassazione (dal 5/1/2024) | 60% del minimo di legge |
| Aspetto | Conciliazione giudiziale |
|---|---|
| Applicabilità | Tutte le controversie tributarie (primo/grado e Cass., escluso il Cass. pass. in giudicato) |
| Modalità di avvio | Istanza congiunta depositata in segreteria (fuori udienza) o richiesta alla prima udienza (in udienza) |
| Chi la propone | Contribuente, Amministrazione finanziaria, concessionario, o d’ufficio dal giudice |
| Effetto principale | Estinzione del giudizio con sentenza di cessazione della materia del contendere |
| Spese di lite | Compensate fra le parti; rifiuto immotivato = maggiorazione 50% a carico del soccombente |
| Pagamento | Versamento entro 20 gg dall’accordo (in rate: max 8 trimestri, 16 se >50k) |
Domande frequenti
- D: La conciliazione sospende la riscossione?
R: Sì. Dal ricorso in Commissione la riscossione del credito tributario è sospesa di diritto (art. 39 DPR 602/73). Durante il tentativo di conciliazione (e fino all’omologa), l’agente della riscossione non può eseguire il credito oggetto della causa. Una volta perfezionato l’accordo e versate le somme, il debito si considera definito per l’importo conciliato e non viene più riscosso. - D: È obbligatorio accettare la conciliazione offerta dall’ufficio?
R: No, la conciliazione è sempre facoltativa per il contribuente. Se l’accordo non viene raggiunto, il giudizio prosegue normalmente. Tuttavia, come visto, il rifiuto immotivato di un’offerta può esporre al rischio di dover pagare più spese in caso di soccombenza finale. - D: Cosa succede se sono già stato soccombente in primo grado?
R: Nulla vieta di conciliare anche dopo una sentenza di primo grado sfavorevole. Il contribuente può raggiungere un accordo in appello (o in Cassazione) per pagare di meno rispetto alla sentenza. Ovviamente, più avanzato è il grado del giudizio, minore è la percentuale di sanzione da versare (50% in appello, 60% in Cassazione). - D: È possibile compensare l’accordo con crediti d’imposta?
R: Sì. Nel pagamento delle somme concordate è ammessa la compensazione con crediti certi e liquidi del contribuente. Ad esempio, se l’accordo prevede di versare 10.000€ di tributo, il contribuente può usare un credito IVA o altre somme a rimborso, secondo le regole ordinarie della compensazione. - D: Come si procede se l’atto impugnato è già stato definito con adesione o dilazione?
R: Se il tributo era già stato definito con adesione o un altro istituto amministrativo, in genere non rimane nulla da conciliare. Tuttavia, se rimane una controversia residua (ad esempio su sanzioni o interessi), si può applicare la conciliazione per quelle somme residue. In ogni caso non è possibile duplicare benefici: l’adesione e la conciliazione non si sommano sulla stessa materia. - D: Chi decide le modalità pratiche di deposito dell’accordo?
R: La modulistica è libera, ma di solito si usa un atto congiunto di istanza di conciliazione sottoscritto dalle parti. È consigliabile indicare chiaramente l’oggetto, le somme concordate e i riferimenti all’atto impugnato. Vanno rispettate le scadenze di deposito (10 giorni liberi prima dell’udienza, se fissata). Si raccomanda sempre di depositare una copia per ciascuna parte. - D: La conciliazione si applica anche alle impugnazioni pendenti in Cassazione da prima del 5 gennaio 2024?
R: No, la norma di estensione alla Cassazione (comma 4-bis art.48) è applicabile ai ricorsi notificati in Cassazione dal 5/1/2024 in poi. Le pendenze anteriori a quella data seguono la disciplina tradizionale: non si poteva conciliarsi in Cassazione, quindi devono essere definite con altri mezzi (ad es. rinuncia condizionata, compensazione, ecc.) o proseguire il giudizio fino alla decisione.
Conclusioni
Dal punto di vista del contribuente, la conciliazione giudiziale rappresenta un’opportunità per chiudere un contenzioso tributario con costi certi e generalmente inferiori rispetto al proseguimento del giudizio. Riducendo le sanzioni e fissando subito l’importo da versare, si acquisisce un vantaggio economico e pratico (stop alla riscossione coattiva, definizione rapida). Il nuovo scenario normativo rende la conciliazione ancora più interessante, estendendola a tutte le fasi del contenzioso (inclusa la Corte di Cassazione). Resta fondamentale valutare di volta in volta la convenienza dell’accordo e predisporre un testo chiaro e completo, per evitare sorprese. In sintesi, la conciliazione giudiziale tributaria è uno strumento deflativo flessibile e potente, da tenere in considerazione al pari degli altri istituti deflativi (accertamento con adesione, definizioni agevolate, ecc.) nelle strategie di difesa fiscale del contribuente.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 (Codice del processo tributario), artt. 48, 48-bis, 48-ter e succ., come modificati da leggi successive (in particolare DLgs. 220/2023).
- DPR 29/9/1973, n. 602, art. 15-ter (disposizioni su sanzioni per mancato pagamento delle somme conciliative).
- L. 23/12/2005, n. 266 (art. 11-quinquiesdecies, introduttivo dell’istituto).
- L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), commi 206-212 (conciliazione agevolata tra le novità).
- Cass. trib., sent. 15/11/2013, n. 25683 (principio sull’appellabilità della sentenza di estinzione per conciliazione).
- DLgs. 30/12/2023, n. 220 (attuazione della riforma fiscale 2023-2024), in particolare gli artt. 1, 4, c.2 (conciliabilità in Cassazione) e conseguenti.
- Circolari e prassi dell’Agenzia delle Entrate sul contenzioso e gli strumenti deflativi (sito agenziaentrate.gov.it, sezione Contenzioso); documenti di prassi del Dipartimento della Giustizia Tributaria (MEF).
Hai un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Se hai impugnato un avviso di accertamento o un atto dell’Agenzia delle Entrate, puoi risolvere la controversia in via rapida ed efficace grazie alla conciliazione giudiziale tributaria.
Questa procedura ti consente di evitare una sentenza, chiudere la lite in modo vantaggioso e pagare meno.
Vediamo come funziona e perché può convenire.
🛡️ Come funziona la conciliazione giudiziale tributaria
📌 È una soluzione negoziale che si attiva dopo aver presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
📂 Si può proporre prima dell’udienza o anche durante il processo
✍️ Prevede un accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate, con pagamento agevolato
💰 Consente una riduzione delle sanzioni fino al 50%
⚖️ Una volta omologata dal giudice, la conciliazione chiude definitivamente il contenzioso
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📑 Esamina il tuo atto impugnato e la tua posizione fiscale
📌 Verifica se la conciliazione è la strategia migliore nel tuo caso
✍️ Prepara la proposta conciliativa e la documentazione necessaria
🤝 Negozia con l’Agenzia delle Entrate per ottenere le condizioni più favorevoli
⚖️ Ti assiste durante l’udienza e cura l’omologazione dell’accordo
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e risoluzioni stragiudiziali
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
✔️ Autore di strategie fiscali difensive per imprese, professionisti e persone fisiche
✔️ Consulente in trattative fiscali con l’Agenzia delle Entrate
Conclusione
La conciliazione giudiziale tributaria è uno strumento potente per chiudere una causa fiscale, risparmiare e guardare avanti.
Con l’aiuto giusto puoi evitare il rischio di una sentenza sfavorevole e ottenere una soluzione concreta e definitiva.
📞 Contatta ora l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: una buona difesa inizia da una strategia intelligente.