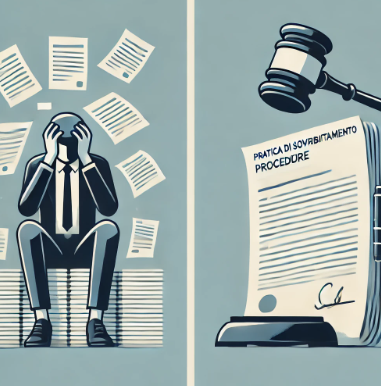Hai una sentenza penale di condanna e ti stai chiedendo se puoi comunque accedere alla procedura di sovraindebitamento? Temi che il passato giudiziario possa bloccarti la possibilità di liberarti dai debiti?
Il sovraindebitamento è uno strumento pensato per chi non riesce più a far fronte ai propri debiti, anche se ha avuto problemi penali in passato. Ma ci sono delle condizioni precise: non tutte le condanne impediscono l’accesso alla procedura. Per questo è fondamentale capire subito cosa prevede la legge e come difendersi.
Chi può accedere al sovraindebitamento anche se ha una condanna penale?
– Chi non ha commesso reati legati all’indebitamento stesso (come frodi fiscali o bancarotte fraudolente)
– Chi ha debiti accumulati per motivi estranei al reato
– Chi dimostra di aver agito in buona fede e di non avere più la possibilità reale di pagare
Quali condanne possono bloccare il sovraindebitamento?
– Quelle per reati tributari (evasione, frode fiscale)
– Bancarotta fraudolenta o reati commessi nel contesto di procedure concorsuali
– Reati contro il patrimonio commessi per ottenere finanziamenti o eludere obblighi di pagamento
Tuttavia, non basta la condanna: serve che ci sia un legame diretto tra il reato e l’indebitamento. Se i debiti sono precedenti, indipendenti o sopraggiunti per altre ragioni, si può comunque accedere alla procedura.
Cosa può fare chi ha una sentenza penale e vuole liberarsi dai debiti?
– Richiedere l’accesso al piano del consumatore, alla liquidazione controllata o all’esdebitazione per incapiente, a seconda dei requisiti
– Dimostrare con documentazione che il debito non è frutto di dolo, frode o malafede
– Presentare una domanda ben motivata al gestore della crisi o all’OCC, che valuterà il caso
– Con il supporto di un avvocato esperto, anticipare e contrastare eventuali eccezioni sollevate dai creditori o dal giudice
Cosa NON devi fare mai?
– Pensare che la condanna penale chiuda ogni possibilità: non è così
– Presentare domanda da solo, senza supporto tecnico-legale: rischi di vedertela rigettare per vizi formali
– Omettere nel fascicolo i procedimenti penali: meglio dichiarare tutto e spiegare
– Aspettare che sia il giudice a sollevare il problema: meglio prevenire e chiarire fin dall’inizio
La presenza di una sentenza penale non è automaticamente un ostacolo al sovraindebitamento. Molto dipende dalla natura del reato, dalla buona fede del debitore e dalla documentazione allegata.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi da sovraindebitamento e contenzioso penale-tributario – ti spiega quando una condanna può impedire l’accesso alla procedura, come valutare la tua posizione e cosa fare per difenderti.
Hai una condanna penale e non sai se puoi accedere al sovraindebitamento?
Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione penale, la natura dei tuoi debiti e costruiremo una strategia per ottenere l’accesso alla procedura e liberarti da un passato che non deve condannarti per sempre.
Introduzione
Il sovraindebitamento è la situazione di squilibrio economico in cui un soggetto – consumatore, professionista o piccolo imprenditore – non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti con le risorse disponibili. Per affrontare questa condizione, l’ordinamento italiano offre specifiche procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotte dapprima con la Legge 3/2012 (detta “legge salva-suicidi”) e oggi confluite nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022). Tali procedure mirano a dare una seconda chance al debitore onesto ma sfortunato, permettendogli di ristrutturare o liquidare i propri debiti e ottenere la liberazione dalle obbligazioni residue (esdebitazione), a determinate condizioni. L’idea di fondo, in linea con le raccomandazioni europee, è che il sovraindebitato “meritevole” possa reinserirsi nell’economia legale, evitando di restare oppresso a vita dai debiti e incentivando la regolarizzazione del “sommerso”.
In questa guida affronteremo in dettaglio il rapporto tra le procedure di sovraindebitamento e la sentenza penale di condanna, ovvero l’impatto che eventuali precedenti penali del debitore possono avere sulla possibilità di accedere alle procedure e, soprattutto, di ottenere l’esdebitazione finale dei debiti. Il tema è complesso e delicato: da un lato c’è l’esigenza di favorire il “fresh start” del debitore onesto, dall’altro occorre evitare che strumenti pensati per aiutare chi è in buona fede diventino un rifugio per chi ha commesso illeciti penali gravi (specie in ambito economico-finanziario). Esamineremo dunque la normativa italiana vigente (aggiornata a luglio 2025), con un taglio avanzato ma dal linguaggio chiaro e divulgativo, rivolgendoci sia a professionisti del diritto (avvocati, commercialisti) sia a debitori privati o imprenditori interessati a comprendere i propri diritti e obblighi.
Daremo conto delle recenti riforme in materia, inclusa l’entrata in vigore del Codice della Crisi e le modifiche successive (anche in attuazione della Direttiva UE 2019/1023), nonché delle più aggiornate sentenze di merito e di legittimità. Saranno incluse tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni. Il tutto, come richiesto, dal punto di vista del debitore, ossia focalizzando gli aspetti pratici che chi si trova schiacciato dai debiti e magari ha anche problemi con la giustizia penale deve assolutamente conoscere. Iniziamo tracciando il quadro generale delle procedure da sovraindebitamento oggi disponibili e vediamo poi come una condanna penale incide su tali procedure.
Procedure di sovraindebitamento: quadro normativo attuale
La disciplina del sovraindebitamento è stata profondamente innovata dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), emanato con D.Lgs. 14/2019 e successivamente modificato (da D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 83/2022 e altri provvedimenti minori fino al D.Lgs. 136/2024). Questo codice ha assorbito la previgente Legge 3/2012, armonizzando le procedure “minori” di composizione delle crisi con quelle tradizionali fallimentari. Dal 15 luglio 2022 il CCII è pienamente in vigore, sicché le domande nuove di sovraindebitamento seguono le regole del Codice (restano applicabili alcune norme della Legge 3/2012 solo per procedure pendenti o aspetti transitori). È importante dunque conoscere la nuova terminologia e i nuovi strumenti previsti, che in parte ricalcano quelli precedenti ma con significative differenze. Di seguito riassumiamo le principali procedure di sovraindebitamento oggi disponibili per il debitore persona fisica o piccolo imprenditore non fallibile (ossia sotto le soglie di fallibilità).
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): Procedura riservata ai debitori consumatori (persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale). Il debitore propone un piano di pagamento dei debiti, basato sulle proprie risorse e su eventuali apporti di terzi, da attuarsi entro un certo periodo. La particolarità è che non serve il voto dei creditori: il piano, dopo il vaglio di fattibilità dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e il controllo di legalità del tribunale, può essere omologato anche senza il consenso dei creditori, purché il giudice verifichi la sussistenza dei requisiti di legge (in particolare la meritevolezza del debitore). Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori e, se il debitore esegue regolarmente quanto promesso, i debiti restanti vengono considerati estinti per effetto dell’omologazione stessa (si parla di effetti esdebitativi del piano). In pratica, il consumatore che completa il piano ottiene la liberazione dai debiti residui senza bisogno di un ulteriore provvedimento di esdebitazione, poiché è la stessa omologazione a comportare la “forgiveness” delle obbligazioni non soddisfatte (fatte salve alcune eccezioni che vedremo).
- Concordato minore (ex accordo di composizione della crisi): Procedura aperta sia a debitori non consumatori (imprenditori sotto-soglia, professionisti, start-up innovative, enti non commerciali, ecc.) sia – volendo – anche ai consumatori in alternativa al piano. Si tratta di un accordo con i creditori: il debitore, con l’ausilio dell’OCC, formula una proposta di concordato offrendo ai creditori il migliore soddisfacimento possibile (ad es. pagamento parziale dei crediti, eventualmente suddivisi in classi). I creditori votano sulla proposta; per l’approvazione serve una maggioranza qualificata (la legge richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ammessi al voto, salvo diverse maggioranze previste dal giudice in caso di suddivisione in classi). Se i creditori approvano e il tribunale omologa l’accordo (verificando legalità e fattibilità), il concordato minore diventa vincolante per tutti i creditori concorsuali, compresi i dissenzienti. Anche qui l’esecuzione integrale dell’accordo produce l’effetto di esdebitazione: i crediti rimasti insoddisfatti si intendono estinti in virtù dell’accordo stesso, che ha natura negoziale/concorsuale. Il concordato minore corrisponde in larga parte al vecchio “accordo di composizione” della L.3/2012, ma nel CCII risulta potenziato e integrato con la disciplina generale dei concordati preventivi (ad esempio è prevista la figura del commissario giudiziale e la possibilità di misure protettive). Non è più richiesta espressamente la “fattibilità economica” come concetto distinto dalla convenienza, secondo l’orientamento del Codice, ma rimane centrale la buona fede del debitore.
- Liquidazione controllata dei beni (ex liquidazione del patrimonio): È una procedura giudiziale concorsuale che prevede la liquidazione del patrimonio del debitore ad opera di un liquidatore nominato dal tribunale, con ripartizione del ricavato ai creditori. Può accedervi qualunque debitore sovraindebitato (consumatore o no), e rappresenta il rimedio di ultima istanza quando non sia possibile (o conveniente) un piano o un concordato. La liquidazione controllata può essere avviata su richiesta del debitore oppure – novità del CCII – su iniziativa dei creditori o del Pubblico Ministero: infatti l’art. 268 CCII consente ai creditori, e al PM in caso di imprenditore minore, di chiedere l’apertura della liquidazione se il debitore è in stato di insolvenza. Ciò rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla Legge 3/2012, dove la procedura era solo su base volontaria: oggi il debitore può in teoria essere “forzato” alla liquidazione controllata, analogamente a quanto avviene col fallimento/liquidazione giudiziale per le imprese maggiori. Durante la liquidazione controllata, il debitore è spossessato dei propri beni (che vengono gestiti dal liquidatore per soddisfare i creditori) e gode degli effetti di stay delle azioni esecutive individuali, con alcune eccezioni. In particolare, è importante segnalare che – secondo la Suprema Corte – il creditore fondiario (banca munita di mutuo fondiario) conserva il suo privilegio processuale ex art. 41 TUB e può proseguire o iniziare l’esecuzione immobiliare sul bene ipotecato anche se il debitore entra in liquidazione controllata. Ciò significa che, se il sovraindebitato ha una casa gravata da mutuo fondiario e la banca ha avviato pignoramento, la procedura di sovraindebitamento non blocca la vendita dell’immobile: la banca potrà andare avanti separatamente (una differenza chiave rispetto ai creditori ordinari). Al termine della liquidazione controllata, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui tramite decreto del tribunale, previa verifica di specifiche condizioni di meritevolezza e comportamento (vedi infra). Su questo punto incide fortemente l’eventuale presenza di condanne penali, come tratteremo a breve. Da notare che il CCII ha reso l’esdebitazione più accessibile e rapida: in base all’art. 282 CCII, la liberazione dei debiti può scattare automaticamente alla chiusura della procedura o decorso il termine di 3 anni dall’apertura, senza necessità di un’apposita istanza, purché risultino soddisfatte le condizioni previste. Questo recepisce l’obiettivo della direttiva europea di assicurare il fresh start entro 3 anni. Resta ferma la possibilità per i creditori o il Pubblico Ministero di opporsi o chiedere la revoca dell’esdebitazione se emergono irregolarità o se le condizioni non erano in realtà presenti.
- Esdebitazione del debitore incapiente: Si tratta di una procedura innovativa, introdotta prima in via temporanea nella L.3/2012 (nel 2020, con il c.d. “Decreto Ristori”) e poi stabilmente recepita negli artt. 283 e 284 CCII. È un istituto che consente al debitore persona fisica privo di qualunque patrimonio o reddito disponibile (il cosiddetto incapiente) di ottenere la cancellazione totale dei debiti senza dover pagare nulla ai creditori, in virtù della sola situazione di indigenza. In sostanza, il debitore incapiente – che non può offrire “utilità nemmeno future” ai creditori – può presentare direttamente al tribunale, tramite l’OCC, un ricorso per essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione pur senza attivare una liquidazione controllata. È una sorta di “esdebitazione di diritto” concessa una sola volta nella vita, purché ricorrano rigorosamente i presupposti di legge. Tra questi, oltre alla condizione oggettiva di insolvenza e totale incapienza, vi è un severo giudizio di meritevolezza: sarà escluso dall’esdebitazione chi ha dolosamente o con colpa grave causato la propria situazione debitoria. In altre parole, occorre che il sovraindebitamento derivi da eventi sfortunati e non da comportamento fraudolento o irresponsabile del debitore. Ad esempio, un soggetto che abbia accumulato debiti con condotte volontarie illecite (truffe, frodi, gioco d’azzardo patologico senza tentare cure, ecc.) non sarà ritenuto meritevole di questa clemenza. Anche qui la presenza di condanne penali per reati rilevanti può pesare nell’apprezzamento della meritevolezza: di fatto, se i debiti derivano da un reato commesso dal debitore, l’istanza verrà respinta (si pensi a chi chiede di cancellare debiti derivanti da risarcimenti danni per una truffa da lui compiuta). Se invece l’incapiente ottiene l’esdebitazione, per i quattro anni successivi dovrà comunicare al proprio OCC e al tribunale ogni eventuale sopravvenienza attiva (eredità, donazioni, vincite, redditi imprevisti), in quanto è obbligato fino a concorrenza del 10% dell’importo originario dei debiti a soddisfare i creditori con tali nuove utilità. Questo meccanismo evita abusi e tutela i creditori nel caso in cui la situazione del debitore migliori sensibilmente entro un arco di tempo ragionevole. In caso di omissioni o false comunicazioni su sopravvenienze, il beneficio può essere revocato anche dopo la concessione.
Come si vede, il panorama delle soluzioni per il sovraindebitamento è piuttosto articolato. La legge richiede sempre che il debitore si comporti con lealtà e trasparenza, sia nella fase di proposta (fornendo all’OCC e al giudice un quadro veritiero e completo di attivo, passivo, redditi e atti di disposizione compiuti) sia nella fase di esecuzione del piano/accordo o nella procedura liquidatoria. Violazioni gravi del dovere di buona fede possono condurre a inammissibilità della domanda o a diniego dell’esdebitazione. In primis, la legge sanziona ogni eventuale frodi ai creditori: ad esempio, aver sottratto o nascosto beni, simulato titoli di prelazione, falsificato documenti contabili, contratto nuovi debiti senza prospettiva di adempimento o favorito di proposito alcuni creditori a discapito di altri (pagamenti preferenziali nei mesi precedenti) sono condotte che precludono o fanno revocare il beneficio. Su questi aspetti, tuttavia, non ci addentreremo oltre nel dettaglio generale, poiché l’obiettivo di questa guida è esaminare in particolare un fattore specifico di estrema rilevanza: la presenza di una sentenza penale di condanna a carico del debitore.
Nei paragrafi che seguono analizzeremo come incide una condanna penale definitiva sulle varie procedure di sovraindebitamento e sull’esdebitazione. Vedremo quali reati impediscono per legge di ottenere la liberazione dai debiti, come comportarsi se si ha un procedimento penale in corso, cosa succede ai debiti derivanti da reato (multe, ammende, risarcimenti a vittime) nell’ambito di un piano o di una liquidazione, e infine daremo consigli pratici e risposte ai quesiti più comuni per chi si trova in queste situazioni.
Condanna penale ed esdebitazione: reati ostativi e condizioni
Il principale punto di intersezione tra diritto penale e sovraindebitamento riguarda l’accesso al beneficio finale dell’esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura. La legge prevede infatti che determinati precedenti penali del debitore siano una causa ostativa alla concessione dell’esdebitazione. L’idea di fondo è chiara: il debitore condannato per gravi reati in materia economica non può essere “premiato” con la cancellazione dei debiti, quantomeno fino a quando quella condanna resta sul suo “curriculum” giudiziario. Questa preclusione esisteva già nella Legge Fallimentare per l’esdebitazione post-fallimento (art. 142 L.Fall.) ed è stata ripresa sia nella Legge 3/2012 (art. 14-terdecies, comma 1, lett. d) sia ora nel Codice della Crisi, art. 280 comma 1, lettera a). Vediamo dunque quali sono i reati rilevanti e in che modo operi questa preclusione.
Reati che impediscono la liberazione dai debiti
L’art. 280 CCII elenca, tra le condizioni per l’esdebitazione, che “il debitore non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato” per una serie di reati penali di particolare gravità, salvo intervenuta riabilitazione. I reati indicati sono:
- Bancarotta fraudolenta, ovvero le condotte fraudolente di distrazione, occultamento di attivo, esposizione di passivo inesistente ecc. in caso di fallimento (ora disciplinata dall’art. 323 e seguenti del Codice della Crisi, che ha riformulato i reati fallimentari). È il classico reato del fallito disonesto. Una condanna per bancarotta fraudolenta in qualsiasi forma (patrimoniale o documentale) rappresenta un ostacolo assoluto all’esdebitazione. Invece la bancarotta semplice, di natura meno grave (derivante da negligenza e non frode), non è espressamente menzionata tra le cause ostative. Pertanto, come rilevato anche dalla giurisprudenza, una condanna solo per bancarotta semplice non impedisce di per sé la concessione del beneficio, non rientrando tra i reati tassativamente indicati. Resta però il fatto che una bancarotta semplice può implicare comportamenti imprudenti del debitore, valutabili sotto il profilo della meritevolezza generale.
- Delitti contro l’economia pubblica, ossia quei reati previsti dagli articoli 499–512 del codice penale (ad esempio: aggiotaggio, ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell’esercizio del commercio, ecc.). Si tratta di reati che tutelano la lealtà del sistema economico e commerciale. Una condanna definitiva per uno di questi delitti impedisce l’esdebitazione. Ad esempio, chi sia stato condannato per truffa ai danni dello Stato o per frode commerciale non potrà accedere al fresh start.
- Delitti contro l’industria e il commercio, ossia quelli previsti dagli artt. 513–517-quinquies c.p. (ad esempio: turbata libertà dell’industria o del commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, contraffazione di marchi, ecc.). Anche qui, la ratio è escludere dall’esdebitazione chi abbia leso la fiducia nei rapporti di mercato con comportamenti criminali.
- Altri delitti commessi in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa. Questa è una categoria residuale ma ampia, che richiede un’attenta interpretazione. In pratica vi rientrano tutti i reati di natura dolosa strettamente legati all’attività imprenditoriale del debitore non già ricompresi nelle categorie sopra. Esempi: i reati fallimentari diversi dalla bancarotta fraudolenta (come il ricorso abusivo al credito, art. 341 CCII, o la denuncia di creditori inesistenti, art. 343 CCII); alcune fattispecie di reato tributario gravi – come la dichiarazione fraudolenta o l’emissione di fatture false, l’omessa dichiarazione o l’occultamento di scritture contabili – in quanto spesso commesse per avvantaggiare l’impresa (in effetti la prassi e la dottrina le ricomprendono tra i reati “connessi all’attività d’impresa” anche se codificate fuori dal c.p.). Anche il reato di riciclaggio o autoriciclaggio di proventi illeciti può rientrare se commesso nel contesto aziendale. Inoltre, la dottrina ritiene inclusi i numerosi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) quando commessi nell’interesse o vantaggio dell’impresa. Ad esempio, se un imprenditore individuale viene condannato per un reato ambientale o per un infortunio sul lavoro (che sono tra quelli elencati nel catalogo 231/2001) commessi nell’esercizio dell’azienda, tale condanna dovrebbe precludere l’esdebitazione. In sintesi, qualunque reato doloso strettamente legato al modo in cui l’impresa era gestita e che abbia contribuito al dissesto finanziario può costituire causa ostativa. Rileva però solo la condanna definitiva: un procedimento penale in corso per tali reati sospende la decisione, ma finché non vi è sentenza irrevocabile non scatta l’esclusione (vedi oltre).
È importante sottolineare che la riabilitazione penale “cancella” l’effetto ostativo di queste condanne. La legge fa salvo infatti il caso in cui il condannato abbia ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza la riabilitazione ex artt. 178 e 179 c.p.: in tal caso, pur permanendo la macchia nel casellario giudiziale, ai fini dell’esdebitazione quella condanna non verrà considerata. Approfondiremo più avanti il tema della riabilitazione.
Da segnalare, infine, che oltre ai reati tipicamente “imprenditoriali” sopra elencati, nella prassi si considerano ostative anche condanne per reati tributari gravi (come omesso versamento IVA, indebite compensazioni, ecc.), pur se non menzionati testualmente nell’art. 280, in quanto indice di grave malafede fiscale. Ad esempio, l’essere stato condannato per frodi fiscali o truffa ai danni dello Stato è sicuramente visto come incompatibile con la “meritevolezza” richiesta al debitore per ottenere l’esdebitazione. Pertanto, in un’ottica cautelativa, si può affermare che qualunque condanna definitiva per delitti dolosi di natura economico-patrimoniale (fallimentari, societari, fiscali, finanziari) costituirà un serio impedimento al fresh start.
Tabella riepilogativa – Reati ostativi all’esdebitazione (art. 280 c.1 lett. a, CCII):
| Categoria di reato | Esempi tipici | Effetto sulla domanda di esdebitazione |
|---|---|---|
| Bancarotta fraudolenta (fallimento) | Distrazione di beni, scritture false | Ostativa: condanna definitiva preclude il beneficio. |
| Delitti contro l’economia pubblica | Aggiotaggio, frode sul mercato, illecita concorrenza | Ostativa: condanna definitiva preclude il beneficio. |
| Delitti contro l’industria e il commercio | Vendita prodotti falsi, violazione segni distintivi | Ostativa: condanna definitiva preclude il beneficio. |
| Altri reati connessi all’attività d’impresa | Bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito, reati fiscali (es. dichiarazione fraudolenta, false fatture), riciclaggio aziendale, reati societari che causano dissesto, ecc. | Ostativa se reato doloso connesso al business. Bancarotta semplice non menzionata perciò non ostativa ex se, ma valutabile. Altri reati dolosi d’impresa = ostativi (salvo riabilitazione). |
| Nota: Riabilitazione conseguita ex art. 178 c.p. | – | Rimuove l’effetto ostativo della condanna. Condanne con pena sospesa e poi estinta (es. esito positivo messa alla prova) non rientrano perché non vi è sentenza di condanna definitiva. |
Come si evince dalla tabella, il legislatore ha voluto escludere dall’esdebitazione i debitori che abbiano commesso reati di particolare disonestà finanziaria. Questo principio è coerente con la natura premiale dell’esdebitazione: il beneficio va al debitore sovraindebitato “onesto ma sfortunato”, non a chi ha deliberatamente violato la legge traendo vantaggi indebiti. Un passo della giurisprudenza sintetizza bene tale ratio: “non si possono premiare comportamenti penalmente illeciti con la cancellazione del debito”. In pratica, se il sovraindebitamento è conseguenza di una condotta fraudolenta o criminale del debitore, la liberazione dai debiti non sarà concessa.
Va aggiunto che l’art. 280 CCII contempla anche altre cause (non penali) per negare l’esdebitazione, quali: aver già beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti o più di due volte in totale, aver aggravato volontariamente il dissesto con atti in frode, non aver cooperato durante la procedura, ecc. Queste riguardano la condotta del debitore nell’ambito concorsuale e mirano a evitare abusi seriali del meccanismo. Ad esempio, un debitore non consumatore può teoricamente accedere al sovraindebitamento più volte, ma non può ottenere il beneficio se ha già goduto di due esdebitazioni in passato. Un consumatore, invece, può “ripulirsi” al massimo due volte in vita sua, con almeno 5 anni tra l’una e l’altra. Queste limitazioni, tuttavia, esulano dal tema penale specifico e non verranno qui approfondite oltre.
Procedimento penale in corso e sospensione
Un caso particolare merita attenzione: cosa succede se il debitore ha un procedimento penale in corso per uno dei reati ostativi sopracitati, ma non c’è ancora una condanna definitiva al momento in cui si chiude la procedura concorsuale? Il Codice della Crisi disciplina anche questa situazione, stabilendo che, se è in corso un procedimento penale per uno dei reati indicati (o se il debitore è sottoposto a una misura di prevenzione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011), la decisione sull’esdebitazione viene rinviata “all’esito del relativo procedimento”. In altre parole, il tribunale sospende l’esame della richiesta di esdebitazione in attesa che il processo penale si concluda con sentenza definitiva. Ciò per evitare di concedere il beneficio a un debitore che poi potrebbe risultare condannato per un reato ostativo.
Nella pratica, questo significa che il debitore dovrà attendere l’esito del processo penale prima di sapere se potrà essere liberato dai debiti residui. Tale attesa può essere molto lunga: basti pensare che, ad esempio, per il reato di bancarotta fraudolenta la prescrizione è 10 anni (15 anni in caso di atti interruttivi) e i tre gradi di giudizio penale possono richiedere diversi anni. Se il processo penale si protrae, l’esdebitazione rimane sospesa, e il debitore – pur avendo completato la procedura concorsuale – resta tecnicamente obbligato verso i creditori. Questo è un potenziale fattore di frustrazione per il debitore “innocente”: egli potrebbe aver messo a disposizione tutti i suoi beni, ma non poter chiudere i conti finché non venga assolto. D’altra parte, se il procedimento si conclude con assoluzione o proscioglimento, il debitore avrà rimosso l’ostacolo e potrà ottenere l’esdebitazione (con efficacia retroattiva alla chiusura della procedura). Se invece sopraggiunge una condanna definitiva per un reato ostativo, l’esdebitazione sarà definitivamente negata. In questo secondo caso, i crediti non soddisfatti torneranno esigibili integralmente: i creditori potranno riprendere le azioni esecutive individuali per recuperare la parte non pagata (benché sia stata esperita una procedura concorsuale).
Va evidenziato che la legge si riferisce ai reati ostativi dell’art. 280; quindi, se il procedimento penale in corso riguarda reati diversi (es. un reato comune non rientrante tra quelli economici d’impresa), formalmente non dovrebbe determinare sospensione. Ad esempio, se un debitore ha un processo per lesioni personali o per guida in stato di ebbrezza, tali reati non compaiono nell’elenco e non attivano la regola di sospensione. Ovviamente, però, se anche da reati comuni derivano debiti (si pensi al risarcimento del danno alla parte civile per lesioni), questi debiti seguono le regole generali sui debiti da fatto illecito di cui diremo più avanti, e la condotta complessiva del debitore (se riprovevole) può comunque influire sul giudizio di meritevolezza in senso lato. In ogni caso, la sospensione automatica dell’esdebitazione opera soltanto per i processi relativi ai reati-elenco.
Un aspetto importante: la riabilitazione penale, come detto, elimina l’effetto ostativo di una condanna pregressa. Ma se al debitore sta pendendo un procedimento penale, egli ovviamente non è ancora condannato e quindi non può chiedere riabilitazione (che presuppone la condanna definitiva e l’espiazione della pena). In compenso, è stato osservato da alcuni commentatori che un debitore particolarmente accorto e incensurato potrebbe tentare di accelerare la definizione del procedimento penale per poi puntare alla riabilitazione in tempi relativamente brevi. Ad esempio, potrebbe scegliere di patteggiare la pena con sospensione condizionale già in fase di indagini preliminari: così avrebbe una condanna definitiva molto presto, e dopo i termini di legge (3 anni dal passaggio in giudicato, dimostrando buona condotta e – se incapiente – l’impossibilità di pagare le obbligazioni civili) potrebbe chiedere ed ottenere la riabilitazione. Ottenuta la riabilitazione, la condanna non sarebbe più di ostacolo all’esdebitazione, che potrebbe quindi essere concessa. Si tratta di scenari strategici estremi, di pertinenza più che altro degli avvocati difensori, ma è utile sapere che esiste questo possibile percorso combinato tra rito penale e sovraindebitamento. Ovviamente ogni caso va valutato singolarmente, e soprattutto occorre che la pena patteggiata sia compatibile con la sospensione (ad esempio, nel caso di bancarotta fraudolenta non sempre è possibile contenere la pena entro i limiti per la sospensione condizionale, specie se il fatto è grave).
La riabilitazione penale: cos’è e perché rileva
Come accennato, la riabilitazione penale è l’istituto che consente al condannato che abbia tenuto una buona condotta per un certo periodo di tempo dopo l’espiazione della pena, di ottenere dall’Autorità Giudiziaria la cancellazione degli effetti penali della condanna (artt. 178 e 179 c.p.). In concreto, la riabilitazione fa cessare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della sentenza: ad esempio, estingue le interdizioni dai pubblici uffici, rimuove l’iscrizione nel casellario ai fini della “recidiva”, e così via. Ai fini dell’esdebitazione, la riabilitazione assume un ruolo chiave perché – come chiarisce l’art. 280 – evita che le condanne ostative impediscano il beneficio. In altri termini, se Tizio è stato condannato per un reato che rientra tra quelli bloccanti ma successivamente ottiene la riabilitazione, il giudice della procedura concorsuale potrà considerare come non ostativo quel precedente. Naturalmente, ciò non toglie che la vicenda penale possa aver inciso sui debiti in sé (ad esempio se Tizio era condannato per frode fiscale, avrà grossi debiti erariali da sistemare), ma almeno sul piano formale non ci sarà più la preclusione automatica.
I presupposti per ottenere la riabilitazione sono (in sintesi): aver espiato la pena principale da almeno 3 anni (o 8 anni se recidivo specifico o reati di mafia), aver risarcito il danno alle persone offese (o dimostrato l’assoluta impossibilità a farlo), aver tenuto una buona condotta. Per i debitori sovraindebitati, spesso l’ostacolo è proprio l’obbligo di aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimenti, multe): però la legge consente la riabilitazione anche se tali obblighi non sono stati soddisfatti, qualora l’interessato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierli. Questa clausola viene incontro a chi, ad esempio, è insolvente e non può pagare le ingenti somme dovute come risarcimento: in tal caso il giudice di sorveglianza può comunque concedere la riabilitazione considerando lo stato di sovraindebitamento come giustificativo del mancato pagamento.
In concreto, dunque, un debitore sovraindebitato che fosse incappato in una condanna per reato ostativo potrebbe pianificare di chiedere la riabilitazione appena maturati i termini (3 anni dal fine pena, o dal patteggiamento definitivo) per poi subito dopo richiedere l’esdebitazione. Ad esempio, Caio è condannato per riciclaggio e ha debiti correlati; finisce la pena nel 2023, chiede riabilitazione nel 2026 (dimostrando di non poter pagare i danni) e la ottiene; a quel punto, se aveva fatto liquidazione controllata, nel 2026 il giudice potrà concedergli l’esdebitazione in quanto la condanna risulta riabilitata. Senza riabilitazione, Caio avrebbe dovuto essere escluso.
Da notare che la riabilitazione, una volta concessa, perde efficacia se l’interessato commette entro 7 anni un nuovo delitto non colposo (art. 180 c.p.). In tal caso rivivrebbero anche gli effetti penali pregressi. Fortunatamente, ciò non dovrebbe far “resuscitare” l’impedimento all’esdebitazione già ottenuta, che nel frattempo sarebbe divenuta definitiva. Però, un nuovo reato significherebbe probabilmente nuovi debiti e la necessità di un’altra procedura, con la preclusione che si ripresenta. Insomma, il consiglio è: usare la riabilitazione come strumento di ravvedimento autentico, evitando di incorrere successivamente in altre condotte illecite.
Debiti di origine penale: sanzioni e risarcimenti nel sovraindebitamento
Affrontato il tema delle condanne come elemento soggettivo di meritevolezza, veniamo ora a un altro aspetto cruciale per il debitore-condannato: la sorte dei debiti derivanti da reato all’interno delle procedure di sovraindebitamento. In molti casi, infatti, chi subisce una condanna penale si ritrova con significative obbligazioni pecuniarie a suo carico, che possono contribuire allo stato di insolvenza. Pensiamo a: multe o ammende inflitte dal giudice penale, spese processuali da rifondere allo Stato, provvisionali o risarcimenti dovuti alle vittime costituite parti civili, eventuali obbligazioni civili conseguenti al reato (come restituzioni di somme indebitamente percepite, risarcimenti da liquidare in separata sede civile, ecc.). Ci si chiede dunque se tali debiti possano essere inclusi in un piano di sovraindebitamento e soprattutto se possano venire cancellati dall’esdebitazione.
La normativa prevede alcune eccezioni importanti alla regola generale dell’esdebitazione: in particolare non sono mai liberati (restano cioè comunque dovuti anche dopo la procedura) i debiti di natura personale, alimentare o da illecito extracontrattuale. Già la Legge 3/2012 all’art. 14-terdecies comma 3 stabiliva che “l’esdebitazione non opera: a) per gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti; c) per alcuni debiti fiscali sopravvenuti”. Il Codice della Crisi ha sostanzialmente confermato questi principi. Tradotto: anche se il giudice concede l’esdebitazione, essa non copre:
- Gli obblighi di mantenimento e alimentari: ad esempio gli arretrati dovuti per assegni di mantenimento al coniuge divorziato o ai figli. Questi debiti di natura familiare non sono cancellabili, per ragioni di tutela costituzionale della famiglia. Dunque un padre indebitato che deve €10.000 di mantenimento non pagato all’ex moglie, anche se ottiene l’esdebitazione, continuerà a doverli versare.
- I debiti per risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale: questa categoria comprende tutti i risarcimenti dovuti per aver cagionato un danno con un illecito (che può essere anche un reato). Ad esempio: Tizio ha causato un incidente stradale in stato di ebbrezza e deve €50.000 di risarcimento al ferito; oppure Caio ha commesso diffamazione e deve risarcire €10.000 al diffamato; oppure ancora ha truffato una persona e deve restituirle il maltolto e i danni. Ebbene, questi debiti non vengono eliminati dall’esdebitazione. Il perché è intuibile: si tratta di debiti derivanti da un atto illecito del debitore, la cui cancellazione totale risulterebbe ingiusta nei confronti della vittima. Quindi, se anche il debitore sovraindebitato paga una percentuale di questi debiti in sede concorsuale, la parte non pagata rimane a suo carico dopo la chiusura della procedura. In concreto, se nel piano/liquidazione la vittima ha ricevuto ad es. il 20%, potrà ancora pretendere il restante 80% dal debitore dopo l’esdebitazione. Questa norma mette la parola fine a vecchie incertezze: la Cassazione già da anni escludeva dalla discharge fallimentare i debiti da dolo o colpa grave (risarcimenti da reato, appunto) in analogia alla disciplina di altri Paesi, e ora è espressamente codificato.
- Le sanzioni penali o amministrative di carattere pecuniario non accessorie: questo significa che multe, ammende e contravvenzioni pecuniarie derivanti da sentenze penali, così come eventuali sanzioni amministrative (multe stradali, sanzioni tributarie, ecc.), non sono cancellate dall’esdebitazione. Anche qui la ratio è chiara: lo Stato non intende rinunciare alla punizione pecuniaria dei reati o degli illeciti amministrativi. Dunque, se ho €5.000 di multa penale o €2.000 di contravvenzione del codice della strada, li dovrò comunque pagare, esdebitazione o meno. Unica eccezione: la norma parla di sanzioni “che non siano accessorie a debiti estinti”. Ci si riferisce al caso in cui la sanzione pecuniaria sia accessoria a un debito principale che nel frattempo è stato soddisfatto. Ad esempio, se ho pagato integralmente il tributo, la sanzione amministrativa accessoria a quel tributo potrebbe cadere (ma sono situazioni particolari). In generale, se la multa sta ancora lì, l’esdebitazione non la tocca.
- Alcuni debiti fiscali sopravvenuti: per completezza, il codice prevede anche che restino esclusi i debiti tributari che, pur anteriori alla procedura, siano stati accertati successivamente in base a nuovi elementi scoperti dal Fisco. È una disposizione tecnica che evita che il debitore “scappi” da nuove pretese fiscali emerse dopo la chiusura: in tal caso quei nuovi debiti d’imposta restano dovuti.
In virtù di queste esclusioni, va da sé che i debiti derivanti da reato, in particolare i risarcimenti alle parti civili e le multe penali, non potranno mai essere definitivamente scaricati. Il debitore dovrà quindi tenerne conto nella formulazione di un piano o accordo. Da un lato, può includerli tra i debiti da ristrutturare, perché nulla vieta di proporre alle vittime un pagamento parziale nell’ambito del piano; dall’altro, però, se la parte offesa non acconsente e vota contro (nel concordato) o fa opposizione (nel piano del consumatore), il giudice difficilmente omologherà un piano che impera un taglio del risarcimento alla vittima di reato. La giurisprudenza ante-riforma spesso riteneva inammissibili piani del consumatore che non prevedevano il pagamento integrale dei crediti da illecito, proprio in ragione dell’art. 14-terdecies. Col nuovo Codice non ci sono pronunce di legittimità note su questo specifico punto, ma è ragionevole attendersi un atteggiamento prudente: in genere, il debitore che voglia una composizione della crisi farebbe bene a prevedere il pagamento completo (magari dilazionato) dei risarcimenti alle vittime e delle eventuali multe, così da ottenere il loro assenso o almeno non incorrere in opposizioni morali del tribunale. Si consideri inoltre che, se anche il piano prevedesse uno stralcio di tali crediti e venisse omologato, la parte non pagata non sarebbe comunque estinta: dopo la procedura, la vittima potrebbe tornare a chiedere la differenza. Ciò rende di fatto poco utili piani che non soddisfino integralmente questi creditori “sensibili”.
Un discorso a parte vale per i debiti tributari oggetto di reato (es. l’IVA evasa in un’omessa dichiarazione, o contributi previdenziali non versati). In quanto debiti erariali, essi possono essere trattati nelle procedure di sovraindebitamento con le regole proprie (che prevedono ad esempio che l’IVA non può essere falcidiata se non viene soddisfatto almeno il tanto che avrebbe ricavato in una liquidazione – regola del “trattamento dei crediti tributari” introdotta di recente). Però, se dal mancato pagamento di quelle imposte è derivato un reato tributario e una condanna, il debitore dovrà comunque pagare anche la pena pecuniaria (multa) prevista dalla sentenza e le eventuali sanzioni tributarie amministrative: tutte somme non falcidiabili per i motivi detti sopra. Inoltre, per alcuni reati tributari (come l’omesso versamento IVA) la legge penale prevede che il pagamento integrale del debito tributario prima del dibattimento estingua il reato: ciò potrebbe essere un incentivo a trovare le risorse e pagare quelle tasse piuttosto che confidare in uno stralcio concorsuale, poiché lo stralcio non eviterà la condanna penale se il pagamento non è integrale e tempestivo. È un aspetto importante di coordinamento tra piano di rientro e difesa penale: ad esempio, un imprenditore imputato per reati fiscali gravi potrebbe preferire chiedere un termine per pagare il fisco ed evitare la condanna (beneficiando della causa di non punibilità), piuttosto che inserire quel debito in un accordo di sovraindebitamento al 50%: la seconda strada gli lascerebbe comunque la condanna e la tagliola dell’art. 280. Queste valutazioni richiedono un approccio integrato tra avvocato penalista e advisor della crisi.
Riassumendo, per il debitore condannato è fondamentale capire che:
- I debiti penali (multe, ammende) e i debiti per risarcimenti da reato restano fuori dalla “grazia” dell’esdebitazione. Anche dopo il procedimento di sovraindebitamento, quelle obbligazioni perdureranno finché non estinte.
- Nella strategia di gestione del sovraindebitamento, conviene prevedere il pagamento quanto più integrale possibile di tali debiti “protetti” se si vuole arrivare a una soluzione concreta. Ad esempio, se il debitore ha 100.000 € di debiti totali di cui 20.000 € per multa penale e 30.000 € per risarcimento danni, è bene allocare risorse per coprire quei 50.000 € in maniera robusta, magari riducendo la soddisfazione degli altri creditori chirografari, i quali potranno essere falcidiati con meno problemi. Del resto, i creditori ordinari possono vedersi falcidiare i crediti definitivamente, questi creditori speciali no.
- In liquidazione controllata, il liquidatore ricomprenderà comunque questi crediti nel passivo e li soddisferà secondo grado. Al termine, però, se non sono stati pagati integralmente, non saranno inesigibili nei confronti del debitore (contrariamente agli altri). Di conseguenza, lo Stato o la vittima potranno riprendere le azioni esecutive individuali post-esdebitazione per recuperare la parte non ottenuta in concorso.
- Il debitore che usufruisce dell’esdebitazione dell’incapiente non è esonerato dal saldare eventuali debiti per mantenimento o risarcimenti di danni: quell’istituto cancella i debiti concorsuali, ma concettualmente gli alimenti e i risarcimenti da illecito non fanno neppure parte del concorso, essendo esclusi per legge. Ad esempio, un incapiente con solo debiti da risarcimento a una vittima non potrà probabilmente accedere all’esdebitazione perché mancherebbe il presupposto (non è un indebitamento “civile” ordinario ma da illecito, e in più non ne trarrebbe beneficio perché quel debito rimane).
Tabella riepilogativa – Trattamento dei debiti “particolari” nelle procedure di sovraindebitamento:
| Tipo di debito | Inclusione in piano/liquidazione? | Esdebitabile (cancellabile)? |
|---|---|---|
| Obblighi di mantenimento e alimentari (es. assegni familiari) | Inclusi solo formalmente, ma spesso considerati estranei al concorso. | ❌ NON esdebitati. Restano sempre dovuti. |
| Risarcimenti danni da fatto illecito (es. delitti) | Possono essere inclusi nei piani, ma creditori difficilmente accettano decurtazioni. | ❌ NON esdebitati. La parte non pagata resta a carico del debitore. |
| Sanzioni penali pecuniarie (multe, ammende) | Il piano può prevederne il pagamento dilazionato, ma non la falcidia senza consenso Stato. | ❌ NON esdebitate. Devono comunque essere pagate per intero, prima o dopo. |
| Sanzioni amministrative pecuniarie (multe stradali, tributarie) | Come sopra, possibile rateazione in piano se PA acconsente. | ❌ NON esdebitate (se non accessorie a debiti estinti). |
| Debiti fiscali ordinari (imposte, tasse) | ✅ Sì, inclusi con eventuale falcidia nel rispetto delle norme (es. privilegio da soddisfare almeno in parte). | ✅ Sì, esdebitabili** in generale, salvo debiti emersi post, art. 280 c.3】. |
| Debiti previdenziali (contributi) | ✅ Sì, similmente ai tributi (Regole speciali per privilegiati). | ✅ Sì, esdebitabili. |
| Crediti assistiti da pegno/ipoteca (garanzie reali) | ✅ Sì, inclusi. I piani possono prevedere stralcio solo col consenso del creditore o se il valore del bene è inferiore al credito (falcidia con liquidazione del bene). | ✅ Sì, dopo esecuzione delle garanzie l’eventuale debito residuo può essere esdebitato (per creditore fondiario vedi eccezione esecuzione). |
| Debiti verso creditori privilegiati (erario, dipendenti, ecc.) | ✅ Sì, ma occorre generalmente assicurare pagamento parziale minimo pari al realizzo su liquidazione o rispettare cause legittime di prelazione in caso di liquidazione. | ✅ Sì, la quota non soddisfatta viene esdebitata, salvo eccezioni di legge (es. alcuni nuovi debiti fiscali scoperti). |
(Legenda: ✅ = sì; ❌ = no. “Esdebitabili” = vengono cancellati residui; “non esdebitati” = il residuo rimane dovuto.)
Come appare dalla tabella, i debiti legati a condotte illecite (familiari o verso terzi o pubbliche amministrazioni) ricevono un trattamento di favore per i creditori: restano esclusi dalla liberazione. Questa è una precisa scelta di policy legislativa per bilanciare l’interesse pubblico e delle vittime con quello del debitore. Del resto, procedure come il sovraindebitamento non possono diventare un “escamotage” per eludere l’obbligo di risarcire chi ha subito un danno da reato o per non pagare la punizione pecuniaria inflitta dal giudice. Il debitore deve esserne consapevole e programmare la propria uscita dalla crisi tenendo conto di questi pesi morti che non si sganceranno automaticamente.
Un’ultima notazione: se un soggetto ha solo debiti da risarcimento danni derivanti da reato, tecnicamente potrebbe non essere ammesso al sovraindebitamento, perché la legge (art. 2, c.1, L.3/2012 e ora art. 65 CCII) parla di sovraindebitamento come “situazione di difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni diverse da quelle ex art. 1 LF”, ma non esclude quelle da illecito. Tuttavia, in passato alcuni tribunali erano restii a omologare piani dove l’unico creditore era la vittima di reato con un debito da danni, ritenendo che quell’obbligazione non potesse formare oggetto di esdebitazione. Oggi, con la norma chiara sulle esclusioni, il debitore può accedere comunque alla procedura, ma sapendo che quello specifico debito rimarrà. Ad esempio, un consumatore che avesse solo un ingente debito di risarcimento per lesioni potrebbe comunque chiedere un piano del consumatore per dilazionare il pagamento in modo sostenibile: il giudice può omologarlo se ciò aiuta la vittima a recuperare in parte e non c’è pregiudizio per altri. La liberazione totale però non interverrà finché l’obbligazione risarcitoria non è soddisfatta o finché le parti non si accordino.
Il punto di vista del debitore: consigli pratici e domande frequenti
Dal complesso scenario fin qui tracciato, emerge chiaramente che un debitore sovraindebitato che abbia sul groppone anche problemi penali deve muoversi con grande attenzione, possibilmente facendosi assistere da professionisti sia sul versante concorsuale sia su quello penale. In questa sezione adottiamo il punto di vista pratico del debitore, fornendo alcuni consigli utili e rispondendo alle domande più comuni (FAQ) che possono sorgere. L’obiettivo è rendere più chiaro e operativo quanto detto sopra, in modo che chi si trova in queste circostanze sappia cosa fare e cosa evitare.
Domanda: “Ho dei precedenti penali: posso comunque accedere a una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata)?”
Risposta: Sì. L’accesso alle procedure non è precluso dalla mera pendenza di precedenti penali. La legge non vieta a un condannato di presentare domanda di composizione della crisi o di liquidazione. Tuttavia, come abbiamo visto, ciò che può essere compromessa è la possibilità di ottenere l’esdebitazione finale. In altre parole, puoi avviare la procedura, concludere un accordo o liquidare i beni, ma se sei stato condannato per taluni reati gravi non ti verrà concessa la liberazione dai debiti residui. Questo vale soprattutto per condanne relative a reati finanziari/fallimentari (bancarotta fraudolenta, ecc.). Quindi l’istanza di ammissione può essere accolta, ma la chiusura liberatoria potrebbe esserti negata. Ciò detto, anche come condannato puoi comunque usufruire di alcuni benefici: ad esempio, la procedura sospende le azioni esecutive dei creditori (tranne il caso speciale del creditore fondiario già visto) e permette di rateizzare i pagamenti o vendere beni in modo ordinato. Pertanto, valutare la procedura può avere senso lo stesso, specie se vuoi evitare pignoramenti e guadagnare tempo. Sii però consapevole che, senza esdebitazione, dopo la procedura i creditori potrebbero rivalersi su di te per l’eventuale debito non pagato.
Domanda: “Quali sono esattamente i reati che impediscono l’esdebitazione?”
Risposta: Sono principalmente i reati fallimentari e societari gravi e quelli contro l’economia pubblica. In particolare: la bancarotta fraudolenta (di qualsiasi tipo), i reati in materia di aggiotaggio, illecita concorrenza, frodi nei commerci, ecc., i reati contro l’industria e commercio (contraffazioni, frodi commerciali), e ogni altro delitto doloso connesso all’attività d’impresa. Questo ultimo punto ricomprende ad esempio reati tributari come frode fiscale (es. emissione di fatture false) o truffa ai danni dello Stato, se commessi nell’ambito dell’impresa. Anche il riciclaggio di proventi illeciti o altri reati finanziari possono rientrare. Al contrario, reati comuni non economici (es. reati contro la persona, reati stradali, ecc.) non rientrano tra quelli ostativi di per sé. Quindi se hai, poniamo, una condanna per lesioni personali, questa non è nella lista e non blocca l’esdebitazione sul piano normativo (fermo restando che i debiti da risarcimento lesioni non saranno cancellati, come detto). Da ultimo, contano solo le sentenze passate in giudicato (o patteggiate ex art.444 c.p.p.). Un’indagine o un processo in corso comportano sospensione, ma non esclusione automatica finché non c’è verdetto finale. E ricorda: se sei stato riabilitato, quel reato non vale più come ostativo.
Domanda: “Sono imputato in un processo per bancarotta fraudolenta. Posso presentare lo stesso domanda di sovraindebitamento? Cosa succede se la presento?”
Risposta: Puoi presentarla, perché la pendenza di un procedimento non blocca in sé la procedura concorsuale. Se la tua domanda di, ad esempio, liquidazione controllata viene ammessa, la procedura andrà avanti normalmente, i beni saranno liquidati e i creditori soddisfatti pro quota. Tuttavia, il decreto di esdebitazione finale verrà sospeso in attesa dell’esito del tuo processo penale. In pratica, dovrai aspettare la conclusione di tutti i gradi di giudizio penale. Se sarai assolto, allora il tribunale potrà concederti l’esdebitazione (postuma). Se invece sarai condannato definitivamente per bancarotta fraudolenta, la tua condanna rientra tra quelle ostative, quindi non ti verrà concessa l’esdebitazione: resterai responsabile dei debiti non pagati. In sintesi, avviare la procedura ti può aiutare a gestire i debiti nell’immediato (evitando caos esecutivo, etc.), ma la liberazione completa è appesa all’esito penale. Valuta con i tuoi legali se eventualmente sia opportuno attendere l’esito del processo prima di chiudere la procedura concorsuale, oppure tentare come dicevamo un patteggiamento rapido e riabilitazione. Sono scelte delicate da ponderare caso per caso.
Domanda: “Ho una condanna per bancarotta semplice, non fraudolenta. È un problema?”
Risposta: La bancarotta semplice (ad es. per cattiva tenuta delle scritture o per aver aggravato il dissesto) non è espressamente indicata tra i reati ostativi. Dunque in teoria una condanna solo per bancarotta semplice non ti impedisce di ottenere l’esdebitazione. Addirittura c’è stata giurisprudenza che ha concesso l’esdebitazione a un fallito condannato per bancarotta semplice proprio motivando che quel reato non era contemplato tra quelli ostativi. Tuttavia, attenzione: la bancarotta semplice implica che il debitore ha quantomeno tenuto comportamenti imprudenti o irregolari nella gestione. Questo potrebbe comunque essere valutato negativamente dal giudice sotto il profilo della mancanza di diligenza. In concreto però, se non ci sono altri profili di malafede, non essendo un reato doloso di frode, dovresti poter accedere al beneficio. In breve: bancarotta semplice non blocca automaticamente l’esdebitazione, a differenza di quella fraudolenta che invece sì al 100%.
Domanda: “Ho dei debiti enormi con il Fisco per cui sono stato anche condannato penalmente (reati tributari). Posso cancellarli col sovraindebitamento?”
Risposta: I debiti fiscali in quanto tali possono essere inclusi in un piano o accordo di sovraindebitamento e parzialmente falcidiati, rispettando però le regole speciali (in genere devi pagare almeno la parte dei tributi privilegiati in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione, salvo diverso accordo col Fisco). Se riesci a ottenere l’omologazione, e completi la procedura, la parte di imposte non pagata verrà esdebitata – tranne eventuali imposte accertate dopo come “sopravvenienze”. Tuttavia, la condanna penale per reati tributari gravi (es. dichiarazione fraudolenta, omesso versamento IVA sopra soglia) è considerata un reato connesso all’attività d’impresa, dunque rientra fra quelli ostativi. Ciò significa che, se la condanna è definitiva e non sei riabilitato, non avrai diritto all’esdebitazione malgrado la procedura. Puoi sempre sperare di trattare col Fisco un piano dilazionato (magari sfruttando la procedura per bloccare provvisoriamente le azioni esecutive), ma la cancellazione del debito fiscale residuo non ti sarà concessa se quel debito deriva da un tuo illecito penale. Inoltre, come accennato, per alcuni reati tributari il pagamento integrale del dovuto entro certi termini fa ottenere l’estinzione del reato: se punti a evitare la condanna (o a ottenere la non punibilità), la via maestra è pagare il Fisco direttamente, più che sperare nello stralcio concorsuale. Quindi, in sintesi: sì, puoi includere debiti fiscali (e contributivi) nel sovraindebitamento; no, non puoi evitare la condanna penale se non li paghi integralmente; e se sei già condannato, quella condanna potrebbe bloccarti l’esdebitazione (a meno di riabilitazione).
Domanda: “La vittima di un reato da me commesso è mio creditore per danni. Cosa accade al suo credito se ottengo l’esdebitazione?”
Risposta: Il credito della vittima per risarcimento del danno da reato non viene cancellato dall’esdebitazione. Come spiegato, i debiti da fatto illecito restano esclusi dal beneficio. Pertanto, anche se completi la procedura, la vittima potrà ancora esigere da te la parte di risarcimento non pagata durante la procedura. Facciamo un esempio: hai truffato qualcuno per 100.000 €; in sede di liquidazione controllata, quella persona riceve una ripartizione di 20.000 € (20%); tu chiedi l’esdebitazione e in generale la ottieni perché magari non hai altre condanne ostative; ebbene, quei 80.000 € residui di danno non sono esdebitati: il creditore potrà agire contro di te per recuperarli (potrà pignorare eventuali beni futuri, stipendio, ecc.). Per questo, se possibile, cerca di trovare un accordo con la vittima all’interno del piano – magari offrendo un pagamento concordato – altrimenti rischi di chiudere la procedura ma restare comunque indebitato con lei.
Domanda: “Ho una multa penale da 5.000 € impostami dal Tribunale. Posso farla rientrare e non pagarla tutta?”
Risposta: No, le sanzioni penali pecuniarie non possono essere falcidiate né tantomeno condonate dal giudice concorsuale. La multa penale devi pagarla per intero, punto. Ciò che puoi fare è includerla nel piano di ristrutturazione per pagarla magari a rate, oppure in caso di liquidazione il liquidatore la considererà come credito privilegiato dello Stato da soddisfare col ricavato. Ma se dovesse rimanere anche solo un centesimo impagato, quello centesimo continuerà a essere dovuto dopo l’esdebitazione. In altri termini, la presenza di multe e ammende impone di predisporre un piano finanziario che ne preveda il pagamento integrale (magari attingendo a risorse di terzi se tu sei incapiente), altrimenti rischi la revoca della sospensione condizionale della pena (se la multa era legata a una pena sospesa, il mancato pagamento la fa revocare) e, in ogni caso, ti troverai con un debito verso l’erario non eliminato. Quindi: paga le multe penali, se possibile già durante la procedura.
Domanda: “Che succede ai debiti che non vengono esdebitati? Come posso gestirli?”
Risposta: I debiti esclusi (mantenimento, risarcimenti, multe) rimangono legalmente esigibili. Ciò significa che, dopo la chiusura della procedura, i creditori titolari di tali crediti potranno riprendere o iniziare le azioni per recuperarli, senza violare il decreto di esdebitazione (che appunto non li copre). Come gestirli? Le opzioni sono: 1) cercare un accordo transattivo privato con quei creditori (ad es. offrire un saldo e stralcio); 2) se il creditore è lo Stato (multe), valutare se è possibile chiedere una rateizzazione amministrativa o attendere eventuali definizioni agevolate/fiscalizzazioni (talvolta le leggi di bilancio prevedono condoni parziali per multe stradali o simili, ma non è garantito); 3) nei casi estremi, qualora questi debiti “non cancellabili” siano comunque troppi da sostenere, l’unica sarebbe affidarsi nuovamente a un percorso dilazionato volontario (ma non esistono altre procedure concorsuali per cancellarli). Ad esempio, se hai ancora €50.000 di risarcimento da pagare a una vittima, potresti convenire con il suo avvocato un piano di rientro su base privata per evitare che ti pignori in blocco; oppure, se hai reddito ma non patrimonio, potrà pignorarti in piccola parte lo stipendio finché saldi. Non è piacevole, ma almeno avrai eliminato tutti gli altri debiti e potrai concentrarti su questo. L’importante è non farsi trovare impreparati: saper che quei debiti restano ti evita di pensare – erroneamente – di essertene liberato e poi magari subire un’esecuzione a sorpresa anni dopo.
Domanda: “Posso fare qualcosa per superare l’ostacolo della mia condanna e ottenere comunque l’esdebitazione?”
Risposta: L’unico strumento legale per neutralizzare l’effetto di una condanna ostativa è la riabilitazione penale. Se riesci a ottenerla, la condanna non sarà più causa di diniego. Pertanto, verifica con il tuo legale se ne hai i requisiti (di solito: almeno 3 anni dal fine pena, condotta buona, obblighi civili soddisfatti o inesigibilità degli stessi provata). In alcuni casi, per accelerare puoi, come detto, valutare il patteggiamento (se sei ancora a processo) per poi attendere il tempo e chiedere la riabilitazione il prima possibile. Ottenuta la riabilitazione, la tua posizione rispetto all’esdebitazione diventa come quella di un incensurato (limitatamente a quell’aspetto; ovviamente i debiti da reato restano, ma almeno non avrai il marchio di reato ostativo). Quindi sì, la strada è la riabilitazione. Non ci sono invece “deroghe” nella legge fallimentare o nel CCII che consentano al giudice di ignorare una condanna ostativa per particolare tenuità o circostanze attenuanti: se c’è, c’è, e blocca. Solo la riabilitazione la cancella. Infine, ricorda: se la condanna era con pena sospesa, è importante pagare la multa e comportarti bene nel periodo di sospensione, altrimenti rischi la revoca della sospensione e l’esecuzione della pena, e questo ovviamente peggiorerebbe la tua situazione generale.
Domanda: “Cosa devo dichiarare nella domanda di sovraindebitamento riguardo ai miei precedenti penali?”
Risposta: Devi dichiarare tutto con trasparenza. Nel ricorso introduttivo e nella relazione dell’OCC è previsto che siano indicati eventuali procedimenti o condanne a carico del debitore, perché ciò è rilevante ai fini dell’ammissibilità e dell’omologazione. Non nascondere mai di avere subito condanne o di essere imputato: sarebbe un grave errore e configurerebbe un atto in frode ai creditori e al giudice. Anzitutto perché tanto verrà richiesto il casellario giudiziale e i carichi pendenti (molti tribunali lo pretendono come allegato), dunque la verità verrebbe scoperta; in secondo luogo, omettere un precedente equivarrebbe a violare il dovere di lealtà e potrebbe condurre al rigetto o alla revoca della procedura. Quindi, nella modulistica, se c’è una sezione “eventuali condanne riportate”, compilala indicando le sentenze (numero, reato, data, esito). Se sei sotto processo, segnala che è pendente procedimento per il reato X dinanzi al Tribunale Y. Sarà poi il giudice, valutate le circostanze, a decidere se sospendere l’esdebitazione in attesa dell’esito o come procedere. La trasparenza è fondamentale: un debitore condannato può ancora sperare nella comprensione del giudice se dimostra ravvedimento e collaborazione, ma un debitore che mente o occulta informazioni si gioca qualsiasi fiducia.
Domanda: “In caso di società o ditta con soci, la condanna di uno dei soci cosa comporta?”
Risposta: Il Codice prevede espressamente che, se a chiedere l’esdebitazione è una società di persone, vengano considerate le condotte e le condanne dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti negli ultimi 3 anni precedenti. In pratica, se la tua è una SNC, SAS o società semplice, la condanna anche di uno solo dei soci illimitatamente responsabili per reato ostativo impedisce l’esdebitazione per la società e per l’intera compagine. Analogamente, se parliamo di una SRL o SPA (che in base alle nuove norme può accedere all’esdebitazione post-liquidazione giudiziale), rilevano le condotte degli amministratori: un amministratore condannato per bancarotta fraudolenta, ad esempio, precluderà il beneficio alla società a meno che non siano trascorsi più di 3 anni dalla sua gestione o non sia stato sostituito prima. Dunque, a livello di imprese collettive, la presenza di soggetti “disonesti” al timone incide in negativo. Per l’imprenditore individuale, invece, vale ciò che abbiamo detto sinora: la sua condanna è la condanna del debitore stesso. In conclusione: se operi come società e uno dei tuoi soci ha precedenti gravi, purtroppo la società non potrà ripulirsi finché quel socio rimane o se la condanna è recente. Conviene valutare di escludere quel socio dalla compagine e attendere il decorso di tre anni, oppure puntare su una procedura diversa (es. un accordo di ristrutturazione dei debiti “in bonis” se possibile).
Domanda: “Quante volte posso ottenere l’esdebitazione? Una condanna incide anche su questo aspetto?”
Risposta: La legge stabilisce dei limiti di frequenza: un consumatore può ottenere l’esdebitazione al massimo due volte in vita sua, con almeno 5 anni di distanza tra l’una e l’altra. Un debitore non consumatore (es. imprenditore minore) può teoricamente ristrutturare i debiti più volte, ma non può ottenere il concordato minore più di due volte (sempre con 5 anni di intervallo) e, quanto all’esdebitazione post-liquidazione, anch’essa non può concedersi se già avuta nei 5 anni precedenti. Le condanne penali non modificano questi numeri, ma è chiaro che un recidivo del sovraindebitamento con condanna avrà difficoltà enormi a convincere un giudice della propria buona fede per un secondo fresh start. In pratica, la prima volta può essere sfortunato, la seconda già è guardato con sospetto (a meno di casi particolari, il giudice potrebbe rigettare per abuso), la terza è quasi impossibile. Dunque pianifica di usare questa “carta” con saggezza, perché non è infinita. E se hai avuto un’esdebitazione e poi commesso un reato ostativo entro 5 anni, scordati di ripresentare un’ulteriore domanda finché non passa il tempo e non hai risolto la questione penale (magari con riabilitazione).
Domanda: “Durante il piano devo rispettare qualche obbligo legato alla condanna (es. servizi sociali, limitazioni)? La procedura influisce su questo?”
Risposta: La procedura di sovraindebitamento non interferisce con l’esecuzione della pena o delle misure penali. Se sei affidato in prova ai servizi sociali, in detenzione domiciliare, ecc., dovrai continuare a rispettare le prescrizioni indipendentemente dal sovraindebitamento. Allo stesso modo, se la condanna comportava un’interdizione (es. dal commercio), quella interdizione resta operativa: il fatto che tu abbia una procedura concorsuale non ti autorizza a riprendere attività precluse. Certo, l’OCC e il tribunale valuteranno la tua situazione personale: ad esempio, se sei detenuto, potrai farti rappresentare da un procuratore o dal Gestore OCC per gli adempimenti. Oppure, se avevi l’interdizione da incarichi societari, potresti non poter amministrare direttamente i beni: in tal caso sarà il liquidatore a farlo, quindi non cambia nulla. In sintesi, rispetta sempre le misure penali in corso, perché un loro mancato rispetto (es. la revoca di un affidamento in prova per condotta scorretta) peggiorerebbe notevolmente la tua posizione anche agli occhi del giudice concorsuale. Da parte sua, la procedura di sovraindebitamento non ti protegge da eventuali misure di sicurezza o coercitive penali. Ti protegge solo dai creditori civili.
Domanda: “Dopo la conclusione della procedura (ad esempio liquidazione controllata) senza esdebitazione perché avevo una condanna, potrò comunque chiedere l’esdebitazione in futuro se la situazione cambia?”
Risposta: La legge non prevede espressamente un secondo “giro” di esdebitazione su quegli stessi debiti. In pratica, se al termine della liquidazione controllata non ottieni l’esdebitazione a causa di condanna, la procedura si chiude lo stesso e i creditori residui restano liberi di agire. Se successivamente dovessi ottenere la riabilitazione o venissi assolto in appello, teoricamente potresti provare a presentare una nuova procedura per quei debiti rimasti, ma questo in molti casi non sarà fattibile (perché i creditori magari avranno già agito e comunque il tribunale potrebbe non ammettere di “replicare” la procedura solo per l’esdebitazione che non avevi ottenuto). Alcuni autori ipotizzano che, se entro un anno dalla chiusura della liquidazione sopravviene l’assoluzione, tu possa riaprire la questione con un’istanza tardiva di esdebitazione, ma non c’è una norma chiara in merito. Diciamo che conviene far trovare al giudice un titolo riabilitativo entro la fine della procedura stessa. Se ciò non accade, la partita è perlopiù chiusa in senso negativo. Nulla vieta, se nel frattempo non sei stato spogliato di tutto, che alcuni anni dopo, con situazione diversa, tu faccia un altro tentativo di sovraindebitamento: ma dovresti avere nuovi asset o nuova capacità da mettere in gioco, altrimenti presenterebbe profili di abuso. Quindi il succo è: meglio concentrare gli sforzi per soddisfare le condizioni durante la procedura in corso (ad es. ottieni la riabilitazione il prima possibile e chiedi al giudice di attendere quella prima di negare l’esdebitazione).
Domanda: “Ho sentito parlare di meritevolezza del debitore: in che cosa consiste e come incide la mia condanna su di essa?”
Risposta: La meritevolezza è un concetto presente soprattutto nella procedura del piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore). Significa che il giudice valuta se il consumatore abbia assunto i debiti con colpa grave o dolo oppure se abbia tenuto comportamenti imprudenti. Se risulta che, ad esempio, hai fatto spese folli oltre ogni logica o che hai contratto prestiti senza alcuna possibilità di restituirli (credito colposo e sproporzionato), potresti essere ritenuto non meritevole e il piano verrebbe rigettato. Ebbene, una condanna penale può indirettamente riflettere una mancanza di meritevolezza se il reato è correlato alla tua situazione debitoria. Esempio: se sei condannato per truffa ai danni di banche (hai ottenuto finanziamenti con documenti falsi), chiaramente non sei meritevole di un piano del consumatore, perché hai agito con dolo nel creare il debito; il giudice rigetterà per mancanza di buona fede. Viceversa, se la tua condanna è per un fatto scollegato (es. reato stradale) e non ha implicato indebitamento, non incide sulla valutazione dei debiti contratti. In generale, il parametro di meritevolezza nel piano del consumatore è orientato alla condotta del debitore verso i creditori: aver commesso reati finanziari spesso coincide con aver violato la fiducia creditoria, quindi è causa di inammissibilità del piano. Nelle altre procedure (concordato minore, liquidazione) la meritevolezza non è richiesta in ingresso, ma alcune condotte rilevano comunque (atti in frode, ecc.). In sintesi: la tua condotta penalmente rilevante sarà valutata dal giudice concorsuale anche sotto il profilo della correttezza e buona fede; una condanna per frode, riciclaggio, ecc. è un cattivo biglietto da visita e potrebbe farti escludere già in fase iniziale (oltre al problema finale dell’esdebitazione). All’opposto, se la condanna riguarda fatti che non attengono ai debiti (ad es. reati passionali, reati colposi non economici), il giudice potrà non considerarla ostativa al piano, fermo restando l’effetto tecnico sulla non esdebitabilità di eventuali debiti da risarcimento di quel reato.
Domanda: “Ho pagato alcuni creditori prima di altri recentemente per via di pressioni. Questo crea problemi?”
Risposta: Sì, potrebbe creare problemi. Pagare alcuni creditori in prossimità della procedura (nei 6 mesi precedenti la domanda) può essere considerato un atto in frode o almeno un pagamento preferenziale vietato. La legge richiede parità di trattamento: se hai soddisfatto un creditore (magari un parente o un fornitore amico) e hai lasciato a bocca asciutta gli altri, il tribunale potrebbe rigettare o revocare la procedura. Dal punto di vista penale, questo non ti riguarda se non hai commesso reato (a meno che fosse una bancarotta preferenziale in caso di fallimento, ma qui siamo nel sovraindebitamento); tuttavia come debitore devi comunque evitare di alterare la par condicio. Se l’hai fatto, dichiara con onestà nella domanda quei pagamenti e spiega il perché (es. pignoramento in corso, ecc.): l’OCC lo riporterà e il giudice valuterà. È meglio ammettere che nascondere – perché se viene fuori dopo, appare come atto doloso. In alcuni casi, pagamenti “di necessità” (es. saldare l’affitto per non essere sfrattato) possono essere giustificati. Ma pagare ad esempio un debito verso un familiare e non pagare Equitalia potrebbe essere visto male. In ogni caso, non c’entra con la condanna penale, ma incide sulla credibilità del debitore.
Domanda: “Devo coinvolgere un avvocato penalista nel mio sovraindebitamento?”
Risposta: Se hai pendenze penali serie, la collaborazione tra il tuo avvocato penalista e il professionista che ti segue nella crisi (avvocato civilista o commercialista gestore) è altamente raccomandata. Ci sono vari punti di contatto: ad esempio, decidere se presentare subito la domanda concorsuale o aspettare l’esito penale; valutare se un patteggiamento può aiutare i tempi; considerare gli effetti di un pagamento a fini estinzione reato; predisporre memorie al giudice concorsuale spiegando la tua posizione in ambito penale (ad es. se sei in attesa di appello e confidando nell’assoluzione chiedere una proroga della sospensione). Un penalista sa muoversi per ottenere la riabilitazione appena possibile, sa consigliare se chiedere misure alternative (che potrebbero permetterti di continuare a lavorare e pagare i debiti) ecc. D’altro canto, il consulente della crisi deve fornire al penalista i dati finanziari per eventuali offerte risarcitorie alle parti civili. Insomma, è fondamentale un approccio multidisciplinare. Molte Camere Penali e Camere Civili consigliano di creare team integrati in questi casi. Se il tuo avvocato penalista non è pratico di procedure concorsuali, fagli comunque leggere questa guida per fargli capire le implicazioni, e viceversa, assicurati che il gestore della crisi sappia del tuo procedimento penale. La comunicazione e la trasparenza con i professionisti che ti assistono sono la chiave per avere una strategia efficace.
Conclusioni
Affrontare un sovraindebitamento quando si ha anche il fardello di una condanna penale può sembrare un’impresa scoraggiante, ma non è impossibile. Come abbiamo visto, la legge italiana – pur giustamente severa nel negare facili “sconti” a chi si è macchiato di reati gravi – offre comunque dei percorsi attraverso cui il debitore può provare a riemergere. È fondamentale, in tali situazioni, conoscere bene i propri diritti e i propri doveri: sapere in anticipo quali condanne impediscono l’esdebitazione, quali debiti non saranno cancellati comunque, quali comportamenti il giudice si aspetta (collaborazione, trasparenza) e quali invece verranno sanzionati (frodi, reticenze). Aggiornarsi sulle novità normative è altrettanto importante: la materia è stata oggetto di riforme recenti (2020-2022) e la giurisprudenza più recente – ad esempio della Cassazione nel 2024 – sta chiarendo molti punti applicativi (come quello del creditore fondiario in liquidazione controllata).
Dal punto di vista pratico, il debitore con precedenti penali deve essere ancor più scrupoloso e strategico. Scrupoloso nel fornire tutte le informazioni corrette all’OCC e al tribunale (nessun dettaglio deve essere omesso, specie riguardo a condanne o procedimenti) e nel rispettare ogni paletto procedurale. Strategico nel coordinare le vicende penali con quelle concorsuali: ad esempio valutando se sia opportuno accelerare la definizione del processo penale per poter poi ottenere la riabilitazione e quindi l’esdebitazione. Oppure decidendo come allocare le (poche) risorse disponibili: spesso conviene destinare le risorse a pagare i crediti “non esdebitabili” (multe, risarcimenti) e proporre falcidie maggiori sugli altri debiti, poiché i primi comunque resteranno.
Un messaggio importante che emerge dalla disciplina è che l’ordinamento premia il debitore onesto e cooperativo, anche se fallibile, mentre non mostra indulgenza verso chi ha agito con dolo. Ciò si riflette nel favor debitoris ricordato da Cass. 15246/2022: il beneficio va concesso al sovraindebitato onesto salvo che il pagamento ai creditori sia nullo o irrisorio. Ma quando il debitore è stato disonesto (soprattutto penalmente disonesto), scatta un favor creditoris: la legge tutela l’interesse pubblico a non azzerare i debiti derivanti da reato. In quest’ottica, il debitore condannato deve compiere un percorso di riabilitazione morale e materiale: dimostrare di voler risarcire il possibile, di cambiare condotta, e – ove possibile – ottenere anche la formale riabilitazione in sede penale. Solo così potrà aspirare, forse non subito ma nel tempo, a quella “fresh start” che costituisce la finalità ultima dell’esdebitazione.
Chiudiamo ribadendo un consiglio: affidarsi a professionisti esperti. Le vicende qui trattate sono complesse, incrociano diritto penale, fallimentare, civile e tributario. Un avvocato o consulente specializzato saprà guidarti tra le insidie e magari individuare soluzioni creative (ad esempio inserire clausole nel piano che subordinano l’esdebitazione alla riabilitazione ottenuta, o concordare con i creditori particolari trattamenti). Inoltre, mantenere un atteggiamento proattivo e trasparente con il tribunale può giocare a tuo favore: ci sono casi in cui, pur in presenza di qualche ombra, i giudici hanno apprezzato la volontà del debitore di rimediare e hanno concesso fiducia (magari condizionata). L’obiettivo del legislatore non è punire il sovraindebitato, ma evitare abusi: se dimostri di non voler abusare ma solo di risolvere con dignità la tua situazione, il sistema concorsuale può ancora offrirti una via d’uscita.
In definitiva, sovraindebitamento e condanna penale formano un binomio delicato ma gestibile. Questa guida ha cercato di fornire un quadro completo e aggiornato a luglio 2025 delle principali cose da sapere. Ricorda però che ogni storia è a sé: usa queste informazioni come base, ma poi calale nella tua situazione concreta con l’aiuto di un esperto. Solo così potrai sperare di voltare pagina, sia nei confronti dei tuoi creditori che della giustizia. Una nuova partenza è possibile, ma richiede impegno, correttezza e – talvolta – pazienza. Buona fortuna nel tuo percorso di risanamento!
Fonti e riferimenti normativi
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14), artt. 65-83 (procedure di composizione da sovraindebitamento) e artt. 278-283 (esdebitazione del sovraindebitato).
- Legge 27 gennaio 2012 n.3 (Disciplina del sovraindebitamento), in particolare art. 14-terdecies (esdebitazione).
- Corte Suprema di Cassazione, sez. I civ., sent. 19 agosto 2024, n. 22914 – conferma applicabilità del privilegio processuale del creditore fondiario anche nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII.
- Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ord. 16.4.2021 – in tema di piano del consumatore e colpa del debitore, evidenzia come la valutazione della meritevolezza tenga conto anche della condotta del finanziatore nel concedere credito (principio di merito creditizio).
- Corte di Cassazione, sez. I civ., sent. 12 maggio 2022, n. 15246 – afferma il favor debitoris nell’interpretazione dell’istituto dell’esdebitazione, ribadendo che va concesso salvo casi di assoluta mancanza di soddisfacimento dei creditori.
- Corte Costituzionale, sent. 12 gennaio 2024, n. 6 – ha affrontato questioni sulla durata della procedura di liquidazione controllata e la possibile incostituzionalità della sospensione prolungata per processi penali pendenti (nota in Dirittodellacrisi).
- Linee guida OCC e prassi dei Tribunali (es. Trib. Milano, linee guida sovraindebitamento 2022) – raccomandano di allegare alla domanda il certificato penale e dei carichi pendenti, e di indicare analiticamente eventuali procedimenti o condanne.
Hai una condanna penale e sei anche pieno di debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Se ti trovi in una situazione di sovraindebitamento e hai ricevuto o subito una sentenza penale di condanna, potresti pensare che ogni via d’uscita sia preclusa. Ma non è così.
Anche chi ha precedenti penali può, in alcuni casi, accedere agli strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge. Serve però un’attenta valutazione legale.
Condanna penale e accesso alla procedura: è possibile?
Dipende dal tipo di reato, dalla natura del debito e dalla posizione del debitore.
La legge sul sovraindebitamento (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) non esclude in automatico chi ha avuto problemi penali, ma pone dei limiti.
Puoi accedere alle procedure se:
- ⚖️ Il reato non è connesso ai debiti (es. reati personali o diversi da frodi fiscali)
- 📂 Sei in buona fede e non hai aggravato dolosamente l’indebitamento
- 🧾 I debiti nascono da attività lecite o da obblighi di legge
- 🔁 Sei disponibile a collaborare e presentare un piano credibile di rientro
Quando la condanna blocca l’accesso alla procedura?
Il giudice può negare l’ammissione o revocare il beneficio se:
- ❌ Il sovraindebitamento deriva da comportamenti fraudolenti
- 🚫 Il soggetto è stato condannato per reati tributari, bancarotte, truffe aggravate, riciclaggio
- 🧾 I debiti sono collegati a false documentazioni o dichiarazioni mendaci
- 📉 Non c’è un minimo di meritevolezza o collaborazione da parte del debitore
In presenza di queste condizioni, non si può procedere a esdebitazione.
Cosa si può fare se hai una condanna e sei sovraindebitato?
- 📂 Verifica il contenuto e la motivazione della sentenza penale
- ⚖️ Consulta un avvocato esperto per valutare se sussistono i requisiti di accesso
- ✍️ Predisponi una relazione dettagliata che chiarisca le origini e la natura dei debiti
- 💡 Presenta un piano sostenibile di ristrutturazione o liquidazione controllata
- 🔁 Se possibile, chiedi esdebitazione del residuo dopo la procedura
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📑 Analizza la sentenza penale e la compatibilità con le procedure previste dal Codice della crisi
📂 Ricostruisce la tua posizione debitoria e patrimoniale in chiave difensiva
✍️ Redige il piano o la proposta di accordo per l’OCC o il tribunale
⚖️ Ti rappresenta in giudizio per ottenere l’ammissione o l’esdebitazione
🔁 Ti segue anche dopo la procedura per evitare nuove azioni esecutive
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in sovraindebitamento e responsabilità penale connessa ai debiti
✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per persone fisiche, ex imprenditori e professionisti in difficoltà
Conclusione
Avere una condanna penale non significa rinunciare al diritto di ripartire. Con una difesa adeguata puoi ottenere l’accesso alle procedure di sovraindebitamento e alleggerire il peso dei debiti.
L’Avvocato Giuseppe Monardo può aiutarti a dimostrare la tua meritevolezza, costruire una strategia legale e presentare una proposta seria e credibile.
📞 Contatta ora lo Studio per una consulenza riservata se hai debiti e una sentenza penale: la tua seconda possibilità passa dalla legge.