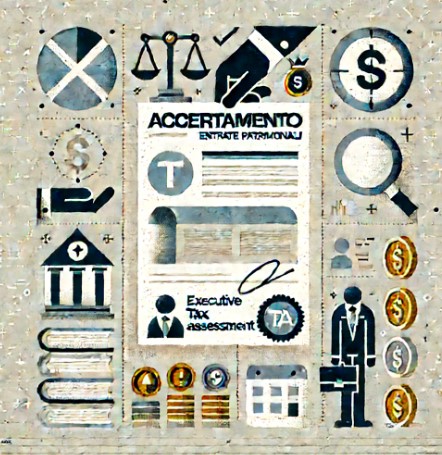Hai ricevuto un accertamento esecutivo per entrate patrimoniali e non sai cosa significa, da dove arriva e soprattutto come difenderti? Ti chiedono soldi per canoni, rette, fitti o servizi comunali e l’atto ha già valore esecutivo?
L’accertamento esecutivo per entrate patrimoniali è uno strumento usato dai Comuni e dagli enti locali per riscuotere crediti diversi da quelli tributari. Ma anche se non si tratta di tasse, l’atto ha valore immediato e può trasformarsi in pignoramento se non agisci nei termini previsti.
Cos’è un accertamento esecutivo per entrate patrimoniali?
– È un atto emesso da un ente pubblico (Comune, Provincia, Ente gestore) per recuperare crediti relativi a servizi, canoni, affitti, rette, mense, scuole, concessioni
– Ha valore di titolo esecutivo, cioè consente all’ente di avviare subito pignoramenti o fermi amministrativi
– Sostituisce la vecchia cartella esattoriale: dalla notifica partono i termini per opporsi
Cosa contiene l’accertamento esecutivo?
– L’importo dovuto, con dettaglio delle voci (canoni, interessi, spese)
– L’indicazione che l’atto ha efficacia esecutiva trascorsi 60 giorni
– Le modalità per pagare o impugnare
– L’avviso che, in mancanza di pagamento o opposizione, l’ente potrà agire coattivamente
Quando è impugnabile e cosa puoi contestare?
– Puoi presentare ricorso al giudice ordinario o amministrativo, a seconda del tipo di credito
– Puoi contestare la prescrizione, il difetto di notifica, l’inesistenza del credito o vizi formali
– Se l’atto è privo di motivazione o fondato su elementi generici o errati, è annullabile
– Se hai già pagato o il credito è stato condonato, prescritto o mai comunicato prima, puoi chiedere l’annullamento
Cosa succede se non fai nulla?
– Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’ente può procedere con:
– Pignoramento del conto corrente
– Fermo amministrativo dell’auto
– Blocco delle somme presso terzi o trattenute sullo stipendio
– Non è necessaria alcuna cartella: l’atto vale già come titolo esecutivo
Cosa puoi fare per difenderti?
– Verificare subito se l’atto è legittimo, fondato e notificato correttamente
– Presentare opposizione al giudice competente entro i termini
– Chiedere una rateizzazione, se il credito è corretto ma non riesci a pagare tutto subito
– Se ci sono vizi evidenti, puoi agire anche in autotutela chiedendone l’annullamento all’ente
Cosa NON devi fare mai?
– Ignorare la notifica: dopo 60 giorni parte l’esecuzione forzata
– Pensare che, siccome non è una tassa, non abbia effetti gravi: il pignoramento arriva lo stesso
– Tentare ricorsi “fai da te” senza capire il giudice competente: puoi perderlo solo per errore procedurale
– Pagare senza controllare: molti atti contengono errori o crediti già prescritti
L’accertamento esecutivo per entrate patrimoniali è uno strumento potente per gli enti locali, ma puoi difenderti. Serve agire subito, con precisione e con le armi giuste.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in opposizione a ingiunzioni e atti esecutivi pubblici – ti spiega cosa significa ricevere un accertamento esecutivo patrimoniale, quando è legittimo e come fermarlo prima che scattino pignoramenti o fermi.
Hai ricevuto un accertamento per entrate patrimoniali e vuoi sapere se puoi annullarlo?
Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso, controlleremo ogni aspetto dell’atto e costruiremo la difesa più efficace per bloccare l’esecuzione e tutelare il tuo patrimonio.
Introduzione
L’accertamento esecutivo è uno strumento introdotto dal legislatore per velocizzare e potenziare la riscossione delle entrate degli enti locali, siano esse tributarie (imposte, tasse) o patrimoniali (entrate diverse dai tributi, come canoni, sanzioni amministrative, tariffe per servizi, ecc.). Introdotto a livello generale con la Legge n. 160/2019 (Bilancio 2020), l’avviso di accertamento esecutivo cumula in un unico atto sia la funzione di accertamento del debito sia la funzione di titolo esecutivo e di precetto per la riscossione forzata. In altre parole, l’ente locale notifica un solo atto al debitore che accerta le somme dovute (ad esempio omessi versamenti di un tributo o di un canone) e contestualmente intima il pagamento entro un termine, avvertendo che, decorso tale termine, l’atto diverrà esecutivo senza bisogno di ulteriori passaggi (come la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale).
Per il debitore (sia esso un privato cittadino, un imprenditore o un professionista), ricevere un accertamento esecutivo significa trovarsi di fronte a una richiesta di pagamento immediatamente seguita da minaccia di esecuzione forzata. Questa guida – aggiornata a giugno 2025 con la normativa vigente e la giurisprudenza più recente – fornisce un’analisi avanzata dell’istituto e indica cosa fare dal punto di vista del debitore. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma con intento divulgativo, rivolgendoci sia ai legali (avvocati) che assistono i contribuenti, sia ai cittadini e imprenditori che vogliono comprendere i propri diritti e le proprie opzioni. Troverete di seguito spiegazioni normative dettagliate, passi pratici da seguire, tabelle riepilogative dei termini e delle azioni possibili, esempi concreti (simulazioni pratiche) e una sezione di Domande & Risposte su dubbi frequenti. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate in fondo alla guida.
Quadro normativo e definizioni
Normativa di riferimento: l’avviso di accertamento esecutivo per le entrate locali è disciplinato principalmente dall’art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Questa norma ha esteso agli enti locali un modello di riscossione già previsto per i tributi erariali (Stato) dal 2010, stabilendo che a partire dagli atti emessi dal 1° gennaio 2020 gli avvisi di accertamento dei tributi locali e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere l’intimazione a pagare e costituiscono essi stessi titoli esecutivi trascorsi i termini di legge. In pratica, dal 2020 gli enti locali non emettono più cartelle esattoriali o ingiunzioni separate per riscuotere coattivamente – l’accertamento diventa esso stesso esecutivo.
La portata di questa riforma è ampia: la riscossione “potenziata” tramite accertamento esecutivo riguarda tutte le entrate degli enti locali indicate dal comma 792. Ciò include sia i tributi locali (IMU, TARI, imposta di pubblicità, addizionali comunali, ecc.) sia le entrate patrimoniali, ossia entrate di diversa natura finanziaria, anche non tributaria, spettanti all’ente. Per entrate patrimoniali si intendono in generale le entrate di diritto pubblico o privato dell’ente locale diverse dalle imposte e tasse. Ad esempio: canoni per utilizzo di beni pubblici, tariffe per servizi comunali, sanzioni amministrative, canoni concessori, oneri di urbanizzazione, affitti di immobili comunali, rette di mense o asili nido, tariffe idriche, ecc.. La dottrina ha distinto le entrate patrimoniali di diritto pubblico (obblighi derivanti da poteri pubblicistici, come sanzioni amministrative e contributi per servizi pubblici) dalle entrate patrimoniali di diritto privato (obblighi derivanti da rapporti contrattuali con l’ente). In entrambi i casi, il comma 792 L.160/2019 mira a fornire a tali crediti dell’ente un titolo esecutivo diretto, superando la “debolezza” che in passato caratterizzava queste entrate (spesso prive di uno strumento immediatamente esecutivo, a differenza dei tributi).
Ambito soggettivo: gli enti legittimati a emettere accertamenti esecutivi sono quelli indicati dalla norma: Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni ed altri enti locali titolari di entrate proprie, nonché i loro concessionari di riscossione (es. società iscritte all’albo ministeriale). Non rientrano invece i tributi erariali o regionali, che seguono regole proprie (per i tributi statali l’accertamento esecutivo esiste già ex art.29 D.L. 78/2010; per alcuni tributi regionali recenti decreti delegati nel 2024 hanno armonizzato la riscossione, estendendo strumenti simili a livello regionale). Va evidenziato che il nuovo accertamento esecutivo non richiede una scelta discrezionale da parte dell’ente locale: la legge ha imposto l’adeguamento della modulistica e dei regolamenti degli enti, di fatto obbligando all’uso di accertamenti in forma esecutiva dal 2020 in poi. In altre parole, un avviso di accertamento locale emesso dopo il 1/1/2020 deve contenere le clausole esecutive previste, pena la sua invalidità o quantomeno la sua inidoneità a fungere da titolo esecutivo.
Entrate tributarie vs. entrate extratributarie: è importante comprendere quali entrate rientrano nell’accertamento esecutivo. La lettera a) del comma 792 L.160/2019 si riferisce espressamente a: (i) avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti locali; (ii) atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali degli enti. Dunque, oltre ai tributi (IMU, TARI, imposta di soggiorno, ecc.), la norma abbraccia qualsiasi entrata patrimoniale dell’ente, senza esplicite esclusioni. Alcuni commentatori inizialmente ritenevano escluse le sanzioni del Codice della Strada, che già seguono un proprio iter (verbale di contestazione, ordinanza-ingiunzione se opposto, iscrizione a ruolo) e per le quali la legge prevede specificità. Tuttavia, il testo normativo non contiene alcuna esclusione espressa per le multe stradali, e autorevole dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che anche le sanzioni C.d.S. possono rientrare nella riscossione potenziata. In pratica, un Comune potrebbe emettere un atto di accertamento esecutivo per riscuotere una multa stradale non pagata, inserendo la relativa intimazione (fermo restando che la multa in sé deve essere già divenuta titolo esecutivo, ad es. per mancato pagamento entro 60 giorni dal verbale). La ratio della norma è infatti di ricomprendere tutte le entrate locali, tributarie ed extratributarie, per dotarle di un procedimento di riscossione uniforme e semplificato.
Di seguito alcune esemplificazioni delle entrate interessate:
- Tributi locali: IMU (imposta municipale sugli immobili), TARI (tassa rifiuti), imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP/COSAP (canone occupazione suolo pubblico, ora confluito nel Canone Unico Patrimoniale), imposta di soggiorno, addizionale comunale IRPEF, ecc. Dopo la L.160/2019, tutti gli avvisi di accertamento di questi tributi sono esecutivi trascorsi 60 giorni dalla notifica.
- Entrate patrimoniali di diritto pubblico:
- Sanzioni amministrative comunali (es. multe per violazioni di regolamenti, sanzioni edilizie, ambientali e perfino multe stradali, come visto). Tali sanzioni, una volta irrogate e notificate secondo le procedure di legge (es. legge 689/1981 per sanzioni amministrative generali, Codice della Strada per le contravvenzioni stradali), se non pagate possono essere riscosse con accertamento esecutivo patrimoniale invece che con ingiunzione.
- Tariffe e canoni per servizi pubblici locali: ad esempio rette di asili nido, quote mensa scolastica, tariffe per il trasporto scolastico, servizi cimiteriali (lampade votive, concessioni cimiteriali), tariffe per l’uso di palestre e impianti sportivi comunali, ecc.. Queste entrate, pur non essendo tributi, derivano da obblighi imposti da regolamenti o atti unilaterali dell’ente e sono considerate entrate pubblicistiche.
- Contributi e oneri vari: contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione dovuti dai privati per permessi edilizi, contributi ambientali (es. oneri per discariche), eventuali contributi consortili gestiti da Comuni, ecc..
- Canoni patrimoniali e di concessione: il Canone Unico Patrimoniale (introdotto dal 2021 ex L.160/2019) che ha unificato Tosap/Cosap, ICP e CIMP, rientra tra le entrate non tributarie ma viene riscosso con accertamento esecutivo come confermato dal MEF. Analogamente, canoni di concessione di beni pubblici, affitti di terreni comunali agricoli, canone per loculi cimiteriali, ecc., se di natura pubblicistica.
- Entrate patrimoniali di diritto privato:
- Fitti e affitti attivi dovuti all’ente su basi contrattuali di diritto privato: affitto di immobili comunali (es. locazione di case popolari, affitto sale comunali per eventi), canoni di locazione di terreni o fabbricati di proprietà dell’ente dati in uso a privati, affitti di banchi mercatali se regolati contrattualmente, ecc..
- Corrispettivi di utenze e servizi a contratto: ad esempio, bollette del servizio idrico integrato gestito direttamente dal Comune (se l’acquedotto è comunale), bollette per energia elettrica o gas erogati dall’ente locale (raro ma possibile in alcuni comuni), altri servizi in cui l’ente agisce iure privatorum.
- Obbligazioni da contratto o danno: somme dovute al Comune in base a convenzioni, penali contrattuali, risarcimenti danni liquidati da sentenze civili a favore del Comune, ecc. – qualora l’ente non intenda attendere un precetto del giudice civile e preferisca attivare la procedura di ingiunzione fiscale (ora surrogata dall’accertamento esecutivo).
Importante: sia per le entrate patrimoniali pubbliche che private, prima di emettere l’accertamento esecutivo l’ente deve aver costitutito il credito in modo certo e liquido. Nel caso di tariffe o canoni periodici, di solito vi è stata una bolletta o avviso di pagamento precedente (o un contratto) non onorato; nel caso di sanzioni, c’è stato un verbale di accertamento notificato e non pagato. Questi atti presupposti fungono da “avviso di mora” antecedente, necessario per legittimare l’ente a iscrivere a titolo esecutivo il credito. Infatti, la procedura potenziata disegnata dalla legge prevede che l’accertamento esecutivo patrimoniale possa sostituire la tradizionale ingiunzione solo se il debitore è già stato reso edotto del credito e posto in condizione di adempiere spontaneamente. In termini pratici: per le entrate di diritto pubblico l’ente emetterà prima, ad esempio, un sollecito di pagamento o un avviso bonario (o semplicemente attenderà la scadenza di pagamento prevista per legge); per le entrate di diritto privato spesso invierà una lettera di messa in mora o una diffida ad adempiere contrattuale. Decorso inutilmente tale fase, potrà notificare l’avviso di accertamento esecutivo inserendovi la formula precettiva.
Evoluzioni recenti: la disciplina dell’accertamento esecutivo locale è stata ulteriormente affinata negli anni successivi. Il D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) in piena emergenza Covid-19 ha temporaneamente sospeso e prorogato alcuni termini di notifica e versamento degli accertamenti esecutivi. Nel 2021 e 2022, provvedimenti come il D.L. 146/2021 hanno chiarito aspetti applicativi (es. la possibilità per i Comuni di avvalersi di definizioni agevolate su accertamenti esecutivi pendenti). Inoltre, con la riforma della giustizia tributaria (D.Lgs. 119/2022) sono cambiati i nomi e la composizione delle Commissioni Tributarie (ora denominate Corti di Giustizia Tributaria) e sono state introdotte misure per accelerare i giudizi, anche rilevanti per i ricorsi contro avvisi esecutivi. Da segnalare che nel 2024, in attuazione di deleghe fiscali, sono stati emanati: il D.Lgs. 110/2024, che ha esteso l’uso dell’accertamento esecutivo anche ad alcuni tributi regionali e rafforzato l’armonizzazione con le regole locali; e il D.Lgs. 87/2024 (c.d. Decreto Sanzioni), che ha modificato il sistema sanzionatorio dei tributi locali e integrato la disciplina delle sanzioni e interessi nelle procedure esecutive (ad esempio uniformando alcune sanzioni per omessi versamenti e recependo il principio della prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative tributarie). Tali novità confermano la volontà del legislatore di consolidare l’accertamento esecutivo come pilastro della riscossione locale.
Contenuto e validità formale dell’avviso esecutivo
L’avviso di accertamento esecutivo notificato al contribuente è un atto polifunzionale. È a tutti gli effetti un atto amministrativo impositivo, soggetto quindi alle regole di motivazione e legittimità proprie degli avvisi di accertamento, ma possiede anche requisiti aggiuntivi che gli conferiscono efficacia esecutiva sostanziale. Occorre dunque distinguere i requisiti formali (di validità dell’atto come provvedimento) dai requisiti sostanziali (necessari perché l’atto funzioni come titolo esecutivo).
Requisiti formali essenziali: come ogni avviso di accertamento, deve indicare correttamente:
- Intestazione e destinatario: i dati del contribuente/debitore, con esattezza anagrafica. Ad esempio, se il contribuente è deceduto, l’atto va intestato agli eredi (collettivamente o nominativamente ai sensi dell’art.65 DPR 600/1973) e notificato secondo le regole speciali – una notifica intestata al defunto è giuridicamente inesistente, come confermato dalla Cassazione.
- Ente emittente e funzionario responsabile: l’ufficio/servizio comunale che emette l’atto e il nome (o almeno la qualifica) del funzionario responsabile che lo sottoscrive. È ammessa la firma digitale o meccanica del dirigente responsabile, purché l’atto indichi gli estremi del provvedimento di delega o adozione della firma a stampa e l’identità del funzionario. La Corte di Cassazione ha ritenuto valida la sottoscrizione dell’avviso locale con firma elettronica o a stampa, a condizione che sia chiaro chi ha emanato l’atto e sotto quale autorità, come previsto dalla normativa speciale.
- Indicazione del tributo o entrata e periodo di riferimento: ad esempio “IMU anno 2020” oppure “Canone occupazione suolo pubblico 2022”, ecc. Deve essere chiara la base giuridica della pretesa (norma istitutiva del tributo/canone) e l’anno o periodo cui si riferisce.
- Importi dovuti dettagliati: l’atto deve scomporre il totale nelle sue voci: imposta o capitale, sanzioni e interessi maturati, più eventuali spese di notifica. Nel caso di tributi, le sanzioni amministrative tributarie vanno irrogate in separato provvedimento contestuale (spesso all’interno dello stesso avviso). L’avviso esecutivo tipicamente addebita anche le spese di notifica sin da subito e preciserà che ulteriori oneri di riscossione si aggiungeranno se si passerà alla fase esecutiva.
- Motivazione: l’atto deve essere motivato in modo da spiegare al destinatario perché deve quelle somme. La motivazione può rinviare ad atti esterni (es. un PVC della Guardia di Finanza, una delibera tariffaria) purché tali atti siano allegati o già noti al contribuente. In generale, come di regola per gli atti impositivi (art. 7 L.212/2000 Statuto del Contribuente), la motivazione «deve riportare tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche» poste a base della pretesa. Cassazione 3860/2025 ha ribadito che il Comune non può in giudizio addurre motivi diversi da quelli esposti nell’avviso. Un avviso carente di motivazione è annullabile in sede di ricorso. Ad esempio, per un’omessa TARI, dovrà essere indicato su quali immobili/superfici e con quali tariffe si calcola l’importo, e perché si ritiene omesso il pagamento (es: mancata presentazione denuncia rifiuti, confronto con banca dati, ecc.).
- Regolare notifica: la notifica dell’avviso deve avvenire con mezzi legali (messo comunale, ufficiale giudiziario, servizio postale raccomandato AR, oppure via PEC per i soggetti obbligati ad averne uno). Trattandosi di un titolo esecutivo in formazione, la giurisprudenza ha chiarito che l’avviso primario (quello che costituisce la prima intimazione) va notificato in modo formale e provato. Un vizio nella notifica (es. notifica inesistente o nulla) comporta che l’atto non diviene definitivo, e quindi non può legittimamente attivare l’esecuzione. È fondamentale quindi che il contribuente riceva l’atto secondo le norme (anche via PEC, se indirizzata al domicilio digitale corretto, come ormai spesso avviene per imprese e professionisti iscritti in INI-PEC).
Contenuto “esecutivo” obbligatorio: oltre ai requisiti di ogni accertamento, l’avviso esecutivo deve recare specifiche indicazioni aggiuntive, imposte dalla L.160/2019, che lo rendono titolo esecutivo. In particolare, il testo dell’atto deve chiaramente contenere:
- L’intimazione ad adempiere al pagamento entro un certo termine:
- Per i tributi: entro il termine previsto per ricorrere (60 giorni dalla notifica, di regola, come da art.21 D.Lgs.546/1992).
- Per le entrate patrimoniali: entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (stesso termine, in pratica, ma formulato distinto perché per queste non c’è un “ricorso tributario” bensì eventualmente altri tipi di ricorso/opposizione).
- L’indicazione che in caso di ricorso tempestivo la riscossione delle sanzioni segue regole particolari: per i tributi, va menzionata l’applicazione dell’art. 19 D.Lgs. 472/1997 (sospensione esecuzione sanzioni tributarie fino sentenza I grado); per le entrate patrimoniali, va indicata l’applicazione dell’art. 32 D.Lgs. 150/2011. Quest’ultima norma (art.32 del “rito semplificato”) stabilisce che le controversie in materia di riscossione di entrate patrimoniali seguono il rito ordinario di cognizione dinanzi al giudice competente (tipicamente il tribunale civile). In sostanza, il debitore è avvisato che se fa opposizione/ricorso, la causa seguirà quei procedimenti (giudice tributario per tributi, giudice ordinario per patrimoniali) e che, ad esempio, per le sanzioni tributarie l’ente non potrà riscuoterle fino a sentenza di primo grado.
- L’espresso avvertimento che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare procedure esecutive e cautelari decorsi i termini. Questa frase conferisce formalmente all’atto la natura di titolo esecutivo (come fosse una sentenza o una cambiale). Se mancasse tale dicitura, l’atto potrebbe non soddisfare i requisiti del comma 792 e quindi non legittimare l’esecuzione. La legge infatti dice che gli atti “devono recare espressamente” tale indicazione.
- L’indicazione del soggetto incaricato della riscossione forzata che agirà dopo la scadenza: ad es. «Trascorsi 60 giorni senza pagamento, la riscossione sarà affidata all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione)», oppure «…sarà proceduto a mezzo della Società X S.p.A. (concessionario iscritto all’albo) per la riscossione coattiva». Questo perché il Comune può scegliere se affidare il recupero all’agenzia statale (Agenzia Entrate-Riscossione) oppure ad un proprio concessionario privato o riscossione in house. In ogni caso, il contribuente deve sapere chi potrebbe bussare alla sua porta per il pignoramento. Se l’ente stesso riscuoterà direttamente (tramite suo ufficio o società in-house), indicherà se stesso come soggetto legittimato. La mancanza di tale indicazione costituisce violazione formale dell’art.792, potenzialmente causa di nullità dell’atto per difetto di un elemento essenziale.
- L’indicazione delle eventuali procedure successive: ad esempio alcuni avvisi riportano frasi tipo «il contenuto del presente atto sarà riportato nei successivi atti da notificare al contribuente in caso di adesione, acquiescenza parziale, conciliazione o sentenza, con rideterminazione degli importi», come previsto sempre dal comma 792 (che impone la reiterazione delle clausole esecutive anche negli atti “secondari” emessi dopo, ad es. un avviso integrativo dopo accertamento con adesione).
Validità e vizi dell’atto: un avviso di accertamento esecutivo che non rispetti i requisiti sopra elencati può essere dichiarato nullo o inefficace su eccezione del contribuente. In particolare, la giurisprudenza ha affermato in linea di principio che la formulazione del comma 792, laddove dice che gli atti “devono contenere” l’intimazione e le altre indicazioni, va intesa come prescrittiva e non meramente direttiva. Quindi, ad esempio:
- Se manca l’intimazione a pagare entro 60 giorni, l’atto è un normale accertamento ma non può acquisire efficacia esecutiva (in sostanza, non vale come titolo per pignorare). Un tale vizio potrebbe portare il giudice a dichiarare illegittima la successiva cartella o pignoramento per difetto di titolo.
- Se manca l’indicazione del soggetto riscossore, la difesa potrà eccepire la nullità dell’atto per violazione di legge (art.1 co.792 lett.a L.160/2019). Alcune Commissioni Tributarie hanno già annullato avvisi esecutivi privi di tale indicazione, ritenendoli non conformi al modello legale (in quanto ledono il diritto di difesa del contribuente che non sa a chi rivolgersi per interloquire o eventualmente pagare).
- Un altro vizio frequente potrebbe essere l’errore sul termine di pagamento/ricorso: ad esempio, se l’ente indicasse un termine inferiore a 60 giorni, violerebbe lo Statuto Contribuente (art.7 co.2 lett. h L.212/2000 prevede minimo 60 gg per adempiere volontariamente) e l’atto potrebbe essere annullato o rettificato in giudizio.
- Sul fronte della motivazione e del merito, valgono tutti i normali motivi di ricorso contro un accertamento: errori sul calcolo, prescrizione del tributo, mancanza dei presupposti, ecc., che vedremo in seguito.
Notifica a mezzo PEC: un cenno sul procedimento di notifica telematica. La normativa generale (art.60 DPR 600/1973 e DL 78/2010) consente la notifica via PEC degli atti tributari ai contribuenti dotati di domicilio digitale. Molti Comuni, tramite i propri concessionari, hanno iniziato a notificare gli avvisi di accertamento esecutivo via PEC (soprattutto alle imprese e ai professionisti iscritti in albi o registri). La notifica PEC è valida se effettuata all’indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali (INI-PEC) e se il file allegato (l’atto) è firmato digitalmente e contiene la relata di notificazione. Per il destinatario, attenzione: la PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata AR, e i 60 giorni decorrono dalla data di consegna nella casella PEC (se avvenuta tra le 7 e le 21, altrimenti dal giorno dopo). Quindi è fondamentale controllare regolarmente la propria PEC per non perdere termini.
Conclusione sulla validità formale: in sintesi, un accertamento esecutivo valido deve apparire al destinatario molto simile a un normale avviso di accertamento (completo di motivazione, riferimento normativo e calcoli), ma con in più delle clausole che lo qualificano come titolo esecutivo (intimazione 60gg, avvertimenti su esecutorietà e riscossione forzata). Se queste parti mancano o sono scorrette, il debitore avrà elementi per far valere l’invalidità dell’atto in sede di opposizione.
Termini e procedura: dalla notifica all’esecuzione
Vediamo ora tempistiche e fasi previste dopo la notifica di un accertamento esecutivo, poiché capire le scadenze è cruciale per il debitore che deve reagire.
Termine per pagare o impugnare – 60 giorni: dalla data in cui l’atto viene notificato (giorno “0”), scattano i termini di legge. Il termine di 60 giorni è generalmente applicabile a tutti i casi, uniformando così le scadenze sia per i tributi (dove coincide col termine di ricorso in commissione tributaria) sia per le entrate extratributarie. Entro questo periodo il debitore può:
- Pagare in tutto o in parte la somma richiesta (anche chiedendo eventualmente una rateizzazione, come vedremo).
- Presentare ricorso o opposizione all’autorità competente (Commissione Tributaria/oggi Corte Giustizia Tributaria per i tributi; giudice ordinario in caso di entrate patrimoniali, secondo i rispettivi riti).
- Non fare nulla – ipotesi sconsigliata – lasciando decorrere il termine.
Allo scadere dei 60 giorni, se non è avvenuto il pagamento integrale né è stato proposto ricorso, l’avviso diventa definitivo ed esecutivo a tutti gli effetti. In gergo, si parla di “atto divenuto definitivo” o “accertamento divenuto titolo esecutivo”. Ciò significa che:
- Il debitore perde la facoltà di impugnare nel merito l’accertamento (salvo casi eccezionali di rimessione in termini, es: notifica nulla).
- L’intero importo indicato è ora immediatamente esigibile dall’ente, che può attivare le azioni di recupero forzoso.
Affidamento al riscossore – entro 30 giorni successivi: la legge (art.1 co.792 lett. b L.160/2019) prevede che “decorso il termine utile per il pagamento, […] decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata”. In pratica, l’ente locale attende ulteriori 30 giorni dopo il giorno 60, dopodiché trasmette il carico da riscuotere al proprio agente della riscossione (che può essere l’Agenzia Entrate-Riscossione oppure altro soggetto). Spesso gli enti effettuano l’affidamento in blocchi periodici (ad esempio fine mese o fine trimestre). Nella prassi, quindi, circa 90 giorni dalla notifica del primo avviso, il debito viene caricato nei sistemi dell’esattore per procedere con l’esecuzione.
Sospensione temporanea dell’esecuzione – 120/180 giorni: la normativa introduce un peculiare periodo cuscinetto: l’esecuzione forzata è sospesa di diritto per 180 giorni dall’affidamento se il carico è affidato a un soggetto diverso dall’ente (es. Agenzia Entrate-Riscossione), ridotti a 120 giorni se l’ente riscuote in proprio. Questo significa che l’agente della riscossione, pur avendo ricevuto il titolo esecutivo, deve attendere tale periodo prima di iniziare pignoramenti e altre azioni esecutive. Lo scopo è dare al debitore un’ultima finestra per pagare spontaneamente o trovare un accordo, nonché consentire eventuali procedure deflattive (es. definizioni agevolate) o interventi normativi. Durante questi 4-6 mesi, il debitore può ancora pagare evitando l’esecuzione (ma ormai con aggiunta delle spese di riscossione). Da notare: questa sospensione non si applica se l’atto era già definitivo da tempo? In realtà la lettera b) del comma 792 la prevede in ogni caso di affidamento, tranne che per i carichi sotto una certa soglia dove l’ente potrebbe procedere direttamente (ma sono casi limitati). Comunque, per il debitore ciò implica che non verrà pignorato immediatamente al giorno 61, avrà ancora alcuni mesi di tregua, sebbene sia fortemente a rischio misure cautelari (come vedremo).
Preavviso di esecuzione (intimazione 5 giorni) dopo 1 anno: un’ulteriore tutela prevista (comma 792 lett. h, in raccordo con l’art.50 DPR 602/1973) è che, se dall’atto esecutivo è trascorso oltre un anno senza che sia iniziata l’espropriazione forzata, occorre notificare al debitore un avviso di intimazione a pagare entro 5 giorni prima di procedere. In sostanza, l’agente della riscossione deve ricordare al debitore che sta per attivare i pignoramenti se è passato molto tempo dalla notifica dell’avviso. Questa intimazione è analoga al precetto previsto nel codice di procedura civile e serve ad evitare azioni esecutive a sorpresa quando è trascorso molto tempo. Va detto che spesso l’Agente della Riscossione invia comunque un sollecito o una comunicazione di presa in carico del debito anche prima (ad esempio, una lettera che informa del debito affidato invitando a pagare entro 30 giorni per evitare aggravio) – ma tale comunicazione non è un atto impugnabile in sé, a meno che il contribuente non intenda far valere la mancata notifica dell’atto presupposto (caso in cui potrà impugnare la cartella o l’intimazione deducendo il vizio originario).
Decorsi i termini – via libera all’esecuzione: allo scadere della sospensione (180 o 120 gg dall’affidamento), l’agente della riscossione può avviare le procedure esecutive e cautelari. In realtà, in alcuni casi l’agente può attivare già misure cautelari (fermo amministrativo di veicoli, ipoteca su immobili) anche durante la sospensione, in quanto la norma menziona la sospensione dell’esecuzione forzata ma non esplicitamente delle misure cautelari. Sulla base del rinvio operato dal comma 792 lett. e) ed f), se agisce l’Agenzia Entrate-Riscossione, essa lo fa secondo le regole del DPR 602/1973, il che comporta ad esempio:
- Possibilità di iscrivere fermo amministrativo sui veicoli del debitore (previa notifica di preavviso di fermo con 30 giorni per pagare) se il debito supera 1.000 €.
- Possibilità di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, se il debito supera 20.000 € (soglia introdotta dall’art.76 DPR 602/73), previa comunicazione di preavviso di ipoteca con 30 giorni di anticipo. Inoltre, l’abitazione principale del debitore, se non di lusso, non può essere espropriata (messa all’asta) per debiti tributari ex art.76 cit., a meno che il debito superi 120.000 € e ricorrano altre condizioni: una tutela importante per i privati, applicabile anche ai debiti verso enti locali.
- Possibilità di attivare pignoramenti presso terzi (stipendi, salari, pensioni, conti correnti) trascorso il termine di intimazione. Spesso gli agenti procedono prima con pignoramenti dei crediti del debitore (es: pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, nei limiti di 1/10 o 1/7 a seconda dell’importo; pignoramento del conto corrente fino a coprire l’importo dovuto). Sono procedure rapide che non richiedono l’accesso in casa o la collaborazione del debitore.
- Possibilità di eseguire pignoramenti mobiliari (meno frequenti) o immobiliari (in casi di debiti ingenti e beni di valore). Un pignoramento immobiliare da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione può scattare, come detto, solo per debiti sopra 120.000 € e su immobili non “prima casa” o di lusso, e comunque dopo aver atteso 30 giorni dall’intimazione e 6 mesi dalla notifica della comunicazione di presa in carico.
- Applicazione di interessi di mora (dal giorno successivo alla scadenza dei 60 gg) e oneri di riscossione aggiuntivi. I compensi di riscossione a carico del debitore, dopo la riforma del 2022, consistono in una quota fissa per atto (ad esempio circa 6€ per la notifica della presa in carico) più un aggio percentuale decrescente (dal 3% al 1%) sulle somme riscosse in base al momento del pagamento. Ad esempio, se l’agente incassa coattivamente, aggiungerà circa il 6% di oneri sul dovuto (percentuale variabile per legge).
Dal punto di vista del debitore, appena il titolo diventa definitivo e viene affidato, il rischio patrimoniale è concreto e prossimo:
- Come detto, trascorsi ~90 giorni dalla notifica iniziale, potrebbe arrivare un atto dell’Agente di Riscossione (che può essere una comunicazione di avvenuto affidamento del debito, oppure direttamente un preavviso di fermo o una intimazione di pagamento 5 giorni se è passato tempo).
- Trascorsi i 180 giorni (circa 9 mesi dalla notifica iniziale), senza alcun ricorso pendente o accordo, il concessionario può procedere con i pignoramenti senza altri avvisi (fatta salva l’intimazione 5 giorni se dovuta). È quindi possibile vedersi improvvisamente bloccato il conto corrente o notificato un atto di pignoramento presso terzi.
- Misure cautelari: anche prima del pignoramento, il debitore può subire provvedimenti come il fermo amministrativo della propria auto/moto (che scatta in automatico 30 gg dopo il preavviso se non si paga) oppure l’ipoteca su un immobile (dopo preavviso). Questi atti, pur non espropriando immediatamente, limitano i diritti del debitore (ad esempio non si può circolare col veicolo soggetto a fermo, e un immobile ipotecato risulta vincolato).
Riepilogo scadenze principali: per aiutare la comprensione, la seguente tabella riassume le fasi temporali successive alla notifica di un accertamento esecutivo e i relativi effetti per il debitore:
Come si evince, il ritmo dell’esecuzione è molto più serrato rispetto al passato (quando tra accertamento e cartella passavano anni). Ora il contribuente ha sì 60 giorni per attivarsi (termine in realtà allungato rispetto ai 30 giorni che di solito erano dati con la cartella esattoriale), ma dopo tale scadenza la procedura procede spedita. Per fare un esempio concreto: un avviso IMU notificato il 1° marzo 2025, se ignorato, diventerà esecutivo il 1° maggio 2025; entro fine maggio potrà essere affidato all’Agente; fino a fine novembre 2025 l’esecuzione resterà sospesa, ma da dicembre 2025 il contribuente rischierà pignoramenti su conto e stipendio senza ulteriori avvisi, e magari un preavviso di fermo auto già a luglio/agosto. Questo impone al debitore tempestività nel valutare come reagire.
Prescrizione e decadenza: merita attenzione la questione dei termini di decadenza per l’emissione degli atti e di prescrizione dei crediti:
- I tributi locali seguono i termini di decadenza previsti dall’art.1, co.161 L.296/2006, ossia notifica dell’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato. Con l’introduzione dell’accertamento esecutivo nulla cambia su questo aspetto: l’ente deve comunque notificare l’avviso (anche esecutivo) entro tale termine. Ad esempio, l’IMU 2020 andava accertata entro fine 2025. Se l’ente notifica oltre il termine di decadenza, l’atto è nullo per decadenza del potere impositivo.
- Per la riscossione coattiva dei tributi locali, si applicavano un tempo termini di decadenza ulteriori (es. formazione del ruolo entro l’anno successivo all’accertamento). Con l’accertamento esecutivo, la giurisprudenza ha chiarito che vi sono due distinti regimi di decadenza a seconda della modalità di riscossione prescelta dall’ente. In particolare, la Cassazione (ord. n.2307/2023) ha affermato che se l’ente utilizza l’ingiunzione fiscale (ex R.D.639/1910) c’è un termine triennale speciale per la sua emissione (introdotto dalla Finanziaria 2007), mentre se utilizza l’accertamento esecutivo vale la regola generale dei 5 anni (coincidente con il termine dell’accertamento stesso). In pratica, oggi quasi tutti usano l’accertamento esecutivo, per cui l’unico termine da monitorare è il quinquennio di decadenza per notificare l’atto.
- La prescrizione delle somme dovute: una volta divenuto definitivo l’accertamento, il credito (tributario o patrimoniale) si prescrive in base alla natura del rapporto. La stragrande maggioranza delle entrate locali, essendo pagamenti periodici o di anno in anno, ricade nella prescrizione breve di 5 anni ex art.2948 n.4 c.c.. La Cassazione ha più volte confermato la prescrizione quinquennale per IMU, TARI, TOSAP, COSAP, canoni e contributi vari, considerandoli prestazioni periodiche o comunque di fonte pubblicistica non codificata tra i diritti reali. Fanno eccezione solo casi peculiari: ad es. l’affitto di un immobile comunale (rapporto contrattuale privato) potrebbe prescriversi in 5 anni se canone periodico, oppure 10 anni se si vuole far valere un riconoscimento di debito; una sanzione amministrativa già inclusa in un provvedimento dell’autorità giudiziaria (es. in sentenza) avrebbe prescrizione decennale come ogni titolo giudiziale. Ma in generale: 5 anni. Quindi, se anche l’ente ha un titolo esecutivo, deve attivare pignoramenti entro 5 anni o notificare atti interruttivi (intimazioni, solleciti) altrimenti il debitore può eccepire prescrizione. Ad esempio, un avviso esecutivo IMU 2017 definitivo a marzo 2018 si prescrive a marzo 2023 se il Comune o l’Agente non compiono atti esecutivi o intimazioni nel frattempo.
Riassumendo: dal lato del debitore, i tempi sono stretti per reagire (60 giorni) e relativamente rapidi per subire l’esecuzione (pignoramenti possibili già dopo 9-12 mesi). È dunque fondamentale capire subito le proprie opzioni e attivarsi.
Cosa fare se si riceve un accertamento esecutivo – Le opzioni del debitore
Ricevere un avviso di accertamento esecutivo può generare preoccupazione, ma è importante mantenere la calma e valutare razionalmente le possibili azioni. Dal punto di vista del debitore si presentano essenzialmente tre strade nei 60 giorni iniziali: pagare, contestare (con un ricorso/opposizione) oppure cercare una soluzione alternativa (rateizzazione, autotutela, ecc.). Analizziamo ciascuna opzione in dettaglio, evidenziando pro e contro e fornendo indicazioni pratiche.
1. Pagare (subito o a rate)
Pagamento integrale entro 60 giorni: pagare quanto richiesto entro la scadenza indicata è l’opzione più “sicura” per chi riconosce la fondatezza della pretesa e vuole evitare ogni aggravio. Effettuando il versamento entro 60 giorni dalla notifica:
- Si evita l’attivazione di qualunque procedimento esecutivo. L’atto si estingue nei suoi effetti, e l’ente non affiderà nulla all’esattore.
- Non maturano ulteriori interessi moratori oltre quelli eventualmente calcolati nell’atto (in genere gli avvisi esecutivi già computano gli interessi fino alla data di notifica; pagando entro 60 gg non vi saranno interessi di mora successivi né spese di esecuzione aggiuntive).
- Sanzioni ridotte: per alcuni tributi, il pagamento entro certi termini può comportare benefici sanzionatori. Ad esempio, in materia erariale, l’acquiescenza all’accertamento entro 60 gg dà diritto alla riduzione delle sanzioni a 1/3 (art.15 D.Lgs. 218/1997). Molti Comuni applicano analoghi incentivi: se l’atto lo prevede, pagando entro 60 giorni si potrebbe usufruire della riduzione di 1/3 delle sanzioni irrogate. In mancanza di esplicita previsione nell’avviso, comunque la L.160/2019 ha disposto che non si applica la “sanzione per tardivo versamento” ulteriore se si paga entro i 60 giorni (ossia non scatterà il 30% di cui all’art.13 D.Lgs.471/1997 sul ritardato pagamento del dovuto accertato). È sempre bene leggere se l’avviso contiene riferimenti a “acquiescenza” o riduzioni in caso di pagamento tempestivo.
- Chiusura rapida della questione: il contribuente evita spese legali e incertezze di un contenzioso. Questa scelta è consigliabile quando il debitore riconosce la correttezza dell’addebito (es. un omesso versamento effettivamente non pagato) e ha le risorse finanziarie per estinguere il debito.
Pagamento parziale e sgravio parziale: può accadere che alcune voci siano contestate e altre no. Il contribuente ha facoltà di pagare solo una parte dell’importo (ad esempio, solo il tributo senza le sanzioni, o solo alcune annualità in contestazione). Attenzione: il pagamento parziale non blocca l’esecuzione sulla parte residua. L’ente potrà procedere per recuperare il resto. Tuttavia, in sede di eventuale giudizio, un pagamento parziale potrebbe essere interpretato come acquiescenza parziale su quella parte (rendendo incontestabile quanto pagato). Bisogna quindi valutare se pagare parzialmente conviene: talvolta si paga intanto l’imposta dovuta e si litiga solo su sanzioni e interessi (per ridurre l’importo soggetto a mora e a possibile pignoramento). Questa è una scelta strategica che va ponderata magari con l’aiuto di un professionista.
Richiesta di rateizzazione: non tutti hanno liquidità per pagare in un’unica soluzione. La buona notizia è che sia nella fase amministrativa presso l’ente, sia successivamente presso l’Agente della Riscossione, esistono procedure per ottenere una dilazione del pagamento. Ecco come procedere:
- Rate presso l’ente (entro i 60 giorni): molti enti locali, nei propri regolamenti generali delle entrate, prevedono la possibilità di concedere rateazioni prima dell’affidamento al riscossore. Di solito il contribuente deve presentare un’istanza motivata all’ufficio tributi entro il termine di pagamento, dichiarando la difficoltà a pagare in unica soluzione e proponendo un piano di rate (spesso mensili) entro un massimo di anni (spesso 3 o 5 anni a seconda dell’importo). Ad esempio, un Comune potrebbe consentire 12 rate mensili per debiti fino a €5.000, 24 rate per debiti fino a €20.000, e così via, dietro prova della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Se l’ente accoglie la richiesta, di solito l’accordo di dilazione comporta anche la sospensione dell’affidamento in riscossione finché si rispettano le rate. Nota: il mancato pagamento anche di una sola rata può far decadere il beneficio e l’ente affiderà il residuo all’esattore immediatamente.
- Rate presso l’Agente della Riscossione: se il debito è già stato affidato ad Agenzia Entrate-Riscossione, il contribuente può comunque chiedere una rateizzazione direttamente a quest’ultima (ai sensi dell’art.19 DPR 602/73, applicato anche a entrate locali). Attualmente, per importi fino a €120.000 non è richiesta prova di difficoltà e l’Agente concede piani fino a 72 rate (6 anni) automaticamente; per importi superiori serve documentare lo stato di difficoltà e si può arrivare fino a 120 rate (10 anni). La domanda va presentata prima che inizino atti esecutivi importanti (dopo un pignoramento già avvenuto, ad esempio, la concessione è più complessa). Se il piano è concesso, l’agente sospende le procedure esecutive già avviate (ad es. un fermo auto non ancora iscritto rimane sospeso, ecc.) e il debitore paga le rate con interessi di dilazione.
- Vantaggi della rateazione: ovviamente diluire il pagamento rende più gestibile l’esborso ed evita i danni immediati di un pignoramento. Inoltre, la richiesta di rateazione non richiede cauzioni (per legge, dal 2016, le PA non chiedono più polizze fideiussorie per importi sotto 60.000 € in dilazione, e anche oltre di solito no). Lo svantaggio è che sul debito si continuano a maturare interessi di rateazione (più bassi di quelli di mora) e l’agente della riscossione iscrive comunque fermo e ipoteca a garanzia se l’importo è alto (è prassi di Agenzia Riscossione ipotecare se debito >20k anche se rateizzato, a tutela).
- Come fare domanda: in genere, l’avviso allega un modulo o indica la possibilità di chiedere piani di pagamento. Se non indicato, conviene contattare l’ufficio tributi dell’ente entro i 60 giorni e chiedere istruzioni. Molti Comuni pubblicano sul sito moduli per rateazione delle ingiunzioni/accertamenti esecutivi. Per Agenzia Riscossione, la domanda si può fare online sul suo sito allegando documento d’identità, o presso i suoi sportelli, una volta che il carico risulta a ruolo (verificabile anche tramite PIN/Spid nell’area riservata).
Attenzione: la rateizzazione non interrompe i termini di ricorso. Se il contribuente intende contestare il debito, chiedere la dilazione potrebbe essere interpretato come riconoscimento del debito (specie nella fase amministrativa). In linea teorica, la Cassazione distingue rateazione “di atti non definitivi” (che non implica rinuncia al ricorso) da acquiescenza (pagamento di atto definitivo con riduzione sanzioni implica accettazione). Tuttavia, nella pratica, se pensate di fare ricorso, meglio non firmare rateizzazioni che contengano clausole di rinuncia a ricorsi. Valutate con un legale se pagare a rate e rinunciare al contenzioso (magari spuntando sconti su sanzioni) oppure se contestare formalmente.
2. Presentare ricorso o opposizione
Se ritenete che l’accertamento esecutivo sia errato o ingiusto, o anche solo in parte infondato, avete il diritto di contestarlo davanti a un giudice. La procedura e il giudice variano a seconda della natura del credito contestato:
- Per i tributi locali (entrate tributarie), la giurisdizione appartiene alle Commissioni Tributarie – ora denominate Corti di Giustizia Tributaria di primo grado – competenti per territorio (di solito quella della provincia dove ha sede l’ente impositore). Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, ai sensi dell’art.21 D.Lgs.546/1992.
- Per le entrate patrimoniali non tributarie, la giurisdizione in genere spetta al Giudice Ordinario. Nella pratica, tuttavia, non esiste uno “schema unico” di ricorso per tutte le entrate patrimoniali, perché dipende dal tipo di entrata:
- Se si tratta di una sanzione amministrativa (es. multa per violazione regolamento comunale), normalmente la legge specifica il percorso di opposizione (spesso ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica del verbale/ordinanza). Se quel termine è decorso e l’atto è ora esecutivo, il debitore ha perso la possibilità di contestare il merito (può solo pagare o far opposizione all’esecuzione per vizi formali). In altri termini, l’accertamento esecutivo in questo caso è più un atto di riscossione che di accertamento (il “merito” è definito nel verbale originario). Quindi attenzione: se ricevete un accertamento esecutivo per una multa stradale o altra sanzione, non è un nuovo verbale da impugnare entro 60 gg in tribunale – quel termine era 30 gg al momento del verbale/ordinanza. Ora potete solo pagare o, al limite, contestare irregolarità della riscossione.
- Se si tratta di un corrispettivo/entrata patrimoniale in senso stretto (canone, affitto, bolletta, ecc.), l’accertamento esecutivo è assimilabile a una sorta di ingiunzione di pagamento amministrativa. Contro di esso non è previsto un “ricorso” amministrativo specifico (come invece per i tributi). Il debitore potrebbe teoricamente proporre un’opposizione in via ordinaria al tribunale civile competente, con atto di citazione, al fine di contestare l’esistenza del debito. Tuttavia, spesso conviene attendere l’eventuale atto esecutivo (pignoramento) e formulare le difese in quella sede (come opposizione all’esecuzione), soprattutto se il termine di 60 gg è quasi scaduto o se si confida in questioni formali (notifica nulla, prescrizione) da far valere. Ne parleremo tra poco.
Riassumendo: per i tributi locali si fa ricorso tributario in 60 giorni; per le entrate extratributarie non c’è un ricorso “di merito” standard entro 60 giorni, salvo il caso di atti che abbiano di per sé natura provvedimentale impugnabile davanti al TAR (raro per questioni di denaro) – generalmente la tutela del debitore extratributario è attraverso le opposizioni all’esecuzione dinanzi al giudice civile.
Vediamo in dettaglio la procedura di ricorso tributario, poi quella di opposizione civile, e infine alcuni aspetti comuni (sospensiva, ecc.):
Ricorso tributario (per tributi): va presentato entro 60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Può redigerlo il contribuente stesso se il valore della causa è fino a €3.000, altrimenti è necessaria l’assistenza di un difensore abilitato (avvocato, commercialista o esperto ex lege). Il ricorso deve indicare:
- L’ente contro cui si ricorre (es: Comune di X – Ufficio Tributi).
- L’atto impugnato (estremi dell’avviso di accertamento esecutivo, numero e data di notifica).
- I motivi di ricorso, cioè le ragioni di illegittimità dell’atto: possono essere motivi formali (es: notifica nulla, difetto di motivazione, carenza di firme, ecc.) e motivi sostanziali (es: il tributo non è dovuto perché… esenzione, errore di persona, prescrizione maturata, calcolo errato, doppia imposizione, ecc.). È fondamentale esporre chiaramente i fatti e le norme violate.
- L’eventuale istanza di sospensione dell’atto: il contribuente può chiedere al giudice tributario di sospendere l’esecutività dell’accertamento, ma deve provare che l’esecuzione imminente gli causerebbe un danno grave e irreparabile (ad es., compromettere la continuità aziendale, costringerlo a vendere la casa, ecc.). Questa richiesta va motivata e va presentata con il ricorso o con atto separato entro 60gg, e il giudice deciderà in tempi brevi (circa 30-40 giorni).
- L’indicazione del valore della lite (somma contestata al netto di sanzioni e interessi, se si contestano anche quelli va incluso).
- La firma e l’elezione di domicilio del difensore (o del ricorrente pro se).
Il ricorso tributario, diversamente da altri processi, si propone con notifica all’ente impositore (es. al Comune, di solito tramite PEC all’indirizzo pec istituzionale). Poi entro 30 giorni dalla notifica va depositato (telematicamente via SIGIT o fisicamente) presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria competente, insieme alla ricevuta di avvenuta notifica. Per le controversie fino a €50.000, il ricorso in Commissione Tributaria vale anche come reclamo/istanza di mediazione (art.17-bis D.Lgs.546/92). Significa che la presentazione del ricorso apre una fase di 90 giorni in cui l’ente può formulare una proposta di mediazione (solitamente riduzione delle sanzioni) o accogliere parzialmente il ricorso. Se entro 90 giorni non c’è accordo, il ricorso diventa procedibile in Commissione (attenzione: in tal caso i 90gg sospendono il processo, ma non sospendono l’esecuzione dell’atto, per quella serve comunque una sospensiva del giudice!). Molti Comuni tendono a difendere l’atto, ma se il contribuente ha argomenti solidi, la mediazione può portare a riduzioni sanzioni del 35% e chiusura bonaria della lite.
Durante il processo tributario:
- L’ente di regola non può eseguire oltre certi limiti: c’è infatti la regola del “pagamento frazionato in pendenza di giudizio” (art.68 D.Lgs.546/92). Essa prevede che, se il contribuente impugna l’atto, l’ente può iscrivere a ruolo provvisoriamente solo 1/3 delle imposte accertate (senza sanzioni) in attesa della sentenza di primo grado. Questo principio, tuttavia, non è stato esplicitamente coordinato con la riforma dell’accertamento esecutivo e ha creato dubbi. Molti enti sostengono che l’art.68 non si applichi agli accertamenti esecutivi perché la riscossione è “sospesa per legge” 180 giorni e dopo quel termine l’atto è comunque esecutivo anche se impugnato. In pratica, alcuni enti inviano comunque il titolo all’agente della riscossione trascorsi i 180 giorni, anche se sanno del ricorso, limitandosi a non includere le sanzioni. Questa zona grigia è pericolosa per il contribuente: si rischia di subire pignoramenti anche con ricorso pendente, se non si è ottenuta una sospensiva. Perciò ribadiamo: chiedete sempre la sospensione al giudice tributario se l’importo è rilevante e l’esecuzione imminente vi danneggerebbe. Se la Commissione la concede, l’ente o l’Agente non potranno procedere fino alla decisione di merito (o altri termini fissati dal giudice). Se la nega, si può riproporla in appello, ma intanto l’Agente potrebbe agire.
- La durata del giudizio tributario di primo grado varia (6-24 mesi circa). Nel frattempo, se non c’è sospensiva, l’Agente può mettere a ruolo i 2/3 delle imposte dopo sentenza di primo grado se vi è soccombenza parziale del contribuente (ancora art.68). In caso di ricorso in appello, analoghe regole frazionatorie.
- Se il contribuente vince, l’atto viene annullato e cessano tutti gli effetti (con diritto a rimborso di quanto eventualmente pagato in pendenza). Se perde, può appellare in secondo grado entro 60 gg. Atti come ipoteche o fermi già iscritti in pendenza di giudizio, se la sentenza annulla l’atto, vanno cancellati.
Opposizione in sede civile (per entrate patrimoniali): per le entrate non tributarie, come detto, non c’è un organo “tributario” cui ricorrere. La tutela giudiziaria avviene secondo le forme ordinarie. In generale:
- Se il debitore vuole contestare il fondamento del debito (ad esempio nega di aver usufruito del servizio, o contesta il calcolo del canone), la forma di tutela è l’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c.. Questa può essere proposta anche prima che inizi l’esecuzione (se ha già un titolo esecutivo notificato) oppure dopo l’inizio della stessa. Poiché l’accertamento esecutivo è un titolo stragiudiziale, l’opposizione ex art.615 ante esecuzione va proposta al tribunale civile competente per materia/valore, con atto di citazione (o ricorso se si vuole chiedere sospensione urgente). Non c’è un termine perentorio di 60 gg qui: l’opposizione all’esecuzione può essere fatta finché l’esecuzione non è conclusa, quindi anche dopo i 60 giorni, purché prima che il processo esecutivo si chiuda (es: prima che i beni siano venduti). Tuttavia, se si aspettano troppi mesi, si rischia di subire pignoramenti; conviene attivarsi il prima possibile. In sede di opposizione all’esecuzione il debitore può far valere motivi come: l’inesistenza del credito (es: “non devo questa somma perché… ho già pagato / non ero tenuto / c’è un errore”); l’estinzione sopravvenuta (prescrizione maturata dopo, ecc.); la mancata notifica dell’atto presupposto (caso frequente: “non ho mai ricevuto l’avviso di accertamento, me ne sono accorto solo ora col pignoramento”).
- Se il debitore contesta invece soltanto la regolarità formale degli atti dell’esecuzione (es: il pignoramento contiene vizi di forma, o l’agente ha violato regole procedurali), si tratta di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., da farsi entro termini brevissimi (20 giorni dalla notifica dell’atto viziato).
- Competenza del giudice: di norma, le opposizioni su titolo e merito del debito vanno al Giudice Ordinario competente per materia/valore: quasi sempre il Tribunale civile (se il debito supera €5.000; per importi minori potrebbe essere il Giudice di Pace, ma se l’atto ha natura di ingiunzione amministrativa anche il GP potrebbe declinare per valore… meglio il Tribunale). L’art.32 D.Lgs.150/2011 conferma che le controversie su riscossione di entrate patrimoniali seguono il rito ordinario davanti al Tribunale.
- Particolarità: se la controversia tocca profili di diritto amministrativo (es: validità di una delibera tariffaria comunale) o coinvolge atti autoritativi, talvolta potrebbe esservi giurisdizione del giudice amministrativo, ma ciò è raro perché parliamo di recupero di somme di denaro dove la giurisdizione è generalmente o tributaria o ordinaria.
Coordinamento tra giudice tributario e civile: un punto complesso è che talvolta un credito potrebbe avere natura tributaria ma il contribuente, perso il termine per il ricorso tributario, tenta la via del giudice civile in opposizione all’esecuzione. Ad esempio, cartelle pazze non notificate: per anni c’è stato dibattito se l’opposizione alla cartella di pagamento per difetto di notifica dell’accertamento dovesse essere fatta in Commissione Tributaria o dal giudice ordinario. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che appartiene al giudice tributario qualsiasi questione inerente l’esistenza del rapporto tributario e la legittimità sostanziale del titolo, anche quando sollevata in sede di esecuzione. Dunque, se il contribuente eccepisce “Non mi avete mai notificato l’accertamento, quindi la riscossione è illegittima”, deve farlo davanti al giudice tributario (magari impugnando tardivamente l’accertamento appena ne ha avuto conoscenza, come ammesso dalla giurisprudenza). Il giudice civile in genere dichiara il difetto di giurisdizione su questioni così. Viceversa, le questioni attinenti alla fase esecutiva in senso stretto (es: vizi del pignoramento, pignoramento su beni impignorabili) spettano al giudice dell’esecuzione civile. Quindi per il debitore:
- Se vi siete dimenticati di fare ricorso tributario e arriva la cartella/pignoramento, potete impugnare la cartella o il pignoramento davanti al giudice tributario sollevando la nullità dell’atto presupposto mai notificato, entro 60 giorni dalla conoscenza (orientamento consolidato ammette l’impugnazione “differita” dell’accertamento quando si scopre con la cartella). Oppure, in subordine, fare opposizione in tribunale; ma attenzione che il tribunale potrebbe dire che dovevate andare in commissione.
- Per le entrate extratributarie, invece, tutto il contenzioso è per il giudice ordinario: quindi anche la mancata notifica di un sollecito precedente o un’eccezione di prescrizione del canone rientrano nei poteri del tribunale civile adito in opposizione.
Istanza di sospensione dell’esecuzione (in sede civile): analogamente al processo tributario, anche nel processo civile il debitore può chiedere di sospendere l’efficacia esecutiva dell’accertamento in attesa della decisione. In un’opposizione ex art.615 cpc, si può chiedere al giudice (con ricorso d’urgenza o in citazione) la sospensione dell’esecuzione ex art.624 cpc se questa è già iniziata, o un provvedimento d’urgenza ex art.700 cpc se non è ancora iniziata. Il giudice valuterà se vi sono gravi motivi (fondata apparenza del diritto del debitore e rischio di danno grave). Ad esempio, se l’opponente dimostra fumus di prescrizione maturata e c’è in corso un pignoramento immobiliare della casa, è probabile ottenere la sospensione.
Costi e rischi del ricorso: intraprendere un giudizio comporta alcuni costi (contributo unificato – ad es. circa €30 per valori minori o su €120 per valori fino a 50k in commissione tributaria; onorario del difensore) e soprattutto l’incertezza dell’esito. Se si perde, oltre a dover pagare il dovuto (magari con interessi maturati intanto), si possono dover pagare le spese di giudizio all’ente. D’altro canto, se l’atto è viziato, si può ottenere giustizia e in alcuni casi anche la condanna dell’ente alle spese e al rimborso di quanto eventualmente pagato.
Autotutela e interlocuzione con l’ente: un’opzione parallela che consigliamo di esperire immediatamente, contestualmente alle scelte sopra, è il tentativo di autotutela. L’autotutela è la facoltà dell’ente di annullare o correggere i propri atti senza bisogno del giudice, se si accorge di errori evidenti o su istanza motivata del contribuente. Presentare una istanza di riesame in autotutela all’ufficio che ha emesso l’accertamento può essere utile in caso di errore palese (importo già pagato, scambio di persona, errore di calcolo, doppia imposizione, decesso del contribuente, ecc.). Ad esempio, il Comune di Parma informa i contribuenti che in caso di “inesattezze o errori” nell’avviso IMU possono chiedere un riesame in autotutela, allegando la documentazione a supporto. L’ente non è obbligato a rispondere favorevolmente, ma spesso, di fronte a prove schiaccianti (es: ricevuta di versamento dimenticata dall’ufficio) annullerà o rettificherà l’atto. Ciò può far risparmiare tempo e soldi ad entrambi. Importante: chiedere l’autotutela non sospende i termini di ricorso né quelli di pagamento. Occorre quindi ricorrere comunque entro 60 gg se non si ha risposta, per non decadere, oppure pagare per sicurezza e attendere rimborso. Cassazione n.3860/2025 ha chiarito che l’esercizio dell’autotutela da parte del Comune è discrezionale e non vincolato alla presenza di soli errori formali: anche vizi sostanziali possono essere corretti in autotutela (finanche in “malam partem”, ossia peggiorando la posizione del contribuente, emettendo atto integrativo). Dunque, tentare il dialogo può portare a soluzioni (es: ridurre sanzioni, concedere più tempo). Se l’ufficio riconosce un errore, emanerà un provvedimento di annullamento o rettifica dell’accertamento, che va notificato al contribuente e contiene i nuovi importi (anche questi atti, se rideterminano l’imponibile, devono recare la formula esecutiva e i 60gg, come prevede il comma 792).
In sintesi sulla contestazione:
- Valutate bene i motivi di opposizione: sono fondati? ci sono precedenti sentenze a favore? Raccogliete documenti (ricevute, delibere) utili a dimostrare le vostre ragioni.
- Rispetto dei termini: non lasciate scadere i 60 giorni sperando nell’autotutela. Presentate ricorso se il termine si avvicina, per sicurezza, anche se state trattando con l’ente.
- Focalizzatevi sui punti vincenti: in molti casi, i vizi formali (es. notifica nulla, firma mancante) fanno annullare l’atto più facilmente di contestazioni sul merito del tributo (dove l’ente potrebbe avere margini di discrezionalità o interpretazioni dubbie). Se ci sono vizi di forma evidenti, sollevateli.
- Assistenza legale: per questioni complesse o importi elevati, affidatevi a un professionista esperto di fiscalità locale. Vi saprà indicare precedenti utili (ad es., Cassazione 7188/2022 ha annullato una cartella Cosap perché mancava un titolo esecutivo idoneo, principio ora superato dall’avviso esecutivo ma indicativo dell’importanza del titolo).
- Effetti sul debito: il ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Se temete un’esecuzione, chiedete la sospensiva al giudice e parallelamente potete valutare di pagare parzialmente (ad esempio versare il tributo senza sanzioni) per ridurre il valore in gioco e mostrare buona fede.
3. Soluzioni alternative e deflattive
Oltre al pagamento integrale o al ricorso, esistono alcune soluzioni intermedie che vale la pena considerare:
- Accertamento con adesione (definizione concordata): per i tributi locali, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione (ex D.Lgs.218/1997) prima di fare ricorso, allo scopo di avviare un contraddittorio con l’ufficio e magari definire l’accertamento in maniera concordata con riduzione delle sanzioni al 1/3. Molti Comuni hanno un proprio regolamento sull’adesione. L’istanza va inoltrata entro 60 giorni dalla notifica; ciò sospende il termine per ricorrere per 90 giorni. In questo periodo, verrete convocati dall’ufficio tributi per discutere. Se trovate un accordo (ad esempio riconoscete l’imponibile ma ottenete sanzioni ridotte), viene redatto un atto di adesione da firmare e il contribuente dovrà pagare le somme concordate (anche qui possibile a rate in 8 trimestri). L’accertamento definito in adesione non è più impugnabile ma in compenso evita il contenzioso e riduce le sanzioni del 50% (1/3 invece di 2/3). Per il debitore è utile se ci sono errori quantificativi o incertezze interpretative: si può spuntare un abbattimento sanzionatorio e chiudere velocemente. Se l’adesione fallisce, l’ufficio emetterà eventualmente un avviso di accertamento “rideterminativo” (ad es. confermando l’importo originale o modificandolo) che avrà anch’esso la formula esecutiva e altri 60 giorni per ricorrere.
- Ravvedimento operoso “lungo”: talvolta l’atto arriva dopo che il contribuente si è già accorto di un’omissione e avrebbe voluto ravvedersi. La Legge 160/2019, infatti, ha esteso il ravvedimento operoso anche oltre i termini (fino a notificazione dell’accertamento) per i tributi locali. Se l’ente non vi aveva ancora notificato nulla e vi siete accorti del mancato pagamento, potete ravvedervi pagando sanzioni ridotte. Dopo che l’avviso esecutivo è emesso, il ravvedimento non è più ammesso: ma potete valutare se l’ente ha applicato sanzioni corrette o meno. Ad esempio, il ravvedimento “lunghissimo” (oltre 2 anni) prevede sanzione 5% invece che 30%. Se il Comune vi contesta tardivamente qualcosa e non vi ha applicato la sanzione ridotta come da ravvedimento, potreste far presente che prima della notifica avreste potuto ravvedervi – a volte gli enti in sede di adesione concedono lo sconto come se vi foste ravveduti spontaneamente.
- Definizioni agevolate / sanatorie: negli ultimi anni, vari provvedimenti nazionali hanno offerto possibilità di definire in modo agevolato i carichi fiscali, incluse le ingiunzioni/accertamenti locali. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 ha dato facoltà ai Comuni di aderire allo “Stralcio” dei debiti fino 1.000 € e alla “Definizione agevolata” (c.d. rottamazione) delle ingiunzioni e accertamenti esecutivi affidati dal 2000 al 2017. Molti enti locali hanno deliberato in tal senso, consentendo ai debitori di pagare solo il tributo senza sanzioni (o addirittura nulla se sotto 1000 €) per chiudere i vecchi debiti. Conviene quindi informarsi presso l’ente o attraverso le notizie normative se vi siano procedure agevolate attive. Ad esempio, se avete un accertamento esecutivo notificato nel 2022 ancora pendente, verificate se il Comune ha aderito alla “rottamazione quater” per i propri crediti: potreste presentare domanda ed estinguere il debito con forte sconto sulle sanzioni. Queste opportunità sono straordinarie e a tempo: nel 2025 potrebbero essercene di nuove (magari in manovra finanziaria) o quelle del 2023 ancora in corso.
- Transazione o conciliazione extra-giudiziale: per importi rilevanti, specie se il debitore è in difficoltà (ad es. un imprenditore colpito da molteplici accertamenti), è talvolta possibile negoziare con l’ente un piano di rientro personalizzato o una riduzione del debito a saldo e stralcio. Questa strada è discrezionale: alcuni Comuni preferiscono riscuotere poco ma subito che niente dopo anni. Soprattutto se il debitore minaccia fallimento/concordato, l’ente può accettare una transazione fiscale (strumento previsto ad es. nella crisi d’impresa, D.Lgs.14/2019). Ma anche al di fuori delle procedure concorsuali, nulla vieta di proporre all’ente: “vi pago subito il 70% e chiudiamo la partita”. Serve volontà politica e una delibera della Giunta per accettare la transazione su tributi locali (non semplice, ma neppure impossibile in situazioni eccezionali).
- Aspettare la prescrizione: se siete in una situazione in cui ritenete che l’ente difficilmente procederà o il debito è minore, una (rischiosa) “opzione” è non fare nulla e confidare che trascorrano 5 anni senza atti interruttivi, così da eccepire poi la prescrizione. Questa tattica è sconsigliata perché comporta comunque il peso psicologico del debito pendente e non offre garanzie (l’ente in qualsiasi momento entro 5 anni potrebbe notificare un’intimazione e interrompere i termini). La prescrizione va eccepita in giudizio dal debitore: ciò significa che se venite pignorati al 4° anno e non eccepite nulla, il giudice non applica d’ufficio la prescrizione. Dunque, non fare nulla non è mai realmente “sicuro”. Meglio piuttosto ricorrere e far valere la prescrizione se già maturata.
Esempi pratici (simulazioni)
Di seguito proponiamo due scenari pratici per illustrare come un debitore può gestire un accertamento esecutivo in diverse situazioni:
Esempio 1 – Tributo locale (TARI) non pagato per errore:
Il signor Rossi riceve a luglio 2025 un avviso di accertamento esecutivo TARI dal Comune Alfa, in cui gli si chiede di pagare €800 (di cui €600 di tassa rifiuti 2022 non versata, €120 di sanzioni e €80 di interessi) entro 60 giorni. Rossi si rende conto che c’è stato un disguido: aveva cambiato residenza a metà 2022 e pensava che la TARI venisse cessata automaticamente, invece doveva presentare dichiarazione di variazione. Effettivamente il tributo è dovuto, ma la sanzione per omessa denuncia gli pare elevata. Inoltre, nota che l’avviso non ha considerato che nei primi mesi del 2022 lui già pagava la TARI nel vecchio Comune. Come può agire Rossi?
- Controllo contenuto atto: Rossi verifica che l’atto è stato notificato regolarmente (raccomandata AR ricevuta il 10 luglio 2025). Contiene l’intimazione a pagare entro 60gg e l’indicazione che sarà l’Agenzia Entrate-Riscossione a riscuotere dopo (perfettamente conforme alla legge).
- Interlocuzione e adesione: Entro fine luglio, Rossi presenta al Comune un’istanza in autotutela spiegando l’errore e allegando il certificato di residenza. Propone di pagare la TARI dovuta ma chiede l’annullamento delle sanzioni (invocando la buona fede e il fatto che ha pagato doppia TARI per due comuni nei mesi di sovrapposizione). Contestualmente, per non rischiare, il 1° agosto presenta anche istanza di accertamento con adesione, sospendendo il termine di ricorso.
- Esito della trattativa: L’ufficio tributi esamina la posizione: riconosce che c’è stata doppia imposizione per 3 mesi (Rossi pagava al vecchio comune fino a marzo 2022 e il nuovo comune gli sta richiedendo anche quei 3 mesi). In sede di adesione, a settembre 2025, propone a Rossi: eliminazione della quota di tassa per i 3 mesi già pagati altrove (–€75) e riduzione della sanzione del 50% (da €120 a €60) considerando la collaborazione. Rossi accetta. Si firma l’accordo di adesione: importo concordato €600 tributo + €60 sanzioni + €80 interessi – €75 esenzione = €665. Questo importo Rossi potrà pagarlo in 4 rate trimestrali su richiesta.
- Conclusione: il Comune emette un avviso di accertamento esecutivo integrativo con gli importi ridotti. Rossi paga come da accordo. L’atto originario viene archiviato senza ulteriori conseguenze. Rossi ha risolto evitando il contenzioso e con un risparmio economico (ha risparmiato €60 di sanzioni e €75 di tassa doppia).
- Nota: se l’ufficio non fosse stato disponibile, Rossi avrebbe avuto ancora tempo (fino a ottobre, grazie alla sospensione di 90gg) per proporre ricorso alla Commissione Tributaria, probabilmente vincendo sulla parte duplicata e chiedendo magari la non applicazione di sanzioni per errore scusabile. In questo caso l’adesione ha anticipato la soluzione.
Esempio 2 – Entrata patrimoniale extratributaria (COSAP) contestata:
La ditta Beta S.r.l. riceve nel marzo 2025 un avviso di accertamento esecutivo patrimoniale dal Comune Beta relativo a canone per occupazione di suolo pubblico (COSAP): €5.000 per occupazione con dehor dal 2020 al 2021, più €500 di interessi e €1.500 di indennità di occupazione abusiva (sanzione amministrativa). Totale €7.000. La ditta aveva presentato domanda di rinnovo concessione nel 2020 ma non aveva mai avuto risposta formale; ha continuato ad occupare credendo valesse il silenzio-assenso. Il Comune invece la ritiene abusiva per quelle annualità. Come può reagire la società?
- Analisi natura e giurisdizione: Il COSAP/canone unico è un’entrata patrimoniale (natura non tributaria ma concessoria). Le controversie su canoni di concessione sono di competenza del giudice ordinario (rapporti di concessione/contratto). Dunque Beta S.r.l. non può andare in Commissione Tributaria, dovrà eventualmente agire in tribunale civile.
- Valutazione merito: Beta S.r.l. ritiene di aver ragione sul merito (la concessione doveva intendersi rinnovata). Tuttavia, non ha un provvedimento espresso; sa che l’ente potrebbe opporre che serviva una nuova autorizzazione. Situazione incerta.
- Opzioni disponibili: Entro 60 giorni Beta S.r.l. non ha un “ricorso” dedicato, ma può:
- Avviare un dialogo con l’ufficio comunale (presenta una memoria in autotutela spiegando che c’era domanda di rinnovo e chiedendo l’annullamento dell’indennità di abusiva).
- Valutare se presentare un’opposizione al provvedimento al tribunale (ma un giudice civile potrebbe dire: l’atto amministrativo concessorio implicito doveva impugnarsi al TAR in 60 gg… intricata questione).
- Prepararsi piuttosto a contestare la riscossione se l’ente procede.
- Scelta strategica: Beta S.r.l. decide di non pagare e di non iniziare subito causa civile, confidando di trovare accordo. L’ufficio però rigetta l’istanza di autotutela sostenendo che la concessione era scaduta e dovevano attendere nuovo atto. Trascorrono 60 giorni, l’avviso diventa definitivo a maggio 2025.
- Affidamento e sospensione: il Comune affida a luglio il titolo ad Agenzia Riscossione. Beta S.r.l. a questo punto riceve a settembre 2025 una comunicazione dall’Agenzia che invita a pagare entro 30 giorni €7.350 (aggiunti compensi) per evitare azioni.
- Opposizione all’esecuzione: Beta S.r.l. decide di agire legalmente. A ottobre 2025, prima che scadano i 30 giorni della comunicazione, deposita un ricorso in tribunale ex art.615 cpc chiedendo di sospendere la riscossione e contestando: (a) l’inesistenza del debito da indennità abusiva perché l’occupazione era legittima; (b) in subordine, l’eccessività dell’importo. Chiede anche al giudice un provvedimento d’urgenza di sospensione, illustrando che l’Agente potrebbe a breve pignorare i conti e ciò bloccherebbe l’attività.
- Fase giudiziale: Il Tribunale concede in via d’urgenza la sospensione (riconosce che c’è fumus sul fatto che la PA non rispose alla domanda, generando affidamento). La società quindi per ora non subisce pignoramenti. La causa civile prosegue con istruttoria: si discute se la mancata risposta configuri silenzio-assenso. Nel 2026 il Tribunale accoglie in parte l’opposizione: dichiara non dovuta l’indennità di occupazione abusiva (€1.500) perché l’impresa era in attesa di riscontro (richiamando principi di buona fede amministrativa, e il fatto che la Cassazione in casi simili ha ritenuto che l’occupazione “non formalmente autorizzata ma in attesa di rinnovo” non integra illecito, come da Cass.31331/2019 citata dal legale); ritiene però dovuto il canone base (€5.000 + interessi). Condanna ciascuna parte a metà delle spese.
- Esito finale: il debito residuo di Beta S.r.l. è €5.500 più spese legali proprie. Il Comune, preso atto della sentenza, emette (nel 2026) un nuovo avviso esecutivo patrimoniale solo per €5.500 (anche questo possibile: l’ente esegue la sentenza civile che ha forza di giudicato su quella somma). Beta S.r.l. a quel punto paga (o se volesse, potrebbe appellare per non pagare neanche il canone, ma valuterebbe costi/benefici).
- Considerazioni: in questo caso extratributario, la tutela è passata per il giudice civile e la sospensione dell’esecuzione è stata fondamentale per evitare danni all’azienda. Se la società avesse ignorato la comunicazione, a novembre 2025 l’Agente le avrebbe pignorato il conto per l’intero €7.350, poi avrebbe dovuto fare causa per farseli restituire. Muovendosi in tempo ha evitato esborsi immediati.
Esempio 3 – Manca notifica, scoperta tardiva:
Il signor Verde nel 2024 non ha pagato l’IMU su un terreno, per un importo di €2.000. Il Comune gli ha notificato nel gennaio 2025 un accertamento esecutivo IMU, ma all’indirizzo sbagliato (vecchio indirizzo, non più residente lì, nessuno ha ritirato e l’atto è tornato indietro per compiuta giacenza). Verde non sa nulla. Nel febbraio 2026, riceve dalla Agenzia Entrate-Riscossione un avviso di intimazione a pagare €2.500 entro 5 giorni, riferito a “accertamento IMU 2024 Comune X notificato il 10/1/2025, divenuto definitivo”. Verde cade dalle nuvole: non ha mai visto quell’accertamento. Cosa può fare ora?
- Difesa per omessa notifica: la legge consente al contribuente di contestare la mancata notifica di un atto impositivo anche oltre i termini, non appena ne viene a conoscenza. Verde qui ha saputo dell’accertamento solo tramite l’intimazione di pagamento. Dunque egli può presentare un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria contro l’accertamento originario, eccependo la nullità/inesistenza della notifica e quindi la non debenza di quanto richiesto. Deve farlo entro 60 giorni dalla intimazione (che è considerata atto successivo dal quale ha avuto conoscenza). Nel ricorso, chiederà anche la sospensione, dato il termine di 5 giorni dell’intimazione e il rischio pignoramento. Le Commissioni Tributarie in casi analoghi concedono sospensione e poi annullano l’atto se provato che la notifica era viziata. Verde allega al ricorso la documentazione (certificato storico di residenza che prova che al 10/1/2025 era residente altrove e il Comune ha notificato a indirizzo vecchio).
- Giudizio tributario: è assai probabile che la Commissione accolga il ricorso di Verde, annullando l’accertamento per notifica nulla. Di conseguenza, cade anche l’intimazione e ogni atto successivo. L’Agente dovrà rinunciare all’esecuzione. Il Comune potrà eventualmente rinotificare l’accertamento (se ancora nei termini di decadenza, altrimenti ha perso il credito). Verde in questo modo ha difeso i suoi diritti nonostante la tardività, sfruttando lo strumento dell’impugnazione differita.
- In alternativa: se per ipotesi Verde avesse erroneamente deciso di andare dal giudice dell’esecuzione civile per bloccare il pignoramento (opposizione ex 615), il giudice civile molto probabilmente avrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario (perché si discute di valida notifica di un atto tributario). Quindi è cruciale scegliere il giudice giusto per ogni questione: notifica di tributo = giudice tributario, e farlo tempestivamente.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande comuni con relative risposte, per chiarire ulteriormente dubbi pratici dal punto di vista del debitore.
D: Che cos’è esattamente un avviso di accertamento esecutivo patrimoniale?
R: È un atto emesso da un ente locale (Comune, ecc.) che accerta un determinato importo dovuto dal destinatario e contestualmente ingiunge il pagamento entro un termine, avvertendo che trascorso tale termine l’atto vale come un titolo esecutivo. In pratica un unico documento svolge la funzione sia di avviso di accertamento (indica il debito, la motivazione e permette la difesa) sia di precetto esecutivo (minaccia l’esecuzione forzata). Questo strumento è utilizzato sia per tributi locali (ad es. IMU, TARI non pagate) sia per entrate extratributarie (es. multe, canoni, bollette comunali). È “esecutivo” perché passati 60 giorni dalla notifica senza ricorso o pagamento, l’ente può procedere alla riscossione coattiva senza dover emettere una cartella esattoriale o ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice.
D: Quali enti lo possono emettere e per quali tipi di entrate?
R: I soggetti emittenti sono gli enti locali: Comuni, Province, Città metropolitane, loro Unioni o Consorzi, e i concessionari di riscossione da essi incaricati. Le entrate interessate sono tutte quelle di competenza dell’ente locale:
- Tributi locali (IMU, TARI, imposta di soggiorno, ecc.) – questi sono sempre accertati con avvisi esecutivi dal 2020 in poi.
- Entrate patrimoniali extratributarie, sia di natura pubblicistica (sanzioni amministrative, canoni per servizi pubblici, contributi vari, COSAP/Canone Unico, ecc.) sia di natura privatistica (affitti, corrispettivi contrattuali verso il Comune). Di fatto, qualsiasi somma dovuta al Comune che prima si sarebbe riscossa con ingiunzione fiscale o ruolo esattoriale ora passa per questo strumento. Non ci sono esclusioni esplicite, neanche per le multe stradali (inizialmente si dubitava fossero escluse, ma il testo normativo non le esenta e anzi dottrina autorevole ritiene incluse anche quelle). Tuttavia, va precisato che per le sanzioni del Codice della Strada il processo sanzionatorio segue il suo corso (verbale -> ricorso Giudice di Pace/Prefetto, ecc.): l’accertamento esecutivo interviene solo in fase di riscossione se la multa è definitiva e impagata, sostituendo la cartella.
D: Ho ricevuto un avviso esecutivo: cosa devo fare immediatamente?
R: Segnarsi la data di notifica (es. la data sulla PEC o sull’avviso di ricevimento) e calcolare i 60 giorni. Entro quel termine devi decidere come reagire:
- Verifica innanzitutto che l’atto sia corretto formalmente: è intestato proprio a te? Riguarda un tributo/periodo che ti risulta? C’è la motivazione chiara? Importi e calcoli tornano? Se noti errori palesi (ad es. ti chiedono una tassa già pagata), raccogli le prove (ricevute, F24, ecc.).
- Se riconosci di dovere quei soldi, la scelta più semplice è pagare entro 60 giorni (vedi oltre per rateizzazione).
- Se ritieni l’atto sbagliato o ingiusto, devi attivarti per contestarlo: preparare un ricorso (tributario o altro a seconda del caso) o quantomeno segnalare all’ente le tue ragioni (istanza di autotutela) e valutare con un consulente i margini di vittoria in giudizio.
- Puoi anche fare entrambe le cose: ad esempio, presentare istanza di adesione/autotutela per vedere se l’ente corregge, e contestualmente predisporre il ricorso da inviare se non risolvono.
- Non ignorarlo! Se non fai nulla entro 60 gg, l’atto diverrà definitivo e potranno pignorarti beni e conti in pochi mesi.
D: Posso chiedere una dilazione del pagamento?
R: Sì. Hai due opportunità:
- Direttamente all’ente entro i 60 giorni: molti Comuni concedono rateazione degli avvisi di accertamento esecutivi per comprovate difficoltà. Devi presentare un’istanza motivata all’ufficio tributi prima della scadenza. Se accettata, l’ente ti darà un piano (es. 6, 12, 24 rate mensili a seconda dell’importo) e sospenderà l’invio al riscossore finché paghi le rate. In alcuni regolamenti è previsto che la prima rata va pagata entro i 60gg.
- All’Agente della Riscossione (dopo affidamento): se il debito è già passato ad Agenzia Entrate-Riscossione, puoi chiedere a loro la rateizzazione ex art.19 DPR 602/73. Fino a €120.000 bastano una semplice richiesta (massimo 72 rate mensili); sopra serve documentare la situazione economica (possono dare fino a 120 rate). Se la ottieni, l’Agente sospende le azioni esecutive in corso (un eventuale fermo auto già iscritto però resta finché non finisci di pagare tutte le rate).
In sintesi, sì, la rateazione è possibile e conviene chiederla appena capisci di non poter pagare in unica soluzione. Ricorda solo che, se contestualmente vuoi fare ricorso, la richiesta di rateazione potrebbe essere vista come ammissione del debito. In genere, però, la Cassazione ha detto che la dilazione di per sé non implica rinuncia al ricorso, specie se richiesta per evitare esecuzione. Meglio comunque consultare un legale in tali casi. E tieni presente che se salti le rate, decadi dal beneficio e l’intero debito residuo torna esigibile subito, con ripresa delle azioni esecutive.
D: Se faccio ricorso, la riscossione si blocca automaticamente?
R: No, non automaticamente. Il ricorso (tributario) presentato entro 60 giorni evita che l’atto diventi definitivo, ma non sospende di per sé la riscossione. Per sospendere la riscossione occorre:
- o ottenere una sospensiva dal giudice (tributario o civile a seconda del caso) dimostrando un danno grave e immediato;
- oppure, in ambito tributario, in parte opera la regola del pagamento frazionato: l’ente non dovrebbe riscuotere più di 1/3 delle imposte fino alla sentenza di primo grado. Ma, come detto, questa tutela è incerta con l’accertamento esecutivo (alcuni enti la ignorano).
Quindi, è prudente assumere che senza sospensiva l’Agente può procedere dopo i 180gg. Dunque, se ricorri, presenta anche istanza di sospensione al giudice. In alternativa, se temi tempi lunghi, puoi valutare di pagare parzialmente (es. solo il tributo) per ridurre il rischio. Ma ribadiamo: il ricorso in sé non ferma Equitalia (Agenzia Riscossione) – serve un ordine del giudice o un accordo di dilazione.
D: Che differenza c’è rispetto alla vecchia cartella esattoriale?
R: La cartella esattoriale era un atto emesso dall’Agente della Riscossione su un ruolo consegnato dall’ente, richiedeva di pagare entro 60 gg e in caso contrario dopo poteva eseguire. In pratica la cartella era un “passo successivo” all’accertamento: prima l’ente emetteva un avviso (non esecutivo), se non pagavi incaricava l’Agente che emetteva la cartella come titolo esecutivo. Ora invece non c’è più quel doppio passaggio per i crediti locali: l’avviso di accertamento stesso funge da titolo esecutivo, evitando la cartella. Ciò riduce i tempi di molti mesi/anni. Per il contribuente, la differenza è che deve attivarsi prima: non può più aspettare la cartella per impugnare – se non impugna l’accertamento esecutivo entro 60 giorni, poi non avrà altri “appelli” (se non contestare eventualmente il pignoramento, che è molto più limitato). In sintesi:
- Cartella: arrivava in media 1-2 anni dopo l’accertamento; dava 60 gg per pagare; se non pagavi, in 1 anno circa partiva pignoramento. Potevi impugnarla se per caso l’ente non ti aveva notificato l’atto prima.
- Accertamento esecutivo: arriva subito; 60 gg per pagare o ricorrere; se nulla fai, in meno di 1 anno puoi subire pignoramento. Non ci sarà più un’altra finestra di impugnazione tipo “cartella” (a parte la comunicazione di intimazione se passa un anno).
In compenso, l’accertamento esecutivo informa meglio il contribuente su tutto fin da subito (riporta anche chi farà la riscossione, ecc.) e uniforma a 60 gg il termine di difesa (prima alcuni atti andavano opposti in 30 gg, ora tendenzialmente no).
D: Cosa succede se ignoro l’atto e non pago?
R: Trascorsi i 60 giorni, l’atto diventa definitivo. Dopo ulteriori 30 giorni l’ente lo manda all’Agente della Riscossione. A quel punto:
- Potresti ricevere una comunicazione di sollecito o di presa in carico (non obbligatoria, ma spesso inviata).
- Trascorsi 180 giorni dall’affidamento (quindi circa 8-9 mesi dalla notifica iniziale), l’Agente può iniziare ad aggredire i tuoi beni:
- Soldi su conti correnti: può notificarti (senza preavviso specifico, se non l’eventuale intimazione 5 giorni) un pignoramento presso la banca, bloccandoti il conto fino a concorrenza del debito.
- Stipendio/Pensione: può pignorare il datore di lavoro o l’INPS prendendo una quota mensile (solitamente 1/10 o 1/7 dello stipendio netto a seconda dell’importo).
- Veicoli: può disporre il fermo amministrativo sui tuoi veicoli (ti arriverà un preavviso di fermo da pagare entro 30 gg, se non paghi iscriveranno il fermo al PRA e non potrai usare né vendere l’auto). Soglia: di solito lo fanno per debiti sopra €1.000.
- Immobili: può iscrivere ipoteca su tuoi immobili se il debito supera €20.000. Ti mandano preavviso 30 gg prima. L’ipoteca blocca la possibilità di venderli in modo regolare e crea un vincolo. Se il debito supera €120.000 e hai altri immobili (non prima casa non di lusso), può partire anche un pignoramento immobiliare con successiva vendita all’asta (ma è l’ultima ratio, e hai tutele come l’art.76 DPR 602/73 che protegge la prima casa in molti casi).
- Inoltre, il debito aumenterà per via degli interessi di mora (annuali) e degli oneri di riscossione (fino al 6% circa) che l’Agente ti addebiterà.
Insomma, ignorare l’atto significa andare incontro a procedure esecutive. Anche se non possiedi nulla di valore, l’Agente può rinnovare ogni anno la richiesta finché non paghi, e se mai acquisisci beni o crediti, potrà colpirli (le cartelle/ruoli si prescrivono in 5 anni ma ogni atto esecutivo interrompe questo termine). Dunque è altamente sconsigliabile ignorare: meglio affrontare il problema subito, magari concordando un pagamento rateale sostenibile.
D: Possono davvero pignorarmi lo stipendio o il conto senza altri avvisi?
R: Sì, dopo averti notificato l’accertamento esecutivo e (se prevista) l’intimazione di pagamento dopo un anno, non devono inviarti altro prima del pignoramento. L’avviso di accertamento esecutivo conteneva già la funzione di “precetto”. Dunque, per legge, non serve un ulteriore precetto del codice civile. L’unica eccezione è l’avviso di intimazione 5 giorni se è trascorso oltre un anno. In pratica:
- Se l’Agente agisce entro pochi mesi dalla consegna del carico (entro un anno dalla notifica iniziale), può fare direttamente gli atti esecutivi (pignoramenti, fermi) senza mandarti un precetto. Quindi potresti ritrovarti il conto bloccato da un giorno all’altro trascorsi circa 9-12 mesi dalla notifica iniziale.
- Se invece è stato più “lento” e fa passare oltre 1 anno, ti invia prima un avviso di intimazione (di solito arriva per raccomandata o PEC) che ti dà 5 giorni per pagare. Se ancora nulla, a quel punto procedono.
In ogni caso, è legittimo procedere senza ulteriori avvisi oltre quelli previsti dalla legge. Ovviamente, per pignorarti lo stipendio o altro, dovranno notificare un atto di pignoramento al terzo (datore di lavoro, banca) e anche a te contestualmente: ma a quel punto il pignoramento è già eseguito (il datore trattiene dallo stipendio dal mese dopo). Quindi sì, possono farlo. Con le cartelle era simile: dopo la cartella, Equitalia poteva pignorare dopo 60gg + intimazione se >1 anno. Adesso dopo l’accertamento esecutivo i tempi sono ridotti perché quell’atto ha già valore esecutivo.
D: Possono mettermi un’ipoteca sulla casa? E farmela vendere all’asta?
R: Possono ipotecare immobili di tua proprietà per garantirsi il credito, ma la vendita all’asta della prima casa per debiti tributari è proibita in molti casi. In dettaglio:
- L’ipoteca può essere iscritta dall’Agenzia Riscossione se hai un debito totale > €20.000. Ti notificheranno prima un preavviso di ipoteca dandoti 30 gg per pagare o fare osservazioni. Se non risolvi, dopo 30 gg possono iscriverla al Catasto/Pubblici registri. L’ipoteca non ti toglie la casa, ma impedisce di venderla liberamente (perché eventuali acquirenti la vedrebbero gravata). E l’Agente potrebbe, in futuro, espropriare quell’immobile se il debito supera certe soglie.
- Il pignoramento immobiliare e la vendita all’asta sono soggetti a limiti: l’art.76 DPR 602/73 (applicabile tramite rinvio alle regole di riscossione coattiva) vieta di espropriare l’unico immobile di residenza del debitore, salvo sia di lusso (categorie A/8, A/9) o che su quell’immobile gravino altre ipoteche di terzi. Quindi, se hai una sola casa in cui risiedi e non è villa di lusso, non possono venderla all’asta per i debiti fiscali. Possono però ipotecarla (il che incide se un domani la vendi tu, dovrai estinguere il debito per cancellare l’ipoteca).
- Se invece hai altri immobili (seconde case, terreni, capannoni) o la casa di residenza è di lusso, l’Agente potrebbe pignorarli se il debito supera €120.000. Anche qui c’è la regola dell’avviso 30 gg prima. Di solito l’Agente privilegia pignorare conti e stipendi (più rapidi) e ricorre a immobili solo per importi grossi o se altri metodi falliscono.
In sintesi: ipoteca sì sopra 20k, asta della prima casa no (salvo eccezioni), asta altri beni sì sopra 120k.
(NB: Queste soglie e tutele valgono per crediti tributari e contributivi. Per crediti di natura privatistica pur avuti dall’ente – es. affitto comunale – teoricamente l’ente potrebbe agire come un privato senza quei limiti. Ma spesso l’ente affidando ad Agenzia Riscossione soggiace a quelle stesse regole generali).
D: Qual è il termine di prescrizione di questi debiti?
R: La prescrizione dipende dalla natura del credito:
- Per i tributi locali, si applica la prescrizione breve quinquennale salvo eccezioni specifiche. La Cassazione ha chiarito che IMU, TASI, TARI, Tosap/Cosap, imposta pubblicità ecc. si prescrivono in 5 anni, richiamando l’art.2948 c.c. che copre le prestazioni periodiche annuali. Anche le sanzioni tributarie seguono 5 anni (diverso dalle sanzioni penali o multe stradali, ma per tributi sì quinquennale secondo giurisprudenza costante).
- Per le entrate extratributarie, bisogna valutare: se derivano da un rapporto di diritto privato (contratto di locazione, fornitura di servizi), la prescrizione ordinaria è 10 anni, breve 5 anni se prestazioni periodiche (es. canoni annuali di locazione: secondo Cassazione, 5 anni). Le sanzioni amministrative (multe) ad esempio del Codice della Strada hanno prescrizione 5 anni dal momento in cui la violazione è definitiva.
- Importante: la notifica dell’accertamento interrompe la prescrizione in essere (che solitamente decorreva dall’anno dopo quello dovuto per i tributi, o dalla scadenza pagamento per il resto). Dopo la notifica, se l’atto resta impagato, decorre un nuovo termine di prescrizione per il diritto di procedere alla riscossione forzata. La giurisprudenza in passato oscillava se fosse 5 o 10 anni: l’orientamento attuale è che se la legge non prevede un termine decadenziale specifico, vale la prescrizione ordinaria del credito sottostante anche per la riscossione. Quindi diremmo 5 anni. Ad esempio Cass. 20172/2021 ha ritenuto che la cartella esattoriale IMU non pagata si prescrive in 5 anni (non 10). Nel dubbio, comunque, la maggior parte dei crediti locali è 5 anni.
- Se nel frattempo ci sono atti interruttivi (intimazioni, pignoramenti) il termine si rinnova da capo.
Riassumendo: praticamente tutti i debiti verso Comuni per tributi, canoni, sanzioni sono soggetti a prescrizione di 5 anni, tranne poche eccezioni (es. fitti passivi decennali, ingiustificato arricchimento decennale, danno erariale decennale, ecc., che però non rientrano in questa procedura di accertamento esecutivo di solito).
D: Ci sono sentenze recenti che tutelano i contribuenti in questo ambito?
R: Sì, citiamo alcuni precedenti significativi:
- Cass. civ. sez. trib. n.7188/2022: ha stabilito che “le entrate non tributarie possono essere riscosse a mezzo ruolo solo se vi è un idoneo titolo esecutivo”, confermando la necessità del titolo anche per COSAP e canoni simili. Questa sentenza riguardava una cartella Cosap priva di un accertamento a monte ed è stata risolta a favore del contribuente. Dopo la L.160/2019, comunque, il legislatore ha rimediato prevedendo l’accertamento esecutivo proprio come tale titolo anche per le entrate patrimoniali.
- Cass. sez. trib. n.36675/2022: ha sancito la nullità insanabile di un avviso di accertamento intestato a persona deceduta e notificato presso il vecchio indirizzo. In altre parole, notificare un accertamento a un defunto è come non averlo notificato affatto; serve ripeterlo correttamente agli eredi.
- Cass. sez. trib. n.3860/2025: sentenza molto recente, ha ribadito i principi sulla motivazione degli atti tributari e sull’autotutela. Ha affermato che la motivazione dell’avviso deve contenere tutti gli elementi conoscitivi in possesso dell’ufficio e delimitare le ragioni della pretesa. Inoltre, ha affrontato il tema dell’autotutela (in quel caso un Comune aveva annullato in autotutela un accertamento per sostituirlo con un altro più corretto) chiarendo che l’autotutela può essere esercitata anche per vizi sostanziali senza violare il principio di unicità dell’accertamento, purché entro i termini di legge. Questo per il contribuente significa che non può opporsi a un nuovo avviso “correttivo” lamentando che c’era già un atto precedente, se il Comune lo ha ritirato in autotutela entro i termini.
- Cass. ord. n.2307/2023: ha chiarito il doppio regime di decadenza tra ruolo e ingiunzione (3 anni per ingiunzioni TARI post accertamento, 5 anni se accertamento esecutivo). Questo è rilevante per chi ancora si vede notificare ingiunzioni “vecchio stile” – significa che per quelle il Comune deve rispettare il termine breve speciale (ad es. per TARI era 3 anni dalla notifica dell’accertamento).
- Corte Costituzionale n.37/2015 (un po’ datata ma importante): dichiarò incostituzionale l’automatica esecutorietà dei ruoli senza previa notifica dell’accertamento (si riferiva ai tributi erariali). Ciò ha spinto a riformare garantendo sempre un atto precedente notificato al contribuente. L’accertamento esecutivo locale infatti conserva il diritto di difesa: prima di pignorare, l’ente deve averti notificato quell’avviso contenente l’intimazione.
- Cass. SU n.7822/2020: ha stabilito una linea netta sulle opposizioni a cartella per mancata notifica di atti presupposti – competenza tributaria, come già ricordato. Quindi in caso di vizi di notifica occorre rivolgersi al giudice tributario (principio da applicare analogicamente all’accertamento esecutivo).
In generale, la giurisprudenza recente è attenta a bilanciare l’efficienza della riscossione con il diritto di difesa del contribuente. Si segnala anche un consolidamento sul fatto che il contribuente può impugnare i soli atti tassativamente elencati (art.19 D.Lgs.546/92): per esempio, una comunicazione di “presa in carico” inviata da Agenzia Riscossione non è impugnabile come atto autonomo, a meno di far valere in quella sede la mancata notifica dell’atto principale. Quindi non tutti gli avvisi che arrivano sono contestabili: lo sono l’avviso di accertamento esecutivo, l’eventuale intimazione 5 giorni, il preavviso di fermo/ipoteca (in Commissione tributaria questi sono impugnabili come atti della riscossione), il pignoramento (anche quello impugnabile in Commissione se si contesta il fatto che l’ente poteva procedere). Ma un avviso generico di “il tuo debito è in riscossione dal 1/1/2025” non è titolo autonomo. Su questo punto, Cass. 21254/2023 ha proprio stabilito che l’avviso di presa in carico non rientra tra gli atti impugnabili.
D: L’ente locale può ancora usare la cartella esattoriale o l’ingiunzione fiscale invece dell’accertamento esecutivo?
R: Tecnicamente dal 2020 la legge impone il nuovo modello, quindi dovrebbe usare solo l’accertamento esecutivo. Tuttavia, in fase transitoria, alcuni enti hanno continuato ad emettere cartelle via Agenzia Riscossione per accertamenti antecedenti o per prassi consolidate. Altri hanno utilizzato l’ingiunzione fiscale R.D.639/1910 (uno strumento simile al decreto ingiuntivo in mano al Comune). Oggi, per atti dal 2020 in avanti, questo non è più legittimo perché la legge 160/2019 ha di fatto sostituito il sistema: le entrate devono essere riscosse con l’accertamento esecutivo. Se un Comune notificasse ancora un “accertamento semplice” seguito poi da un’ingiunzione separata, potrebbe esporsi a eccezioni di nullità (perché la legge ha abrogato l’obbligo di ingiunzione separata). La Cassazione ha detto che esistono regimi diversi di decadenza se l’ente “sceglie” uno o l’altro, ma dal 2020 la scelta non dovrebbe esserci più: l’accertamento è unico e esecutivo. Quindi aspettarsi oggi una cartella di pagamento per un tributo locale corrente è raro; semmai arriverà come comunicazione dell’Agente ma sempre in base a un accertamento esecutivo sottostante. L’ingiunzione fiscale potrebbe ancora essere usata per crediti di altri enti non coperti da L.160 (es: aziende speciali, consorzi, casi particolari) o per annualità vecchie. In conclusione: no, dal 2020 gli enti locali non dovrebbero più emettere cartelle o ingiunzioni separate per nuove entrate; tutto passa dagli avvisi accertamento esecutivi. Fa eccezione la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative statali (es. multe Prefettura) che ancora viaggia a ruolo, ma quelle non sono entrate comunali.
D: Come posso contestare un vizio formale (es. notifica errata) dell’accertamento esecutivo?
R: Devi comunque presentare ricorso (o opposizione) al giudice competente entro i termini, deducendo quel vizio come motivo. Ad esempio, se l’avviso ti è arrivato ma la notifica è stata fatta in modo irregolare (es. consegnato a persona non autorizzata), presenti ricorso alla Commissione Tributaria chiedendo l’annullamento per nullità della notifica e in subordine contestando il merito. Oppure, se non l’hai ricevuto affatto e scopri dopo il debito, impugni l’atto quando ne vieni a conoscenza allegando la nullità di notifica. Il giudice, se riscontra il vizio, annullerà l’atto (spesso senza entrare nel merito). Importante: i vizi di notifica di norma devono essere eccepiti dal contribuente alla prima occasione utile, sennò si sanano per raggiungimento dello scopo se poi fai ricorso nel merito. Quindi se rilevi difetti formali (mancata indicazione del funzionario, intestazione sbagliata, notifica a indirizzo vecchio…), inseriscili subito nei motivi di ricorso.
Se il vizio è clamoroso (es. atto intestato a soggetto completamente diverso), potresti anche rivolgerti all’ente in autotutela: spesso preferiscono annullare d’ufficio l’atto viziato piuttosto che andare in giudizio e perdere. Ad esempio, un Comune ha annullato in autotutela una serie di accertamenti TARI notificati a nominativi errati, per poi riemetterli corretti (senza sanzioni) agli effettivi destinatari.
D: Se il contribuente muore e arriva un accertamento, cosa devono fare gli eredi?
R: Se l’avviso era intestato al de cuius ma notificato dopo la morte direttamente a lui, come detto è nullo. Gli eredi in tal caso non devono pagare quell’atto, ma è bene che informino l’ente del decesso e chiedano la riemissione intestata a loro. Se invece l’ente notifica correttamente agli eredi (collettivamente o singolarmente) entro i termini di legge, gli eredi ne rispondono nei limiti dell’attivo ereditario. Gli eredi hanno gli stessi 60 giorni per fare ricorso se ritengono infondato l’accertamento, e possono eccepire eventualmente errori (ad es. se l’ente non ha seguito le regole dell’art.65 DPR 600/73: notifica collettiva nell’ultimo domicilio del defunto se ignoti gli eredi, oppure notifica nominativa ai singoli eredi noti). Spesso l’ente ignora il decesso e notifica comunque al vecchio indirizzo: in tali casi gli eredi potrebbero scoprire il debito solo in fase di riscossione e impugnarlo tardivamente come visto sopra.
D: In caso di difficoltà economica estrema (fallimento, nullatenenza) ha senso fare qualcosa?
R: Sì, conviene sempre comunicare la situazione all’ente: se ad esempio sei fallito o hai avviato una procedura di sovraindebitamento, i debiti tributari locali possono rientrare in quelle procedure. In caso di fallimento, gli accertamenti esecutivi devono essere inviati al curatore e non possono essere eseguiti (c’è il blocco delle azioni esecutive). Se sei privato nullatenente, ignorare del tutto comporta comunque che in futuro, se avrai qualche introito, verrai colpito. Meglio affrontare la questione, magari chiedendo una rate minima (Agenzia Entrate-Riscossione concede rate da €50 al mese se il reddito è basso). Oppure attendere eventuali condoni. L’importante è non accumulare ulteriori sanzioni: ad es., se sai di non poter pagare tributi correnti, almeno presenta le dichiarazioni per non incorrere in sanzioni per omessa dichiarazione (che sono ben più alte). Potrebbe essere utile farsi assistere da un professionista per valutare soluzioni come il saldo e stralcio tramite un piano di rientro ex L.3/2012 (per i privati) o transazione fiscale nel concordato (per aziende).
D: Il mio avviso esecutivo cita articoli di legge e procedure che non conosco (es. art.32 D.Lgs.150/2011, art.19 D.Lgs.472/97). Devo fare qualcosa in merito?
R: No, sono riferimenti normativi che l’ente è tenuto a inserire per legge. In particolare:
- L’art.19 D.Lgs.472/97 dice che se fai ricorso tributario, le sanzioni tributarie irrogate non sono riscuotibili finché non c’è sentenza di primo grado (quindi l’ente/Agente non ti chiederà di pagarle fino a esito). L’avviso lo riporta così sai che in caso di ricorso le sanzioni restano “congelate” secondo quella norma.
- L’art.32 D.Lgs.150/2011 informa che per i crediti patrimoniali se fai causa, il giudizio segue il rito ordinario. Non devi fare nulla di specifico, se non sapere che non c’è un rito speciale (ad es. se fosse stata una multa stradale c’è un rito particolare dal Codice della Strada, ma qui no, si va in tribunale con citazione normale).
- L’art.50 DPR 602/73 (richiamato dalla lettera h) dice dell’avviso di intimazione entro 5 gg dopo un anno. Anche qui: serve a informarti che se passa molto tempo ti manderanno quell’ulteriore avviso prima di pignorare.
In sintesi, sono notizie per il contribuente, non ci sono adempimenti da fare: l’ente le scrive perché la legge gli impone di comunicarti i tuoi diritti/doveri in caso di ricorso e riscossione.
D: Quanto mi costerà l’eventuale causa?
R: Nei ricorsi tributari, se il valore è sotto €3.000 puoi difenderti da solo (costi minimi: ~€30 di contributo unificato). Sopra, devi pagare un difensore: i costi variano a seconda della complessità, possono andare da poche centinaia di euro per cause semplici, a un paio di migliaia per cause complesse in primo grado. Se vinci, spesso il Comune viene condannato a rifonderti le spese (ma succede solo se il giudice ritiene la tua ragionevole, a sua discrezione). In opposizioni civili, costi analoghi o leggermente superiori (contributo unificato civile dipende dal valore: €98 fino a 5k €, €237 fino a 26k €, e così via). Considera anche i tempi (1-2 anni) e l’impegno. Valuta la convenienza: per importi modesti, magari conviene cercare un accordo o pagare piuttosto che andare in causa. Per importi alti, o questioni di principio, invece investire nella difesa può far risparmiare molto.
D: Vale la pena farsi assistere da un professionista (avvocato tributarista, commercialista) in questi casi?
R: Se la situazione è intricata, l’importo elevato, o ci sono di mezzo questioni giuridiche fini (es. distinguere giurisdizione, interpretare norme locali, predisporre atti giudiziari), sì, conviene. Un esperto saprà:
- Analizzare l’atto trovando eventuali vizi tecnici.
- Verificare la normativa comunale e casi analoghi (ad es., c’è magari una circolare del MEF o sentenza regionale che risolve la questione).
- Redigere ricorsi efficaci citando le giuste fonti di diritto.
- Negoziare meglio con l’ente un’eventuale soluzione di adesione.
Se invece l’importo è piccolo e la questione semplice (es. ti sei scordato di pagare €200 di tassa, non hai motivi per opporlo), puoi anche gestirla da solo pagando o chiedendo rate. Ricorda però che i funzionari comunali spesso sono più propensi a venire incontro se vedono un’istanza ben argomentata magari su carta intestata di un legale: sanno che potresti dar loro filo da torcere in giudizio, dunque possono preferire transare. Dunque, paradossalmente, coinvolgere un professionista può portare a chiudere la lite prima e con uno sconto (oltre che aumentare le chance di vincere in giudizio in caso di contenzioso).
D: Potrò comunque usufruire di eventuali condoni o “rottamazioni” in futuro se ora presento ricorso o rateizzo?
R: Sì, in genere sì. Ad esempio, nella Definizione agevolata 2023 dei carichi locali, erano inclusi anche gli accertamenti esecutivi affidati all’agente entro 2022, indipendentemente dal fatto che fossero rateizzati o in contenzioso (bastava rinunciare al contenzioso eventualmente). Quindi, se oggi fai ricorso ma domani esce una sanatoria, potrai aderire rinunciando al ricorso (il che di solito comporta pagare solo il tributo senza sanzioni). Anche se rateizzi, nulla vieta che la residua somma possa essere condonata. Occhio però: se paghi interamente, e poi esce un condono, non è previsto rimborso (solitamente i condoni valgono per chi ha debiti pendenti, non rimborsano chi ha già pagato). È capitato con lo stralcio 2023: chi aveva già pagato nulla ha potuto recuperare. Quindi, se appare probabile una rottamazione e il tuo è un debito elevato, può valere la pena aspettare o pagare solo a rate minime tenendo il debito “aperto”. È un azzardo e non garantito (non si sa se e quando il legislatore condonerà, e condonare troppi debiti locali penalizza i bilanci comunali, quindi non succede spesso). Diciamo: non contare sul condono, ma se avviene, di solito ti permette di chiudere anche se sei in causa o in piano di rate.
D: Ho sentito parlare del “funzionario responsabile della riscossione” e di nuove figure negli enti. Mi riguarda?
R: È un aspetto organizzativo: la L.160/2019 ha previsto che gli enti nominino un Funzionario Responsabile per la riscossione coattiva (una sorta di “ufficiale della riscossione” interno) con poteri di firmare pignoramenti ecc. per l’ente. Alcuni enti piccoli che riscuotono in proprio devono dotarsi di questa figura. Per te, contribuente, cambia poco: se l’ente riscuote direttamente, magari riceverai atti di pignoramento firmati da questo funzionario comunale invece che dall’Agente Entrate Riscossione. Ma i tuoi diritti di difesa restano gli stessi. È più un tema “interno” alla P.A. che non incide sulle procedure già spiegate (i termini, l’esecuzione, ecc. seguono le stesse regole).
D: Se ricevo una “comunicazione di presa in carico del debito” dall’Agenzia Entrate-Riscossione, posso impugnarla?
R: Come accennato, no, quella non è un atto autonomamente impugnabile. È solo una lettera informativa. Gli atti contro cui puoi fare ricorso sono elencati tassativamente: avvisi di accertamento (anche esecutivi), provvedimenti di irrogazione sanzioni, cartelle di pagamento, ingiunzioni, fermi, ipoteche, pignoramenti, intimazioni. Una comunicazione generica che dice “abbiamo ricevuto il tuo carico X, se vuoi pagare fallo entro tot” non rientra in questi. Quindi non sprecare un ricorso su quella, verrebbe dichiarato inammissibile. Piuttosto, se dietro c’è un vizio (tipo non hai avuto l’atto base), impugna l’atto base come visto. Se invece la comunicazione è corretta e vuoi contestare il merito, purtroppo se il termine di ricorso contro l’avviso originario è passato, non puoi più farlo: potrai solo eventualmente opporre la cartella/intimazione sul piano esecutivo (questioni formali, non il merito del tributo).
Conclusione
Dal punto di vista del debitore l’accertamento esecutivo rappresenta una sfida: occorre prestare massima attenzione a questo atto, che concentra in sé l’intero potere di accertamento e riscossione dell’ente locale. Se ignorato, può portare in tempi relativamente brevi a misure forti (pignoramenti, fermi, ecc.) sul patrimonio del debitore. Tuttavia, il sistema prevede anche le necessarie garanzie: il debitore ha diritto a essere informato con un atto motivato, ha 60 giorni per difendersi, può ottenere la sospensione dal giudice se ne ricorrono i presupposti e ha la possibilità di rateizzare il debito per attenuarne l’impatto. Inoltre, importanti sentenze della Suprema Corte hanno consolidato principi a tutela del contribuente (sulla prescrizione quinquennale, sulla necessità di una valida notifica, sulla motivazione degli atti, ecc.), ai quali si può fare riferimento nelle opposizioni.
In definitiva, “cosa fare” di fronte a un accertamento esecutivo patrimoniale si riassume così:
- Non trascurarlo: leggere attentamente l’atto, capire per cosa si è addebitati e se ci sono errori.
- Entro i 60 giorni, decidere se pagare (magari a rate) oppure impugnare. Pagare conviene se il debito è corretto e sostenibile; impugnare conviene se ci sono validi motivi di illegittimità o infondatezza.
- Se si impugna, seguire la procedura giurisdizionale appropriata (ricorso tributario o opposizione civile) e chiedere misure cautelari se necessario. Prepararsi anche all’eventualità di proseguire con appello se non si ottiene ragione in primo grado.
- Nel frattempo, comunicare con l’ente: un accordo in adesione o in autotutela può risparmiare tempo e denaro. Spiegare la propria situazione (ad es. difficoltà economica, errore scusabile) può portare a una soluzione più favorevole (riduzione sanzioni, ecc.).
- Monitorare la fase di riscossione: se non hai pagato tutto, tieni d’occhio la posta (anche PEC) per eventuali avvisi di Agente Riscossione. Appena ne arriva uno, valuta se il tuo ricorso è pendente (allora segnala all’agente l’esistenza della sospensiva, se c’è) oppure se devi fare opposizione all’esecuzione.
- Preservare i diritti essenziali: se rischi il fermo dell’auto che ti serve per lavorare, sappi che puoi chiederne la sospensione al giudice mostrando il pregiudizio grave. Se hai solo la casa dove vivi, conosci la norma che la protegge da vendita (e se l’agente tentasse comunque, sarebbe un abuso da far valere).
- Tenere traccia di tempi e scadenze: se l’ente o l’agente lasciano passare 5 anni senza atti, ricorda di far valere la prescrizione.
Questa guida ha fornito un panorama completo e aggiornato al 2025 per muoversi con consapevolezza nell’ambito dell’accertamento esecutivo locale. Pur essendo rivolta ai debitori, bisogna infine considerare che l’obiettivo del legislatore è stato anche quello di aumentare la compliance: sapere che il Comune può agire così rapidamente spingerà molti a mettersi in regola spontaneamente. D’altro canto, gli enti locali devono applicare queste norme con responsabilità e correttezza, perché ogni errore procedurale può essere censurato in giudizio come abbiamo visto. In caso di dubbi specifici sulla propria situazione, è sempre consigliabile consultare un professionista. Con le informazioni qui raccolte, però, il debitore è già in grado di orientarsi sulle scelte da compiere e di dialogare a ragion veduta con l’ente o con il proprio consulente legale.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) – art.1, commi 784-793: introduzione avviso di accertamento esecutivo per tributi ed entrate patrimoniali locali.
- Decreto Leg.vo 31 dicembre 1992 n.546, art.21 (ricorso 60 gg) e art.17-bis (mediazione/reclamo tributari); art.68 (sospensione frazionata della riscossione); art.47 (sospensione giudiziale).
- Decreto Leg.vo 18 dicembre 1997 n.472, art.19: sospensione riscossione sanzioni tributarie in pendenza di ricorso.
- Decreto Leg.vo 1 settembre 2011 n.150, art.32: rito ordinario per controversie su riscossione entrate patrimoniali pubbliche.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, art.50 (intimazione 5 gg prima di esecuzione); art.76 (limiti espropriazione immobiliare prima casa).
- Cassazione Civile, Sez. Trib., sent. n.7188/2022 – Necessità di titolo esecutivo per ruoli su entrate non tributarie (Cosap).
- Cassazione Civile, Sez. Trib., sent. n.582/2017 – Natura privatistica canone COSAP e prescrizione quinquennale (richiamata in Cass.7188/2022).
- Cassazione Civile, Sez. Trib., sent. n.31331/2019 – Occupazione suolo pubblico: silenzio-assenso e canoni (sul rapporto concessorio, citata per analogia).
- Cassazione Civile, Sez. Trib., ord. n.2307/2023 – Doppio regime decadenza riscossione tributi locali: tre anni se ingiunzione ex L.296/2006, quinquennio se accertamento esecutivo.
- Cassazione Civile, Sez. Trib., sent. n.36675/2022 – Nullità avviso intestato a soggetto deceduto e notificato presso di lui (notifica inesistente).
- Cassazione Civile, Sez. Trib., sent. n.3860/2025 – Sufficienza motivazione avvisi di accertamento locali: deve contenere tutte le ragioni, motivazione per relationem solo se atti allegati. Conferma esercizio autotutela sostitutiva per vizi sostanziali non viola unicità accertamento.
- Cassazione SS.UU. 19854/2004 e 5791/2008 (precedenti storici) – Giurisdizione tributaria su opposizioni ad atti della riscossione relativi a tributi (includendo vizi notifica atti presupposti).
- Cassazione SS.UU. 7822/2020 – Giurisdizione tributaria su opposizione avverso cartella per omessa notifica atti presupposti (giudice tributario come giudice dell’esecuzione tributaria).
- Cassazione SS.UU. 34447/2019 – Impugnabilità preavvisi di fermo/ipoteca innanzi a giudice tributario come atti della riscossione (principio applicabile).
- Corte Costituzionale n.37/2015 – Illegittimità art. 48-bis DPR602/73 (ruoli provvisori esecutivi) per mancata previa notifica accertamento; necessità contraddittorio preventivo.
- Norme secondarie e prassi: Regolamenti comunali di riscossione coattiva (es. Regolamento Ministero Finanze tipo 2020); Circolare MEF Telefisco 2022 (conferma accertamento esecutivo per Canone Unico).
- Pubblicazioni ufficiali: ANCI-IFEL, Nota di lettura L.160/2019 (gen 2020); Dispense Formez 2020 su riforma riscossione (funzionario responsabile etc.).
- Giurisprudenza di merito: varie Commissioni Tributarie Provinciali/Regionali (CTP/CTR) hanno emanato sentenze su accertamenti esecutivi, spesso confermando nullità per vizi formali (non riportati qui per brevità, ma es. CTP Napoli 2021 su mancata indicazione soggetto riscossore).
Hai ricevuto un accertamento esecutivo per entrate patrimoniali? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Se ti è stato notificato un accertamento esecutivo per entrate patrimoniali da parte di un ente locale (Comune, Provincia, ecc.), non si tratta di una semplice richiesta di pagamento: è un atto che ha valore immediato di titolo esecutivo.
Tradotto: se non ti opponi per tempo, possono partire pignoramenti, fermi, ipoteche o altre azioni forzate.
Cosa sono le entrate patrimoniali e l’accertamento esecutivo?
Le entrate patrimoniali sono somme dovute a un ente pubblico per:
- 🏠 Affitti o concessioni di immobili pubblici
- 🚗 Sanzioni diverse da quelle tributarie
- 🏖️ Canoni di occupazione, spese di suolo pubblico
- 🧾 Indennità, rimborsi, danni o altri obblighi contrattuali verso l’ente
Con la normativa vigente, l’ente può notificare un unico atto di accertamento, che ha valore di intimazione e di titolo per agire forzatamente (senza passare dal giudice).
Perché è pericoloso se non reagisci subito?
- ⚠️ L’atto è immediatamente esecutivo: bastano 30 giorni per avviare il pignoramento
- 💸 Può comportare il blocco del conto corrente, dello stipendio o della pensione
- 🏦 Non serve alcun precetto: l’ente può notificare direttamente al terzo (banca, datore di lavoro, INPS)
- 🧾 Anche una contestazione infondata può trasformarsi in un danno concreto
Quando e come si può contestare?
Puoi contestare l’accertamento se:
- 📅 È stato notificato oltre i termini previsti
- 🔍 Riguarda somme non dovute o già pagate
- 📑 Non è motivato in modo chiaro, o manca la prova del credito
- ⚖️ Presenta errori di calcolo, doppie richieste o dati errati
- 📂 La voce contestata non rientra tra le entrate patrimoniali esigibili
Il ricorso si presenta al giudice ordinario o alla Corte dei Conti, a seconda della natura del credito, entro 30 giorni dalla notifica.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📑 Analizza l’atto di accertamento esecutivo per verificarne la legittimità
📂 Raccoglie la documentazione utile a dimostrare pagamenti o decadenze
✍️ Redige il ricorso al giudice competente e chiede la sospensione dell’esecuzione
⚖️ Ti difende da eventuali azioni forzate già avviate (pignoramento, fermo, ipoteca)
🔁 Ti assiste nel dialogo con l’ente pubblico per rinegoziare o chiudere la posizione
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso su atti esecutivi di enti pubblici e locali
✔️ Consulente per ricorsi per annullamento di accertamenti patrimoniali e blocchi esecutivi
✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per famiglie, imprenditori e professionisti colpiti da pretese patrimoniali illegittime
Conclusione
L’accertamento esecutivo per entrate patrimoniali è un atto aggressivo, ma puoi bloccarlo se agisci nei tempi e con la giusta strategia.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi difenderti in modo efficace, annullare l’atto e fermare il pignoramento prima che sia troppo tardi.
📞 Richiedi ora una consulenza riservata per bloccare l’accertamento esecutivo e tutelare il tuo patrimonio.