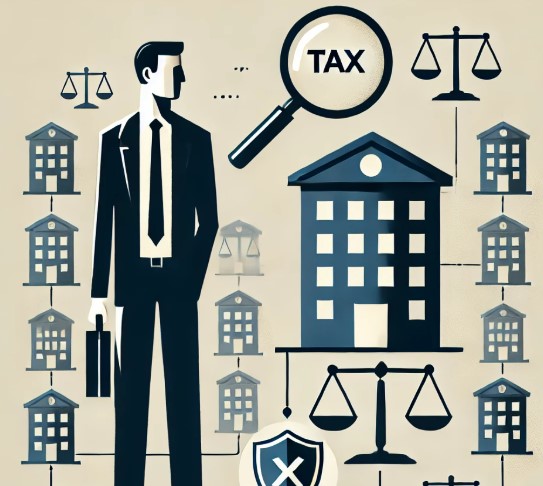Hai ricevuto un accertamento fiscale come amministratore di una holding e ti stai chiedendo perché stanno controllando proprio te, quali responsabilità puoi avere e come puoi difenderti? L’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza ha messo nel mirino la società, ma ora ti trovi coinvolto personalmente?
L’accertamento all’amministratore di una holding è una procedura delicata, perché spesso riguarda operazioni infragruppo, gestione fiscale delle partecipate, distribuzione di utili e controllo effettivo del patrimonio. Ma attenzione: essere amministratore non significa essere automaticamente colpevole, e hai diritto a difenderti con strumenti precisi.
Perché l’amministratore di una holding può subire un accertamento fiscale?
– Perché la holding è al vertice di un gruppo e gestisce partecipazioni, dividendi, flussi di cassa e talvolta costi comuni
– Perché l’amministratore è considerato responsabile delle scelte gestionali e tributarie
– Perché se ci sono anomalie fiscali, sottofatturazioni, prestazioni infragruppo fittizie o operazioni elusive, il Fisco può contestare violazioni anche personali
Cosa può contestarti l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza?
– Responsabilità fiscale diretta, in caso di omesse dichiarazioni, false comunicazioni o operazioni simulate
– Distribuzioni occulte di utili a te imputate come reddito personale
– Compensi non dichiarati, benefit mascherati o uso personale di beni sociali
– Esterovestizione, se la holding ha sede estera ma opera di fatto in Italia
– Condotte elusive o fraudolente in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti)
Cosa puoi fare se ricevi un accertamento come amministratore?
– Analizzare subito l’atto notificato per capire se riguarda te personalmente o solo la società
– Verificare se ci sono presunzioni errate, come l’attribuzione automatica di redditi o responsabilità
– Se l’accertamento è fondato su un verbale di constatazione, valutare l’adesione con sanzioni ridotte
– Se coinvolge solo la società, difendere il corretto ruolo gestionale e la separazione patrimoniale
– Se ti attribuiscono redditi personali non dichiarati, documentare che si trattava di operazioni lecite e tracciate
Come si può impostare una difesa efficace?
– Ricostruendo con precisione l’organigramma, i ruoli e le deleghe nella holding
– Dimostrando la reale natura delle operazioni infragruppo con contratti, bilanci e corrispondenza
– Contestando eventuali presunzioni o ricostruzioni induttive non supportate da prove
– Affidandoti a un avvocato esperto per valutare ricorso, autotutela o definizione agevolata
Cosa NON devi fare mai?
– Firmare verbali o accertamenti senza averli analizzati: potresti assumerti responsabilità non tue
– Pensare che “essere solo l’amministratore” ti esoneri da controlli: il Fisco può colpire anche sul piano personale
– Confondere il patrimonio della società con il tuo: il rischio è che ti vengano imputati redditi non tuoi
– Agire senza supporto legale: il Fisco può usare ogni errore a tuo svantaggio
Essere amministratore di una holding non significa essere automaticamente responsabile di tutto. Ma se parte un accertamento, serve una strategia difensiva tecnica, tempestiva e costruita su misura.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e responsabilità degli amministratori – ti spiega quando l’Agenzia delle Entrate può colpire l’amministratore, cosa può contestare e come difenderti in modo efficace.
Hai ricevuto un accertamento come amministratore di holding e vuoi tutelarti?
Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la documentazione, valuteremo la tua posizione e costruiremo una difesa completa per proteggere il tuo ruolo, il tuo patrimonio e i tuoi diritti.
Introduzione
Gli amministratori di società holding – tipicamente società di capitali che detengono partecipazioni in altre società – possono trovarsi coinvolti in accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate o altri enti. Un avviso di accertamento è l’atto con cui il Fisco contesta al contribuente maggiori imposte dovute, sanzioni e interessi, a seguito di verifiche o controlli. Normalmente questi atti sono emessi nei confronti della società contribuente; tuttavia, in casi particolari, l’accertamento può essere rivolto personalmente all’amministratore (o ai soci) di una holding. Dal punto di vista del debitore – ossia dell’amministratore destinatario dell’atto o comunque potenzialmente obbligato – è cruciale comprendere quando e perché ciò avviene e soprattutto cosa fare per tutelare i propri diritti e il proprio patrimonio.
In questa guida avanzata, destinata a professionisti (avvocati, consulenti) ma anche a imprenditori e privati con interessi societari, esamineremo in dettaglio:
- I principi normativi italiani che regolano la responsabilità tributaria di amministratori e soci, con focus sulle holding.
- I diversi tipi di accertamento fiscale che possono riguardare una holding e il suo amministratore (ad esempio accertamenti tributari ordinari, presuntivi, accertamenti emessi ai sensi di leggi speciali).
- Le possibili responsabilità sanzionatorie (amministrative e penali) a carico dell’amministratore in relazione ai debiti tributari della società.
- Le implicazioni patrimoniali personali: in quali casi il Fisco (o altri creditori) può aggredire i beni personali dell’amministratore.
- Le strategie difensive e procedure da attuare (“cosa fare”) quando si riceve un accertamento in tali contesti, incluse le opzioni di definizione agevolata, ricorso in Commissione (ora Corte di Giustizia Tributaria) e così via.
- Riferimenti a norme aggiornate al 2025 e alle più recenti sentenze della giurisprudenza (Corte di Cassazione e giustizia tributaria) che hanno inciso sulla materia.
- Tabelle riepilogative e esempi pratici (simulazioni), per riassumere i punti chiave e mostrare casi concreti dal punto di vista del debitore.
- Una sezione di Domande e Risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più frequenti in modo diretto.
Principi generali: patrimonio sociale e responsabilità dell’amministratore
Nel diritto societario italiano vige il principio fondamentale della separazione patrimoniale tra la società di capitali e le persone dei suoi soci o amministratori. In altre parole, i debiti della società (incluse le imposte dovute) devono essere pagati con il patrimonio sociale, e di regola **soci e amministratori non ne rispondono con i propri beni personali】. Questo vale sia per debiti sorti durante la normale attività della società, sia per quelli emergenti in fase di liquidazione. Dunque, come afferma la Cassazione, un atto impositivo intestato direttamente a un amministratore, anziché alla società contribuente, è normalmente nullo in quanto rivolto a un soggetto estraneo all’obbligazione tributaria. Ciò riflette il postulato che, salvo eccezioni di legge, il legale rappresentante di una società non può essere chiamato a pagare personalmente i tributi dovuti dalla società stessa.
Tuttavia, queste eccezioni esistono e rivestono un ruolo cruciale nel caso di holding. In particolare, l’ordinamento italiano prevede alcune ipotesi in cui, a determinate condizioni, i soci o gli amministratori diventano personalmente responsabili per i debiti sociali (compresi quelli tributari). Le due norme cardine in materia, sulle quali torneremo diffusamente, sono:
- Art. 2495 cod. civ.: riguarda la responsabilità di soci e liquidatori dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. I soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; i liquidatori rispondono se il mancato pagamento dei debiti sociali è dovuto a loro colpa. In pratica, dopo lo scioglimento di una società di capitali, i creditori (compreso il Fisco) possono ancora agire contro i soci (fino a concorrenza delle somme ricevute in liquidazione) o contro i liquidatori negligenti.
- Art. 36 del D.P.R. 602/1973: prevede una particolare responsabilità tributaria personale a carico di liquidatori, amministratori e anche soci, se non sono stati assolti gli obblighi di pagamento delle imposte con le attività della liquidazione. Questa norma – parte della disciplina sulla riscossione delle imposte – è stata rafforzata dal 2014 estendendola a tutte le imposte dovute dalla società (non solo alle imposte sui redditi). Come vedremo, l’art. 36 consente all’Erario di emettere un atto di accertamento motivato direttamente nei confronti dell’amministratore o liquidatore inadempiente, atto che potrà essere impugnato innanzi al giudice tributario.
Oltre a queste norme esplicite, la giurisprudenza ha sviluppato ulteriori principi: ad esempio, se la società viene utilizzata in modo fraudolento o come schermo fittizio per evadere il Fisco, allora il velo societario può essere sollevato. La Cassazione ha affermato che, quando la persona giuridica è creata artificiosamente per fini illeciti, la persona fisica che la dirige va considerata al tempo stesso “trasgressore e contribuente”, essendo la società una mera fictio. In tali casi estremi (si pensi a società cartiere prive di attività reale, o a “teste di legno” intestatarie di società in vece altrui), le protezioni normalmente offerte dalla personalità giuridica vengono meno: l’amministratore di fatto o il socio occulto che ha tratto beneficio illecito può essere ritenuto direttamente debitore d’imposta. Come osservato in dottrina, la responsabilità imputata all’amministratore/socio è qui fondata sulla natura fraudolenta dell’operazione, con conseguente inapplicabilità della normativa ordinaria delle società regolari.
È importante notare che la responsabilità personale dell’amministratore, quando prevista, non è solidale illimitata con la società, bensì una forma di obbligazione autonoma e per fatto proprio, legata ai presupposti specificati dalla legge. Ad esempio, la responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 del liquidatore (o amministratore in mancanza di liquidatore) è circoscritta alle imposte che egli avrebbe dovuto soddisfare con le attività sociali in liquidazione. Analogamente, la responsabilità dei soci post-chiusura ex art. 2495 c.c. è limitata a quanto da essi riscosso. Questi limiti evidenziano come tali figure non ereditino in toto il debito fiscale sociale, ma ne rispondono entro confini precisi.
Un altro principio generale da tenere presente è la distinzione fra società di capitali e società di persone. Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.), i soci stessi (in particolare i soci illimitatamente responsabili, come i soci SNC e gli accomandatari di SAS) rispondono direttamente e solidalmente di tutti i debiti sociali, tributi inclusi. Perciò, in quelle società, l’accertamento fiscale può colpire direttamente il socio-amministratore in virtù della struttura societaria. Ma nel caso di una holding di capitali (S.r.l. o S.p.A.), come detto, vale la separazione patrimoniale e solo le eccezioni di legge consentono di colpire l’amministratore a titolo personale.
Riassumendo i concetti chiave in una tabella:
Tabella 1 – Responsabilità per debiti tributari: società vs amministratori/soci
| Situazione | Regola generale | Eccezioni legali (responsabilità personale) | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Società di capitali operativa, debiti tributari correnti | La società risponde con il proprio patrimonio. L’amministratore non è obbligato personale per imposte e sanzioni dovute dalla società. | Nessuna responsabilità personale dell’amministratore, salvo violazioni penali (vedi oltre). Un accertamento intestato direttamente all’amministratore sarebbe nullo. | Art. 2472 c.c.; Art. 7 DL 269/2003 (sanzioni solo a carico della società). |
| Società di persone (SNC, accomandatari SAS) | Soci illimitatamente responsabili rispondono anche con patrimonio personale dei debiti sociali. | Non applicabile (qui la responsabilità dei soci è la regola stessa). | Art. 2291 c.c.; Art. 2313 c.c. (accomandatari). |
| Società di capitali cancellata (liquidazione conclusa) | In assenza di norme speciali, la società estinta non può essere destinataria di atti e i debiti insoddisfatti rimangono in linea di principio insoddisfatti. | – Soci: rispondono entro le somme ricevute in liquidazione.- Liquidatori: rispondono se il mancato pagamento è dovuto a loro colpa (fino a danno causato).NB: Per 5 anni dalla cancellazione, l’estinzione non ha effetto verso il Fisco (inopponibilità quinquennale), consentendo accertamenti alla società stessa. | Art. 2495 c.c.;Art. 28 co.4 D.lgs. 175/2014 (estinzione inefficace 5 anni verso Erario). |
| Liquidazione in corso: omesso pagamento imposte | – | Liquidatori (o amministratori se non nominati liquidatori) rispondono personalmente delle imposte non pagate utilizzando l’attivo della liquidazione, se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima di pagare soci o altri creditori di rango inferiore. Responsabilità limitata all’ammontare delle imposte che si sarebbero potute pagare con l’attivo distribuito. | Art. 36 co.1-2 DPR 602/1973; Cass. SS.UU. 32790/2023. |
| Atti distrattivi prima della liquidazione (es. occultamento di attivi) | – | Amministratori che, nei 2 esercizi precedenti lo scioglimento, hanno compiuto operazioni di fatto liquidatorie o occultato attività sociali rispondono personalmente delle imposte corrispondenti ai beni occultati. | Art. 36 co.4 DPR 602/1973. |
| Utilizzo fraudolento della società (società-schermo, teste di legno) | – | Soci/amministratori considerati trasgressori diretti: la società viene ignorata come soggetto. Possono essere chiamati a rispondere integralmente del debito tributario come se fosse proprio (oltre a sanzioni penali). Necessaria prova rigorosa dell’abuso dello schema societario. | Cass. 19716/2013; Cass. 25989/2013; Cass. 13259/2015. |
| Società a ristretta base (pochi soci) con utili non dichiarati | – | Presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati nella società. L’Agenzia può emettere avvisi di accertamento IRPEF verso i soci (incluso l’eventuale amministratore-socio) imputando loro tali somme come dividendi occulti. Presunzione iuris tantum: il socio può fornire prova contraria (ad es. che utili reinvestiti o che era estraneo alla gestione). | Cass. 12288/2025;Cass. 2464/2025;Art. 7 co.5-bis D.lgs. 546/1992 (onere della prova in giudizio). |
(Nella tabella sopra, per semplicità espositiva, non sono distinti i casi di “holding” da quelli di società normali: le regole generali sono le medesime. Le holding, essendo spesso società a ristretta base con funzioni di detenzione patrimoniale, rientrano di frequente nelle ultime due categorie: società a base familiare con possibili utili extracontabili, oppure veicoli potenzialmente passibili di contestazioni di abuso di personalità giuridica se usati per fini illeciti.)
Nei prossimi paragrafi esamineremo più da vicino tutti questi tipi di accertamento e situazioni, dal punto di vista pratico dell’amministratore di holding che li subisce, approfondendo le implicazioni patrimoniali, le sanzioni e le strategie difensive.
Tipologie di accertamento fiscale che possono coinvolgere l’amministratore di una holding
Accertamento fiscale è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria determina un maggior reddito imponibile o imposta dovuta rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, emettendo un atto (avviso di accertamento) motivato. Per una holding, possiamo distinguere varie tipologie di accertamento che, direttamente o indirettamente, chiamano in causa la figura dell’amministratore:
- 1. Accertamento tributario ordinario verso la società (holding) – È il caso classico in cui l’Agenzia delle Entrate verifica la dichiarazione dei redditi (IRES, IRAP) della holding o la liquidazione IVA, riscontrando irregolarità. Può trattarsi di un accertamento analitico (fondato su dati contabili con rettifiche puntuali) o induttivo (basato su presunzioni quando la contabilità è inattendibile), ai sensi del D.P.R. 600/1973. Esempi: ripreso a tassazione un costo ritenuto indebito, contestazione di ricavi non dichiarati, rettifica di detrazioni IVA, ecc. In tale scenario, l’avviso di accertamento è intestato alla società holding, quale soggetto passivo d’imposta. L’amministratore, pur non essendo formalmente il destinatario, è coinvolto in quanto legale rappresentante: sarà lui a ricevere la notifica per la società, a dover eventualmente predisporre la difesa della società (col supporto di professionisti) e ad eseguire o impugnare l’atto. Dal punto di vista giuridico, però, il debito d’imposta rimane in capo alla società e non diventa automaticamente personale dell’amministratore. Se infatti la holding è in bonis (attiva e patrimonialmente capiente), l’amministratore non rischia l’escussione dei propri beni: la pretesa fiscale dovrà essere soddisfatta dal patrimonio sociale. Caso pratico: Alfa S.r.l. (holding) subisce un accertamento per maggiori ricavi non dichiarati nel 2022. L’avviso chiede ad Alfa S.r.l. €100.000 di IRES e IVA. L’amministratore Tizio, pur preoccupato, sa che il debito è della società: se Alfa paga o se ne ha le risorse, i suoi beni personali non sono toccati. Egli dovrà attivarsi per valutare se pagare, fare ricorso o tentare un accordo (accertamento con adesione) nell’interesse della società. Solo in eventuali fasi successive, se la società non paga e dovesse ad esempio essere liquidata senza soddisfare il Fisco, potrebbero emergere responsabilità personali (vedi oltre). In sede di accertamento ordinario, però, l’amministratore agisce come organo della società, non come obbligato diretto.
- 2. Accertamenti basati su presunzioni nei confronti della società (holding non operativa, holding di famiglia, ecc.) – Il legislatore ha predisposto alcune metodologie di accertamento presuntivo che spesso riguardano le holding. Un esempio è la disciplina delle “società non operative” (cosiddette società di comodo ai sensi della L. 724/1994, art. 30). Le holding pure, che detengono partecipazioni e asset ma non svolgono attività industriale o commerciale diretta, a volte faticano a superare i test di operatività (ricavi minimi in rapporto alle attività patrimoniali). Se una holding viene considerata di comodo, le norme attuali le attribuiscono un reddito minimo presunto (calcolato con percentuali sul valore di immobili, partecipazioni, crediti) su cui comunque pagare imposte, indipendentemente dal risultato contabile. L’accertamento scatta qualora la società dichiari redditi inferiori al minimo presunto e non rientri in cause di esclusione o disapplicazione. Dal punto di vista dell’amministratore, un tale accertamento (o, più spesso, una comunicazione di irregolarità su “reddito minimo”) va gestito presentando istanza di interpello disapplicativo se la holding ha valide ragioni per i bassi ricavi (ad es. partecipazioni che non distribuiscono utili) oppure mettendo in conto di dover far risultare un reddito imponibile forfettario. Anche qui la pretesa è verso la società; l’amministratore non è debitore personale, ma deve agire diligentemente per evitare che la società accumuli un debito fiscale per redditi presunti. Simulazione: Beta Holding S.p.A. possiede immobili sfitti e partecipazioni, risultando non operativa. Dichiarando perdite fiscali, riceve dall’Agenzia Entrate una comunicazione che le imposte saranno calcolate su un reddito minimo di €50.000. L’amministratore Caio valuta un interpello per escludere Beta dalla disciplina (dimostrando, ad esempio, che la società è in start-up e non un mero schermo patrimoniale) oppure accetta la determinazione forfettaria pagando le maggiori imposte con fondi sociali. Ancora, Caio personalmente non subisce conseguenze immediate – salvo il dovere di evitare usi elusivi della società che potrebbero configurare abuso.
- 3. Accertamento “in capo all’amministratore” per utili non dichiarati dalla holding (presunzione di distribuzione ai soci) – Questa è una tipologia di particolare rilevanza per le holding a base ristretta (es. società familiari o con un unico socio-amministratore). La Corte di Cassazione da anni applica la regola secondo cui, in presenza di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento di utili extrabilancio (redditi non dichiarati) in capo alla società fa sorgere una presunzione semplice che tali utili siano stati immediatamente distribuiti ai soci in proporzione alle quote. Ciò consente al Fisco di emettere accertamenti anche nei confronti dei soci persone fisiche (talora coincidenti con gli amministratori) per tassare quei redditi come dividendi percepiti e non dichiarati (soggetti ad IRPEF). Ad esempio, se Gamma S.r.l. (holding posseduta al 100% dall’amministratore) occulta ricavi per 1 milione di euro, l’Ufficio potrà: (i) accertare in capo a Gamma S.r.l. le imposte IRES su quel milione; (ii) parallelamente o successivamente, accertare in capo all’amministratore-socio un reddito di capitale non dichiarato (dividendo presunto) di pari importo, da tassare IRPEF. Fondamento giuridico: questa presunzione non è scritta in una legge tributaria, ma è un orientamento giurisprudenziale consolidato basato su massime di esperienza: in una piccola società, pochi soci controllano l’operato e presumibilmente si appropriano degli utili “in nero”. È però una presunzione di carattere semplice, che il contribuente può vincere con prova contraria. Negli ultimi anni vi sono stati sviluppi importanti: la Cassazione ha oscillato tra una linea rigorosa (che richiede al socio di provare non solo di non aver ricevuto quegli utili, ma anche che la società li abbia accantonati o investiti altrove) e una linea più aperta che ammette come prova contraria anche la totale estraneità del socio alla gestione. Una recente ordinanza (Cass. n. 2464/2025) ha confermato quest’ultima impostazione: il socio può evitare la tassazione dimostrando di non essere stato a conoscenza della produzione di utili occulti né in grado di influire sulla gestione, ad esempio perché socio meramente formale senza alcun ruolo operativo. Questo accade, ad esempio, quando il socio dimostra di essere un prestanome ignaro e che gli utili occulti sono stati trattenuti dall’amministratore di fatto senza suo coinvolgimento. In alternativa, il socio può provare che gli utili extracontabili non sono stati affatto distribuiti ma reinvestiti nella società o lasciati nelle casse sociali (onere probatorio assai gravoso). In ogni caso, la prova contraria deve essere rigorosa: la Cassazione ha chiarito che mere dichiarazioni di disinteresse o generiche documentazioni bancarie non bastano. Occorre dimostrare in modo certo e scrupoloso l’assenza di benefici personali, ad esempio evidenziando che i flussi finanziari anomali non sono transitati sui conti personali dei soci, oppure che il socio era completamente esterno alla gestione (magari perché la conduzione era tutta in mano a un altro socio/amministratore). Effetti pratici: per l’amministratore di una holding che sia anche socio di maggioranza, il rischio è di ricevere un accertamento IRPEF a titolo personale qualora la società subisca rettifiche per redditi non contabilizzati. Ci si trova quindi doppia imposizione economica (sulla società e sul socio), contro la quale bisogna attivarsi separatamente: la società impugna il proprio avviso IRES/IVA, e il socio impugna il proprio avviso IRPEF, possibilmente coordinando le difese. Va sottolineato che la legittimità di questo meccanismo è stata ribadita anche di recente: la Cassazione ha ritenuto ininfluente perfino l’eventuale invalidità dell’avviso alla società o l’entrata in vigore dell’art. 7, co.5-bis del D.lgs. 546/92 (norma introdotta nel 2022 per rafforzare le garanzie probatorie), affermando che la presunzione di distribuzione rimane applicabile e l’onere della prova contraria resta a carico del contribuente. In altre parole, finché l’accertamento a carico della società accerta utili occulti (specie se è definitivo perché la società non ha impugnato nei termini), l’Ufficio può procedere contro i soci quasi automaticamente, e saranno questi ultimi a dover fornire prove robuste per evitare la tassazione. Esempio pratico: Omega Holding S.r.l. ha 2 soci (ognuno 50%), uno dei quali è anche amministratore unico. Un controllo della Guardia di Finanza accerta maggiori ricavi non contabilizzati per €200.000 negli anni 2020-2021. La società non impugna gli avvisi di accertamento, che diventano definitivi. L’Agenzia notifica quindi a ciascun socio un avviso per “redditi di capitale” non dichiarati di €100.000 (ciascuno, pari al 50%). I soci ricorrono: uno (che era amministratore) prova che i soldi non sono stati distribuiti ma reinvestiti nell’acquisto di macchinari (esibendo documenti contabili e bancari); l’altro socio sostiene di non aver partecipato alla gestione e di non sapere degli utili. La Commissione (ora Corte di Giustizia Tributaria) può accogliere il primo ricorso se ritiene provato l’accantonamento degli utili in società; quanto al secondo socio, dovrà dimostrare la propria estraneità assoluta (ad es. era socio solo di nome, senza accesso ai conti né ruolo decisionale). Se questa prova riesce – e deve essere molto dettagliata e convincente – l’accertamento a lui potrà essere annullato. In caso contrario, entrambi i soci saranno tenuti a pagare le imposte su €100.000, oltre a eventuali sanzioni per omessa dichiarazione.
- 4. Accertamento tributario emesso direttamente nei confronti dell’amministratore (in qualità di liquidatore o ex-amministratore) – Questa è l’ipotesi prevista espressamente dall’art. 36 del DPR 602/1973, di importanza nevralgica in caso di holding che cessano l’attività lasciando debiti fiscali. Quando una società (di capitali) viene posta in liquidazione, il liquidatore ha l’obbligo di pagare, con le attività di bilancio, prima le imposte dovute (per il periodo di liquidazione e quelli precedenti). Se il liquidatore non adempie a tale obbligo – e distribuisce attivo ai soci o soddisfa crediti di ordine inferiore al Fisco, lasciando le imposte insoddisfatte – egli risponde personalmente del pagamento delle imposte non versate, entro il limite di quanto avrebbe potuto pagare al Fisco con le risorse della liquidazione. La norma estende questa responsabilità anche agli amministratori in carica al momento dello scioglimento qualora non sia stato nominato alcun liquidatore formale. Inoltre, sono chiamati a rispondere (entro il valore dei beni ricevuti) anche i soci che negli ultimi due esercizi precedenti la messa in liquidazione abbiano ricevuto assegnazione di denaro o beni sociali dagli amministratori, nonché i soci che ricevono beni in distribuzione durante la liquidazione. Infine, come accennato, lo stesso art. 36 (comma 4) prevede che gli amministratori che, nei due anni precedenti la liquidazione, abbiano compiuto operazioni liquidatorie di fatto oppure occultato attività sociali (anche con omissioni in contabilità) sono anch’essi soggetti a questa responsabilità personale. La procedura in questi casi è peculiare: l’Agenzia delle Entrate notifica all’amministratore (o liquidatore, o socio) un atto di accertamento motivato, ai sensi del comma 5 dell’art. 36, per accertare la sua responsabilità e quantificare l’importo dovuto. Questo atto si notifica, ad esempio, quando la società è già estinta o in via di estinzione e il Fisco rileva che imposte relative a periodi ante cessazione non sono state pagate. Importante: Secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 32790/2023), l’azione di responsabilità ex art. 36 non presuppone che il debito tributario della società sia già iscritto a ruolo o definitivamente accertato. In altre parole, il Fisco può procedere direttamente contro il liquidatore/amministratore con questo avviso, anche in parallelo o in assenza di un accertamento formale a carico della società, purché motivi l’inadempimento degli obblighi di pagamento. Ciò perché la responsabilità del liquidatore ha natura civilistica e autonoma, non è una semplice estensione del debito sociale. Nell’impugnare l’avviso, comunque, l’amministratore potrà contestare sia i presupposti della propria responsabilità (es. che in realtà non vi erano attivi distribuibili, o che ha pagato debiti di ordine superiore), sia l’eventuale insussistenza del debito tributario societario. Su quest’ultimo punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che il liquidatore può far valere anche la non debenza delle imposte della società sottostanti, a garanzia del suo pieno diritto di difesa. Esempio pratico: Delta Holding S.p.A. viene sciolta nel 2024 e cancellata dal registro imprese. Nel 2025 l’Agenzia scopre che Delta non aveva versato IVA e IRES per €300.000 negli anni precedenti, e che durante la liquidazione l’amministratore (nominato liquidatore) ha pagato altri creditori e distribuito ai soci parte dell’attivo, lasciando il debito fiscale insoluto. Nel 2025 notifica quindi all’ex amministratore un avviso di accertamento ex art. 36 DPR 602/73 chiedendogli €250.000 (supponiamo questo l’importo che, con l’attivo disponibile, avrebbe potuto soddisfare del debito fiscale). L’amministratore potrà difendersi provando, ad esempio, che quei tributi non erano dovuti (magari erano in contestazione, o soggetti a condono) e/o che, nell’ordine legale dei pagamenti, aveva crediti di grado superiore da pagare (ad es. dipendenti, creditori privilegiati) e che nulla residuava per il Fisco, oppure ancora che lui non ha colpa perché le somme ai soci le ha dovute assegnare su ordine del tribunale (ipotesi rara). Se non fornisce tale prova, dovrà pagare di tasca propria. I soci, dal canto loro, potrebbero aver ricevuto importi in liquidazione: anche a loro l’Ufficio può notificare avvisi per recuperarli fino a concorrenza del valore distribuito. Per esempio, se due soci hanno avuto €100.000 ciascuno in sede di bilancio finale, potrebbero ricevere accertamenti di pari importo come coobbligati parziali. È chiaro come da prospettiva del “debitore” ex art.36 (l’amministratore/liquidatore) sia fondamentale documentare puntualmente di aver rispettato la regola del pagamento prioritario delle imposte o di non aver avuto in mano risorse sufficienti. L’azione ex art.36 ha natura sussidiaria: colpisce il liquidatore solo se con il suo comportamento ha leso l’Erario preferendo altri o distribuendo attivo indebitamente. Va aggiunto che dal 2015 è stata eliminata la limitazione dell’art.36 alle sole imposte sui redditi: oggi vale per tutte le imposte dovute dalla società (IVA, imposte indirette, ecc.). Inoltre, il D.Lgs. 175/2014 ha introdotto la regola dell’estinzione “inefficace” per 5 anni verso il Fisco, applicabile alle cancellazioni dal 2014 in poi: ciò significa che se la società viene cancellata, il Fisco per cinque anni può ancora notificare atti alla società medesima (presso la sede risultante) come se fosse in vita, evitando di dover subito evocare art.36 o 2495 c.c. Trascorsi i 5 anni, se emergono nuovi debiti tributari, l’unica via sarà l’azione verso soci/liquidatori. In ogni caso, se un accertamento viene notificato alla società già estinta, esso è impugnabile e in genere destinato a essere dichiarato improcedibile – ma qualora i soci abbiano incassato attivo, potrebbero comunque essere successivamente chiamati. La strategia migliore per un amministratore che liquidando la holding si trova con debiti fiscali è: pagare il Fisco con priorità; se ciò non è possibile, conservare evidenza di aver usato l’attivo correttamente (per debiti privilegiati) e di non aver occultato nulla. È anche opportuno redigere bilanci finali chiari e, se necessario, accantonare somme per imposte potenzialmente in contestazione, per evitare l’addebito personale futuro.
- 5. Altre forme di accertamento e responsabilità – Meritano un breve cenno altre situazioni che possono riguardare una holding e il suo amministratore:
Accertamenti contributivi (INPS, INAIL): se la holding ha dipendenti o amministratori con contributi previdenziali, gli enti possono accertare omissioni contributive. La responsabilità per contributi previdenziali segue regole diverse: in caso di società di capitali, l’INPS non può chiedere all’amministratore i contributi non versati dalla società (valgono le stesse logiche della separazione patrimoniale). Tuttavia, se la società cessa, i contributi non pagati possono essere insinuati al passivo o, in caso di atti distrattivi, l’amministratore può rispondere per violazione di obblighi di legge (anche penalmente, ad es. per omesso versamento di ritenute previdenziali, che oltre una certa soglia è reato). Alcune normative speciali, ad esempio sull’appalto di opere, prevedono una responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore anche per i contributi dei lavoratori: ciò può coinvolgere una holding committente, ma è una fattispecie peculiare. In generale, però, non esiste un art.36 analogo per contributi: l’INPS eventualmente deve far valere l’art.2495 c.c. in sede civile (o denunciare per reati fallimentari).
Accertamenti per IVA di gruppo o consolidato fiscale: se la holding ha optato per la liquidazione IVA di gruppo o per il consolidato fiscale nazionale, eventuali accertamenti possono riguardare rettifiche di gruppo. In tali ipotesi la holding (capogruppo fiscale) potrebbe essere solidalmente responsabile per le imposte dovute dalle controllate consolidate. È una responsabilità della società holding in quanto tale (non dell’amministratore personalmente), ma l’amministratore deve gestire attentamente questi regimi perché errori di una controllata possono riflettersi in obblighi di versamento a carico della capogruppo. Ad esempio, in consolidato fiscale, la consolidante risponde del pagamento dell’IRES di gruppo: un accertamento su una controllata potrebbe generare un maggior IRES a carico della consolidante (holding). L’amministratore della holding dovrà quindi curarsi di far valere eventuali cause esimenti (ad es. se la controllata aveva teso un comportamento doloso, potrebbe poi rivalersi su di essa). In ogni caso, ciò rimane nell’ambito della responsabilità della persona giuridica holding.
Accertamento all’“amministratore di fatto”: un punto particolare merita l’amministratore di fatto. Spesso nelle holding familiari o di gruppo esistono figure non formalmente investite di cariche ma che di fatto dirigono l’ente. L’ordinamento equipara il gestore di fatto all’amministratore di diritto sotto molti profili di responsabilità (civile, fallimentare, penale). In ambito tributario, la Cassazione ha recentemente confermato che è legittimo notificare un avviso di accertamento direttamente all’amministratore di fatto, purché la motivazione “per relationem” rinvii al PVC (processo verbale di constatazione) notificato alla società. Ciò è accaduto ad esempio in Cass. ord. n.5930/2025: un soggetto che, pur senza carica ufficiale, esercitava poteri di gestione è stato destinatario di un accertamento per redditi non dichiarati, basato sugli stessi elementi raccolti a carico della società. La logica è che l’atto impositivo notificato alla società è conoscibile da colui che, sebbene privo di investitura formale, ne esercita la gestione. Dunque, chi pensa di “schermarsi” dietro un prestanome (amministratore di diritto) deve sapere che il Fisco può individuare il dominus di fatto (incrociando firme, deleghe, movimentazioni finanziarie) e chiamarlo personalmente a rispondere dell’evasione. In simili accertamenti, l’amministratore di fatto sarà trattato come contribuente principale (non solo come responsabile in solido): tipicamente gli verranno imputati redditi che lui ha percepito o distratto. Un caso classico è quello delle società fittizie: la Cassazione ha definito l’amministratore di fatto, in tali circostanze, come “trasgressore e contribuente” coincidente, il che implica che imposte e sanzioni possano essere pretese da lui bypassando la persona giuridica. Questo concetto è complementare a quanto visto sull’abuso di società. Per l’amministratore di fatto destinatario di un accertamento, la difesa è ovviamente complessa: deve negare di aver avuto quel ruolo (se sostenibile) o comunque contestare nel merito le pretese. Dal punto di vista del debitore reale, se la prova dell’amministrazione di fatto è solida, sarà difficile sfuggire alla responsabilità.
Come si vede, le tipologie di accertamento che coinvolgono un amministratore di holding spaziano dall’ordinario al peculiare. Si va dalla gestione quotidiana di una verifica fiscale alla chiamata in causa diretta come debitore. Nel prossimo capitolo approfondiremo le responsabilità sanzionatorie, ovvero quali sanzioni (amministrative e penali) possono gravare sull’amministratore, distinguendole dalle obbligazioni tributarie in senso stretto.
Responsabilità sanzionatorie dell’amministratore: sanzioni tributarie e conseguenze penali
Quando si parla di sanzioni in ambito fiscale, bisogna distinguere tra sanzioni amministrative tributarie (multe pecuniarie per violazioni tributarie, regolate dal D.Lgs. 472/1997 e dalle leggi speciali) e sanzioni penali (reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 e altre norme). L’amministratore di una holding può essere interessato da entrambe, ma in modo ben diverso:
Sanzioni amministrative tributarie
Le sanzioni amministrative (ad es. per dichiarazione infedele, omessa fatturazione, omessi versamenti) colpiscono il trasgressore e, in linea di principio generale, non si trasferiscono su soggetti diversi. Per le società di capitali, la legge stabilisce chiaramente che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. Ciò significa che se una holding commette un’infrazione tributaria (ad esempio presenta una dichiarazione infedele, o versa in ritardo l’IVA), la sanzione pecuniaria sarà irrogata alla società stessa, e non all’amministratore personalmente, in via ordinaria. Questa regola – introdotta dall’art. 7 del DL 269/2003 – recepisce il principio di personalità della sanzione: il contribuente-soggetto passivo è la società, quindi è la società a subire la multa. Conseguentemente, l’amministratore di per sé non riceve cartelle per sanzioni se l’ente non paga (diversamente da quanto accade, ad esempio, per le sanzioni del Codice della Strada in capo al conducente). Anche eventuali pignoramenti per sanzioni dovranno colpire i conti sociali, non quelli personali del legale rappresentante.
È bene sottolineare questo punto, perché spesso imprenditori e amministratori temono di dover pagare di tasca propria le sanzioni fiscali della società: in assenza di comportamenti illeciti particolari, ciò non accade. Ad esempio, se la holding riceve un avviso di accertamento con imposte e una sanzione del 100%, la società dovrà versare imposta e sanzione; se non paga, l’Agenzia Entrate Riscossione potrà aggredire i beni sociali (crediti, immobili intestati alla società) ma non potrà iscrivere ipoteca sulla casa dell’amministratore solo per recuperare quella sanzione. L’unico caso in cui l’amministratore potrebbe essere chiamato a coprire una sanzione tributaria è quello eccezionale di “abuso della personalità giuridica” di cui si è detto: se la società è pura facciata e l’amministratore è considerato il vero contribuente/trasgressore, allora la sanzione (formalmente intestata alla società) in sostanza colpisce lui poiché la società è inesistente come schermo. La Cassazione, confermando la regola ordinaria, ha proprio evidenziato che nelle ipotesi ordinarie non si irrogano sanzioni al legale rappresentante. Quindi, salvo frodi gravi, l’amministratore non paga le multe fiscali della società.
Esempio: Zeta S.r.l. (holding) omette di dichiarare un reddito e viene sanzionata con €50.000 (oltre alle imposte evase). La società fallisce e non paga. L’Agenzia della Riscossione non potrà chiedere quei €50.000 all’amministratore Mevio, perché la sanzione è “relativa al rapporto fiscale” della società ed è a carico esclusivo di Zeta S.r.l.. Potrà eventualmente insinuare il credito da sanzione nel fallimento di Zeta, ma se non ci sono attivi, la sanzione rimarrà insoddisfatta. Mevio potrebbe temere conseguenze personali, ma la legge lo tutela: diversamente, le sanzioni aggirerebbero la limitazione di responsabilità societaria. Anche in caso di cancellazione della società, Equitalia (AER) non può notificare cartelle per sanzioni ai soci o amministratori (infatti una risoluzione interna ha stabilito che ai soci ex art.2495 c.c. non vanno richieste sanzioni, mancando base normativa).
In sintesi, le sanzioni amministrative tributarie colpiscono la holding e restano a carico di essa. L’amministratore però ne subisce gli effetti indiretti: ad esempio, una grossa sanzione erariale aggrava la situazione finanziaria della società, può portare a iscrizioni a ruolo e pignoramenti di conti sociali, e quindi l’amministratore dovrà gestire una crisi di liquidità o una possibile insolvenza della società anche per questo motivo. Ma, finché mantiene la separazione, i suoi beni personali sono al riparo dalle sanzioni. Naturalmente, se l’amministratore ha prestato garanzie personali (fideiussioni) per debiti tributari – cosa rara ma possibile, ad es. in dilazioni concesse – allora in forza di quella garanzia potrebbe essere chiamato a pagare; ma non è per obbligo di legge generale, è per un impegno specifico che ha sottoscritto.
Va anche menzionato che l’amministratore potrebbe personalmente subire sanzioni amministrative non tributarie connesse a obblighi fiscali: esempi sono le sanzioni amministrative del Codice Civile (artt. 2621-2622 c.c. e segg., un tempo penali ora in parte depenalizzate) per irregolarità contabili, o le sanzioni amministrative antiriciclaggio, ecc. Ma queste esulano dal campo tributario e seguono regole proprie. Nel campo tributario stretto, l’amministratore persona fisica può essere destinatario di sanzioni solo se identificato come autore di una violazione riferita alla sua persona, non al ruolo di rappresentante. Esempio: l’omessa presentazione della dichiarazione IVA della società è violazione della società (sanzione a carico di essa), mentre l’omessa presentazione della dichiarazione IRPEF personale dell’amministratore è violazione sua (sanzione a lui). Può sembrare banale, ma si pensi a un amministratore che confonde i piani e non presenta la propria dichiarazione dei redditi come persona fisica (magari percepiva compensi dalla holding, o altri redditi): in tal caso ovviamente sarà sanzionato come contribuente IRPEF. Questo per dire che l’amministratore, al di là del suo ruolo sociale, deve curare anche i propri obblighi fiscali personali.
Conseguenze penali (reati tributari)
Diverso è il discorso delle responsabilità penali. La normativa penal-tributaria individua precise fattispecie di reato a carico di chi, con dolo, realizza evasione fiscale oltre determinate soglie. Qui l’amministratore (o chi firma le dichiarazioni, o chi pone in essere atti fraudolenti) può essere chiamato a rispondere penalmente in prima persona. I reati tributari principali (D.Lgs. 74/2000, aggiornato da vari interventi, ultimo D.Lgs. 75/2020 e D.Lgs. 14/2023) che possono interessare un amministratore di holding sono:
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici o false fatture (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000): punisce chi, per evadere, inserisce elementi fittizi nelle dichiarazioni (es. utilizzo di fatture false, o di altri mezzi fraudolenti). Soggetto attivo tipico è il legale rappresentante che firma la dichiarazione infedele. Pena: reclusione da 4 a 8 anni (art.2) se utilizzo di fatture false per importi evasi > €100k; da 3 a 8 anni (art.3) se altri artifici con imposta evasa > €100k.
- Dichiarazione infedele (art. 4): è la presentazione di dichiarazione dei redditi o IVA con dati inesatti, senza artifici, con imposta evasa > €100k e incidenza > 10% sul dichiarato. È reato meno grave (dolo specifico richiesto), con pena da 2 a 4 anni e mezzo. Un amministratore può incorrervi se “abbellisce” i conti inserendo meno ricavi o più costi in dichiarazione, superando le soglie.
- Omessa dichiarazione (art. 5): se l’amministratore omette di presentare, per la società, la dichiarazione dovuta (es. IRES) ed evade > €50k imposta, commette reato. Pena da 2 a 5 anni.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8): reato spesso contestato a chi dirige società cartiere. Se l’amministratore della holding emette fatture false (ad es. per creare costi fittizi a vantaggio di altre società), rischia da 4 a 8 anni di carcere (soglie > €100k per anno).
- Occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10): amministratore che nasconde o distrugge i libri per impedire ricostruzione del reddito: pena da 3 a 7 anni.
- Omessi versamenti:
- Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis): se la società non versa ritenute (es. su stipendi) > €150k annui, il legale rappresentante commette reato (da 6 mesi a 2 anni).
- Omesso versamento IVA (art. 10-ter): se la società, entro la scadenza annuale, non versa l’IVA dovuta > €250k, l’amministratore commette reato (6 mesi – 2 anni).
- Questi reati sono di natura omissiva, meno infamanti di quelli fraudolenti, ma molto comuni. Riguardano l’amministratore che, pur avendo presentato la dichiarazione IVA o le CU dei dipendenti, non ha pagato le imposte. Spesso in crisi di liquidità l’imprenditore sacrifica IVA e ritenute per pagare altri costi. Fino al 2023, la giurisprudenza era rigida: la crisi di liquidità non esimeva da colpevolezza, perché ritenuta “rischio d’impresa”. Novità 2023-2024: la riforma fiscale (D.Lgs. 14/2023, art. 5) ha introdotto una causa di non punibilità se l’omesso versamento dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute al momento di incasso dell’IVA o esecuzione delle ritenute. In particolare, il nuovo comma 3-bis dell’art.13 D.Lgs. 74/2000 stabilisce che i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter “non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute […] all’incasso dell’IVA o all’effettuazione delle ritenute”, e impone al giudice di considerare la crisi di liquidità non transitoria causata da insolvenze di terzi o mancati pagamenti della PA, non superabile con misure idonee. Questo significa che, d’ora in poi, un amministratore perseguito per omesso versamento IVA potrà essere assolto se prova che la sua società è stata travolta da una crisi imprevista e inevitabile (ad es. un cliente principale fallito, crediti verso la PA non incassati, ecc.) che gli ha impedito oggettivamente di versare l’imposta. È un cambiamento epocale: la Cassazione ha già applicato la novella nel 2024, discostandosi dal precedente orientamento e annullando condanne quando risultava accertata una gravissima crisi di liquidità non imputabile al dolo dell’imprenditore. Resta inteso che la soglia di punibilità (250.000 € per IVA, 150.000 € per ritenute) permane; sotto tali soglie, non vi è reato (ma restano le sanzioni amministrative del 30% per omesso versamento, a carico della società).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11): punisce chi, al fine di non pagare imposte o interessi dovuti (anche dalla società), compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni per vanificare la riscossione. Un amministratore di holding può incorrervi, ad esempio, se trasferisce patrimoni sociali a terzi o all’estero per evitare che Equitalia vi iscriva ipoteca. Pena da 6 mesi a 4 anni (fino a 6 anni se il debito superava 200k). Questo reato è particolarmente insidioso perché può scattare anche a carico dell’amministratore che, temendo accertamenti, svuota la società o aliena beni personali sottoponibili a esecuzione. Esempio: Tizio sa di avere una cartella imminente da 500k per la sua holding, e vende a prezzo fittizio un immobile intestato alla holding a una società estera per renderlo irreperibile: sta commettendo il reato di sottrazione fraudolenta.
In generale, la politica criminale tributaria colpisce l’amministratore in quanto garante fiscale della società: è lui che materialmente presenta le dichiarazioni e decide i pagamenti, dunque lui risponde penalmente se viola intenzionalmente gli obblighi. Dal punto di vista del debitore, le conseguenze penali non implicano (salvo confisca, vedi infra) un obbligo civile di pagamento, ma possono portare a sanzioni detentive e misure cautelari personali (es. interdizione) e reali (sequestro/confisca). Infatti, nei procedimenti penali per reati tributari, il giudice può disporre il sequestro preventivo dei beni dell’indagato fino a concorrenza del profitto del reato (che spesso coincide con l’imposta evasa). In caso di condanna, scatta la confisca obbligatoria del profitto dell’evasione, anche per equivalente su beni dell’amministratore. Ciò significa che, pur restando il debito tributario formalmente a carico della società, l’amministratore condannato può vedersi confiscare somme proprie pari alle imposte evase, così da soddisfare indirettamente l’Erario. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di sequestri sui conti societari e personali per garantire tali importi.
Esempio: Caio, amministratore di Sigma S.p.A., è imputato per omessa dichiarazione IVA con €1 milione evaso. La società è insolvente. Il GIP dispone sequestro per equivalente sui beni di Caio (conto corrente personale, auto) fino a €1M. Se Caio viene condannato, quei beni saranno confiscati in via definitiva. In pratica, Caio finisce per sopportare il costo economico dell’imposta evasa, oltre alla pena, malgrado in sede civilistica l’obbligato fosse la società. Questo è un forte incentivo per l’amministratore a regolarizzare (pagare il dovuto con ravvedimento, se possibile) prima che si arrivi al penale, perché poi subentrano misure afflittive.
In conclusione, dal punto di vista dell’amministratore come debitore occorre distinguere: le sanzioni amministrative fiscali generalmente non ricadono sul suo patrimonio (tranne scenari eccezionali), mentre le sanzioni penali possono colpirlo personalmente, con la possibilità che lo Stato confischi i suoi beni per recuperare il maltolto. Pertanto, quando si affronta un accertamento fiscale, l’amministratore deve anche valutare se vi siano profili penalmente rilevanti: ad esempio, un accertamento da €300.000 di IVA evasa potrebbe preludere a un’indagine penale per omesso versamento IVA (se non già scattata); un processo verbale che contesta fatture false potrebbe anticipare una denuncia per dichiarazione fraudolenta. In tali casi, cosa fare? Bisogna attivare subito una difesa tecnica anche sul fronte penale, eventualmente valutare il pagamento del debito tributario come causa di non punibilità (per alcuni reati, es. omesso versamento, il pagamento integrale entro la chiusura del dibattimento estingue il reato: art. 13 D.Lgs.74/2000) o utilizzare strumenti come il patteggiamento se opportuno.
Per riassumere le principali differenze, si propone la seguente tabella riepilogativa:
Tabella 2 – Sanzioni tributarie vs. responsabilità dell’amministratore
| Violazione fiscale (esempi) | Sanzione amministrativa | Conseguenze per amministratore (penali e patrimoniali) | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione infedele della società (imposta evasa < €100k, o altra sotto soglia penale) | Sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell’imposta evasa a carico della società (D.Lgs. 471/97). | Nessuna sanzione penale (sotto soglia). L’amministratore non paga la sanzione: rimane a carico della società. | Art. 1 co.2 D.Lgs. 471/97; Art. 7 DL 269/2003. |
| Dichiarazione fraudolenta con fatture false (> soglia) | Sanzione amministrativa 200% dell’imposta (in teoria) per la società, ma spesso non irrogabile perché coincide con fatti criminosi. | Reato a carico di chi ha agito (amministratore): pena 4-8 anni (art.2 D.Lgs.74/2000). Sequestro/confisca beni personali pari all’imposta evasa. | Art. 2 D.Lgs. 74/2000; Art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 (confisca). |
| Omesso versamento IVA > €250k (dichiarazione presentata ma non pagato) | Sanzione amministrativa del 30% dell’imposta non versata (a carico società). | Reato di cui all’art.10-ter D.Lgs.74/2000: 6 mesi – 2 anni reclusione per l’amministratore. Non punibile se omesso per crisi non imputabile (nuovo comma 3-bis). Sequestro/confisca pari a IVA non versata possibile. | Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000; Art.13 co.1 e 3-bis D.Lgs.74/2000. |
| Omesso versamento ritenute > €150k | Sanzione amm.va 30% su società. | Reato art.10-bis D.Lgs.74/2000: 6 mesi – 2 anni reclusione. Non punibile se causa forza maggiore come sopra. | Art. 10-bis D.Lgs. 74/2000; Art.13 co.3-bis D.Lgs.74/2000. |
| Emissione di fatture false (es. holding “cartiera”) | La sanzione amm.va (100% importo fatture inesistenti) colpisce la società emittente; spesso in questi casi la società è fittizia. | Reato art.8 D.Lgs.74/2000: 4–8 anni reclusione per l’amministratore di fatto; confisca dei profitti. | Art. 8 D.Lgs. 74/2000. |
| Occultamento di beni per non pagare le imposte (società o amm. sposta risorse per frodare il Fisco) | Eventuali sanzioni a seconda degli atti (es. se omette comunicazioni al fisco). | Reato art.11 D.Lgs.74/2000 (“sottrazione fraudolenta”): 6 mesi – 4(–6) anni reclusione per l’autore (amministratore). Possono essere sequestrati i beni alienati o il ricavato. | Art. 11 D.Lgs. 74/2000. |
(Le sanzioni amministrative elencate sono a titolo esemplificativo; la normativa prevede varie modulazioni. Le conseguenze penali indicate presuppongono il dolo dell’amministratore e superamento delle soglie di punibilità. In tutti i casi di reato, il pagamento del tributo dovuto e delle sanzioni amministrative prima del dibattimento può attenuare le pene o estinguere alcuni reati minori, come da art.13 D.Lgs.74/2000.)
Cosa fare in caso di accertamento: strategie di difesa e tutela del patrimonio dell’amministratore
Trovarsi di fronte a un avviso di accertamento – sia esso intestato alla holding che si amministra, oppure eccezionalmente all’amministratore stesso – richiede un’azione tempestiva e ponderata. Vediamo le mosse fondamentali dal punto di vista pratico, assumendo come “debitore” il nostro amministratore (in proprio o nella sua veste di rappresentante della società):
1. Analizzare la natura dell’atto e del destinatario
Appena notificato un atto, la prima cosa è capire chi è il contribuente destinatario e per quali tributi/anni. Può sembrare banale, ma nel contesto illustrato non lo è: se l’accertamento è intestato alla società, l’amministratore agisce per conto di essa e le eventuali imposte richieste riguardano il c/c aziendale, non quello personale (almeno immediatamente). Se invece l’atto è intestato all’amministratore persona fisica, occorre verificare il motivo: si tratta di un accertamento IRPEF per redditi imputati a lui (es. utili extracontabili presunti)? Oppure di un atto ex art.36 DPR 602/73 che lo chiama a rispondere di imposte sociali? La distinzione è cruciale perché determina il diverso contenzioso: un ricorso andrà intestato o alla società o alla persona fisica a seconda del caso, e differenti saranno i motivi di difesa. Dunque: leggere attentamente l’intestazione e la motivazione. Se l’amministratore riceve, ad esempio, un “Avviso di accertamento IRPEF 2022” a suo nome, saprà che è un problema personale (forse redditi da capitale non dichiarati, o compensi da amministratore contestati). Se invece riceve “Avviso di accertamento IRES 2021” intestato alla Holding X Srl, allora è la società sotto accertamento e lui ne è solo il tramite giuridico. In quest’ultimo caso, potrebbe dover informare l’assemblea o gli altri soci (specie se egli non è unico proprietario) circa l’atto ricevuto.
2. Consultare professionisti e raccogliere la documentazione
Date le elevate somme e complessità in gioco, è opportuno che l’amministratore si avvalga subito di un dottore commercialista o avvocato tributarista di fiducia. Il professionista aiuterà a esaminare la legittimità formale dell’atto (rispetto di termini decadenziali, motivazione sufficiente, firma dell’autorità competente, ecc.) e il merito della pretesa. Parallelamente, l’amministratore-debitore deve reperire tutta la documentazione utile: bilanci, dichiarazioni fiscali, verbali di eventuali verifiche (PVC), corrispondenza con il Fisco, prove che supportino eventuali tesi difensive (es. estratti conto, contratti, verbali assemblee). Anche eventuali sentenze o circolari rilevanti dovrebbero essere individuate: un avvocato tributarista può ricercare giurisprudenza simile (ad esempio, se è un caso di presunzione di utili, citerà le ultime Cassazioni favorevoli, come Cass. 2464/2025; se è un caso di art.36, terrà conto di Cass. SS.UU. 2023). Questa fase di studio preliminare è fondamentale per decidere il da farsi.
3. Valutare le opzioni: acquiescenza, definizione, ricorso
Una volta capita la portata dell’accertamento, bisogna scegliere come reagire entro termini brevi. In genere le opzioni sono:
- Pagare/acquiescenza: se la pretesa è fondata e l’importo sostenibile, una società (o il contribuente) può decidere di pagare subito l’accertamento. La legge prevede, in caso di acquiescenza (pagamento entro 60 giorni senza ricorso), la riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3. Ad esempio, sanzione 90% scende al 30%. Questa può essere una scelta sensata quando l’amministratore riconosce l’errore e vuole beneficiare dello sconto, evitando ulteriori aggravi. Va però considerata la liquidità: la holding ha i fondi? L’amministratore, se l’atto è a lui, ha quella somma? Si può chiedere una rateazione: per avvisi non ancora in cartella, è possibile rateizzare fino a 8 rate (o 16 se importo > €50.000) presentando istanza entro i 60 giorni. Attenzione: pagando (anche la prima rata) si rinuncia a impugnare. Quindi l’acquiescenza è una scelta irreversibile.
- Accertamento con adesione: è uno strumento di definizione agevolata in via amministrativa, consistente in un contraddittorio con l’ufficio per concordare un importo inferiore. L’amministratore/società può presentare istanza di adesione (entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso) e ciò sospende per 90 giorni il termine per fare ricorso. Durante l’adesione, ci si siede con l’Agenzia per discutere il caso: spesso l’Ufficio può ridurre imponibili o sanzioni per chiudere bonariamente la vicenda. Vantaggi: sanzioni ridotte a 1/3 del minimo (simile all’acquiescenza) in caso di accordo; pagamento dilazionabile in 8 rate (fino a 16 se >€50k). L’adesione è utile se ci sono spazi di trattativa (ad esempio su valutazioni, stime, incertezza interpretativa) e se l’amministratore vuole evitare un contenzioso lungo. Se la società/amm. ritiene invece il Fisco completamente in errore o l’importo esorbitante, l’adesione potrebbe fallire. In ogni caso, tentar l’adesione non pregiudica il ricorso: se non si raggiunge accordo, l’atto resta impugnabile (i 60 gg decorrono di nuovo dalla chiusura del mancato accordo). NB: Non è ammessa adesione per atti di pura irrogazione sanzioni o per atti ex art.36 DPR 602/73 rivolti a liquidatori – questi ultimi non sono accertamenti di imposta in senso classico, quindi si tende a dover ricorrere direttamente (su ciò la disciplina non è chiarissima, ma in pratica spesso l’Ufficio non tratta in adesione responsabilità liquidatori).
- Ricorso al giudice tributario: è la strada da intraprendere se si decide di contestare formalmente l’accertamento. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica (salvo sospensioni per adesione) alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Dal 2023, la riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha introdotto alcune novità: per le liti di valore fino a €3.000 il giudice monocratico, possibili testi in giudizio (prima esclusi), ecc. Nel ricorso occorre indicare i motivi in fatto e diritto per cui l’accertamento è illegittimo o infondato. Esempi: errore nel calcolo, violazione di legge (es. avviso nullo per difetto di motivazione), interpretazione non conforme a diritto, vizi procedurali (mancato contraddittorio obbligatorio, se dovuto). L’amministratore dovrà firmare il ricorso (se per la società, lo firma il legale rappresentante) insieme al difensore abilitato, se necessario. Attenzione: per le controversie sopra €3.000, la difesa tecnica (avvocato, commercialista) è obbligatoria. Nel ricorso si può anche chiedere la sospensione dell’esecuzione, se l’atto è esecutivo (vedi punto 5) e il pagamento immediato causerebbe un danno grave. La sospensione viene decisa dal giudice in tempi brevi (entro 180 giorni dalla richiesta).
- Mediazione/reclamo: per importi fino a €50.000, il ricorso inizialmente vale come reclamo e proposta di mediazione alla Direzione Entrate competente. L’amministratore in sostanza presenta il ricorso che però viene vagliato dall’ufficio legale dell’Agenzia: se trovano un accordo (riduzione delle somme, ecc.) si chiude la mediazione col pagamento concordato (sanzioni ridotte al 35%, vantaggioso). Se dopo 90 giorni non c’è accordo, il ricorso prosegue automaticamente in giudizio. Questa è una fase obbligatoria per le liti minori; la probabilità di successo dipende dalla bontà delle argomentazioni. Ad esempio, per un avviso da €30k su spese indebite contestate, l’Agenzia in sede di mediazione potrebbe offrire sanzioni dimezzate o togliere una piccola parte di imponibile. L’amministratore deve valutare se accettare (spesso conviene per chiudere subito con spesa ridotta). Se la controparte invece rigetta il reclamo, si andrà avanti.
- Definizioni agevolate speciali: il panorama fiscale recente ha visto varie misure di tregua fiscale (es. definizione liti pendenti, conciliazione agevolata, stralcio interessi, rottamazione cartelle). Al luglio 2025, ad esempio, è in corso il “concordato preventivo biennale 2025/2026” previsto dal D.Lgs. 13/2024, che consente ad imprese in regola con dichiarazioni di concordare col Fisco il reddito futuro per due anni evitando accertamenti. Però questo riguarda la prevenzione per il futuro, più che la gestione di accertamenti già emessi. Se l’amministratore si trova con un contenzioso in corso, dovrebbe informarsi se vi siano strumenti straordinari: ad esempio, la definizione agevolata delle liti pendenti (prevista dalla Legge di Bilancio 2023 per liti incardinate al 2022) che permetteva di chiudere pagando solo una percentuale del tributo. Tali misure hanno finestre temporali specifiche. Dunque, è bene che il difensore verifichi se l’accertamento rientri in qualche sanatoria recente o prevista.
In sintesi, di fronte a un accertamento l’amministratore deve decidere se collaborare (pagare/adesione) o contrastare (ricorso). La scelta dipende dalla fondatezza della pretesa e dalla sostenibilità finanziaria. Se la holding (o l’amm.) ha certamente torto e rischia sanzioni alte, aderire conviene per ridurre danni. Se invece vi sono valide argomentazioni o l’importo è insopportabile, il ricorso è doveroso. Spesso si tenta prima l’adesione per vedere se l’Ufficio concede uno sconto accettabile; in mancanza, si ricorre.
4. Attenzione ai termini di esecuzione e riscossione
Dal 2020 in poi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate sono divenuti atti immediatamente esecutivi trascorsi i termini di impugnazione. Ciò significa che, 60 giorni dopo la notifica, l’accertamento non pagato né sospeso diventa titolo esecutivo e dopo ulteriori 30 giorni viene affidato all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione – AER) per procedere al recupero forzoso. In pratica non esiste più la “cartella di pagamento” successiva all’accertamento: l’avviso stesso contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni e l’avvertimento che, decorsi 30 gg dalla scadenza, si procede ad esecuzione. Per l’amministratore ciò implica che non può aspettare passivamente: se non fa nulla, in circa 90 giorni dall’atto rischia misure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche).
Se si presenta ricorso, l’affidamento all’AER non è automaticamente sospeso: l’atto comunque, trascorsi 60 gg, può essere inviato all’esattore, ma l’amministratore può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione (vedi sopra). In assenza di sospensiva, l’Agenzia della Riscossione può, per legge, intanto riscuotere un terzo delle imposte contestate (oltre interessi) in pendenza di giudizio di primo grado. Il restante è “congelato” fino a sentenza. Se poi il contribuente perde in primo grado, per proseguire l’appello deve versare un ulteriore importo (totale due terzi); dopo la sentenza di secondo grado, l’intero. Queste regole (art.68 D.Lgs.546/92) sono complesse, ma in sostanza: aspettarsi che, senza un provvedimento di sospensione, almeno il 33% del tributo venga richiesto dall’Agente anche se il ricorso è pendente.
Quindi, “cosa fare” sul piano pratico: se non si paga integralmente entro 60 gg, conviene presentare comunque istanza di sospensione all’AER motivata dalla pendenza del ricorso, e soprattutto chiedere la sospensione in sede giudiziale. Se la sospensione viene concessa, l’esecuzione è bloccata fino alla decisione di merito. Se viene negata, l’amministratore valuti di versare quel terzo per evitare pignoramenti (eventualmente attingendo a risorse della società se l’atto riguarda questa).
Tutela del patrimonio personale: Nel caso di accertamenti a carico della società, l’esattore aggredirà i beni sociali (conto corrente intestato alla società, crediti verso clienti, ecc.). Solo se l’ente non ha beni, e l’atto è contro la società, si aprirà poi la questione se l’amministratore può diventare bersaglio (lo diventa solo attivando art.36 o altre norme come visto, non automaticamente). Nel caso di accertamenti a carico dell’amministratore personalmente (IRPEF o art.36), invece, l’Agente può colpire direttamente i suoi beni: conto corrente personale, stipendio, auto, immobili intestati. Vale dunque la pena che l’amministratore-debitore valuti misure protettive. Ad esempio:
- Se l’importo è elevato, potrebbe tentare di ottenere una rateizzazione con AER appena il carico arriva. Rateizzando, si evitano azioni esecutive a patto di pagare le rate. Piani fino a 72 rate (6 anni) o straordinari 120 rate (10 anni) possono essere concessi se si prova difficoltà economica. La rateazione fa decadere eventuali ipoteche/fermi già iscritti solo dopo pagamento integrale, ma sospende nuove azioni esecutive finché si paga regolarmente.
- Monitorare la possibilità di definizioni agevolate dei ruoli: ad esempio, la “rottamazione-quater” nel 2023 ha permesso di estinguere debiti in cartella senza sanzioni e interessi. Se l’accertamento diventa cartella, ci si può auspicare una futura “rottamazione” per risparmiare. Non è garantito, ma la storia recente mostra vari provvedimenti simili. Nel frattempo, aderire a una rateazione consente di prendere tempo.
- Evitare di compiere atti di disposizione patrimoniale sospetti dopo la notifica dell’accertamento: vender casa alla moglie per 1 euro, svuotare conti, intestare l’auto al figlio – queste mosse possono essere revocate in sede civile (azione revocatoria) o addirittura integrate reato di sottrazione fraudolenta (art.11, vedi sopra). È invece legittimo mettere in sicurezza il patrimonio prima che i problemi insorgano, ad es. attraverso un trust o un fondo patrimoniale, ma tali atti devono essere fatti in bonis e con motivazioni non meramente elusive, sennò il fisco può contestarli. Farlo dopo l’accertamento è pericoloso. L’amministratore debitore deve quindi muoversi con trasparenza: meglio accordarsi per pagare a rate piuttosto che farsi inseguire e peggiorare la propria posizione penale.
- Se l’amministratore possiede un unico immobile adibito a prima casa, va ricordato che la legge vieta l’esproprio esattoriale su di esso, salvo sia di lusso (cat. A8/A9) o vi sia ipoteca già iscritta per debiti oltre €20.000. Dunque, AER non può pignorare l’abitazione principale non di pregio per debiti sotto certe soglie (DL 69/2013). Può però iscrivere ipoteca (se debito > €20k) a garanzia e potrà agire se il debito supera €120k (limiti fissati dall’art. 76 DPR 602/73). Quindi l’amministratore non deve pensare di finire in mezzo a una strada automaticamente: la normativa offre qualche scudo per la prima casa. Altri beni (seconde case, terreni, liquidità) sono invece aggredibili più facilmente.
- Se l’importo è insostenibile e l’amministratore è un imprenditore individuale o ha garanzie personali in giro, potrebbe valutare soluzioni di composizione della crisi. Per le persone fisiche non consumatrici c’è la possibilità del concordato minore o liquidazione controllata (nuovo Codice della Crisi) in caso di sovraindebitamento, con inclusione dei debiti tributari (che però salvo accordo rimangono, ma si possono transare sanzioni e interessi). Un privato consumatore invece può accedere al piano del consumatore se i debiti sono incolpevoli. Tuttavia, convincere il Fisco a falcidiare imposte non è semplice (imposte costituiscono credito privilegiato ex art. 21 D.Lgs. 14/2019). Insomma, vie di esdebitazione personale esistono, ma scenario molto estremo. Di norma, si cerca di risolvere col Fisco in via amministrativa.
5. Monitorare gli sviluppi e agire di conseguenza
La gestione di un accertamento non finisce con la presentazione del ricorso o con la firma di un accordo. L’amministratore deve: seguire l’iter del contenzioso (udienze, eventuali appelli); assicurarsi che la società (se ancora attiva) contabilizzi correttamente eventuali imposte dovute o accantonamenti; nel caso di definizioni concordate, verificare di rispettare i pagamenti rateali (il mancato pagamento di una rata fa decadere dai benefici e riattiva l’importo pieno con sanzioni). Inoltre, se il caso presenta profili penali, occorre coordinare la difesa tributaria con quella penale (spesso l’esito del contenzioso tributario può influire sul penale, ad es. se il giudice tributario annulla un accertamento per inesistenza del fatto, ciò aiuta molto nel penale).
Dal punto di vista del debitore, mantenere un atteggiamento collaborativo con il Fisco può essere vantaggioso: l’Amministrazione Finanziaria oggi dispone di margini per chiudere le liti, e spesso apprezza contribuente che paga almeno in parte o che non adotta tattiche dilatorie pretestuose. Ciò non significa rinunciare ai propri diritti, ma ad esempio: chiedere un’udienza di trattazione anche in sede di reclamo per spiegare le proprie ragioni, presentare istanze di autotutela ben motivate (talvolta gli Uffici, riscontrato un errore evidente, annullano in autotutela prima del processo), proporre soluzioni transattive (nel 2023 alcune liti pendenti sono state definite pagando il 90% del solo tributo se si rinunciava all’appello, ecc.). Tutto questo richiede un approccio professionale.
Riassumendo le azioni da fare subito in caso di accertamento:
- Controllare destinatario e termini (60 giorni per ricorso/pagamento; eventuale 90 giorni adesione; termini decadenza atto).
- Coinvolgere consulenti esperti.
- Decidere se aderire o ricorrere, considerando benefici (riduzione sanzioni) vs possibilità di vittoria.
- Se ricorso: depositarlo tempestivamente, chiedere sospensiva se importi elevati.
- Se adesione: partecipare attivamente al contraddittorio portando documenti per convincere a ridurre.
- In ogni caso, entro 60 giorni evitare inerzia: o paga (magari parzialmente) o contesta, per non subire l’esecuzione.
- Valutare rateazione immediata se liquidità scarsa, per evitare aggressioni.
- Prestare attenzione ai propri beni: non compiere atti irrazionali di occultamento; se necessario, consultare un legale per soluzioni di protezione patrimoniale legittime.
- Seguire l’intera procedura e, una volta conclusa (per accordo o sentenza), dare esecuzione a quanto stabilito (pagare il dovuto) per chiudere definitivamente la vicenda ed evitare ulteriori interessi o iscrizioni a ruolo.
Domande frequenti (FAQ)
D: Un amministratore di società holding può essere ritenuto responsabile personalmente dei debiti tributari della società?
R: In linea generale no, per le società di capitali vige la separazione tra patrimonio sociale e personale. L’amministratore non risponde dei debiti fiscali della società, salvo eccezioni previste dalla legge. Le principali eccezioni sono: (a) la responsabilità dei liquidatori/amministratori ex art. 36 DPR 602/73, se non pagano le imposte con le attività sociali in liquidazione; (b) la responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c., limitata alle somme ricevute in liquidazione; (c) l’ipotesi in cui la società sia usata come schermo fraudolento (in tal caso l’amministratore può essere trattato come vero contribuente). Inoltre, i soci di società di persone (non di capitali) rispondono sempre personalmente. Al di fuori di questi casi, eventuali cartelle o accertamenti intestati all’amministratore per imposte sociali sono illegittimi.
D: Cosa posso fare se ricevo un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate?
R: Hai 60 giorni di tempo dalla notifica per decidere. Le opzioni principali sono: pagare (per intero o chiedendo rateazione) beneficiando della riduzione delle sanzioni per acquiescenza; oppure presentare un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente per contestare la pretesa. In alternativa, entro 60 giorni puoi presentare istanza di accertamento con adesione: ciò sospende i termini e consente di negoziare con l’Ufficio, magari ottenendo uno sconto. Se l’accordo fallisce, avrai altri 60 giorni per ricorrere. Durante questi passaggi, valuta con un professionista la fondatezza dell’accusa. Se fai ricorso, puoi anche chiedere la sospensione dell’atto per evitare che il Fisco inizi la riscossione coattiva. È importante non lasciar decorrere i termini: dopo 60+30 giorni dalla notifica l’atto diviene esecutivo e potresti subire pignoramenti. Quindi, agisci rapidamente scegliendo la strada più opportuna (definizione o contenzioso).
D: La mia holding ha ricevuto un PVC dalla Guardia di Finanza. Possono fare accertamenti anche a me personalmente (socio e amministratore)?
R: Sì, in certe circostanze. Il PVC (processo verbale di constatazione) è solitamente redatto nei confronti della società. L’Agenzia Entrate emetterà accertamenti sulla base di esso. Se la tua holding è a ristretta base e il PVC trova utili non dichiarati, aspettati (oltre all’accertamento IRES alla società) un accertamento IRPEF verso di te come socio, per dividendi non dichiarati, in virtù della presunzione di distribuzione. Inoltre, se dal PVC risulta che tu sei amministratore di fatto o che hai beneficiato di redditi sociali occulti, potresti ricevere un atto intestato direttamente a te (ad esempio per compensi occulti). La Cassazione ha confermato che un accertamento a carico dell’amministratore di fatto è legittimo richiamando il PVC societario. Quindi sì, se sei socio-amministratore e la verifica trova irregolarità, puoi subire accertamenti personali correlati a quelli societari. È fondamentale, in tal caso, difendere sia la società sia te stesso, coordinando le argomentazioni (es. per evitare doppia imposizione dello stesso reddito).
D: Se la società non paga le imposte perché fallisce o viene liquidata senza attivo, il Fisco può rivalersi sul mio patrimonio di amministratore?
R: Può farlo solo attraverso gli strumenti legali previsti. Nel caso di fallimento, l’Agenzia delle Entrate si insinua al passivo e partecipa al riparto come gli altri creditori. Non può chiedere a te direttamente il pagamento dei tributi della società fallita, a meno che il curatore agisca contro di te per responsabilità (azione di responsabilità per mala gestio) o che tu abbia commesso reati tributari/fallimentari (in tal caso, però, sarebbero sanzioni penali, non pagamento del tributo in sé). Se invece la società si è liquidata volontariamente senza pagare le imposte, l’Agenzia può utilizzare l’art. 36 DPR 602/73, come spiegato: notificherà un atto a te (se eri liquidatore o amministratore all’epoca) per farti pagare le imposte dovute entro i limiti di quanto avresti dovuto destinare al Fisco. Dovrà però provare che vi erano attivi da destinare ai tributi o che li hai distratti. Senza tali presupposti, niente azione. Inoltre, se tu come amministratore hai distribuito utili ai soci prima di pagare le imposte, il Fisco può chiedere ai soci (potresti anche essere tu stesso socio) la restituzione di quanto incassato, fino a copertura del debito fiscale. In sintesi: per debiti tributari il Fisco non può automaticamente escutere l’amministratore, ma se rileva un tuo comportamento scorretto nella liquidazione (o una liquidazione “pilotata” per non pagare tasse), agirà contro di te nei modi detti.
D: Quali difese ha un socio/amministratore destinatario di un accertamento per utili extracontabili presunti?
R: La difesa consiste nel fornire prova contraria alla presunzione che hai ricevuto quei utili. Secondo la giurisprudenza, ci sono due strade: dimostrare che la società in realtà non ha distribuito quegli utili, ad esempio perché li ha reinvestiti o accantonati (servono riscontri contabili, finanziari, movimentazioni di cassa che mostrino che il denaro è rimasto in azienda); oppure dimostrare che tu, come socio, eri del tutto estraneo alla gestione, e quindi non hai saputo né potuto partecipare ad alcuna distribuzione. Quest’ultimo caso ricorre se magari eri socio solo sulla carta mentre l’amministratore di fatto era un altro, oppure se eri socio di minoranza tenuto all’oscuro. Dovrai portare elementi concreti: ad es. verbali che attestano che non avevi deleghe, corrispondenza in cui protesti per mancato accesso ai conti, ecc. Semplicamente affermare “non ne sapevo nulla” non basta. La prova deve essere rigorosa: la Cassazione pretende documentazione convincente e dettagliata (non generiche affermazioni). Inoltre, è utile evidenziare se la tua quota societaria era piccola e magari detenuta solo per investimento, o se tu risiedevi altrove e non partecipavi all’attività: tutto ciò per incrinare la “massima di esperienza” che in pochi soci tutti sanno tutto. In parallelo, può essere una difesa contestare a monte l’accertamento alla società: se cade quello (ad es. il giudice annulla l’accertamento dei maggiori utili alla società), cade anche il tuo (perché verrebbe meno il presupposto). Dunque spesso conviene far trattare i due ricorsi (società e soci) in modo coordinato, talvolta chiedendone la riunione.
D: Se la società riceve un accertamento IVA/IRES e io la impugno, devo pagare qualcosa nel frattempo?
R: In assenza di provvedimenti di sospensione, la legge prevede che l’accertamento diventi esecutivo dopo 60 giorni. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate Riscossione può iniziare a riscuotere un importo provvisorio pari al 1/3 delle imposte accertate (non delle sanzioni) decorso tale termine, anche se hai fatto ricorso. Quindi, potresti ricevere una cartella o intimazione per quel terzo. Per evitare la riscossione, dovresti ottenere una sospensione dal giudice tributario (o pagare spontaneamente il terzo, ma di solito si chiede sospensione). Se il giudice concede la sospensiva, nulla è dovuto finché non c’è sentenza. Se invece la sospensione è negata, è prudente pagare il terzo (o chiedere rateazione) per non subire pignoramenti sul conto societario. Se vinci la causa, quanto pagato ti verrà restituito con interessi. Se perdi, dopo la sentenza dovrai pagare il resto (un ulteriore terzo dopo la CTP, e saldo dopo la CTR, come da art.68 D.Lgs.546/92). Nel caso l’accertamento sia intestato a te personalmente, la stessa regola vale sul tuo patrimonio. Quindi riassumendo: il ricorso non sospende automaticamente il pagamento, devi attivarti per ottenerla o per pagare parzialmente in attesa di giudizio. Ignorare del tutto la pretesa potrebbe portare a misure esecutive ben prima della sentenza.
D: Cosa rischio penalmente come amministratore se la mia holding ha evaso imposte?
R: Se l’evasione supera le soglie di rilevanza penale, rischi un procedimento penale a tuo carico, con possibili condanne detentive e altre conseguenze (interdizione dai ruoli direttivi, confisca beni, menzione nel casellario). I reati più frequenti: dichiarazione infedele (sopra €100k evasi), dichiarazione fraudolenta (se usate fatture false o frodi), omesso versamento IVA (>€250k) o ritenute (>€150k). Le pene vanno da 6 mesi fino a 8 anni a seconda del reato. La buona notizia è che la recente riforma consente l’esenzione da pena per omessi versamenti dovuti a cause di forza maggiore (crisi di liquidità non colpevole). Inoltre, pagare il dovuto prima del processo può in alcuni casi evitare la condanna (per omessi versamenti integrali, il pagamento entro la prima udienza estingue il reato; per dichiarazione fraudolenta no, ma attenua la pena). Dunque, se sei consapevole di violazioni penali, la strategia migliore è: 1) regolarizzare subito se possibile (ravvedimento operoso, pagamento del dovuto) per rientrare sotto soglia o estinguere il reato; 2) in caso di processo, preparare una robusta difesa documentando, ad esempio, che non avevi volontà di evadere ma sei stato travolto da mancati incassi (questo ora è rilevante per la non punibilità). Devi mettere in conto possibili sequestri preventivi sui conti tuoi o della società equivalenti alle imposte non pagate: è prassi. Pertanto, rischi immediatamente il blocco di disponibilità finanziarie. In caso di condanna, quei beni saranno confiscati. Inoltre, condanne per reati tributari comportano l’interdizione (temporanea o, per pene sopra 2 anni, anche ufficio amministratore di società per la durata dell’interdizione). Quindi, in sintesi: il rischio penale c’è ed è serio se l’evasione è consistente; per mitigarlo occorre agire tempestivamente, con l’aiuto di un penalista esperto in reati tributari, coordinato col tributarista.
D: È vero che se chiudo la società e ne apro un’altra il Fisco non può più colpirmi per i debiti della vecchia?
R: No, questa è una convinzione pericolosa. La chiusura della società non è una bacchetta magica per far sparire i debiti fiscali. Abbiamo visto che: 1) per 5 anni dopo la cancellazione, il Fisco considera la società ancora esistente ai fini delle notifiche, quindi può tranquillamente notificare atti impositivi o cartelle alla società estinta (presso l’ultima sede) e questi producono effetto verso soci e liquidatori; 2) anche dopo, il Fisco ha strumenti per agire contro soci e amministratori (art.36 DPR 602/73, art.2495 c.c.). Inoltre, se tenti il classico stratagemma di trasferire attività e business a una newco lasciando in oldco i debiti, rischi accuse di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (reato) o di abuso del diritto in ambito fiscale (l’Agenzia potrebbe ritenere responsabile in solido la nuova società se c’è continuità aziendale, usando la disciplina sull’abuso). Anche a livello civilistico, i creditori potrebbero far dichiarare la nuova società successore nei debiti se è una prosecuzione sotto mentite spoglie. Quindi, chiudere la holding per non pagare tasse e aprirne un’altra identica è una pessima idea sul piano legale. L’unico modo lecito di chiudere senza pagare è se veramente la società non ha più nulla e né soci né amministratori hanno colpe: in tal caso il debito fiscale rimane insoluto (lo Stato farà quel che può con i pochi asset) e voi non ne rispondete oltre. Ma attenzione: se anche solo hai distribuito 1 euro ai soci, quell’euro può essere chiesto indietro, e se hai pagato altri creditori lasciando il Fisco a bocca asciutta, il liquidatore (o tu se facevi tutto) può dover rispondere. In pratica, conviene affrontare il problema con l’Agenzia (rate, transazioni) piuttosto che illudersi di far perdere le tracce con una liquidazione pilotata.
D: Quali sono le sentenze più recenti e importanti in questo settore?
R: Ne citiamo alcune che abbiamo discusso:
- Cass., Sez. Unite, 27/11/2023 n. 32790 – Principio di diritto su art.36 DPR 602/73: la responsabilità del liquidatore è autonoma e civilistica; l’accertamento verso di lui non richiede la preventiva iscrizione a ruolo del debito sociale, e il liquidatore può contestare anche la debenza dell’imposta sociale nel suo ricorso. Rafforza la mano del Fisco (può agire subito contro liquidatore) ma tutela il diritto di difesa di quest’ultimo (può far valere ogni ragione).
- Cass., ord. 6/03/2025 n. 5930 – Ha confermato la legittimità di un accertamento notificato all’amministratore di fatto di una SRL, motivato per relationem col PVC della GDF notificato alla società. Sancisce che il gestore occulto non può nascondersi dietro la mancanza di una carica formale.
- Cass., ord. 2/02/2025 n. 2464 – Ha ribadito che per vincere la presunzione di distribuzione utili ai soci di società a base ristretta è ammessa la prova dell’estraneità totale del socio alla gestione. Ciò allinea la giurisprudenza recente su una posizione più equilibrata a favore dei contribuenti non coinvolti attivamente.
- Cass., ord. 9/05/2025 n. 12288 – Ha confermato l’orientamento “classico” sulla presunzione di utili ai soci, ignorando l’art.7 co.5-bis del D.lgs.546/92 (che richiede un efficace riscontro probatorio) e mantenendo fermo che basta provare la ristretta base sociale e l’accertamento societario definitivo perché scatti la presunzione. Quindi evidenzia come la Cassazione sia ancora molto rigida: onere della prova contraria in capo al socio.
- Cass., sent. 10/10/2024 n. 26473 – Ha sottolineato la necessità di una prova “molto rigorosa” per dimostrare l’estraneità del socio e superare la presunzione di distribuzione. In quel caso ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo insufficiente la documentazione presentata dal socio a sua discolpa, e ha ribadito che l’art.7 co.5-bis (riforma del 2022) non toglie valore alla presunzione se non viene accompagnata da prove forti.
- Cass., sent. 25/11/2024 n. 41238 (III Sez. Pen.) – In ambito penale, ha applicato la nuova causa di non punibilità per omesso versamento IVA dovuto a crisi di liquidità: ha annullato una condanna considerando il comma 3-bis dell’art.13 D.Lgs.74/2000 introdotto a giugno 2024. Questa pronuncia è significativa perché segnala un cambio di passo: la Cassazione “assolve” l’imprenditore se prova che il mancato pagamento fu dovuto a eventi eccezionali fuori dal suo controllo (ad es. grosso cliente insolvente, ecc.).
Oltre a queste, citiamo: Cass. 28/08/2013 n.19716 (società artificiosa => amministratore considerato contribuente); Cass. 20/11/2013 n.25989 (sullo stesso tema); Cass. 26/06/2015 n.13259; Cass. 11/05/2012 n.7327 (onere Agenzia di provare avvenuta distribuzione ai soci per agire ex 2495 c.c.); Cass. 07/06/2016 n.11683 (responsabilità soci SNC per debiti anche senza dimostrare incassi); Cass. SS.UU. 05/12/2012 n.21773 e SS.UU. 14815/2008 (sull’estinzione società e sorte processuale). Tutte concorrono a delineare il quadro: responsabilità circoscritte ma effettive in caso di abuso, presunzioni sui soci difficili da vincere, Fisco che può recuperare imposte dai liquidatori negligenti.
D: L’amministratore di una holding può stipulare accordi con il Fisco per prevenire accertamenti futuri?
R: Sì, esistono meccanismi come la cooperative compliance (per grandi contribuenti) o il concordato preventivo biennale introdotto dal 2024 per PMI, che è una sorta di accordo su base imponibile futura. La cooperative compliance richiede dimensioni notevoli e comporta dialogo costante col Fisco. Il concordato biennale 2025-2026, rivolto a soggetti di minori dimensioni con certe condizioni, consente di concordare un maggior reddito per i due anni in cambio della certezza che su quel periodo non verranno fatti accertamenti (se rispetti l’accordo). Una holding potrebbe aderire se rientra nelle soglie e vuole “comprare pace fiscale” per un paio d’anni. Inoltre, per specifiche operazioni dubbie l’amministratore può presentare interpelli all’Agenzia per ottenere un parere ed evitare sanzioni in caso di risposta conforme. Insomma, c’è la possibilità di un rapporto preventivo col Fisco: se la holding ha potenziali zone grigie (es. residenza fiscale, transfer pricing interno al gruppo, ecc.) è saggio interpellare l’Agenzia prima di agire. Questo riduce il rischio di accertamento e di contestazioni soggettive all’amministratore per condotte elusive. Tuttavia, una volta che l’evasione è avvenuta, resta solo da gestirne le conseguenze come detto sopra. Prevenire è meglio che curare: una pianificazione fiscale corretta, la compliance ai doveri documentali e dichiarativi e un dialogo trasparente col Fisco quando opportuno, sono la miglior strategia per un amministratore di holding che voglia evitare guai.
Esempi pratici e casi simulati
Di seguito si riportano alcune simulazioni per illustrare concretamente l’applicazione dei principi esposti, dal punto di vista dell’amministratore “debitore”.
Caso 1: Accertamento IRES alla holding e IVA non versata – difesa e penalità
Tizio è amministratore unico e socio al 100% di Alfa Holding Srl. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento intestato ad Alfa Srl per l’anno d’imposta 2022: il Fisco contesta costi indebiti per €200.000, rideterminando un maggior reddito IRES con imposta €48.000 e sanzione 90% (€43.200). Inoltre risulta un’IVA non versata di €30.000 (sanzione 30% €9.000). La società attualmente è in crisi di liquidità.
Scenario e azioni: Tizio, come legale rappresentante, ha 60 giorni. Dopo consulto col commercialista, decide di impugnare perché alcuni costi negati (consulenze infragruppo) in realtà erano documentati. Contestualmente chiede accertamento con adesione per cercare un accordo: l’ufficio in sede di adesione riconosce il 50% dei costi contestati come leciti. Si prospetta un accordo: imposta ridotta a €24.000, sanzioni ridotte a 1/3 del minimo (dal 90% al 30%). Tizio accetta perché Alfa Srl non potrebbe comunque pagare €90k tra imposte e sanzioni, mentre pagando circa €24k+€7k sanzioni = €31k risolve. Rateizza in 6 rate semestrali da ~€5k. Per l’IVA non versata (€30k del 2022), l’accertamento esecutivo ingloba anche quella: Tizio sa che quell’omesso versamento è sotto soglia penale (30k < 250k) quindi niente reato, ma la sanzione 30% (€9k) va pagata dalla società. Include anche questa nel calcolo di quanto Alfa deve sborsare. Grazie alle rate, Alfa Srl (che aveva ancora qualche fondo) riesce a onorare la prima rata. Tizio inoltre si attiva per regolarizzare l’IVA del 2023 onde non accumulare altre violazioni. In questo caso, Tizio come persona fisica non subisce accertamenti IRPEF (il maggior reddito era IRES, riguarda solo la società) né responsabilità personali perché Alfa sta pagando. Se Alfa non avesse potuto pagare neppure a rate, Tizio avrebbe considerato altre opzioni, come provare la definizione agevolata in tribunale (ma nel 2025 non ce n’è per atti nuovi), o in estremo la liquidazione della società. Ma liquidare con debiti IVA avrebbe innescato l’art.36, quindi ha preferito fare l’adesione e chiudere il debito col 30% di sanzioni. Dal suo punto di vista, la scelta è stata razionale: evitare un processo incerto e togliere di mezzo il rischio di pignoramenti (che sarebbero partiti dopo 60 giorni).
Caso 2: Società cancellata con debiti fiscali – accertamento al liquidatore ex art.36
Beta Holding SpA (gruppo familiare) si è sciolta nel 2023. Il liquidatore, Caio (uno dei due soci), ha venduto gli immobili sociali distribuendo il ricavato ai soci (lui e suo fratello) dopo aver pagato fornitori e banche. Restavano tuttavia debiti tributari: €100.000 di IVA e €50.000 di IRAP non pagati relativi al 2021-2022. Nessun accertamento era stato notificato prima della cancellazione, ma nel 2024 l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento ex art.36 DPR 602/73 nei confronti di Caio, quale liquidatore, chiedendogli €150.000 + interessi.
Scenario e difesa: Caio riceve questo atto a suo nome. La motivazione spiega che Beta SpA in liquidazione non ha pagato quelle imposte e che Caio ha assegnato beni ai soci (divisi €500k a testa) senza soddisfare l’Erario. Caio si rende conto che effettivamente ha chiuso la liquidazione distribuendo utili e riserve ai soci e pagando altri creditori, lasciando le imposte indietro. Forse pensava che la cancellazione avrebbe estinto il debito. Ora scopre che ne è personalmente responsabile. Si rivolge a un avvocato e decide di impugnare l’atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Le possibili difese sono limitate: Caio non può negare di aver distribuito attivo (è nei bilanci finali). Tenta però due strade: (1) eccepire che parte di quelle imposte non erano dovute (Beta aveva chiesto un credito IVA di €20k, mai ottenuto, quindi secondo lui il debito netto IVA sarebbe inferiore); (2) sostenere che alcuni crediti da lui pagati avevano privilegio superiore alle imposte (ad esempio pagò i dipendenti e il TFR prima di chiudere). Fornisce documenti in tal senso. Se riuscisse a dimostrare che, sottraendo quei crediti privilegiati, l’attivo rimasto non sarebbe comunque bastato a pagare interamente l’IVA, potrebbe chiedere di ridurre la sua responsabilità a quanto effettivamente “distratto”. Dato che l’Agenzia gli chiede l’intero (150k), Caio spera di convincere il giudice a ridurre. Nel frattempo, Caio si preoccupa di come pagare se perde: il suo patrimonio consiste principalmente in una casa (prima casa) e in investimenti. Sa che l’Agente Riscossione non potrà ipotecare/vendere la prima casa se unica e non di lusso, ma può aggredire il denaro sul conto. Quindi valuta, in parallelo al ricorso, di proporre all’Agenzia un accordo transattivo: offre €100.000 in un’unica soluzione, magari attingendo a risparmi (ricordiamo che Caio ha ricevuto €500k di liquidazione!). L’ufficio potrebbe essere interessato, ma formalmente l’art.36 non prevede “adesione”. Tuttavia, Caio può utilizzare lo strumento del reclamo/mediazione (il valore è 150k, quindi >50k, niente reclamo obbligatorio; però potrebbe anticipare all’ufficio legale la proposta transattiva). Se l’Agenzia intuisce che Caio in giudizio potrebbe farsi ridurre l’importo, forse accetterà 100k subito. Questa trattativa informale a volte avviene. Se avviene, Caio si farebbe mettere per iscritto l’abbandono della pretesa residua e pagherebbe. Se invece la lite va avanti e Caio perde, dovrà pagare 150k più interessi. Avrà 60 gg dalla sentenza per farlo (o appello, ma in appello dovrebbe intanto versare qualcosa). In quel caso, l’Agenzia Riscossione potrebbe puntare ai conti di Caio e ai suoi investimenti. Caio potrebbe trovarsi a vendere parte del suo patrimonio finanziario per saldare. La lezione qui: Caio, come liquidatore, ha sottovalutato il vincolo di pagare prima il Fisco. Se avesse destinato parte dei 1 milione distribuito ai soci al pagamento dei 150k di imposte, ora non avrebbe questo problema.
Caso 3: Presunzione utili ai soci – socio amministratore vs socio estraneo
Gamma Holding Srl, 2 soci al 50% (Aldo e Beppe). Aldo è anche amministratore unico e gestisce tutto; Beppe è un investitore che non interviene nella gestione. Verifica fiscale anni 2019-2020: accertati ricavi non dichiarati per €400.000. Gamma non impugna l’accertamento (Aldo, mal consigliato, fa cancellare la società pensando di far perdere le tracce). Nel 2025 l’Agenzia notifica ad Aldo e Beppe (persone fisiche) due avvisi IRPEF, ciascuno per €200.000 di redditi di capitale 2019-2020 non dichiarati.
Difese opposte: Aldo, in quanto amministratore-socio, sa di aver effettivamente prelevato in nero quei soldi per fini personali. Beppe invece non ha ricevuto nulla né sapeva dell’evasione. Entrambi fanno ricorso. Aldo praticamente non ha prova contraria: gli utili non risultano in azienda (Gamma è stata chiusa e i conti sono stati svuotati). Non può neanche sostenere di essere estraneo (era lui il gestore!). L’unica speranza per Aldo sarebbe attaccare la legittimità della presunzione, magari dicendo che la società aveva 2 soci non parenti, quindi non “ristretta base familiare” – argomento però debole, la giurisprudenza applica la presunzione anche se i soci non sono familiari stretti. Aldo potrebbe tentare di ridurre il quantum mostrando che parte di quei 400k sono rimasti in cassa o investiti (ma se li ha presi lui, difficile). In sostanza, Aldo è consapevole che dovrà pagare l’IRPEF su quei 200k. Beppe invece imposta la difesa sul dimostrare la sua estraneità totale: produce email in cui chiedeva più trasparenza ad Aldo e veniva tenuto all’oscuro, copia delle deleghe bancarie (solo Aldo aveva firma sui conti), evidenze che lui risiede all’estero per lavoro e non frequentava la società. Porta anche la testimonianza di un dipendente (ora ammessa in Commissione tributaria dopo la riforma) che conferma che Beppe non si vedeva mai e non decideva nulla. Inoltre, Beppe mostra che i suoi conti personali non hanno ricevuto alcun bonifico o prelievo sospetto in quegli anni, né il suo tenore di vita è aumentato. Queste prove vanno nella direzione di convincere il giudice che “non tutti i soci partecipavano alla gestione” e quindi l’automatismo della distribuzione a tutti i soci può essere vinto. Se il giudice riconosce l’estraneità di Beppe, annullerà l’accertamento a lui relativo. Per Aldo invece confermerà. Risultato: Aldo dovrà pagare IRPEF + sanzioni, Beppe nulla. È uno scenario coerente con Cassazione recente, che ammette di escludere dal novero dei soci beneficiari colui che provi concretamente di non aver avuto parte attiva. Da notare che Aldo, avendo chiuso la società per nascondere le tracce, può anche trovarsi ora un problema penale: 400k evasi IRES in 2 anni significa reato di dichiarazione infedele (soglia superata), e lui ha pure distrutto le scritture (cancellazione con documenti non consegnati al Fisco). Quindi Aldo potrebbe essere imputato ex art.10 D.Lgs.74/2000 per occultamento di contabilità e art.4 per infedele. Beppe no, perché penalmente risponde chi ha agito (Aldo). Questo caso evidenzia come i soci “passivi” possano salvarsi in sede tributaria, ma molto dipende dalla qualità delle prove contrarie.
Caso 4: Accertamento all’amministratore di fatto – figura di comodo
Ditta X SRL, amministratore legale è un prestanome (il signor Tizio, nullatenente). L’amministratore di fatto è Caio, che tramite deleghe bancarie e procure occulte gestisce tutto. La società X in tre anni emette fatture false per 2 milioni di euro, poi non presenta dichiarazione e sparisce. Nel 2025 l’Agenzia notifica a Caio un avviso di accertamento per IVA evasa e IRPEF redditi diversi di €2 milioni, qualificandolo come amministratore di fatto e beneficiario delle somme.
Scenario: Caio si vede recapitare questo pesante atto. Formalmente, la società X è inattiva e Tizio irreperibile. Il Fisco (anche attraverso la GdF) ha tracciato i flussi: le somme incassate da X per fatture false venivano bonificate a una società estera riconducibile a Caio. Dunque Caio è trattato come contribuente principale: l’IVA non versata da X viene richiesta a lui, presumendo che fosse il vero autore dell’evasione (concetto di “fictio societatis”). Inoltre, i proventi illeciti derivati dalle fatture false vengono considerati reddito non dichiarato in capo a Caio (qualificati come redditi diversi o redditi d’impresa in base alle circostanze). Caio è di fronte a un problema enorme: civilmente e penalmente. Sul piano tributario, le possibilità di difesa sono minime: non può certo sostenere di essere estraneo, le prove lo incastrano. Potrebbe contestare qualcosa sulla quantificazione, ma trattandosi di fatture per operazioni inesistenti, l’IVA evasa è nota, e i ricavi illeciti pure. Magari invocherà la nullità della notifica (ma è stata fatta regolarmente a lui). In sostanza, Caio come amministratore di fatto finirà col pagare tutto, se ne ha i mezzi, o altrimenti subire aggressione di beni. In parallelo Caio sarà imputato per reati gravi (dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, associazione a delinquere fiscale se del caso). La sua posizione è pessima. Se Caio avesse evitato di fare il prestanome e avesse fatto emergere i redditi, oggi non sarebbe in questo guaio. Questo caso estremo serve a capire che l’ordinamento, quando rileva abusi tramite prestanome, può bypassare completamente la società e colpire l’individuo: l’amministratore di fatto viene equiparato al soggetto obbligato d’imposta e gli vengono attribuiti tutti i redditi e le imposte evase. Dal punto di vista del “debitore” Caio, non c’è scampo: può solo cercare clemenza in sede penale collaborando (magari patteggiando) e cercare un accordo in sede esattoriale (difficile su importi così derivanti da frodi). Alla fine Caio probabilmente subirà confisca di tutto il confiscabile e magari una pena detentiva. Questo ribadisce che l’uso distorto della personalità giuridica viene punito severamente, e non offre reale protezione patrimoniale all’amministratore occulto.
Conclusione
Essere amministratore di una holding comporta vantaggi (controllo su un patrimonio societario, limitazione di responsabilità verso i terzi in condizioni normali) ma anche precisi doveri legali e rischi in caso di irregolarità fiscali. Dal punto di vista dell’amministratore “debitore” – colui che si trova bersaglio di pretese erariali – questa guida ha messo in luce alcuni punti fermi:
- Prevenzione e correttezza: la miglior difesa è evitare di incorrere in violazioni. Mantenere una contabilità trasparente, assolvere agli obblighi fiscali (dichiarativi e di versamento) e non utilizzare la holding per finalità elusive o personali improprie, mette al riparo da gran parte degli accertamenti. Se la holding è ben gestita e in buona fede fiscale (come richiesto dallo Statuto del Contribuente), eventuali contestazioni potranno essere chiarite più facilmente e senza accuse di dolo.
- Consapevolezza delle eccezioni: non bisogna credere che la forma societaria sia uno schermo assoluto. Abbiamo visto come la legge e i giudici, in presenza di determinati presupposti (liquidazioni non diligentissime, società a base ristretta, abusi), possano penetrare la separazione patrimoniale e chiamare l’amministratore (o i soci) a rispondere. Un amministratore accorto conosce queste situazioni e le evita: ad esempio, prima di distribuire dividendi o capitali ai soci, si assicura di aver pagato (o accantonato) le imposte dovute, così non incapperà nell’art.36. Oppure, se la holding è inattiva, considera l’onere del test di comodo e valuta di scioglierla o chiederne la disapplicazione in anticipo per non accumulare redditi presunti. Se la società ha pochi soci, l’amministratore informa i soci che eventuali utili nascosti potrebbero essere imputati loro comunque, cosicché tutti siano allineati su comportamenti leciti.
- Reazione tempestiva agli accertamenti: qualora l’accertamento arrivi, l’atteggiamento migliore è affrontarlo di petto, senza panico ma neanche sottovalutazione. Ci sono strumenti per ridurre il danno (adesione, acquiescenza) e strumenti per far valere le ragioni (ricorso). Lasciar scadere i termini o cercare rifugi illegali peggiorerà la situazione. Un amministratore informato sa, ad esempio, che dopo 60 giorni dall’avviso il Fisco può iniziare la riscossione, dunque pianifica con i consulenti le mosse entro quel limite.
- Tutela del proprio patrimonio: l’amministratore di holding, specie se anche imprenditore, dovrebbe attuare in tempi non sospetti una minima pianificazione patrimoniale personale. Non per evadere, ma per proteggersi da evenienze. Ad esempio, tenere separato il patrimonio familiare da quello aziendale (non mischiare conti personali e sociali), considerare strumenti come polizze o trust per proteggere alcuni beni – sempre con l’aiuto di professionisti per farlo legittimamente. In caso di crisi aziendale con debiti tributari, valutare percorsi di composizione negoziata o procedure concorsuali può essere meglio che accumulare reati o debiti irrecuperabili. L’importante è non fare il passo più lungo della gamba: se l’azienda va male, coinvolgere il Fisco in una trattativa (piani di rientro) è preferibile al muro contro muro.
- Aggiornamento costante: le leggi fiscali e le interpretazioni giurisprudenziali evolvono (come la riforma del 2022-2023 sul processo tributario, o quella del 2024 sui reati di omesso versamento). È essenziale per un amministratore, e i suoi consulenti, restare aggiornati. Una nuova sentenza della Cassazione (come quelle citate) può aprire opportunità difensive prima impensabili, o al contrario chiudere scappatoie. Ad esempio, sapere che la Cassazione chiede prove rigorose di estraneità spinge un socio innocente a raccogliere più documenti possibile, mentre un amministratore negligente capisce che difficilmente potrà farla franca.
In conclusione, il punto di vista del debitore amministratore deve coniugare la conoscenza dei propri diritti (non pagare ciò che non è dovuto; impugnare atti illegittimi; godere di riduzioni di sanzioni; non subire pene se non vi è colpa) con la consapevolezza dei propri doveri (agire con diligenza nella gestione fiscale; non disperdere garanzie ai creditori; collaborare col Fisco in modo leale come richiede l’art.10 L.212/2000). Solo così egli potrà navigare in sicurezza il complesso campo degli accertamenti fiscali riguardanti la holding, minimizzando i rischi di coinvolgimento personale e proteggendo sia l’azienda sia il proprio patrimonio.
Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a Luglio 2025)
- Codice Civile: art. 2291 c.c. (responsabilità soci SNC); art. 2313 c.c. (SAS); art. 2476 c.c. co.7 (azione dei creditori sociali vs amministratori SRL); art. 2495 c.c. (responsabilità post liquidazione).
- D.P.R. 29/09/1973 n.602, art. 36 – Responsabilità ed obblighi di amministratori, liquidatori e soci per il pagamento delle imposte.
- Legge 27/12/2003 n. 289 (Finanziaria 2003), art. 7 (divenuto art.7 DL 269/2003 conv. L.326/2003) – Sanzioni tributarie esclusivamente a carico della persona giuridica.
- D.Lgs. 18/12/1997 n.472, art. 11 – Principio di personalità nelle sanzioni e solidarietà (in combinato con art.7 DL 269/2003).
- Statuto del Contribuente (L. 212/2000): art. 10 (Tutela dell’affidamento e buona fede, non punibilità per obiettive incertezze); art. 12 (Diritti del contribuente verificato, ad es. contraddittorio endoprocedimentale).
- D.P.R. 22/12/1986 n.917 (TUIR): Artt. 47, 59 (qualificazione fiscale degli utili ai soci).
- D.P.R. 26/10/1972 n.633 (IVA): disciplina generale sull’imposta, obblighi di dichiarazione e versamento.
- D.L. 30/08/1993 n.331, art.62-sexiesdecies (presunzioni su ricavi non dichiarati? Norme redditometro, ora D.L. 78/2010).
- Legge 23/12/1994 n.724, art. 30 – Disciplina società di comodo (test di operatività, reddito minimo presunto); aggiornato da L. 111/2023 delega fiscale.
- D.Lgs. 31/12/1992 n.546, art. 19 (attì impugnabili); art. 68 (sospensione dell’esecutività parziale delle sentenze; pagamento provvisorio 1/3 – 2/3); art. 7 co.5-bis (onere della prova in giudizio introdotto da L.130/2022).
- D.L. 31/05/2010 n.78, art. 29 – Avviso di accertamento esecutivo: ha introdotto dal 1/10/2011 la speditezza della riscossione sugli avvisi.
- Circolare Agenzia Entrate 20/03/2020 n.5/E – Chiarimenti su accertamento esecutivo (termini di versamento, sospensioni Covid ecc.).
- D.L. 34/2019 (“Decreto Crescita”) e D.L. 146/2021 – Modifiche soglie penali (es. innalzamento soglia omesso versamento IVA a 250k).
- D.Lgs. 10/03/2000 n.74 (Reati tributari): art. 2 (dich. fraudolenta mediante fatture); art. 3 (dich. fraudolenta altri artifici); art. 4 (dich. infedele); art. 5 (omessa dichiarazione); art. 7 (otras – non più utilizzato); art. 8 (emissione fatture false); art. 10 (occultamento scritture); art. 10-bis (omesso versamento ritenute); art. 10-ter (omesso versamento IVA); art. 11 (sottrazione fraudolenta); art. 12-bis (confisca); art. 13 (cause di non punibilità e attenuanti: pagamento del debito tributario, nuova co.3-bis su cause non imputabili).
- D.Lgs. 14/2023 (Attuazione riforma fiscale 2023): art. 5 ha inserito il comma 3-bis art.13 D.Lgs.74/2000 (non punibilità per crisi di liquidità sopravvenuta).
- Cass. Civ., Sez. Unite, 05/12/2008 n.14815 – Estinzione società di capitali e rapporti pendenti: afferma sopravvivenza per definire rapporti (superata in parte da norme 2014).
- Cass. Civ., Sez. Unite, 05/12/2012 n.21773 – Su effetti processuali dell’estinzione della società; i soci subentrano nei giudizi in corso salvo 2495 c.c..
- Cass. Civ., Sez. Unite, 12/03/2013 nn.6070 e 6071 – Responsabilità ex art.2495 c.c. e limiti; posposizione cancellazione ecc. (spesso citate in dottrina).
- Cass. Civ., Sez. Unite, 29/11/2023 n.32790 – Fisco vs liquidatori (art.36 DPR 602/73): niente iscrizione a ruolo necessaria, natura civilistica responsabilità, liquidatore può contestare debito.
- Cass. Civ., Sez. V, 11/05/2012 n.7327 – Agenzia che vuole soci responsabili ex 2495 deve provare che vi fu distribuzione attivo ai soci.
- Cass. Civ., Sez. V, 07/06/2016 n.11683 – Inopponibilità art.2495 per SNC: soci illimitatamente responsabili comunque anche se non dimostrato incasso.
- Cass. Civ., Sez. V, 28/08/2013 n.19716 – Società fittizia a scopo illecito: amministratore di fatto è trasgressore e contribuente, società come mera fictio.
- Cass. Civ., Sez. V, 20/11/2013 n.25989 – Conferma tesi persona giuridica fittizia => responsabilità persone fisiche.
- Cass. Civ., Sez. V, 26/06/2015 n.13259 – Su abuso personalità giuridica e inopponibilità ai fini tributari (linea simile alle precedenti).
- Cass. Civ., Sez. V, 18/10/2017 n.24534 – (e molte altre) sul principio presunzione utili soci a base ristretta.
- Cass. Civ., Sez. V, 09/07/2024 n.18764 – Ammette prova contraria mediante estraneità del socio (citata in ordinanza 2025).
- Cass. Civ., Sez. V, 02/02/2025 n.2464 – Conferma orientamento recente: socio può vincere presunzione provando estraneità totale alla gestione. Ribadisce evoluzione giurisprudenziale in favore contribuente.
- Cass. Civ., Sez. V, 09/05/2025 n.12288 – Mantiene orientamento tradizionale: onere su socio di provare reinvestimento o estraneità; l’ufficio basta provi base ristretta e utili non dichiarati. Ignora art.7 co.5-bis D.lgs.546/92.
- Cass. Civ., Sez. V, 10/10/2024 n.26473 – Prova contraria “molto rigorosa” per estraneità socio; necessità di indizi certi e concordanti, non generici.
- Cass. Pen., Sez. III, 20/04/2022 n.19651 – Ammetteva considerare gravissima crisi per escludere dolo omesso versamento (precursore riforma).
- Cass. Pen., Sez. III, 11/11/2024 n.41238 – Svolta giurisprudenziale su omesso versamento IVA: applica nuova causa non punibilità per crisi non imputabile.
- Cass. Pen., Sez. III, 20/07/2024 n.30532 – Simile ambito (cita art.13 co.3-bis, vedi osservatorio).
- Circolare AE 24/06/2025 n.9/E – Guida al concordato preventivo biennale 2025-26: spiega requisiti e benefici dell’accordo fiscale biennale.
- Prassi Agenzia Entrate Riscossione: Direttiva 15/04/2011 n.12 di Equitalia (rateazioni soci ex 2495 c.c. solo con garanzia); istruzioni interne su ipoteche prima casa (DL 69/2013).
Sei l’amministratore di una holding e hai ricevuto un accertamento fiscale? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Se sei stato colpito da un accertamento personale in quanto amministratore di una holding, potresti essere chiamato a rispondere non solo per la società, ma anche per presunte responsabilità dirette o solidali.
In queste situazioni delicate, è fondamentale muoversi con attenzione, per limitare le conseguenze fiscali, patrimoniali e penali.
Perché l’Agenzia delle Entrate colpisce l’amministratore?
L’Amministrazione finanziaria può contestare all’amministratore di una holding:
- 📊 Condotte elusive o simulatorie nelle operazioni tra società del gruppo
- 📉 Utilizzo della holding come “scatola vuota” o strumento di vantaggio fiscale
- 🔍 Gestione unitaria del gruppo non dichiarata (con rischio di accertamento consolidato)
- ⚠️ Responsabilità per omessi versamenti IVA, IRES, IRAP o ritenute
- 💼 Irregolarità nei finanziamenti infragruppo o distribuzione di utili occulti
In alcuni casi, l’Agenzia può agire direttamente sull’amministratore, sia come responsabile solidale che come beneficiario economico.
Quali rischi corri come amministratore?
- 🧾 Contestazione di utili extracontabili o compensi in nero
- ⚖️ Responsabilità per dichiarazioni infedeli della società
- 🔗 Coinvolgimento in esterovestizione, stabile organizzazione occulta o abuso del diritto
- 💸 Rischio di sanzioni personali, pignoramenti, blocco dei beni
- 🚫 Procedimenti penali per reati tributari (omessa dichiarazione, indebite compensazioni, ecc.)
Come difendersi da un accertamento come amministratore?
- 📂 Verifica immediatamente la natura e i presupposti dell’accertamento
- 🧾 Raccogli documentazione societaria, delibere, contratti e corrispondenza intersocietaria
- 🧠 Analizza il ruolo concreto ricoperto: formale o operativo?
- ⚖️ Prepara una difesa tecnica e fiscale, eventualmente con perizia contabile
- ✍️ Presenta ricorso se l’accertamento è infondato, sproporzionato o viziato
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📑 Analizza l’avviso di accertamento e i profili di responsabilità personale
📂 Verifica la distinzione tra attività della holding e responsabilità dell’amministratore
✍️ Redige ricorsi contro contestazioni personali e tributarie
⚖️ Ti rappresenta nel contenzioso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e nella fase penale
🔁 Ti supporta nella gestione corretta dei rapporti infragruppo e nella pianificazione fiscale
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in accertamenti a carico di amministratori e holding
✔️ Consulente in caso di procedimenti per elusione, esterovestizione e responsabilità fiscale personale
✔️ Iscritto come Gestore della crisi d’impresa presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Essere amministratore di una holding non significa essere automaticamente responsabile per tutte le contestazioni del Fisco. Ma serve una difesa mirata e documentata per evitare danni personali e societari.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi affrontare ogni accertamento con una strategia legale solida, competente e calibrata sulla tua posizione reale.
📞 Richiedi ora una consulenza riservata per proteggere te e la tua holding da un accertamento fiscale.