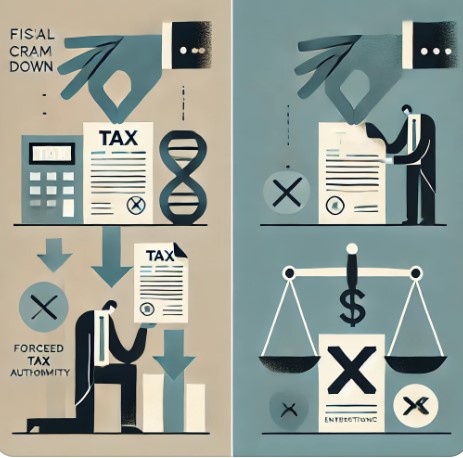La tua impresa è in crisi ma ha ancora potenzialità? Vuoi evitare la chiusura e ristrutturare i debiti anche senza il consenso di tutti i creditori?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto della crisi d’impresa, concordati preventivi e ristrutturazione aziendale – è pensata per aiutarti a capire come funziona il concordato in continuità e il meccanismo del cram down fiscale e contributivo.
Scopri quando è possibile accedere al concordato in continuità aziendale, come salvaguardare l’attività operativa durante la procedura, e in quali casi il tribunale può approvare il piano anche in presenza di dissenso da parte del Fisco o dell’INPS grazie al cram down.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, valutare la tua situazione con un avvocato esperto e costruire un piano sostenibile per ristrutturare i debiti, continuare a lavorare e rilanciare la tua impresa.
Introduzione
Il concordato preventivo in continuità aziendale è un istituto di ristrutturazione del debito che consente all’impresa in crisi di continuare l’attività, salvaguardando i livelli occupazionali e il valore dell’azienda. In tal contesto, il cram down è un meccanismo di omologazione coattiva del piano concordatario: consente di superare il dissenso dei creditori imponendo loro il piano anche in caso di voto contrario. La disciplina del cram down si articola principalmente in due ambiti: il cram down fiscale e previdenziale (art. 88, co. 2-bis CCII) e la ristrutturazione trasversale dei debiti (cross-class cram down, art. 112, co. 2 CCII).
Questa guida analizza la normativa aggiornata (Codice della crisi D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche, in particolare il “Decreto correttivo-ter” D.Lgs. 136/2024) e la giurisprudenza recente fino a maggio 2025. Sono fornite tabelle riepilogative di concetti chiave, procedure e condizioni, oltre a una sezione Q&A con i dubbi più comuni e simulazioni pratiche con esempi numerici. Infine, si approfondiscono i ruoli dei creditori, dei professionisti, del tribunale e del commissario giudiziale nella procedura.
Normativa di riferimento
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)
Il Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII) ha riformato e unificato le regole concorsuali italiane. In particolare, il concordato preventivo in continuità (CPC) è disciplinato negli artt. 163-176 e ss. CCII, con norme specifiche nel Titolo VI (arts. 181-187) e riferimenti generali come gli artt. 85 (classi dei creditori), 86 (moratoria), 172 (attestazione di fattibilità), 180-182-bis (omologazione e piani) e 184 (effetti del piano).
- Art. 85 CCII – Classi di creditori: i creditori vengono raggruppati in classi omogenee, in base a diritti di prelazione simili (privilegiati, chirografari, etc.). Il piano concordatario può differenziarne il trattamento.
- Art. 86 CCII – Moratoria: sospende le esecuzioni individuali e gli effetti dell’aggravamento del credito per le obbligazioni sorte prima del concordato.
- Artt. 107-109 CCII – Ammissibilità al voto e maggioranze: stabiliscono che il concordato in continuità è approvato quando sia stato votato favorevolmente dall’unanimità delle classi (art. 109, c.5 CCII). In caso contrario, interviene il meccanismo del cross-class cram down (art. 112).
- Artt. 114-bis CCII – Modifiche al piano: il tribunale può autorizzare variazioni al piano anche dopo il voto, con l’assistenza del commissario giudiziale.
- Artt. 117-118 CCII – Effetti del concordato: definiscono l’esdebitazione e la ripartizione ai creditori post-omologa. In particolare, con l’omologa tutti i creditori ammessi al voto ottengono il trattamento previsto dal piano (art. 117, c.1), sostituendo ogni loro diritto precedente.
- Artt. 182-ter CCII – Priorità relativa: richiamato dall’art. 88 CCII, regola il trattamento dei crediti in caso di insufficienza dell’attivo.
Cram down fiscale e previdenziale (art. 88 CCII)
L’art. 88 CCII, novellato dal correttivo-ter, disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo. In particolare, l’art. 88, comma 2-bis CCII (al pari dell’art. 182-bis LF previgente) prevede il cosiddetto cram down fiscale e previdenziale: il tribunale può omologare coattivamente la transazione fiscale contenuta nel concordato anche in assenza di adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, se ricorrono due condizioni:
- Mancata adesione obbligatoria: l’Agenzia delle Entrate (o l’INPS/INAIL) non ha espresso parere favorevole alla proposta concordataria.
- Convenienza del piano: il piano proposto ai creditori pubblici deve risultare conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, sulla base della relazione del professionista indipendente. In pratica, i creditori fiscali e contributivi devono ottenere con il concordato (omologato anche coattivamente) un trattamento non deteriore rispetto a quello che avrebbero in liquidazione.
In sintesi, l’art. 88 CCII attribuisce al tribunale il potere di “buttare giù” il dissenso dei creditori pubblici nelle procedure concordatarie, purché (1) la loro adesione fosse determinante per raggiungere le maggioranze richieste (art. 109 CCII) e (2) il piano sia vantaggioso per essi. Va rilevato che, secondo dottrina prevalente, nel concordato in continuità questo istituto si applica analogamente a quanto previsto per il concordato liquidatorio, proprio perché la continuità valorizza maggiormente l’azienda.
Ristrutturazione trasversale dei debiti (cross-class cram down, art. 112 CCII)
L’art. 112, comma 2 CCII (originato dalla direttiva UE 2019/1023) disciplina il cross-class cram down: se in un concordato preventivo in continuità una o più classi dissentono, il tribunale, su richiesta del debitore, può comunque omologare il piano senza l’adesione di tutte le classi, purché ricorrano congiuntamente quattro condizioni:
- a) Rispetto della priorità assoluta: il valore di liquidazione (quanto si ottiene vendendo l’azienda in sede concorsuale) deve essere distribuito rigorosamente secondo la graduazione delle cause di prelazione (art. 84 CCII). In altre parole, i creditori privilegiati sono soddisfatti per primi; solo se rimane un surplus queste risorse aggiuntive possono essere assegnate ai chirografari.
- b) Priorità relativa sul surplus: il valore aggiuntivo generato dalla prosecuzione dell’attività (il “plusvalore concordatario” rispetto alla liquidazione) deve essere distribuito in modo che i creditori delle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto alle classi inferiori. In pratica, nessuna classe danneggiata deve trovarsi in uno stato peggiore del peggiore scenario possibile.
- c) Nessun superamento del credito: nessun creditore deve ricevere dall’accordo più dell’ammontare del proprio credito riconosciuto. Non si prevedono risarcimenti extra-creditizi.
- d) Maggioranza qualificata di classi: la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi ammessa al voto e almeno una di queste classi approvanti deve essere formata da creditori di grado superiore (privilegiati o garantiti). In mancanza di classi privilegiate favorevoli, è sufficiente che almeno una classe di creditori qualificati (ad es. garanti o parzialmente soddisfatti in continuità) approvi il piano.
Questi requisiti corrispondono a direzione della priorità assoluta e relativa ispirate dalla direttiva europea. L’art. 112 consente così di imporre un piano anche ai creditori che lo hanno respinto con il loro voto contrario, salvaguardando il principio che chi pecca di minoranza non deve essere trattato meno favorevolmente di quanto farebbe la liquidazione.
Modifiche normative recenti
La disciplina iniziale del codice è stata integrata dal D.Lgs. 27 settembre 2024, n. 136 (c.d. decreto correttivo-ter). Tra le modifiche più rilevanti al concordato, segnaliamo:
- Art. 88 CCII: è stato eliminato il richiamo all’art. 112 nel comma 1, comma che ora non cita più l’ambito del concordato in continuità. Tuttavia, gli interventi chiariscono che l’art. 88 si applica comunque anche alla procedura in continuità; il correttivo ha invece specificato che, nella valutazione dell’approvazione trasversale (art.112, lett. d), non si possono considerare favorevoli alla maggioranza le classi pubbliche che non abbiano espresso adesione. Ciò implica che, per contare come classe che approva il piano, i creditori fiscali/previdenziali devono aver formalmente aderito, diversamente dalla precedente interpretazione più estensiva.
- Art. 112 CCII: il correttivo-ter ha precisato regole operative (non mutate le condizioni) e ha reso esplicito che il cross-class cram down si applica solo al concordato in continuità, come già previsto originariamente.
- Art. 114-bis CCII: introdotta la facoltà del giudice delegato di autorizzare modifiche al piano dopo il deposito della domanda, sempre con il coinvolgimento del commissario giudiziale.
- Legge 147/2021 (D.L. 118/2021 conv.) ha anticipato alcune misure (ad es. composizione negoziata) e mantenuto disposizioni del vecchio diritto fallimentare (es. ammissione provvisoria, art. 107).
In sintesi, il diritto vivente accoglie un favor per il concordato in continuità: sia il codice che la dottrina sottolineano che, ove possibile, la continuità aziendale va privilegiata rispetto alla liquidazione, integrando e ampliando gli strumenti (cram down e ristrutturazione trasversale) per superare le resistenze dei creditori (favor rei concordatarii).
Orientamenti giurisprudenziali recenti (fino a maggio 2025)
La giurisprudenza italiana più recente ha affrontato vari profili del cram down nel concordato in continuità, spesso evidenziando contrasti interpretativi. Di seguito alcuni casi chiave:
- Tribunale di Napoli, 24 aprile 2024 (pres. Scoppa, relatore Feo) – Applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità. Il Tribunale ha autorizzato l’omologazione del piano nonostante il dissenso dei creditori fiscali e previdenziali, affermando che il rinvio dell’art. 88 CCII all’art. 112 (c.1) va interpretato nel senso che l’art. 112 si aggiunge e non esclude il potere dell’art. 88, comma 2-bis. In altri termini, l’istituto del cram down fiscale è stato ritenuto applicabile anche al concordato preventivo in continuità aziendale, purché sussistano le condizioni di legge. Il tribunale ha quindi convertito in voto favorevole quello (mancante) dei creditori pubblici, avendo verificato che il piano offriva loro un trattamento non peggiorativo rispetto alla liquidazione.
- Tribunale di Caltanissetta, 19 dicembre 2024 (pres. Canto, est. Di Francesco) – Cram down fiscale nel concordato in continuità (disciplina previgente al correttivo-ter). Qui si è ribadito che la disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024 (art. 88, co. 2-bis, v.i.) consente l’omologazione coattiva nel concordato in continuità. Il tribunale ha interpretato l’inciso iniziale di art. 88 CCII (“fermo restando quanto previsto… dall’art. 112, comma 2 CCII”) non come esclusione dell’art. 88, ma come integrazione. Anche secondo questo orientamento, l’assenza di adesione dell’Agenzia delle Entrate non impedisce l’applicazione del cram down fiscale al concordato in continuità, essendo tale istituto finalizzato a evitare il fallimento quando il piano sia coerente con l’alternativa liquidatoria.
- Corte d’Appello di Bari, 4 dicembre 2024, n. 232/2024 – Cross-class cram down nel concordato con continuità. In appello sulla stessa fattispecie, la Corte di Bari ha confermato l’omologa del concordato in continuità attraverso il cross-class cram down, respingendo il reclamo dell’Agenzia delle Entrate. La decisione ha ribadito l’osservanza delle regole di priorità assoluta e relativa: il valore di liquidazione è stato distribuito secondo graduazione delle prelazioni, e il plusvalore della continuità è stato assegnato in modo da trattare almeno al pari i creditori dissenzienti rispetto alle classi omologanti. Inoltre, si è richiamato che almeno una classe “maltrattata” (in questo caso, i creditori pubblici stessi) aveva votato a favore, soddisfacendo la lettera (d) di art. 112 CCII. In sintesi, la Corte di Bari ha confermato la validità del cram down trasversale nel concordato in continuità, chiarendo i criteri di distribuzione del valore di liquidazione e del surplus (cfr. tabella riepilogativa infra).
- Tribunale di Ferrara, 11 dicembre 2024 (rel. Cocca) – Cram down fiscale: orientamento restrittivo. Diversamente, il Tribunale di Ferrara ha assunto una posizione restrittiva. Pur essendo chiamato a decidere un concordato in continuità, il giudice ferrarese ha ritenuto che, secondo il testo anteriore al correttivo-ter, il cram down fiscale non fosse applicabile in continuità aziendale. Nel suo parere, l’unica ragione per introdurre il cram down fiscale sarebbe stata fornita dal successivo correttivo (D.Lgs. 136/2024), tacendo così implicita la sua liceità nel previgente assetto normativo. Questo orientamento rigido contrasta nettamente con Napoli e Bari, generando un conflitto interpretativo risolto in parte dal correttivo-ter.
In sintesi, fino all’intervento normativo del 2024 la giurisprudenza era divisa: alcuni tribunali (Napoli, Bari) consentivano un’interpretazione estensiva che applicava il cram down anche ai concordati in continuità, mentre altri (Ferrara) ritenevano che ciò non fosse permesso ante-riforma. Il correttivo-ter ha ora esplicitamente ammesso il cram down fiscale anche in continuità (art. 88, co. 2-bis come ridefinito) ma ha escluso che i creditori pubblici non aderenti possano essere conteggiati nella maggioranza per la ristrutturazione trasversale.
Tabelle riepilogative
Per chiarezza espositiva, di seguito si riportano tabelle riassuntive dei concetti, delle condizioni e degli effetti principali.
| Istituto / Aspetto | Riferimento normativo | Contenuto chiave |
|---|---|---|
| Cram down fiscale/previdenziale | Art. 88, comma 2-bis CCII (ex art.180 LF) | Omologazione coattiva della transazione fiscale nei concordati (anche in continuità), in caso di non adesione del Fisco o INPS. Richiede: 1) mancanza di adesione da parte dell’Agenzia Entrate (o enti previdenziali) determinante per il raggiungimento delle maggioranze; 2) convenienza del piano proposto rispetto all’alternativa liquidatoria. Il piano fiscale può quindi essere imposto ai creditori pubblici anche se dissentono. |
| Cross-class cram down (ristrutturazione trasversale) | Art. 112, comma 2 CCII | Omologazione del concordato in continuità nonostante il dissenso di una o più classi. Il tribunale omologa su richiesta del debitore se ricorrono congiuntamente queste condizioni: (a) rispetto assoluto delle graduazioni di prelazione nel valore di liquidazione; (b) rispetto relativo nel valore eccedente: i dissenzienti ricevono almeno quanto le classi di pari grado e più di quelle inferiori; (c) nessun creditore ottiene oltre il proprio credito; (d) la proposta è approvata da una maggioranza di classi, con almeno una classe “maltrattata” (di grado superiore) favorevole. In tal modo si realizza l’“imposizione” del piano avverso classi opponenti, garantendo al tempo stesso i principi di priorità assoluta e relativa. |
| Condizioni generali di omologazione | Art. 107-109 CCII | Il concordato in continuità è di regola omologato solo se l’intera proposta viene approvata all’unanimità delle classi (art. 109, c.5). In difetto di unanimità, interviene il cross-class cram down se sussistono le condizioni ex art.112. Il giudice verifica comunque: completezza documentale, veridicità degli allegati, fattibilità del piano (relazione ex art.172 CCII) e convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione (art. 182-quinquies CCII). |
| Effetti dell’omologazione | Artt. 117-118 CCII | Con l’omologa, il piano diventa vincolante per tutti i creditori: i dissenzienti perdono i diritti previsti dal proprio credito e ricevono quanto stabilito dal piano concordatario (art. 117). In particolare, i creditori che (pur ammessi al voto) non hanno partecipato all’accordo in ogni caso ottengono il valore pattuito nel piano. Il concordato in continuità ha effetto costitutivo nei rapporti di lavoro (salva continuità dei contratti e tutela salario) e purifica o non estingue i diritti reali di garanzia (il debitore continua a gestire l’impresa con i beni ipotecati e pignorati secondo piano omologato). |
| Concordato in continuità vs liquidatorio | Art. 109, 111 CCII | Nel concordato liquidatorio l’impresa cessa l’attività e il piano prevede la liquidazione del patrimonio per pagare i creditori. Nel concordato in continuità l’impresa prosegue l’attività e il piano prevede la prosecuzione con eventuali cessioni parziali, ricapitalizzazioni o ristrutturazioni. Il codice privilegia la continuità (favor rei concordatarii): l’attestazione e la convenienza sono valutate con sguardo orientato alla conservazione del valore aziendale. |
| Ruolo del commissario giudiziale | Art. 161, 172 CCII e ss. | Il commissario nominato all’ammissione (art. 161) verifica la sussistenza del debito, esamina i libri contabili e partecipa alle trattative. Redige la relazione tecnica ex art. 172 CCII sull’ammissibilità e fattibilità del piano, esprimendo parere sulla convenienza dell’accordo. Durante la procedura, affianca il debitore nella negoziazione di eventuali modifiche al piano e assicura la trasparenza (art. 105, 106 CCII). È l’“angela custode” dei creditori e riferisce periodicamente al tribunale sull’andamento della procedura. |
Ruoli chiave nella procedura concordataria
La procedura del concordato in continuità coinvolge diversi attori, ciascuno con compiti ben definiti:
- Imprenditore-debitore: presenta la domanda di concordato con il piano di ristrutturazione, corredato di documenti contabili e stato passivo. In sede di composizione negoziata, è assistito da professionisti (commercialisti, avvocati) che redigono il piano e la relazione ex art. 161 CCII. In particolare, il debitore deve fornire una relazione del professionista indipendente (art. 172 CCII) che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, anche comparando il trattamento proposto con l’alternativa liquidatoria. Durante l’iter del concordato, il debitore può chiedere modifiche al piano (art. 114-bis CCII) con l’assistenza del commissario. In caso di dissenso, il debitore può invocare il cram down chiedendo al tribunale di omologare il piano coattivamente.
- Creditori: raggruppati in classi omogenee (art. 85 CCII), sono convocati all’assemblea dove esprimono il voto sulla proposta. La maggioranza richiesta per l’approvazione ordinaria è stabilita dall’art. 109 CCII (di regola tutte le classi favorevoli). Tra i creditori, particolare rilievo hanno i creditori pubblici qualificati (Fisco e previdenza): essi votano su base diversa (valutazione del credito chirografario e oneri di riscossione, art. 88, commi 4-5 CCII). In caso di cram down fiscale, il loro dissenso può essere neutralizzato (per effetto di art. 88, c.2-bis) se il piano soddisfa le condizioni di legge. I creditori possono inoltre proporre opposizioni al decreto di omologazione (art. 180 CCII) e hanno diritto di opporsi in giudizio a successive decisioni del giudice delegato o del tribunale.
- Commissario giudiziale: nominato dal tribunale all’apertura della procedura (art. 161 CCII), è figura centrale. Ha il compito di verificare la regolarità della documentazione, collaborare alla composizione del piano e, dopo l’ammissione, vigilare sull’andamento della procedura. In particolare, il commissario formula relazioni tecniche, partecipa alle trattative con i creditori e affianca il debitore nella negoziazione di eventuali modifiche al piano e alla proposta (già ex art. 114-bis CCII, introdotto dal correttivo-ter). Egli accerta la veridicità dei dati aziendali e, in caso di cram down, è spesso chiamato dal tribunale a verificare che le condizioni per l’omologazione coattiva siano rispettate (ad esempio, analizzando la convenienza del piano per i creditori pubblici).
- Tribunale (giudice delegato): presiede la procedura concordataria. Decide sull’ammissibilità del concordato, fissa udienze, convoca l’assemblea dei creditori e, sulla base delle risultanze (piano, pareri dei commissari e degli oppositori), delibera sull’omologa. Se tutti i presupposti formali e sostanziali sono rispettati, il giudice delegato omologa il concordato (anche in forma coattiva se richiesto e ammissibile). In sede di cram down, valuta le condizioni di legge (art. 88 e 112 CCII) e può quindi imporre il piano. Inoltre, il tribunale decide su reclami, opposizioni al piano e questioni incidentali connesse al concordato. Il Pubblico Ministero assiste d’ufficio alle udienze e può prospettare criticità (ad es. chiedendo il fallimento se rileva gravi vizi) per tutelare l’interesse pubblico e dei creditori.
- Professionisti di crisi (esperti e consulenti): il legislatore richiede la relazione di un professionista indipendente incaricato dal debitore (art. 161-bis, 172 CCII) che attesti la fondatezza del piano. In sede di composizione negoziata, possono intervenire gli “esperti in composizione” (L. 3/2012) che valutano la convenienza del piano e la validità delle trattative pre-concordat. Inoltre, nel caso di concordato semplificato (procedura veloce), i professionisti esterni collaborano alla relazione ex art. 67 L.F. Richiamiamo anche il ruolo del collegio sindacale (nelle società che lo hanno): pur non previsti esplicitamente nel codice come organo di procedura, esso svolge funzioni di controllo sulla regolarità degli atti sociali e può essere ascoltato dal tribunale per rilievi contabili.
Tabelle di approfondimento
Condizioni del cram down: confronto tra fiscale e cross-class
| Tipologia di cram down | Riferimento normativo | Presupposto attivazione | Condizioni di applicabilità |
|---|---|---|---|
| Cram down fiscale/previdenziale | Art. 88, c. 2-bis CCII (ex LF) | Concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) con transazione fiscale nel piano; mancato raggiungimento dell’unanimità delle classi per includere i creditori pubblici. | (1) Mancata adesione da parte di Agenzia delle Entrate o INPS/INAIL determinante per il superamento delle maggioranze (art. 109 CCII). (2) Convenienza: il piano proposto ai crediti pubblici deve essere non peggiore dell’alternativa liquidatoria (come attestato dal professionista). Se queste condizioni sussistono, il tribunale omologa forzosamente il piano, trasformando in “sì” il mancato consenso degli enti pubblici. |
| Cross-class cram down(ristrutturazione trasversale) | Art. 112, c. 2 CCII | Concordato in continuità con una o più classi dissenzienti; richiesta dal debitore. | Il tribunale omologa se tutte queste condizioni (let. a–d) congiuntamente ricorrono: |
- a) Priorità assoluta: il valore di liquidazione è ripartito rispettando la graduazione delle prelazioni (creditori privilegiati in via prioritaria).
- b) Priorità relativa: il plusvalore (excedente della continuità) è distribuito in modo che i creditori delle classi dissenzienti ottengano complessivamente almeno quanto le classi di pari grado e più delle classi inferiori.
- c) No sovraccarico: nessun creditore riceve dal piano oltre il proprio credito riconosciuto.
- d) Maggioranza qualificata: la proposta è approvata da maggioranza delle classi e almeno una classe favorevole è “di grado superiore” (privilegiata o con diritti di prelazione).
Principali differenze: concordato in continuità vs concordato liquidatorio
| Aspetto | Continuità aziendale | Liquidatorio (cessazione) |
|---|---|---|
| Oggetto del piano | Prosecuzione dell’attività d’impresa (diretta o indiretta); può includere piani di ristrutturazione, cessioni di ramo d’azienda, nuovi finanziamenti. | Vendita dei beni aziendali, incasso crediti, adempimento parziale dei debiti. |
| Maggioranze richieste | Approvazione da tutte le classi (art.109, c.5 CCII), salvo cross-class (art.112). | Idem (unanimità delle classi); non è prevista ristrutturazione trasversale (non si attiva art.112). |
| Requisito convenienza | Concordato più coerente con la sopravvivenza aziendale; valutazione del piano in regime di continuità (favor rei). | Piano liquida e suddivide gli attivi realizzabili; valutazione sul valore di realizzo dei beni. |
| Effetti sulla compagine | Possibile mantenimento di soci e amministratori; non è previsto abbattimento del capitale (salvo legittima restrutturazione). | Di norma azzeramento del capitale sociale; ogni attività residua è liquidata. |
| Ruolo del commissario | Affianca il debitore anche nelle trattative post-ricezione della domanda, proponendo modifiche al piano (art.114-bis). | Il commissario (o curatore) gestisce la liquidazione sotto la supervisione del giudice; non interviene negoziazione. |
| Enti pubblici nel piano | Possono essere inclusi nel piano (transazione fiscale) e sottoposti al cram down (art.88). | Anche qui è ammessa la transazione fiscale, ma senza il proseguimento d’impresa come alternativa. |
| Valore di liquidazione | Si calcola considerando la continuità aziendale (budget, valutazioni going-concern). | Si calcola in forma atomistica: valore netto vendibile dei beni, quote attivo realizzabile secondo principi di liquidazione (meglio l’esigibilità storica dei crediti e il realizzo forzato dei beni). |
Tabelle procedurali e di confronto
Fasi principali del concordato in continuità
| Fase | Descrizione |
|---|---|
| 1. Presentazione domanda | Il debitore deposita al tribunale la domanda di concordato con allegati il piano (di continuità) e la relazione di un professionista indipendente (art. 161 CCII). Se è previsto cram down fiscale, deve anche essere depositata la proposta di transazione fiscale secondo art. 162 CCII. |
| 2. Nomina del commissario | Se il tribunale ammette la domanda, nomina uno o più commissari giudiziali (art. 161). Contestualmente, sospende le esecuzioni individuali (moratoria) e fissa l’udienza per l’eventuale nomina di un giudice delegato. |
| 3. Relazione del commissario | Il commissario esamina la documentazione e la situazione aziendale. Redige la relazione ex art. 172 CCII sulla fattibilità del piano e sulla convenienza rispetto al fallimento. La relazione viene depositata in cancelleria e trasmessa alle parti. |
| 4. Convocazione dei creditori | Il tribunale convoca l’assemblea dei creditori (art. 104 CCII), solitamente entro 60 giorni dal deposito del piano. Viene anche comunicato l’invito alle Amministrazioni Pubbliche (per il voto sui crediti tributari). |
| 5. Assemblea di voto | I creditori si riuniscono e votano in classi (ogni classe esprime un voto unico). Per l’approvazione ordinaria è richiesta l’unanimità delle classi (art. 109 CCII) o altra maggioranza qualificata specificata nel piano stesso. |
| 6. Esito voto e verbale | Se tutte le classi votano a favore, si passa all’omologa ordinaria. Se manca unanimità: – Se ricorrono le condizioni del cross-class cram down (art.112 CCII), il debitore può richiedere l’omologa coattiva. Il commissario giudiziale potrà integrare la relazione valutando le condizioni del cross-class (valore liquidazione e assegnazione surplus).- In caso di cram down fiscale, il tribunale può omologare anche se l’Agenzia Entrate o l’INPS non hanno aderito, verificando le condizioni di legge (art.88, c.2-bis). |
| 7. Udienza di omologa | Il giudice delegato fissa l’udienza di omologa del concordato preventivo. Durante l’udienza finale, valuta il piano, le relazioni dei commissari, le opposizioni dei creditori e dei pubblici ministeri. Se ritiene tutto regolare e, in caso di cram down, le condizioni soddisfatte, emette il decreto di omologa (eventualmente con decreto di omologa coattiva). |
| 8. Omologa e suoi effetti | Con il decreto di omologa, il concordato diviene vincolante per tutti i creditori. Il tribunale dichiara l’omologa anche in mancanza di adesione del Fisco se sussistono le condizioni del cram down fiscale (art.88) e anche in mancanza del consenso di alcune classi se sono soddisfatte le condizioni del cross-class cram down (art.112). Dopo l’omologa, il piano si esegue secondo gli schemi concordatari e i creditori dissenzienti ricevono il valore stabilito dal piano (art.117). |
Effetti del concordato omologato (in continuità)
- Sui debiti: Tutti i debiti oggetto di concordato (tributari, contributivi, chirografari, privilegiati) vengono soddisfatti secondo le previsioni del piano. Eventuali quote residue rimanenti escono da bilancio, mentre le garanzie reali (ipoteche, pegni) permangono sui beni in uso (il debitore continua ad usufruirne nell’esercizio aziendale).
- Sui creditori dissenzienti: Anche i creditori che hanno votato contro o che non hanno partecipato al voto (sia siano classi trattate coattivamente in cram down, sia in forza del voto maggioritario trasversale) ricevono lo stesso trattamento stabilito dal piano, perdendo ogni diritto di prelazione non più soddisfatto. Non possono più rivalersi sul patrimonio oltre quanto previsto dall’accordo.
- Sulla compagine sociale e sul management: Nel concordato in continuità, il piano può prevedere il mantenimento della compagine sociale e degli amministratori (salvo responsabilità); non è necessario azzerare il capitale sociale. In generale il codice tutela la continuità aziendale, quindi l’impresa resta in vita (salvo piani che prevedano cessioni o cessazioni parziali).
- Sui dipendenti: I rapporti di lavoro continuano; la procedura concordataria non autorizza licenziamenti collettivi. Il trattamento dei creditori lavorativi è equiparato a quello dei privilegiati (in prima classe di prelazione) e beneficia delle quote stanziate dal piano, garantendo così la salvaguardia dei redditi da lavoro.
- Sulle obbligazioni sociali: Con l’omologa vengono meno le azioni esecutive sul patrimonio aziendale, che confluisce nella nuova gestione stabilita dal piano (salvo specifiche riserve). Il debitore resta amministratore ordinario dell’azienda in continuità, sotto il controllo del commissario fino all’esecuzione definitiva del concordato.
Queste tabelle sintetizzano i meccanismi e gli effetti concreti del cram down e del concordato in continuità. Le complessità operative (ad es. calcolo dei valori di liquidazione e di continuità, criteri di ammissione del credito, etc.) richiedono solitamente l’intervento di consulenti specializzati, ma le regole essenziali sopra indicate costituiscono la base dell’analisi e della decisione giudiziale.
Domande frequenti (Q&A)
1. Che cosa significa “cram down” nel concordato preventivo?
È l’“omologazione coattiva” del concordato: il tribunale omologa il piano anche se non tutte le classi dei creditori hanno votato favorevolmente. In pratica, il giudice può imporre ai creditori il piano concordatario, se sussistono particolari condizioni di legge (vedi art. 88 e 112 CCII). Il nome inglese “cram down” significa letteralmente “far inghiottire a forza” il piano ai creditori dissenzienti.
2. Qual è la differenza tra il cram down fiscale e il cross-class cram down?
- Il cram down fiscale (art. 88 CCII, c.2-bis) riguarda il dissenso dei creditori pubblici (Fisco e previdenza) in qualunque concordato (liquidatorio o con continuità). Si applica quando queste amministrazioni non hanno espresso adesione: il tribunale omologa il piano se garantisce loro un soddisfacimento non peggiore dell’alternativa liquidatoria.
- Il cross-class cram down (art. 112 CCII) riguarda specificamente il concordato in continuità: consente l’omologa anche se una o più classi di creditori commerciali dissentono, a condizione che siano rispettate le regole di distribuzione delle quote di liquidazione (priorità assoluta e relativa). In breve, il cross-class serve a “valorizzare” l’accettazione di classi sufficientemente ampie e di grado elevato, superando il dissenso di altre classi.
3. Il concordato in continuità può essere omologato se mancano voti favorevoli?
Sì, in certi casi. Se nel concordato in continuità non vota unanimemente ciascuna classe (art. 109 CCII), il debitore può richiedere al giudice l’omologa coattiva. A seconda dei creditori dissenzienti, si applica: (i) il cram down fiscale se sono creditoripubblici qualificati; (ii) il cross-class cram down se sono classi ordinarie. In entrambi i casi è necessario soddisfare le condizioni di legge sopra descritte, altrimenti la procedura non può proseguire e sarà dichiarato fallimento.
4. Il debitore può modificare il piano dopo il deposito?
Sì. Grazie al correttivo-ter (art. 114-bis CCII), il giudice può autorizzare, anche in udienza, modifiche al piano concordatario già depositato, purché il commissario giudiziale le condivida. In pratica, il debitore può integrare o adeguare la proposta iniziale in corso di concordato, con l’assistenza del commissario. Questo serve a migliorare le chance di omologazione quando emergano criticità durante il voto.
5. Come si calcola il valore di liquidazione e il “surplus” di continuità?
Il valore di liquidazione è la stima dei proventi realizzabili vendendo separatamente i beni aziendali (o ritenendo il patrimonio esistente come liquidato). Il “plusvalore concordatario” è la differenza tra il valore assunto nella continuità (ad es. valutazione di un’azienda che prosegue come going-concern) e quello di liquidazione. Sul piano pratico, spesso si fa riferimento alle perizie del professionista del debitore e a eventuali offerte d’acquisto. Il tribunale valuta questi valori (esplicitamente nel cross-class cram down) per verificare il rispetto della graduazione delle prelazioni.
6. Cosa avviene se un creditore non partecipa al voto?
Se un creditore ammesso al voto non si esprime, si considera come non aderente. Nel conteggio delle maggioranze, il suo credito è sommato al totale votante. Tuttavia, ai fini del cram down, la mancata partecipazione dell’Amministrazione Finanziaria può essere “curata” dalla legge (art. 88), mentre le classi dissenzienti nel cross-class devono comunque subire il trattamento previsto dal piano, purché le condizioni di art. 112 siano soddisfatte.
7. Quali sono gli effetti del concordato omologato sui creditori dissenzienti?
Anche i creditori dissenzienti (di fatto “losing bidders”) ottengono il pagamento o il trattamento previsto dal piano, sebbene abbiano votato contro. Non possono più rivalersi con mezzi esecutivi individuali; ogni loro diritto preconcordatario è sostituito dall’accordo. In particolare, se il piano è stato imposto coattivamente (cram down), i dissenzienti escono dalla procedura come creditori “omologati passivi” e percepiranno quanto indicato nella proposta (art. 117 CCII).
8. Che differenze esistono tra concordato in continuità diretta e indiretto?
Si parla di continuità diretta se il debitore prosegue l’attività con la propria organizzazione, eventualmente con nuovi apporti. È “indiretta” quando parte dell’azienda viene ceduta ad un altro imprenditore o società collegata che ne garantisce la continuità operativa (art. 104-bis CCII). In ambedue i casi si applica il concordato in continuità, ma nel caso indiretto il piano può prevedere per esempio la vendita del ramo d’azienda a un’altra impresa, condizionandone l’omologa all’effettivo subentro di un compratore. In entrambi i tipi, valgono le regole generali del concordato in continuità illustrato sopra.
9. Chi valuta la “convenienza” del piano rispetto all’alternativa liquidatoria?
La relazione del professionista indipendente (art. 172 CCII) deve confrontare il trattamento concordatario con quello derivante da un’ipotesi di fallimento. Questa relazione, sostenuta da dati contabili e previsioni economiche, è fondamentale per il giudice nel disporre sia l’omologa ordinaria sia quella coattiva (ad es. nel cram down fiscale si richiede espressamente che il piano sia conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione).
10. In che modo il tribunale applica il cram down fiscale se l’Agenzia Entrate è assente al voto?
Il tribunale tratta l’assenza del creditore pubblico come se fosse un voto favorevole se e solo se sono soddisfatte le due condizioni di legge: l’assenza deve essere determinante per la maggioranza delle classi e il piano proposto deve essere conveniente per l’Amministrazione. In pratica, il giudice rilascia l’omologa indicando che “si omologa anche senza l’adesione dell’ente pubblico perché ricorrono i requisiti dell’art. 88 CCII”. Questa operazione è spesso definita “omologazione forzata” o “omologa coattiva”.
Simulazioni pratiche e casi studio
Per comprendere l’applicazione concreta dei principi, presentiamo alcuni esempi numerici semplificati.
Caso 1: Cram down fiscale nel concordato in continuità
Contesto: La società Alfa S.p.A. propone un concordato con continuità. Debiti: 80 verso una banca (privilegiato), 50 verso fornitori (chirografo), 30 verso l’INPS (crediti contributivi). Attivi destinabili in continuità: 100 (valore azienda, going-concern). Valore di liquidazione stimato: 80 (vendita forzata dei beni).
Proposta di piano:
- Banca (credito 80 privilegiato) riceve il 100% (80).
- Fornitori (50 chirografari) ricevono il 50% (25).
- INPS (30 contributi) riceve il 60% (18).
Votazione assemblea: le classi sono: privilegiati (banca), chirografari fornitori, previdenziali (INPS). La banca e i fornitori votano sì (classi apprezzate), l’INPS non partecipa (o vota no).
Verifica condizioni:
- Assenza adesione INPS: non partecipando, rientra nella condizione di “mancata adesione” ex art. 88.
- Convenienza del piano per INPS: in caso di fallimento, liquidazione = 80, la banca sarebbe pagata 80 (per intero) e l’INPS e i fornitori (ammontanti a 30+50=80) si dividerebbero il valore residuo (80-80=0), quindi INPS riceverebbe 0 nella liquidazione. Nel piano concordatario, l’INPS invece riceve 18. Poiché 18 > 0, il trattamento è conveniente rispetto all’alternativa (non è peggiorativo).
- Requisito maggioranze: l’art. 109, c.2 CCII menzionato da art.88 (percentuali) non era essenziale qui perché il tribunale in ogni caso salva il comma 5, c. (cfr. Trib. Napoli).
Omologa: Il tribunale applica l’art. 88, co. 2-bis e omologa il piano imponendo il trattamento anche all’INPS, trasformando il suo dissenso (o assenza) in voto favorevole. In tal modo Alfa S.p.A. prosegue l’attività e soddisfa in parte l’INPS (18/30) che altrimenti nulla avrebbe ottenuto, salvando così posti di lavoro e valore d’impresa.
Caso 2: Cross-class cram down con classi dissenzienti
Contesto: Beta S.r.l. propone un accordo con continuità. Debiti: 100 ipotecati con garanzia di fabbricati (privilegiati primo grado), 80 verso fornitori (chirografari), 60 verso altri fornitori (chirografari di un’altra classe). Valore di liquidazione stimato: 100 (beni ipotecati venduti). Continuità garantisce un valore complessivo di 140.
Classi e voti: Classi creditori: (A) ipotecari, (B) fornitori1, (C) fornitori2. In assemblea: A e B votano favorevolmente, la classe C (60) vota contro. Totale attivo = 100+80+60 = 240. Sì = 100+80 = 180 (75% dei crediti), No = 60 (25%). Non c’è unanimità (classe C dissente) ⇒ si verifica il cross-class.
Verifica condizioni art.112:
- a) Priorità assoluta: Liquidazione 100 è distribuita ai privilegiati (classe A) per intero (100/100). Non resta nulla per gli altri. Quindi la graduazione è rispettata (A in prelazione).
- b) Priorità relativa: Il plusvalore concordatario è 40 (140 cont vs 100 liquid.). Distribuzione del plusvalore: supponiamo il piano assegni 30 agli ipotecari (classe A) e 10 ai fornitori2 (classe C dissenziente), mentre i fornitori1 (classe B) ottengono i 80 già statuiti (più altri benefit dal surplus?). Diciamo che dal surplus la classe C dissenziente riceve complessivamente 10. In liquidazione la classe C non avrebbe preso nulla (essendo residua). Nel piano, Classe C ottiene 10 su credito 60 (≈17%). Mentre la classe B (pari grado) avrebbe ottenuto lo 0% in liquid., riceve 80/80=100% + nulla dal surplus. Classe C quindi riceve sicuramente più di quanto avrebbe in liquidazione (rispetto relativo rispettato perché almeno non ottiene meno di classe B). Inoltre, il piano assicura che i dissenzienti C ricevano “almeno quanto” i pari grado B (in questo esempio, 10 vs 0).
- c) Nessun eccesso: Nessun creditore prende oltre il proprio credito (a monte i privilegiati 100/100, fornitori1 80/80, fornitori2 10/60).
- d) Maggioranza di classi favorevoli: Le classi favorevoli sono A e B (2 su 3). Almeno una classe favorevole (A) è privilegiata. La classe “sacrificata” C (dissenziente) è appunto di grado inferiore. Quindi una classe privilegiata ha approvato, come richiesto.
Omologa: Tutte le condizioni del cross-class sono rispettate. Anche se la classe C ha respinto il piano, il tribunale omologa il concordato “per ristrutturazione trasversale”, imponendo il pagamento dei 10 alla classe C dissenziente. Le classi A e B rimangono accontentate secondo piano. Al termine, Beta S.r.l. continua l’attività con i creditori soddisfatti come da piano, nonostante il dissenso della classe C.
Caso 3: Concordato in continuità con risorse esterne
Contesto: Gamma S.p.A. (società manifatturiera) ha un debito complessivo di 300 (privilegi 100, dipendenti 50, fornitori 150). Il valore aziendale in continuità è stimato 200. Per raggiungere la maggioranza necessaria, Gamma trova un investitore interessato: i nuovi soci si impegnano a integrare 50 di nuova finanza fresca per il piano, ma a una condizione: i creditori dovranno accettare un trattamento inferiore rispetto a quanto verrebbero liquidati senza questa iniezione.
Procedimento: Con 50 di cash addizionale, la capacità di pagamento complessiva sale a 250. Il piano propone: privilegiati 100 (100%), dipendenti 50 (50%), fornitori 150 (66%). In assemblea manca l’unanimità: le classi di creditori (privilegiati, dipendenti, fornitori) vedono un sì dai primi due (100% e 100%), no dai fornitori (66%). Ciò significa 150 sì vs 150 no. Il cross-class chiede verifica:
- Liquidazione (senza investitore): gli attivi sarebbero stimati 200 (patrimonio fisso e some di magazzino, meno eventuali costi), mentre i debiti complessivi sono 300. Nel processo di liquidazione la regola di priorità darebbe ai privilegiati 100 e nulla agli altri. I fornitori in liquidazione riceverebbero 0, mentre nel piano concordatario ricevono 100 (due terzi dei 150).
- Con 50 di risorse esterne, il piano convince il tribunale che il trattamento dei fornitori (pur ridotto dal 100 all’66%) è comunque superiore al nulla che avrebbero in liquidazione, e tutte le condizioni di art.112 sono rispettate: valore di liquidazione rispettato (100 ai privilegiati), plusvalore distribuito offrendo agli altri creditori qualcosa anziché zero, nessun creditore prende più del proprio credito, e la maggioranza di classi favorevoli include quella privilegiata.
Risultato: Il piano in continuità viene omologato con cram down trasversale anche per i fornitori dissenzienti, grazie alle risorse esterne che hanno permesso di migliorare il trattamento rispetto all’alternativa fallimentare. La società rimane in attività, consolidando il debito e immettendo capitale nuovo.
Questi esempi illustrano come il meccanismo del cram down (fiscale o cross-class) consenta di perseguire il risanamento aziendale anche contro la volontà di alcune categorie di creditori, a patto che le regole di legge su priorità e convenienza siano rigorosamente rispettate.
Ruoli di creditori, professionisti, tribunale e commissario
- Creditori: partecipano al procedimento votando sulla proposta. Sono organizzati per classi secondo il grado di prelazione (art. 85 CCII). Hanno diritto a essere informati (convocazioni, relazioni), possono formare comitati (se nominati, artt. 138 ss.) e devono essere sentiti in particolare nelle eventuali opposizioni al concordato. Nel cram down fiscale, il Fisco e gli enti previdenziali sono trattati come creditori privilegiati (con voto speciale) e il loro dissenso può essere neutralizzato dall’omologa coattiva. In caso di cross-class, i creditori dissenzienti sanno che accettando l’art. 112 rischiano di vedersi convertire il proprio voto, mentre quelli favorevoli “trascinano” il piano verso l’omologa.
- Professionisti del debitore: gli avvocati e commercialisti che redigono il piano accompagnano l’imprenditore durante tutta la procedura. Devono assicurare la completezza della documentazione (bilanci, prospetti, piani finanziari), curando la redazione della relazione di fattibilità e comparazione con la liquidazione. Il professionista indipendente (art. 161-bis CCII) verifica i dati forniti dal debitore e attesta la veridicità della situazione patrimoniale ed economica. Durante la composizione negoziata l’esperto incaricato dalla legge (L. 3/2012) esamina la convenienza del piano per i creditori. Tali relazioni tecniche sono fondamentali per il giudice nel valutare fattibilità e conformità del piano.
- Tribunale e giudice delegato: il giudice delegato coordina la procedura in tribunale fallimentare. Apre la procedura, nomina il commissario, convoca i creditori, raccoglie il parere del PM e i reclami. L’ultimo atto del giudice delegato è l’udienza di omologa: se il concordato è approvato regolarmente, emette il decreto di omologa; se mancano voti, valuta le istanze di cram down. Ha il potere di omologare il piano anche “forzosamente” (cram down) se sussistono le condizioni normative. Inoltre, può autorizzare modifiche ex art. 114-bis e decide sulle opposizioni al concordato.
- Commissario giudiziale: figura di raccordo fondamentale. Nominato dal tribunale all’ammissione, compila la relazione ex art. 172 CCII sull’assetto economico-finanziario e sul piano. Durante la procedura affianca il debitore nelle trattative con i creditori e la stesura del piano: ad esempio, coadiuva nella predisposizione di atti integrativi o modificativi su richiesta del tribunale o del debitore. Il correttivo-ter ha addirittura rafforzato questo ruolo, stabilendo che “nel concordato in continuità aziendale il debitore sarà affiancato dal commissario giudiziale nella negoziazione di eventuali modifiche del piano e della proposta”. Il commissario vigila sull’esecuzione degli obblighi procedurali e redige la relazione finale di verifica (art. 174 CCII) necessaria per l’omologa. In sostanza, è la “coscienza” della procedura, cui spetta l’onere di segnalare al tribunale irregolarità o criticità.
- Pubblico Ministero: assiste obbligatoriamente alle udienze di concordato e può sollevare eccezioni (art. 5 L.Fall). In caso di tentata “forzatura” indebita del concordato, può richiedere al giudice la dichiarazione di fallimento. Il PM tutela l’interesse pubblico (in primis garantendo che le regole siano rispettate) e difende i creditori (ad es. gli obblighi erariali), ma in genere non entra nel merito della convenienza dei piani, lasciando al giudice delegato questo compito tecnico.
- Collegio sindacale (società chiusa): benché non previsto esplicitamente nel CCII, può assumere un ruolo propositivo: al tavolo del concordato i sindaci possono evidenziare vizi contabili o di legittimità del piano, anche segnalando l’eventuale fallacia delle assunzioni prospettiche. Il tribunale può tener conto dei loro rilievi nella valutazione complessiva.
In sintesi, il sistema del concordato in continuità è fortemente collaborativo: il debitore e il suo team predispondono il piano; i creditori (e soprattutto i pubblici) lo esaminano e votano; il commissario garantisce correttezza; il tribunale decide; il PM vigila. Il cram down aggiunge un ulteriore strato di verifica, in cui il giudice valuta se le “promesse” del piano (in particolare verso lo Stato) sono onorabili, ponendo così un freno alla arbitraria imposizione del piano.
Riferimenti normativi e bibliografici
- Normativa nazionale:
– D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 85, 86, 88, 109, 112, 161, 172, 180, 182-bis, 182-quinquies, 114-bis CCII, etc.).
– D.Lgs. 27 settembre 2024, n. 136 – Terzo decreto correttivo del Codice della crisi (modifica l’art. 88 CCII e introduce l’art. 114-bis CCII).
– L. 17 dicembre 2021, n. 233 (convertito da D.L. 118/2021) – Misure urgenti in materia di crisi d’impresa.
– D.Lgs. 14/2019 integrato dalle modifiche successive (es. D.Lgs. 130/2020, L. 40/2022, etc.). - Giurisprudenza citata:
– Tribunale di Napoli, ordinanza 24/4/2024 (Scoppa, est. Feo) – Cram down fiscale ammesso nel concordato con continuità.
– Tribunale di Ferrara, sentenza 11/12/2024 (rel. Cocca) – Cram down fiscale non applicabile in continuità (testo ante correttivo).
– Corte Appello di Bari, 4/12/2024, n. 232/2024 – Cross-class cram down nel concordato in continuità (rigetto reclamo Agenzia Entrate).
– Tribunale di Caltanissetta, 19/12/2024 (Canto, est. Di Francesco) – Cram down fiscale ammesso nel concordato in continuità (disciplina previgente).
– Altre pronunce: Tribunale di Milano 2023, Tribunale di Roma 2023 (esempi sul concordato), Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2022, n. 32890 (sul valore di liquidazione e ristrutturazione trasversale). - Altri riferimenti:
– D. L. 24 dicembre 2012, n. 212 (convertito in L. 23/2013) – Legge Fallimentare (per confronti storici).
– Direttiva UE 2019/1023 sul quadro di prevenzione dell’insolvenza (recepita dal CCII).
Cram Down e Concordato in Continuità: Perché Affidarti a Studio Monardo
Sei un imprenditore e stai valutando un concordato preventivo in continuità aziendale, ma i creditori non collaborano o minacciano di bloccare la proposta?
Con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, hai uno strumento potente dalla tua parte: il cram down fiscale e contributivo.
Ti consente, in presenza di determinate condizioni, di superare il dissenso dell’Agenzia delle Entrate, INPS o altri enti pubblici, e portare comunque a termine il piano di risanamento.
⚠️ Ma attenzione: è una procedura tecnica, che richiede tempismo, documentazione precisa e strategia legale esperta.
Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo
✅ Analizza la situazione aziendale e fiscale, verificando se ci sono le condizioni per accedere al concordato in continuità
✅ Predispone un piano sostenibile e attuabile, dimostrando che la continuità aziendale è più conveniente per tutti i creditori
✅ Invia la proposta ai creditori pubblici (AdER, Agenzia Entrate, INPS) e gestisce ogni fase del contraddittorio
✅ Richiede al giudice l’omologazione forzata (cram down) anche in presenza di diniego da parte dell’Erario
✅ Ti rappresenta in tutta la procedura, coordinando la difesa aziendale e patrimoniale con commercialisti, advisor e professionisti certificati
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in diritto della crisi d’impresa e risanamento aziendale
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di consulenti esperti in procedure concorsuali, contenzioso fiscale e tutela del patrimonio imprenditoriale
Perché agire subito
⏳ Il cram down si applica solo se il piano è tempestivo e fondato su dati certi
⚠️ Senza strategia legale, il dissenso dei creditori pubblici può far saltare l’intera procedura
📉 Rischi reali: fallimento, liquidazione giudiziale, perdita della continuità e responsabilità personali
🔐 Solo un’azione ben guidata può salvare l’azienda, ristrutturare il debito e proteggere la tua posizione
Conclusione
Il cram down fiscale non è una scorciatoia, ma una via legale concreta per salvare imprese sane in difficoltà temporanea, anche senza l’accordo dell’Erario.
Ma serve un piano chiaro, un team competente e un avvocato capace di guidare l’intera procedura.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa costruire una strategia di risanamento efficace, legale e sostenibile, che tuteli l’impresa, l’amministratore e il futuro dell’attività.
Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata. Se vuoi salvare la tua impresa, il tempo è la risorsa più preziosa. Agisci subito.